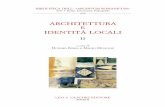Tra Adriatico e Po: commerci e produzioni locali nelle città e nelle campagne tardoantiche
Azioni collettive e mobilitazioni locali: dentro il quartiere Sant'Eusebio
Transcript of Azioni collettive e mobilitazioni locali: dentro il quartiere Sant'Eusebio
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO BICOCCACorso di Laurea in Sociologia
AZIONI COLLETTIVE E MOBILITAZIONI LOCALI: dentro il quartiere Sant’Eusebio
Elaborato finale di SALA ANDREA
Matricola 746231Anno Accademico 2013-2014
Relatore prof. TOSI SIMONE
Indice
Introduzione 1
Capitolo 1 - Città, quartiere, azione 5 1.1 Il rapporto città-quartiere nella ricerca sociale 5 1.2 Definire il quartiere 9 1.3 Una dicotomia classica: politiche “dal basso/informali” vs. politiche “istituzionali” 10 1.4 L’attivazione di quartiere – L’azione collettiva territorializzata/localizzata 16
Capitolo 2 - Cinisello Balsamo: Sant’Eusebio 24 2.1 Uno sguardo sul territorio 25
2.1.1 Cinisello Balsamo, la città 25 2.1.2 Sant’Eusebio, periferia 27
2.2 Storia del quartiere 31 2.2.1 Da Cinisello al quartiere 31 2.2.2 Dagli anni 70’ ad oggi: Sant’Eusebio 32
2.3 Gli attori in campo 39 2.3.1 L’amministrazione comunale 40 2.3.2 La parrocchia 43 2.3.3 Il Marse 45 2.3.4 Il Comitato Inquilini 47
Capitolo 3 - Azioni collettive e attivazioni : una ricerca 49 3.1 Modalità della ricerca empirica 49 3.2 Una schematizzazione degli eventi di attivazione 52
3.2.1 Cosa si intende con attivazione? 52 3.2.2 Come si possono classificare le attivazioni? 55
3.3 Mobilitazioni e conflitti, alcuni approfondimenti 61 3.3.1 Entrare a far parte della città: la questione trasporti e il dirottamento del 1978 61 3.3.2 La domanda di servizi e occasioni di socialità, il caso del mercato “finto” 65 3.3.3 Il Contratto di Quartiere “Sant’Eusebio” 69
Conclusioni 76
Appendice 82
Bibliografia 87
1
Introduzione
Il tema della partecipazione alle politiche pubbliche è un tema ampiamente dibattuto negli
ultimi decenni soprattutto in relazione al contesto urbano. La numerosità degli studi che
hanno come oggetto questi progetti recenti, legati a processi di riqualificazione urbana,
testimoniano un rinnovato interesse per il coinvolgimento dell’ “utenza finale” nella
pianificazione e nella realizzazione delle politiche. Si parla di attenzione rinnovata perché le
prime esperienze che è possibile collocare in questo campo risalgono agli anni ‘50-‘60
quando, grazie all’iniziativa di alcuni pionieri, si è assistito a un periodo di grande popolarità
del lavoro di comunità (Tosi, 2004). In quel periodo si riteneva, infatti, che la comunità fosse
la cornice adatta a sostenere e promuovere lo sviluppo del territorio poiché da essa poteva
arrivare un vero coinvolgimento della popolazione nelle decisioni che avrebbe reso gli
abitanti parte attiva nelle scelte che interessavano la città.
Dagli anni 70 in poi si è deciso di integrare nel corpus delle politiche sociali istituzionali
alcuni dei dispositivi e meccanismi che erano propri delle attivazioni informali e spontanee
cercando in questo modo di aumentare l’efficacia degli interventi e costruire consenso attorno
alle scelte delle politiche pubbliche. Se prima la distinzione tra politiche informali e politiche
istituzionali poteva essere trovata nel grado di coinvolgimento dei destinatari,
necessariamente più alto nel primo caso e più basso nel secondo, più recentemente la
compenetrazione tra i due approcci ha fatto si che i due campi si sovrapponessero creando
situazioni ibride.
Il quartiere Sant’Eusebio a Cinisello Balsamo è esemplificativo in questo senso perché
nella sua storia è possibile individuare esperienze di entrambi i tipi. Dagli anni 70’ fino ai
primi anni ’90, il quartiere è stato teatro di alcune mobilitazioni “dal basso” che, forti del
coinvolgimento e del supporto della popolazione, si opponevano alle politiche istituzionali
classiche. Successivamente, con l’attivarsi dei primi progetti di politiche pubbliche
partecipate, il Comune ha aderito al bando ministeriale Contratto di Quartiere fungendo da
apripista e pioniere per esperienze miste: il pubblico interveniva sul territorio cercando di
integrare le istanze provenienti dalla popolazione.
La tesi cerca di dare conto di queste due fasi analizzandole sotto punti di vista diversi e
approcci complementari. Si inizierà prendendo in esame le mobilitazioni dal basso che
2
caratterizzano la prima fase; queste hanno visto coinvolti una pluralità di attori: dalle
associazioni localizzate sul territorio, a realtà informali e meno strutturate, a gruppi di
ispirazione politica fino a formazioni partitiche e, ovviamente all'istituzione sotto forma di
amministrazione comunale o consiglio di circoscrizione.
Gli ambiti di negoziazione che sono stati portati all'attenzione della sfera pubblica e sono
stati oggetto di discussione sono tra i più vari; la maggior parte di essi, però, sono
riconducibili alla sfera delle politiche urbane. Le mobilitazioni, infatti, rivendicavano la
possibilità degli abitanti di avere voce in capitolo nelle scelte dell'amministrazione circa la
pianificazione del territorio, la dislocazione dei servizi nello spazio, i progetti di
riqualificazione, l'accesso alla casa, la gestione del verde, l’allocazione e funzionamento delle
infrastrutture e la gestione degli spazi pubblici (Vitale, 2007). Esse si definiscono "conflitti
urbani" perché il loro ambito di discussione si esplicita all'interno delle politiche urbane.
Bisogna dunque fare dei distinguo perché per conflitti urbani non si intendono, in questa sede,
tutti i conflitti nati all'interno della città; essa è certamente legata al conflitto (Lefebvre, 1996)
perché lo rende visibile (data la sua centralità sul piano nazionale e internazionale) ma
sarebbe sbagliato ricondurre sotto la stessa bandiera tutte le mobilitazioni nate all'interno di
essa. Inoltre non è corretto pensare che queste stesse attivazioni abbiano per natura un
carattere conflittuale. Esse, infatti, possono nascere da esigenze condivise e manifestarsi sotto
forma di attivazioni collettive welfare dal basso che non sempre "puntano il dito" o
individuano una chiara controparte. Quando è poco definito il soggetto che dovrebbe far
fronte a un’istanza dei cittadini, può capitare che gli interessati si mobilitino in prima persona
per sopperire alla suddetta mancanza, attivandosi collettivamente e in modo spontaneo per il
proprio territorio. Questo tipo di azione, ad esempio, ha tra i suoi precursori la figura di
Danilo Dolci, uno dei primi ad occuparsi di quei territori “marginali” spesso dimenticati
dall’istituzione. La sua opera, tesa a stimolare negli abitanti una presa di coscienza
individuale e collettiva della propria condizione, portava in poco tempo una mobilitazione di
risorse enorme da parte della popolazione nonostante essa stessa possedesse pochissimi
strumenti1.
Tornando a Sant’Eusebio, si può parlare in questo caso di azioni simili? Quali sono i
fattori che hanno permesso il perpetuarsi di queste azioni collettive? Come si vedrà nel
1 Cfr, capitolo I.
3
capitolo I, diversi autori vedono nel concetto di comunità un dispositivo utile ad interpretare il
grado di successo di queste azioni e tra gli obiettivi dell’elaborato c’è quello di stabilire
quanto il suddetto concetto sia aderente alla situazione nel quartiere; cioè, si può parlare di
comunità a Sant’Eusebio?
Un secondo asse, parallelamente, mette a confronto le mobilitazioni della prima fase con
il progetto ben più strutturato e complesso del Contratto di Quartiere ponendo maggior risalto
al ruolo degli attori. In questo caso si cercherà di analizzare le attivazioni nel loro complesso
con l'obiettivo di stabilire se esiste o meno un conflitto anche nelle politiche pubbliche
partecipate, quale il suo grado, quali le modalità e la sua risoluzione. Attraverso una
sistematizzazione delle due dicotomie, alto-basso e conflittuale-consensuale si cercherà di
capire se e come sono cambiati i rapporti di forza tra le parti e qual è il risultato di questo
cambiamento. Prima di ogni mobilitazione, infatti, si confrontano e si misurano una serie di
realtà, con il loro potere contrattuale e la loro capacità di entrare nell’arena decisionale.
Durante l’attivazione queste configurazioni vengono messe in discussione e la “geometria”
subisce un cambiamento: chi ha tratto vantaggio dalla mobilitazione e chi invece ne è uscito
svantaggiato?
Lungo l’ultimo asse, sfruttando l’analisi delle mobilitazioni dal basso e il confronto di
quest’ultime con il Contratto di Quartiere si concentrerà l’attenzione su questa esperienza di
intervento pubblico partecipato. L’obiettivo sarà quello di valutare se la partecipazione è stata
uno strumento utile ai fini della riuscita del progetto, quali vantaggi ha portato e quali criticità
non è riuscito a risolvere.
Nel primo capitolo verrà presa in considerazione la letteratura sociologica sul tema del
quartiere e della città. Si darà conto degli studi e dei testi che trattano del rapporto tra
territorio e tessuto sociale con particolare attenzione alla questione della comunità. Nel terzo
paragrafo, dopo aver definito cosa si intende per “quartiere”, si discuterà della differenza tra
le politiche istituzionali e quelle informali. Infine, dopo aver dato una definizione ampia delle
azioni collettive territorializzate si forniranno alcuni esempi attraverso le esperienze di alcuni
“attivatori”.
Il secondo capitolo sposta l'osservazione sul territorio di Cinisello Balsamo attraverso una
fotografia dei suoi caratteri fondamentali per poi centrare l’analisi sul quartiere di
4
Sant’Eusebio. Si definiranno i confini e la morfologia del territorio preso in esame attraverso
una panoramica sui luoghi significativi e più ricorrenti nei racconti degli intervistati.
Nell’ultimo paragrafo si guarderà al tessuto sociale del quartiere, alle sue “istituzioni”, alle
sue realtà e i ai suoi centri decisionali.
Nel terzo capitolo, dopo una breve introduzione sulle modalità con cui è stata condotta la
ricerca, si classificheranno le mobilitazioni emerse nelle interviste. Attraverso un
approfondimento su alcune vicende “chiave” si traccerà il resoconto delle negoziazioni che
sono state il fulcro delle politiche sociali.
Le conclusioni riprendono i temi qui sopra esposti cercando di fornire una visione
d’insieme: un’analisi delle attivazioni “dal basso”, un confronto tra esse e il Contratto di
Quartiere, una valutazione del Contratto di Quartiere e dell’efficacia della partecipazione
come strumento d’intervento.
5
Capitolo 1 - Città, quartiere, azione
1.1 Il rapporto città-quartiere nella ricerca sociale
Gran parte della letteratura sociologica sul tema del quartiere, ancor prima di definire con
precisione quali siano i confini (terminologici e spaziali) dell’oggetto analizzato si pone
innanzitutto una domanda: ha ancora senso parlare di quartiere come unità di analisi nella
ricerca sociale? Siamo ormai di fronte a fenomeni che trascendono i confini nazionali, reti e
relazioni si formano in spazi “dei flussi”, non localizzati e impossibili da ancorare a un
territorio specifico; il quartiere può ancora ambire ad essere spazio di ricerca significativo?
La risposta è certamente positiva se si considera il quartiere come spazio fisico in cui
osservare il rapporto tra l’individuo e il territorio, o meglio, tra abitanti e territorio. Esso
acquisisce importanza proprio per la sua immediata identificazione con il locale, uno spazio
dove diventa significativo studiare le dinamiche microsociali e le interazioni tra gli individui.
Gli studi di comunità, infatti, sono analisi che hanno per definizione un campo di rilevazione
limitato ma che non rinunciano a proporre quadri teorici più ampi.
L’equazione quartiere=locale ha stimolato, nel corso degli anni, un’intensa attività delle
politiche sociali centrate su specifiche porzioni di territorio. Il quartiere, infatti, è tra i luoghi
che più concorrono alla formazione dell’individuo: crea aspettative, favorisce processi di
identificazione e appartenenza (che possono trasformarsi in stigma) e influenza meccanismi di
attivazione. Proprio per questo sono stati promossi progetti per la riqualificazione dei quartieri
degradati o “a rischio criminalità”, altri orientati alla lotta all’abbandono scolastico o più in
generale ai sintomi di esclusione sociale, altri ancora volti a stimolare processi di
partecipazione e attivazione della cittadinanza. Tutti hanno in comune l’essere stati pensati e
progettati per il “neighbourhood”2 o per aree specifiche della città (Contratti di Quartiere,
Urban I e II, ecc.). Il quartiere è inoltre lo spazio in cui diventano più evidenti i processi di
marketing territoriale applicati alle grandi città; spesso questi luoghi cambiano volto in pochi
anni, recuperando centralità rispetto alla città o rivoluzionando la propria composizione
sociale interna a seguito di grosse riqualificazioni (si pensi ai quartieri Isola e Bicocca a
2 In lingua inglese il termine neighbourhood comprende l’ italiano “quartiere” e “vicinato”. Come scrive McKenzie (1921), si incorpora in un unico vocabolo l’idea di “prossimità fisica ad un determinato oggetto di attenzione(..)” e “l’intimità di relazioni fra persone che vivono vicine tra loro”. Per una definizione più precisa cfr. par. 1.2
6
Milano) (Borlini e Memo, 2008). Più in generale, l’interesse della sociologia per il quartiere
riflette l’attenzione per le trasformazioni causate da processi che investono la società nel suo
complesso: l’urbanizzazione e l’aumento della popolazione che vive in contesti urbani;; la
burocratizzazione con il progressivo aumento degli apparati amministrativi; la
differenziazione e moltiplicazione dei ruoli e delle appartenenze individuali.
L’identificazione del quartiere con l’ambito locale, o più specificatamente, con il concetto
di comunità ha sviluppato negli anni un lungo dibattito in seno alla sociologia.
Quella che è stata definita la “questione di comunità” ha visto contrapporsi due filoni, quello
della perdita di comunità e quello della persistenza della comunità.
Secondo i sostenitori della prima posizione, tra i quali spicca il sociologo tedesco Wirth
(1998), l’avvento della modernità avrebbe avuto sostanziali ripercussioni sulla città: in essa
venivano meno i legami “primari” caratteristici dei contesti comunitari in favore di interazioni
transitorie e fluide. L’argomento del declino delle relazioni “forti” (e quindi comunitarie) tra
gli individui a vantaggio di quelle occasionali e strumentali è ripreso dai sociologi classici
quali Tonnies e Simmel. Entrambi scorgono nella modernità un effetto spersonalizzante, che
favorisce lo sviluppo di individui anonimi e non legati a nessun contesto di appartenenza.
Secondo Tonnies i legami primari, frutto di relazioni di parentela o amicizia sarebbero
esclusivi di situazioni di Gemeinshaft e quindi destinati a scomparire con l’avvento della
società moderna. Simmel (1996, 24), invece, utilizza la dicotomia per soffermarsi sulla
descrizione dell’individuo blasè, la “vittima” della modernità a cui tutto appare “uniforme,
grigio, opaco”, indifferente verso le cose e verso le persone, anonimo e privo delle relazione
che si creano in seno alla comunità. La conclusione che si delinea attraverso questi pensieri è
orientata a screditare l’utilizzo del concetto di comunità nell’interpretazione della società
moderna. Wirth scrive, parlando dei quartieri, che l’appartenenza ad uno di essi è spesso
frutto di una non-scelta: gli individui vengono aggregati forzatamente secondo criteri di
status, razza, religione e lingua e ciò non può stimolare la creazione di comunità in senso
stretto.
Contrariamente, i sostenitori della “persistenza”, basano proprio su quest’ultimo dato una
delle loro argomentazioni a favore dell’esistenza, tuttora, di una vita comunitaria di quartiere.
Young e Willmott (1957), nella loro ricerca su un quartiere dell’East London, rilevano che i
legami creatisi negli anni sono frutto di diverse congiunture, in primis lo status sociale degli
7
abitanti. Gli uomini svolgono quasi tutti lo stesso mestiere (operai) mentre le donne, per la
quasi totalità casalinghe, frequentano gli stessi luoghi in orari della giornata simili riuscendo a
creare molte occasioni di socialità. L’avere una scansione temporale simile consente agli
abitanti di frequentare i medesimi luoghi nei medesimi orari della giornata, condividere
esperienze, rafforzare i legami e dare vita a una vera e propria solidarietà di classe. Anche
Gans (1966) si pone in netto contrasto con le analisi di Wirth riguardo l’effetto
dell’omogeneità sociale nei quartieri. Egli sostiene che proprio l’omogeneità sociale, collegata
a un’alta stabilità residenziale tra gli abitanti, siano i principali fattori che consentono la
costituzione di legami interni al quartiere di carattere quasi primario. La concentrazione dei
poveri, degli stranieri o comunque dei cosiddetti “esclusi” in zone specifiche della città
favorisce la creazione di “villaggi urbani” in cui relazioni e legami si formano e si esplicano
nel quartiere uscendo molto raramente da quel contesto territoriale.
Queste vere e proprie “città nella città” permettono, secondo Gans, di salvaguardare il
concetto e l’esistenza delle comunità: “la comunità è salva” nel quartiere. La città assume in
questo modo un carattere opposto e quasi ostile: mentre il quartiere è la “culla” della
comunità, la città è sentita come disgregatrice, luogo dove i rapporti diventano impersonali,
brevi, strumentali.
A superare l’impasse è giunta, in anni più recenti, la tecnica di ricerca della network
analysis. Lo studio delle reti di relazioni dei singoli individui ha permesso di sviluppare teorie
più complesse e non più strettamente legate alla dicotomia comunità-si versus comunità no.
L’analisi delle reti ha messo in luce l’esistenza di legami forti anche tra realtà spazialmente
distanti facendo tramontare l’idea che la comunità potesse esistere solo in contesti localizzati
o di quartiere (Borlini e Memo, 2008). La dicotomia classica della sociologia è fondata
sull’analisi del complesso passaggio dal mondo “pre-moderno” al mondo “moderno”: le
varianti a questa contrapposizione sono molteplici (comunità-società, razionalità-affettività
ecc.) e anche il rapporto tra città e quartiere è stato per anni interpretato in questo senso. Il
quartiere era visto come spazio naturale della comunità, ad esso si contrapponeva
irrimediabilmente la città, spazio in cui la modernità era nata e stava crescendo
modificandone per sempre la connotazione. Tuttavia, alla luce degli ultimi sviluppi
metodologici sopracitati, sembra piuttosto anacronistico parlare ancora di un concetto di
“comunità” unitario e strettamente legato ai luoghi come lo si era precedentemente inteso.
Molti degli elementi caratteristici della città-moderna infatti si ritrovano ampiamente nei
8
quartieri-premoderni (e “comunitari”) confondendo parecchio i confini tra i due termini.
L’organizzazione “stirata” della città nel suo complesso, l’avanzare della globalizzazione, la
fine dei “sistemi chiusi” (Giddens 1994) sono solo alcuni degli argomenti che contrastano la
visione dicotomica e il concetto di comunità com’era stato precedentemente definito.
Non c’è dunque più spazio per la comunità nel quartiere? La risposta è certamente
complessa ma non totalmente negativa: ad esempio, prendendo come modello gli strumenti
forniti dalla network analysis si può affermare che, ad esempio, potrebbe esistere una
comunità nel quartiere se le reti di relazioni dei residenti fossero sovrapponibili spazialmente
entro i confini dello spazio-quartiere (Borlini e Memo, 2008) . Il problema relativo al concetto
di comunità, riguardante il suo essere troppo legato alla dicotomia modernità-premodernità,
può essere superato mediante l’utilizzo del concetto di “capitale sociale” locale. Non
interessa in questa sede dare una definizione esaustiva del concetto di capitale sociale, data la
sua enormità di sfaccettature e applicazioni differenti3, rimane però da chiarire la sua
importanza sul piano degli studi di quartiere. Esso, se calato in contesti che presuppongono
prossimità spaziale (siano essi quartieri o piccoli paesi) può fornire un’alternativa concreta per
analizzare le reti di relazioni che si creano tra i residenti senza che si debba giustificare la
presenza o meno di una “comunità”. Oltretutto, il capitale sociale, grazie a questa sua nuova
valenza nel locale, è diventato uno tra i principali strumenti per le politiche territoriali a
favore dei quartieri o delle aree urbane “a rischio”. Esso diventa utile per “attivare nella
popolazione comportamenti coesivi, sviluppare fiducia e rafforzare le capacità di operare
insieme per risolvere problemi comuni” (Borlini e Memo 2008, 23; Forrest e Kearns 2001).
3 Per una definizione di capitale sociale cfr. Field J. (2004), trad. it “Il capitale sociale: un’introduzione”, Trento, Erikson.
9
1.2 Definire il quartiere
Si è finora parlato del quartiere, dei suoi rapporti con la città e con il dibattito ancora
aperto circa la “questione di comunità”, senza definirlo in modo specifico. Appurata la sua
importanza generica sul piano della ricerca sociale è indispensabile procedere con una
definizione che svincoli dai numerosi ambiti in cui il termine è utilizzato.
In archittettura e urbanistica sono rilevanti gli edifici e la loro collocazione storica, sul
piano amministrativo si fa riferimento ai bacini di utenza dei servizi, in altre discipline
l’attenzione è posta sulle caratteristiche della popolazione residente ecc. Anche in sociologia
ci si trova in difficoltà a circoscrivere in tutti i suoi aspetti il termine “quartiere”. Nonostante
ciò le definizioni del quartiere fornite dagli autori concordano su tre aspetti: la ridotta
estensione territoriale, il carattere routinario delle interazioni tra gli abitanti, il tipo di funzioni
ricoperte dal quartiere nell’ambito urbano (Borlini e Memo 2008). Come è già stato detto, il
quartiere è una sotto area della città che sta in mezzo tra l’anonimato della città e lo spazio
intimo dell’abitazione privata. La ridotta estensione territoriale permette agli abitanti
interagire tra loro molto più spesso di quanto potrebbero fare con l’esterno;; in questo modo, i
legami che vanno costituendosi favoriscono la presenza di sentimenti di “attaccamento alla
località” (Park 1967) che spesso si traducono in un vero e proprio sentimento di appartenenza.
Nonostante questa prossimità non sia sempre frutto di una scelta, la condivisione di spazi
fisici porta al riconoscimento di una medesima “comunione” d’intenti: si condividono gli
stessi problemi e criticità e spesso ci si attiva collettivamente per farvi fronte. Per gli abitanti,
il quartiere svolge molteplici funzioni; oltre a creare i network di relazioni che permettono
l’attivazione, è il luogo in cui vengono soddisfatti molti bisogni primari,
dall’approvvigionamento all’educazione dei giovani.
Vista l’ampiezza degli argomenti toccati, risulta certamente più utile e significativo tarare
la questione del quartiere mediante il riferimento a un quartiere specifico. In questo modo si
possono individuare le funzioni a cui assolve e in che modo esse si configurano.
10
1.3 Una dicotomia classica: politiche “dal basso/informali” vs. politiche
“istituzionali”
Con il termine “politiche istituzionali” si intendono tutti quegli interventi che vedono
come protagonista e decisore l’istituzione, nelle sue varie forme. Dal livello nazionale fino a
quello, più ristretto, dei comuni, le politiche istituzionali inglobano tutte quelle azioni e quegli
attori che si muovono all’interno di una cornice normativa. L’istituzione, infatti, è il policy
maker per eccellenza; come ovvio, ha gli strumenti e le figure per incidere sulla vita dei
cittadini e migliorarla attraverso interventi di varia natura. Le politiche “dal basso” si
distinguono dalle prime per gli attori in campo; in questo caso i decision maker diventano gli
“attori deboli”: residenti, reti di abitanti, associazioni e comitati radicati nel territorio ecc.
(Tosi 2004).
Ad oggi sembra difficile distinguere in modo netto i due approcci poiché negli anni si è
andata progressivamente affermando l’idea che il coinvolgimento degli utenti finali (i
destinatari delle politiche sociali) nella pianificazione e realizzazione degli interventi fosse un
elemento centrale per l’efficacia delle politiche. Dopo un iniziale periodo di grande popolarità
dei processi di attivazione “informali” con l’affermazione del lavoro di comunità, esso è
ritornato in auge a partire dagli anni ‘70 in forme differenti: si trattava, infatti, di una sintesi
tra politiche pubbliche e azione auto-organizzata.
Fin dalle prime esperienza negli anni ‘50-‘60, gli obiettivi di questi movimenti minoritari
non erano in netto contrasto con quelli di cui si faceva carico l’istituzione;; le modalità
utilizzate erano differenti ma in entrambi i casi si condivideva l’interesse per la comunità e il
suo sviluppo (ne è un esempio il lavoro di Adriano Olivetti a Ivrea che è servito da precursore
e ispiratore delle moderne politiche di welfare). A partire da quella che si può chiamare
“seconda” fase si assiste a un cambiamento nella percezione del lavoro di comunità: viene
riconosciuta una valenza importante nei processi “dal basso” sia per la loro capacità di andare
incontro alle esigenze degli abitanti sia come strumento per creare basi più ampie di consenso
attorno ad alcune scelte politiche (Tosi 2004). D’altra parte, questa insistenza sulla positività
intrinseca di tutto ciò che è frutto di processi partecipativi non ha favorito riflessioni critiche
sulle singole esperienze tanto che spesso la fase di coinvolgimento della popolazione è
additata come meramente ritualistica (Mannarini 2004)
11
Come già accennato si possono individuare due fasi distinte nel rapporto tra politiche
informali e politiche istituzionali, le quali corrispondono allo sviluppo e al declino del lavoro
di comunità (Tosi 2004).
La prima fase, abbraccia gli anni che vanno dall’immediato dopoguerra fino agli anni
sessanta. In un clima di forte interesse per la ricostruzione del paese, distrutto dal conflitto
mondiale, ritorna prepotentemente la questione dell’arretratezza di alcune aree dell’Italia del
sud. Questi due motivi, congiuntamente a un’attivazione anche dal punto di vista normativo
(la riforma agraria e la legge Fanfani), favoriscono la nascita di alcune esperienze di lavoro
comunitario. Inoltre, tra gli elementi che giocano a favore, bisogna ricordare la generalizzata
paura che l’avvento della modernità stava portando;; era necessaria una risposta forte al
progressivo disgregarsi delle forme tradizionali di relazioni e il lavoro di comunità sembrava
rispondere a questa esigenza. Alla nascita esso era privo di basi teoriche forti e si fondava su
esperienze molto eterogenee; il filo conduttore era la critica più o meno radicale alla
modernità e ai suoi aspetti spersonalizzanti. Alcuni si rifacevano ai socialisti utopici
ottocenteschi, altri alla tradizione democratica americana, altri ancora alle teorie libertarie che
sostenevano i principi dell’auto-organizzazione. (Tosi 2004).
Le esperienze di politiche “dal basso” o informali rientrano tra quei processi di
attivazione locale di cui si fanno promotori due grandi figure del dopoguerra italiano: Adriano
Olivetti e Danilo Dolci. Le azioni di Adriano Olivetti rientrano con più immediatezza sotto il
termine “politiche”, probabilmente perché fanno parte di un intento migliorativo di più ampio
respiro attuato fin da subito dall’imprenditore eporediese. Bisogna però considerare che gli
intenti di Olivetti, come emerge da alcuni dei suoi scritti, andavano oltre l'idea di una fabbrica
solidale. Non si trattava, cioè, di dare vita a un'azienda “paradiso” che si occupasse
“solamente” tutti i bisogni dei suoi occupati in un sistema efficacie e chiuso, ma di concepire
la fabbrica come bene comune e quindi interesse della società nella sua interezza.
Olivetti (2014) sottolinea con forza il collegamento tra la fabbrica e il territorio in cui essa
opera: “Quando dovevo reclutare giovani allievi delle scuole medie per formare i quadri futuri
della fabbrica dovevo accordarmi con le autorità scolastiche locali”;; la soluzione a problemi
interni era spesso applicabile al di fuori del contesto lavorativo, e “solo chi avesse potuto
coordinare i problemi interni a quelli esterni sarebbe riuscito a dare la soluzione corretta a
tutte le cose” (ibidem, 32). Ragionare nel contesto locale stimola Adriano ad ampliare i servizi
12
già attivati dal padre Camillo prima del secondo conflitto mondiale. Prima tra tutti,
l'assistenza sanitaria garantita agli occupati presso la fabbrica è il segno di una svolta nel
concepire i rapporti tra imprenditore e lavoratori, ma soprattutto fra azienda privata e società.
Il valore sociale dell'impresa è posto se non al di sopra dei profitti, su un piano parallelo4,
sviluppando l'idea secondo cui il benessere dei lavoratori dev'essere posto al centro di ogni
attività economica (Olivetti 1960). Nascono per questo diversi servizi, per l'epoca
straordinariamente innovativi, di supporto alle famiglie, quali i sussidi di maternità e i primi
provvedimenti per l'educazione: l'asilo nido per i figli dei dipendenti e le colonie estive, un
sistema per garantire l'accesso all'istruzione superiore con borse di studio e incentivi,
l'istituzione di una biblioteca e un centro culturale. Oltre ai servizi si aggiungevano alcune
forme di politiche abitative: la costruzione di alloggi per le famiglie collegati, tramite reti
stradali appositamente costruite, ai luoghi di lavoro. Per Olivetti non esiste una fabbrica o
un'azienda senza radici, che possa essere spostata e impiantata su un qualsiasi territorio, non
esiste un imprenditore che non si occupi delle necessità dei suoi dipendenti: in sostanza, non
esiste impresa senza comunità.
La Comunità olivettiana deve necessariamente uscire dal limitato contesto della singola
industria, è questo il principale intento di cui Adriano si fa portatore. Ovviamente riconosce le
difficoltà che questo processo potrebbe comportare: “un alto grado di solidarietà umana, sia
nei proprietari sia nei lavoratori” (Olivetti 2014, 20) se anche esiste tuttora all'interno della
fabbrica, non è detto che lo sarà per sempre o che potrà essere esportato in contesti più ampi.
Come muoversi per “stimolare solidarietà”? “Bisogna dare consapevolezza di fini al lavoro”
spiega Olivetti (1960, 26): l'industria non può avere i suoi unici fini nel profitto ma deve avere
una “destinazione, una vocazione” nell'agire all'interno della comunità. Questa
consapevolezza, oltre che essere propria dell'imprenditore, dev'essere attributo fondamentale
dei lavoratori che lavorano e vivono la Comunità: consapevolezza dell'importanza e della
centralità del proprio lavoro per lo sviluppo non di un profitto ma del territorio e della
Comunità stessa. Se si comincia a pensare nei termini di una comunità-impresa acquistano
senso tutti i provvedimenti di Olivetti e le azioni migliorative dei contesti lavorativi. Coloro ai
quali erano diretti questi servizi non erano solamente dipendenti dell'azienda ma soprattutto
cittadini della nuova Comunità che partecipavano in prima persona ai fini dell'impresa nel suo
complesso: un'industria che funzionava come uno Stato senza rappresentanti. 4 Bisogna ricordare che non era tra gli intenti di Olivetti, creare una società di assistenza o di sostegno ma riuscire a coniugare due aspetti che paiono tra loro inavvicinabili, il profitto e il benessere dei lavoratori
13
Risulta più difficile pensare alle azioni e le esperienze messe in atto da Danilo Dolci come
vere e proprie “politiche”;; tuttavia, considerando l’evoluzione delle strutture promosse da
Dolci (tra esse l’ex Centro per la Piena Occupazione) non si può tralasciarne l’enorme
importanza ed efficacia che hanno avuto nel migliorare la vita degli abitanti mettendo in
pratica, di fatto, delle politiche sociali “dal basso”. Durante i primi anni del suo operato a
Partinico e Trappeto, Dolci si muove e organizza senza alcuna struttura, il suo metodo si
affina con il lavoro e l’esperienza ma soprattutto attraverso il contatto diretto con la
popolazione; non introduce miglioramenti, stimola e incoraggia l’azione collettiva degli
abitanti. Dopo la fondazione del Centro (oggi rinominato in Centro per lo Sviluppo Creativo)
si può parlare, a ragione, di “politiche informali”: esso diventa il fulcro culturale e politico
della zona promuovendo la rinascita di tutto il territorio circostante. Le esperienze informali e
“non strutturate” cessano o si estinguono negli anni ‘60;; con esse viene meno anche il
dibattito che si era formato attorno a queste forme di lavoro sociale di comunità. Le cause
sono molteplici ma sostanzialmente riconducibili al processo di modernizzazione in atto nella
società dell’epoca: il miracolo economico e l’avvento degli strumenti di comunicazione di
massa favorivano il nascere di nuove ideologie della modernità nelle quali difficilmente la
comunità trovava spazio. Gli studi sulla modernizzazione in atto mettevano in evidenza la
sempre minor importanza della “comunità” e dei valori che le ruotavano attorno, tanto che
alcuni li consideravano ormai completamente tramontati (Popple 1995; Tosi 2004). In quegli
anni, gli approcci teorici prevalenti sostenevano che la comunità e i legami che tesseva tra gli
individui fossero deterrenti, se non addirittura disincentivanti, per lo sviluppo economico. Si
era delineato un prototipo della “società tradizionale” che per certi versi era sovrapponibile
alla “comunità”: rigida e chiusa ai cambiamenti, ostacolata da legami e valori “arcaici”, non
poteva essere compatibile con l’“uomo moderno”, libero e intraprendente (Inkeles 1974).
Anche le teorie marxiste vedevano nella comunità un ostacolo, la sua chiusura rispetto
all’esterno era una minaccia per il formarsi di una coscienza di classe che fosse condivisa
dalla maggior parte della popolazione. Tutto ciò non faceva che erodere le basi teoriche del
lavoro di comunità e delle politiche “dal basso” disincentivandone lo sviluppo.
Una nuova vitalità si ebbe a partire dagli anni ‘70, con forme e modalità differenti rispetto
alla prima fase. Si assiste prima di tutto a un ampliamento, sul piano semantico, dei termini
legati al concetto di comunità; al posto di quest’ultimo si preferisce parlare di “reti”,
“cittadinanza attiva”, “partecipazione” ecc. Il ritorno in auge del lavoro di comunità (ma
14
anche dei processi partecipativi che stavano alla base di ogni attivazione) si deve alla
congiunzione di due cause: in primo luogo l’enfasi posta sulla valenza positiva della
partecipazione da parte delle istituzioni che richiedevano ai cittadini maggior interesse e
adesione (Sgroi 2000, Tosi 2004) e in secondo luogo il clima di quegli anni e la nuova
domanda di servizi da parte dei cittadini. Secondo Wilmott (1989) la costruzione di un
welfare che incidesse sulla vita dei cittadini aveva portato a un'iper-centralizzazione del
potere nelle mani dello Stato centrale: il livello di burocrazia era elevatissimo, i disservizi
sempre più imponenti...la conseguenza diretta di questa complessità e distanza dello Stato
dalla popolazione si traduceva in un generalizzato rifiuto dell'istituzione. Le nuove ragioni del
lavoro di comunità si inserivano in questo contesto, si concordava sulla necessità di
riavvicinare i cittadini alle politiche mediante strutture intermedie, oltre che far fronte alla
crescita dei costi di mantenimento di tutto il sistema.
Per quanto riguarda il clima di quegli anni, si riteneva che la grande ondata di movimenti
sociali avesse indebolito la capacità interpretativa del concetto di classe. Non ci si trovava più
di fronte poche e ben distinte categorie le cui richieste venivano comprese dai decisori (operai
da una parte e imprese dall'altra, per farne un esempio), ma a una pluralità di soggetti che
prima non esistevano: distinzioni di genere, etnia, provenienza geografica creavano molti più
gruppi la cui capacità rivendicativa era più elevata, complice l'aumento della scolarizzazione.
Le politiche convenzionali non sembravano più adatte allo scopo, si era alla ricerca di
maggior flessibilità e coerenza con i vari contesti in cui ci si trovava a operare. In ultimo, la
ricomparsa di situazioni di povertà, l'ampliarsi dei quartieri “marginali” e degradati aveva
portato a una nuova e diversa attenzione rispetto alle politiche sociali. La povertà delle
periferie urbane non era più vista come meramente materiale ma aveva acquisito connotati
relazionali. In sostanza, ciò che mancava ai nuovi “poveri” era una rete di relazioni solida e
ben strutturata che fungesse da “trampolino” per l'uscita dallo stato di deprivazione.
E' proprio nella comunità, e in tutto il bagaglio di concetti che si porta dietro, che si è
cercato (e si cerca tutt'ora) di trovare la soluzione. L’idea di comunità che fa da sfondo a
questa seconda fase, tuttavia, è diversa da quella tradizionale. Non siamo più, come negli anni
‘50, di fronte a una concezione di “comunità” intrinsecamente positiva, luogo naturale delle
relazioni umane. Si tratta, invece, di pensare ad essa come a un’opportunità, uno strumento.
Certamente i due approcci non si escludono e non è scontato il fatto che le esperienze che
prediligono il carattere strumentale rigettino completamente l’idea di comunità come fine a
15
cui tendere. Tuttavia, si perdono alcuni dei caratteri fondamentali che facevano parte del
bagaglio semantico del termine “comunità”: viene meno la dicotomia classica tra comunità e
società e con essa gli aggettivi che caratterizzavano i due poli, la società asettica e fondata sul
singolo contro la naturale positività di tutto ciò che era comunitario o partiva dalla comunità.
La comunità rimane come strumento che può trasformarsi in mezzo efficace per la riuscita
delle politiche sociali, per stimolare la partecipazione della cittadinanza o per creare consenso
attorno a scelte istituzionali. Il significato si amplia anche alla luce dei progressi in ambito
della ricerca sociale, l’analisi dei network mette in luce l’esistenza di community without
propinquity, cioè comunità che esistono anche senza condividere la medesima localizzazione.
Anche il ruolo dei “legami deboli” individuati da Granovetter viene rivisto mettendone in
evidenza l’importanza che essi possono avere in sistemi più aperti. La “comunità”, da chiusa,
immutabile e tradizionale viene riconcettualizzata come dinamica e mutevole, capace di
adattarsi e diventare centrale per lo sviluppo del lavoro sociale di comunità.
Dagli anni '70 ad oggi, sono numerose le esperienze e i progetti che si collocano
nell'impronta del lavoro sociale di comunità. Come già accennato, la nuova attenzione posta
alla comunità come strumento, ai processi partecipativi e al coinvolgimento della popolazione
“dal basso” è stata oggetto di alcune critiche. Alcune di esse sono esposte da Cooke e Khotari
in “Participation: the new Tyranny” (2001). I detrattori sottolineano, in primo luogo, che il
successo o la valenza positiva di un progetto non può essere basata esclusivamente sul fatto
che esso preveda processi partecipativi. (Cooke e Khotari, 2001). La critica si rivolge a tutte
quei progetti, attori, istituzioni e policy makers che hanno fatto della partecipazione una
“fede”: essi hanno basato le loro azioni sull'idea che i processi partecipativi siano
“intrinsecamente positivi” e atti a favorire lo sviluppo delle “giuste tecniche” perdendone di
vista la reale valenza (Cooke e Khotari, 2001). La partecipazione sembra tesa esclusivamente
all'efficienza. Nei progetti interessati, la rete di attori che ha collaborato alla realizzazione,
spesso non riesce ad applicare gli stessi procedimenti al di fuori dell'ottica del progetto: il
sapere acquisito è di natura meramente pratica e tecnica, si punta all'efficienza e non c'è
spazio per discorsi più ampi. L'errore più grande, sostengono altri, è stato quello di
considerare la comunità come unica nel suo territorio, omogenea e idealmente unita da legami
solidaristici quando invece in essa è presente una struttura ben precisa, fatta di relazioni di
potere che spesso rispecchiano strutture burocratiche legate all'istituzione (Hickey e Mohan,
2005).
16
1.4 L’attivazione di quartiere – L’azione collettiva territorializzata/localizzata
Con il termine azione collettiva si intende genericamente5 un’ “azione comune mirante a
raggiungere fini condivisi”6. Ciò che urge precisare è il significato da attribuire a termini
immediatamente successivi: territorializzata e localizzata. I due attributi, pur condividendo la
propria centratura su porzioni specifiche di spazio, non sono sinonimi. Qualsiasi azione è per
forza di cose, localizzata;; avviene cioè in un luogo specifico e insiste su quell’area. Il termine
territorializzata, però, riesce ad aggiungere qualcosa in più, per questo motivo si può
affermare che non tutte le azioni localizzate sono anche territorializzate. Un’azione può essere
definita territorializzata secondo due prospettive, da non intendersi come alternative l’una
all’altra ma integrabili in una definizione più ampia (Mannarini 2004).
Secondo la prima, un’azione può dirsi territorializzata se gli attori coinvolti hanno, anche
se in misura differente, un interesse legato al territorio considerato; ciò non deve essere visto
come espressione di interessi di tipo corporativistico/particolaristico perché, come precisa la
seconda prospettiva, l’azione collettiva diventa territorializzata quando questa condivisione di
interessi è tesa alla valorizzazione delle potenzialità del territorio. In questa cornice, e in
quella sopracitata del lavoro di comunità, si collocano le esperienze di Adriano Olivetti e
Danilo Dolci. In entrambi i casi l’attenzione è posta alla comunità, alle sue specificità e alle
sue esigenze: l’obiettivo degli “attivatori” (Danilo Dolci era un vero e proprio “educatore
delle masse”) è quello di far prendere coscienza agli abitanti delle loro mancanze o necessità
per far si che siano essi stessi ad occuparsene. L’azione collettiva dev’essere frutto di una
vera esigenza degli abitanti, non può essere “calata dall’alto” con la pretesa di fornire
obiettivi preconfezionati.
Prendendo in esame la definizione di azione collettiva territorializzata, secondo cui
l'attivazione deve partire da soggetti che hanno interessi nel territorio e si impegnano per
valorizzarlo, non si può non considerare entrambe le esperienze dei due “attivatori”. Tuttavia,
come già precisato precedentemente, se nel caso di Olivetti si può parlare con più coerenza di
“politiche” (proprio per il loro essere strutturate contestualmente a un impresa in crescita) e
meno di “azione collettiva”, il lavoro di Dolci nella sua impronta pedagogica iniziale è teso a
stimolare “azioni collettive” in senso stretto. E' il caso del digiuno collettivo del 30 gennaio
5 Da qui in poi. 6 “Azione collettiva”, Dizionario di sociologia, (2008) Riccioni, I. (a cura di), Roma, Gremese.
17
1956 e del successivo “sciopero alla rovescia” del 2 febbraio 1956 avvenuti entrambi nella
zona di Partinico e Trappeto, due comuni siciliani non troppo distanti da Palermo. Le azioni
di Dolci non sono però estemporanee, anzi, la fase di preparazione durava già da anni.
Durante la sua permanenza a Partinico, Dolci aveva avuto modo di conoscere l'estrema
povertà degli abitanti delle campagne e lo stato di miseria in cui versava la regione lo aveva
colpito profondamente. Era dell'idea che non ci fosse modo migliore per raccontare la vita
della popolazione se non quello di dar voce agli abitanti stessi; per questo raccoglie le
testimonianze e il suo diario in un libro, “Banditi a Partinico”, in cui da modo ai “poveri
cristi” di esprimersi. Le “conversazioni” sono trascritte senza correzioni né traduzioni7, tra i
meriti di Dolci sicuramente il più importante era la capacità di ascolto; attraverso essa è stato
capace di trovare alcune delle motivazioni profonde che causavano un circolo vizioso della
povertà difficilmente interrompibile con i mezzi tradizionali con cui era abituata ad agire
l'istituzione. Dolci contesta aspramente, dati alla mano, la repressione come mezzo di
risoluzione per l'enorme tasso di criminalità della regione: cosa si può pretendere da quelli
che “avevano avuto dallo Stato italiano, per educarli, solo seicentocinquanta anni di scuola, in
complesso, ed oltre tremila anni di galera”? (Dolci 1974, 57 ). Gli appelli diretti verso le
istituzioni erano stati innumerevoli, eppure la situazione non accennava a cambiare:
mancavano le case, le scuole e addirittura le strade. Spiega Dolci (1956, 103) “Noi non
volevamo che la gente andasse a rubare o a commettere delitti”, “la popolazione faceva
pressione perché si trovasse una soluzione”. Avevano deciso, insieme agli abitanti dei paesi
limitrofi, di recarsi alla “trazzera vecchia”, una strada a pochi chilometri dall'abitato resa
impraticabile dall'incuria, per cercare di ripararla. Intimati a ritornare a casa con la promessa
di lavoro in tempi brevi, ubbidiscono; decidono, però, di organizzare un digiuno collettivo. Il
digiuno viene nuovamente vietato con motivazioni vaghe: non è lecito “andare in molti sulle
spiagge”.
Dolci e i suoi non si perdono d'animo e il mercoledì successivo decidono i modi e i tempi
per andare di nuovo a lavorare alla vecchia trazzera. Dolci pone l'accento sulla totale gratuità
del gesto, ricordando ai braccianti che lo avrebbero seguito che “nessuno poi doveva saltar
fuori e dire << Datemi i soldi per il lavoro fatto sulla trazzera vecchia>>” (Dolci 1956, 104).
7 “Non si cerchi il campione di filologia, la purezza del siciliano classico: il dialetto è in evoluzione verso la lingua nazionale; e chi parlava, per farsi meglio capire, se sapeva, s'impiducchiava di italiano” (Dolci 1956, 68)
18
Ricevuto il divieto dalle forze dell'ordine, poiché lo spostamento dal paese alla strada di
una gran massa di persone poteva costituire una manifestazione non autorizzata, decidono di
spostarsi a piccoli gruppi. La polizia giunge immediatamente, prima allontana Dolci, poi
cerca di convincere i braccianti a smettere di lavorare intimando di non dare ascolto ai
“sobillatori”. Dolci rilasciato dalle forze dell'ordine ritorna sul posto cercando di riprendere il
lavoro, viene immediatamente arrestato e trascinato via di peso; a quel punto tre squilli di
tromba preannunciano l'imminente azione di sgombero della polizia e i braccianti si
disperdono. L'arresto, i 50 giorni di detenzione e il successivo processo hanno eco in tutta la
nazione, si apre un ampio dibattito tra le figure di spicco della cultura italiana sulla validità
della carcerazione. Dolci e i suoi erano stati arrestati per non aver ubbidito agli ordini delle
forze dell'ordine: volevano lavorare ed erano stanchi dei continui rinvii...“avevano fatto
troppe promesse e nessuna, da molti anni, era stata mantenuta” spiega al processo (Dolci
1956, 106). Nel difendersi, Dolci si appella esplicitamente all'articolo 4 della Costituzione
che recita:
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
La sua è un interpretazione estensiva dell'articolo 4, cosa di cui non sembrano essere capaci i
suoi accusatori. L'attivista è convinto non solo che lavorare sia un dovere ma che l'unico reato
di cui si dovrebbe discutere al processo è quello di smettere di lavorare. Il non-lavoro è
ripugnante perché è contro ciò che la Costituzione stessa sancisce; è ad essa, spiega, che ci si
deve appellare in quanto superiore e più importante rispetto a tutte le altre leggi. Lo scontro
che emerge durante il processo, esula il singolo caso dello “sciopero alla rovescia” per
diventare una questione più ampia. In gioco c'è, in primo luogo, la validità e vitalità della
Costituzione in quanto legge vera e applicabile (e non mera utopia8) e in secondo luogo la
legittimità dell'utilizzo di mezzi non convenzionali o informali per stimolare l'attivazione
della popolazione.
In quanto alla prima questione è importante ricordare il clima in cui lo sciopero e il
processo avevano avuto luogo; nel dopoguerra resisteva ancora l'idea, di matrice fascista, 8 “Quando al funzionario di Pubblica Sicurezza, a proposito del lavoro, feci presente l'articolo 4 della Costituzione, mi disse: -Dolci mio, Dolci mio, queste sono utopie-” (Dolci 1974, 74)
19
secondo cui lo Stato assolveva una funzione prima di tutto repressiva. Ciò è ben evidente se si
pensa alla già citata gestione del crimine e della giustizia penitenziaria, lo Stato agiva ex post
punendo chi commetteva reati senza preoccuparsi del “prima” o del “dopo”. Non esisteva
nessuno spazio per l'interpretazione delle norme in senso estensivo, così da poter cogliere
l'essenza che le aveva ispirate...non c'era, per di più, nessuna possibilità di dialogo attorno ad
esse: “Noi rappresentiamo la legge, la legge ha ragione, noi abbiamo ragione”(1956, 77)
sintetizza Dolci riferendosi alle forze dell'ordine.
In quanto alla seconda questione, Dolci si propone come innovatore; le azioni di cui è
stato promotore a Partinico sono alla base della sua nuova proposta educativa che mette al
centro “gli ultimi”. Secondo Dolci, i “poveri cristi” possono fare per loro stessi molto più di
quanto l'istituzione possa concedere loro con i suoi mezzi; se non possono farlo muovendosi
nella cornice delle leggi tradizionali occorre pensare altri modi, nel rispetto della legge più
alta, la Costituzione. Da questa convinzione poi, si passa all'agire vero e proprio, ogni
formulazione teorica non può prescindere da un'attivazione pratica che coinvolga tutti gli
attori in campo. L'azione collettiva dev'essere il più possibile condivisa e capita, occorre che
sia frutto di un processo di avvicinamento e negoziazione tra le parti affinché la sua efficacia
sia tangibile. Oltre ai risultati nel breve periodo (seppur importantissimi nell'immediato,
soprattutto nel contesto siciliano caratterizzato da estrema povertà e rischio di morte per
fame), infatti, l'azione collettiva per lo sviluppo del territorio ha l'enorme pregio di mettere in
contatto i singoli, di facilitare la condivisione di competenze e di porre le basi per azioni
future. Il Centro Studi per la Piena Occupazione è un esempio importante poiché costituisce
la prova che i digiuni e gli scioperi non erano fini a se stessi; il loro intento non era quello di
fermarsi di fronte alla soluzione del problema immediato ma di andare oltre. L'obiettivo era
creare una comunità forte che sapesse far fronte ai problemi che via via potevano porsi e il
Centro era la struttura da cui partire. Ne è una prova lampante la mole di aiuti giunti
attraverso esso dopo il terremoto del gennaio '68 nella valle del Belice. Il Centro è riuscito a
trasformarsi in un vero promotore di politiche sociali tese a migliorare le condizioni degli
abitanti e del territorio in cui è sorto.
Il digiuno e lo sciopero alla rovescia del 56' non sono, ovviamente, gli unici episodi di azione
collettiva legata al contesto locale…La loro importanza risiede certamente nell'essere state
esperienze innovative che oltre a fungere da apripista per episodi successivi, sono riuscite ad
ampliare il dibattito attorno alle azioni collettive su base territoriale. Il denominatore comune
20
che tiene insieme queste azioni “dal basso” situate in contesti storici e sociali differenti, con
gli esperimenti di politiche informali promosse da Olivetti, è da ricercarsi nell'azione di
“coscientizzazione” messa in atto a monte di ogni attivazione. La definizione piuttosto ampia
di azione collettiva territorializzata permette di includere al suo interno esperienze dai
caratteri molto vari. In questo modo è possibile accostare la suddetta definizione a quella di
mobilitazione locale. Vitale definisce la mobilitazione locale come:
“Una precisa classe di azioni collettive, organizzate da “imprenditori”, in cui gli
attori coinvolti sollevano dei problemi locali e li rendono pubblici, interagendo
con autorità e politiche pubbliche e perseguendo uno o più obiettivi condivisi.”
(Vitale 2007, 10)
Utilizzando questa definizione e applicandola a un contesto locale, come può essere quello di
quartiere, è possibile esplicitare una serie di caratteri che accomunano le esperienze del
lavoro di comunità olivettiane di cui si è accennato nel paragrafo 3 e le forme di azione
collettiva ispirate da Dolci. Oltre alla focalizzazione sul territorio, che è tipica di tutte le
esperienze sopracitate, anche le mobilitazioni locali condividono la centralità delle figure
“catalizzatrici”. Anche se con Olivetti e Dolci la figura dell’attivatore raggiunge
l’idealizzazione, non è necessario, per una mobilitazione locale, che tutte le esperienze si
condensino attorno a una solo persona il cui impegno rimane immutato per parecchio tempo.
Vitale parla di “imprenditori sociali” come di “soggetti che intraprendono un’azione
intenzionale, reperendo risorse che mettono a disposizione per organizzare e sostenere una
mobilitazione”: non si intende il termine imprenditore solo nel suo significato ristretto di
individuo che investe il suo capitale per generare profitto ma in un’accezione più ampia.
L’imprenditore in questione è solitamente “politico” o “morale”, può essere un partito
politico, un’associazione, un comitato, un sindacato ecc. che ha interesse nel territorio preso
in esame. Nel caso che verrà preso in analisi nei capitoli successivi questi caratteri sono stati
ampiamente individuati e si cercherà, attraverso l’osservazione delle singole mobilitazioni, di
capirne le implicazioni.
21
Danilo Dolci, l’educatore9
Danilo Dolci nasce il 28 giugno 1924 a Sesana, al tempo in provincia di Trieste, da Enrico e
da Meli Kontelj, di nazionalità slovena. Trascorre un’infanzia itinerante, con il padre
dipendente delle ferrovie, che lo porta a conoscere e visitare diverse regioni italiane. Nel
1943, durante il conflitto mondiale, risiede in Piemonte dove viene arrestato per aver rifiutato
l’arruolamento nell’esercito repubblichino: riesce a fuggire e a rifugiarsi in Abruzzo. Dopo la
guerra fa tappa a Roma, dove segue alcuni corsi universitari di archittettura prima di
proseguire gli studi al Politecnico di Milano. Per pagare gli studi insegna in una scuola serale
di Sesto San Giovanni, è qui che incontra Franco Alasia, suo studente e diventato poi amico.
Nel 1950 compie una scelta decisiva: abbandona gli studi per trasferirsi a Nomadelfia, una
comunità di accoglienza per bambini a rischio o resi orfani dalla guerra, nata nell’ex campo di
concentramento nazifascista di Fossoli (Modena) grazie agli sforzi di don Zeno Saltini. Nel
1952 riparte nuovamente, stavolta in direzione di Trappeto, in Sicilia dove comincia il
percorso che lo porterà ad essere uno dei più grandi sostenitori dei “più miseri”, colui che non
solo ha dedicato una vita al miglioramento delle condizioni materiali delle popolazioni ma si è
prodigato per stimolare un nuovo tipo di educazione basato sulla nonviolenza che ha avuto
gradissimo successo.
Il 14 ottobre 1952, dopo aver assistito alla morte di un bambino per denutrizione decide
di iniziare il primo sciopero della fame che si fermerà solamente quando le autorità
acconsentiranno a mettere in atto alcuni provvedimenti urgenti per far fronte alla situazione.
E’ il primo di una lunga serie. Nel frattempo scrive, attraverso le voci e le storie degli abitanti
racconta l’estrema povertà in cui versa la Sicilia del dopoguerra: senza traduzioni ne filtri
(“Chi legge abbia pazienza di fronte all’espressione non sempre facilmente comprensibile:
così come si parlava abbiamo appuntato: un po’ in siciliano e un po’ in italiano, come
potevano per farsi capire.” ) le parole dei “miserabili” raccontano la durissima realtà di un
territorio che sembra abbandonato a se stesso. Denuncia la mafia e i suoi rapporti con lo Stato
e le istituzioni venendo spesso minacciato, oltraggiato e ostacolato con ogni mezzo.
Nel gennaio del ’56, più di mille persone si riuniscono per uno sciopero della fame
collettivo protestando contro la pratica diffusa della pesca di frodo: i “motopescherecci” si
9 La biografia di Danilo Dolci è tratta da Alasia F. e Martinetti J. Cronologia della vita di Danilo Dolci, “www.danilodolci.org”.
22
spingono fin sopra le coste lasciando interi paesi affamati e privi di ogni risorsa. Non si perde
occasione per mettere in difficoltà Dolci e gli scioperanti, lo sciopero viene vietato con la
motivazione secondo cui “un digiuno pubblico è illegale”. Sempre del 1956 avviene lo
sciopero “alla rovescia”;; centinaia di braccianti disoccupati si mettono a costruire un tratto di
strada vicino al paese di Partinico che risultava impraticabile. La polizia, giunta sul posto
procede all’arresto e all’incarcerazione di Dolci. Il “caso Dolci” esplode in tutto il paese,
intervengono nel dibattito alcune tra le figure più autorevoli dell’epoca. Alla fine Dolci viene
scarcerato al termine di uno storico processo, la cui arringa finale è demandata a Piero
Calamandrei.
Nel 1958, gli viene attribuito il Premio Lenin per la Pace. Dolci utilizza i soldi del premio
per dare vita al Centro Studi e Iniziative per la Piena Occupazione, con sedi in diverse sedi
nei Comuni dell’Isola, che diventerà uno dei più importanti strumenti di sviluppo per la
Sicilia. Le iniziative si susseguono incessantemente, convegni, dibattiti, assemblee
coinvolgono diverse figure di spicco della cultura italiana e non solo. Negli anni successivi
continua la sua attività di denuncia della mafia e dei suoi stretti collegamenti con le istituzioni
locali e nazionali. Nel 1965, durante una conferenza stampa, Dolci denuncia pubblicamente
per collusione il ministro Mattarella, il sottosegretario Calogero Volpe e numerosi notabili
siciliani: oltre cento persone si espongono direttamente firmando e sostenendo la sua
denuncia. Puntualmente arriva la condanna alla reclusione nel carcere dell’Ucciardone: per
Dolci sono due anni e mezzo mentre per Franco Alasia uno e mezzo. Anche in carcere Dolci
si adopera per ascoltare, conoscere e capire i detenuti. Sono spesso padri, figli e parenti degli
abitanti della zona che riconoscono il suo ruolo attivo nel voler cambiare radicalmente le
condizioni di vita proibitive, lo aiutano e lo sostengono tanto che viene nuovamente bollato
come “sobillatore” : dimesso dal carcere gli viene attribuita una “spiccata capacità a
delinquere”.
Il 15 gennaio 1968 un violentissimo terremoto colpisce la Valle del Belice: il Centro
sospende le attività per dedicarsi a tempo pieno all’emergenza. Il Centro si attiva per la
ricostruzione, incontra i cittadini e presenta piani per far fronte all’emergenza direttamente
nei comuni. Il 25 marzo 1970 nasce Radio Libera Partinico che fin da subito si opera per
denunciare lo stato di estremo abbandono in cui versano ancora le zone soggette al terremoto.
Negli anni seguenti non si interrompe nemmeno la ricerca e la sperimentazione pedagogica:
nel 1975 Dolci promuove e fa nascere il Centro educativo Mirto che dopo pochi anni riceve
23
un riconoscimento formale diventando scuola statale sperimentale. Tra i titoli e i
riconoscimenti ricevuti in quegli anni è bene ricordare la laurea Honoris causa in Pedagogia
dell’università di Berna (1968), il Premio Socrate di Stoccolma (1970) “per i contributi di
portata mondiale nel settore dell’educazione” e il Premio Sonning dell’Università di
Copenaghen. Nel frattempo il Centro Studi continua la sua attività di promozione della
cultura e delle arti organizzando seminari, laboratori e incontri con esperti. Dolci inizia a
girare tra le scuole incontrando i ragazzi e le ragazze mentre intensifica i contatti con
personaggi di spicco legati al mondo dell’educazione. Il lavoro al Centro educativo si
intensifica e Dolci è invitato in tutto il mondo a tenere seminari e conferenze. Nel 1996
l’Università di Bologna gli conferisce la laurea honoris causa in Scienze dell’Educazione.
Muore il 30 Dicembre 1997 a Trappeto, nella terra a cui ha dedicato tutta la vita.
24
Capitolo 2 - Cinisello Balsamo: Sant’Eusebio
Sant’Eusebio è una delle zone o circoscrizioni in cui il territorio di Cinisello Balsamo era
diviso prima che quest’ultime fossero abolite. Il quartiere è stato per anni accomunato dal
punto di vista amministrativo a Borgo Misto, del quale condivide la posizione periferica a
nord della città nonché alcuni dei caratteri specifici quali la forte immigrazione o il carattere
orientato all’edilizia popolare. Prima di definirne i confini e la morfologia, prima di
raccontarne la nascita e la storia, occorre spiegare il motivo della scelta e la significatività del
territorio considerato nell’analisi finora condotta.
Il quartiere sant’Eusebio, come altri, è frutto della grande immigrazione verso il Nord
Italia avvenuta nel dopoguerra; non è un quartiere pianificato o pensato per essere funzionale
alla città ma nato e sviluppatosi per rispondere a situazioni di emergenza.
Il suo sviluppo per “accumulazione”, avvenuto in ondate differenti ha comportato la
formazione di una comunità eterogenea tra gli abitanti del quartiere. Essa, pur risentendo
della diversa provenienza geografica dei suoi membri (le due ondate migratorie principali,
infatti, sono di provenienza veneta e dal Sud Italia) e dei conflitti che ne sono conseguiti ha
saputo coagularsi attorno a posizioni coese in difesa del proprio territorio e spesso in aperto
contrasto con l’Amministrazione Comunale. La peculiarità sta proprio nel trovarsi di fronte a
un quartiere nato come strumento per “contenere” l’immigrazione massiccia, periferico in un
paese10 già considerato “dormitorio”, una grande “corea” (Alasia, 1975) in cui si è riuscito a
trasformare lo stigma in una lotta comune per entrare a pieno titolo a far parte di Cinisello.
Sant’Eusebio, infatti, oltre a essere protagonista di alcune forme di azione collettiva che per
certi versi ricordano le proteste di Danilo Dolci in Sicilia (sia per il carattere tendenzialmente
non-violento che per il coinvolgimento di una comunità eterogenea e radicata), è stato uno dei
quartieri che per primi hanno attivato il progetto Contratto di Quartiere avviando un dialogo
con il Comune che ha favorito la riqualificazione dell’intera area11.
10 Cinisello Balsamo diventa città nel 1972. 11 Il progetto CDQ nasce su iniziativa del Ministero dei Lavori Pubblici nel 1998; Cinisello Balsamo riceve il finanziamento, che ammonta a 17 miliardi di lire, già nel 1999 quando viene avviata una sperimentazione su alcuni comuni in tutta Italia. Per il CDQ vedi capitolo III par. 3.3 .
25
2.1 Uno sguardo sul territorio
2.1.1 Cinisello Balsamo, la città
Cinisello Balsamo è un comune di 7596712 abitanti della provincia di Milano. E' il terzo
comune della provincia per numero di abitanti, superato dal vicino Sesto San Giovanni e dal
capoluogo Milano. Confina con i comuni di Bresso, Cusano Milanino, Monza, Muggiò, Nova
Milanese, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni. Nasce nel 1928 dall'unificazione dei due
comuni di Cinisello e Balsamo, per decreto regio durante l'epoca fascista; i due comuni di
fatto sorgevano a poca distanza l'uno dall'altro e l'aumento costante del territorio edificato ha
fatto si che negli anni la distanza tra i due andasse assottigliandosi fino a sparire. Ad oggi il
comune nel suo complesso occupa un'area di circa 13 chilometri quadrati con una densità
abitativa molto elevata, pari a 5899 ab/km . Per trattare di un quartiere o comunque di una
porzione di territorio che fa parte di un contesto più ampio, come un comune, è indispensabile
confrontarne le caratteristiche con le scale superiori. I dati presentati qui di seguito fanno
riferimento al censimento ISTAT del 2011, se non diversamente specificato, e sono relativi
all’intero comune. Si cercherà di fornire un quadro complessivo della condizione socio-
demografica del territorio per poi tarare l’analisi sullo specifico quartiere di Sant’Eusebio.
Si è già detto precedentemente che, dal punto di vista amministrativo, l’area inviduata sulla
mappa come “quartiere Sant’Eusebio” fa parte della più ampia circoscrizione 4 che
comprende al suo interno anche la zona di Borgo Misto. Dal punto di vista storico, le due aree
nascono in periodi leggermente diversi. Borgo Misto, così chiamato perché ha ospitato
l’immigrazione dalle più diverse regioni italiane, dai padovani ai siciliani passando per
bergamaschi, mantovani, sardi e pugliesi, è situato poco più a sud e più vicino a piazza
Gramsci (la piazza principale della città) e ospita fin dagli anni 30’ alcune cascine e case di
campagna con la tradizionale disposizione a corte; è stata una delle prime aree ad essere
edificate per sopperire alla continua richiesta di alloggi. Sant’Eusebio, individuato nell’area
attorno alla chiesetta storica, è in un primo momento solo una distesa di campi; a partire dagli
anni 60’ cominciano a sorgere i primi edifici che oltrepassano (idealmente, perché non esiste
un confine che non sia arbitrario) Borgo Misto per andare a formare quello che diventerà
successivamente il quartiere più a nord della città.
12 Dato aggiornato al 31/12/2013; Comune di Cinisello Balsamo
26
Il grafico in fig. 2.1 se confrontato con piramidi per età regionali o nazionali, fotografa
una popolazione con una buona percentuale di giovani e una sostanziale parità tra il numero
di maschi e femmine con una leggera prevalenza di quest’ultime.
La tabella 2.1 mostra, invece, un confronto tra i censimenti decennali dal 1991 al 2011. Da
notare è l’aumento del numero di famiglie registrate presso l’anagrafe che però non si è
accompagnato a un aumento di popolazione, ma , al contrario con un leggero calo. Ciò è
dovuto, probabilmente, alla progressiva diminuzione delle famiglie allargate e un aumento,
dall’altra parte di nuclei famigliari più ristretti, spesso composti da una sola coppia.
Se, invece, si analizza il grafico presente in fig. 2.2 è possibile dare uno sguardo più ampio
alla variazione della popolazione confrontando la serie storica dei censimenti a partire dal
1861. I dati forniscono un quadro sintetico dello sviluppo demografico di Cinisello Balsamo:
l’aumento della popolazione residente dal ‘51 e la decrescita dopo il 1981 sono strettamente
collegati alla conformazione del territorio e logicamente alle dinamiche della città e dei suoi
quartieri.
Il grafico in fig. 2.3 mostra la distribuzione del reddito per l’anno 2011 in percentuale sul
totale: con un reddito medio di 14.025 Cinisello si colloca sotto la media nazionale che si
attesta sul valore di 19.655. Due dati sono interessanti: il 25,56% dei dichiaranti è sotto i
15000 euro mentre quasi ¾ della popolazione (in questo caso per popolazione è inteso il
numero complessivo di dichiaranti nell’anno di imposta, ovvero 43021) ha reddito inferiore a
26000 euro. Sarebbe certamente più informativo e significativo poter confrontare i dati
relativi al reddito delle famiglie assieme a quello delle persone fisiche, per poter dare un
quadro delle eventuali disuguaglianze presenti sul territorio ma ho preferito mantenere un
singolo anno di rilevazione, vista la difficoltà a recuperare i suddetti dati nel medesimo anno
d’imposta.
TAB 2.1 1991 2001 2011
Popolazione 76.262 72.050 71.128
Famiglie 27.240 28.797 32.372
27
2.1.2 Sant’Eusebio, periferia
Sant’Eusebio sorge nella zona nord di Cinisello Balsamo;; in quanto estremità della città è
collegato al centro tramite due direttrici: via Risorgimento, storica via di accesso alla piazza
principale della città (piazza Gramsci) e via Cilea che garantisce un collegamento più rapido
verso Sesto San Giovanni e Milano. Il quartiere prende il nome dall’antica chiesetta che si
trova lungo via Risorgimento, risalente al ‘30013; attorno ad essa sono nati i primi
insediamenti e, in tempi più moderni, la parrocchia e la chiesa. Dal punto divista
amministrativo, Sant’Eusebio è sempre stato associato al vicino quartiere di Borgo Misto;
insieme andavano a formare la Zona 4 delle cinque zone/circoscrizioni in cui era diviso il
comune. Se si è tutti d’accordo nel partire dalla chiesetta per tracciare i confini del quartiere,
non lo si è nello stabilire dove essi finiscano. Certamente definire i confini di un territorio è
un’operazione complessa che deve necessariamente operare una sintesi tra posizioni
differenti, per cui, i confini qui esposti non hanno pretesa di oggettività e possono essere
trovati in altri testi con delimitazioni diverse. Verso nord, Sant’Eusebio trova il suo limite nei
campi che poco più in là accolgono la tangenziale, a un paio di chilometri da Nova Milanese.
Verso sud c’è chi arriva a comprendere edifici fino a via Alberti mentre l’ufficio istituito in
occasione del CDQ limita il confine all’incrocio tra via A. da Giussani e via Risorgimento per
una parte e all’incrocio tra via Zandonai e via Cilea dall’altra. Ad ovest si trovano alcuni
complessi residenziali più recenti a cura delle cooperative edilizie ma ben presto ci si ritrova
tra i campi che proseguono fino al confine con Paderno Dugnano. Verso est il quartiere
prosegue includendo una porzione del parco inter-comunale “Grugnotorto”, il cimitero nuovo
e il campo sportivo “Scirea” fino ad arrivare ai limiti di Muggiò.
La sua collocazione ai margini del centro cittadino ha causato uno sviluppo urbano
disordinato e frettoloso. L’urbanizzazione è legata alle ondate migratorie che, a partire dagli
anni Sessanta, hanno coinvolto tutta la periferia nord di Milano, complice la richiesta costante
di manodopera dalle fabbriche vicine, le Falck, la Breda, la Marelli. L’espansione è stata
rapida e non priva di risvolti negativi in un primo periodo, tra tutti la mancanza di servizi di
base e di collegamenti con il centro cittadino, cosa che di fatto isolava una buona fetta della
popolazione. Col tempo la situazione è andata via via migliorando e ad oggi Sant’Eusebio
dispone di diversi servizi, associazioni e infrastrutture.
13 Comune di Cinisello Balsamo, archivio storico - La chiesetta di Sant'Eusebio
28
Tra gli edifici rilevanti si annoverano, oltre alle sedi dei servizi di base (supermercato,
scuole), i luoghi che caratterizzano il quartiere come “popolare” ovvero i complessi
residenziali del Palazzone e delle Cinque torri. Il primo dei due, il Palazzone, si trova tra via
Giolitti e via A. da Giussano;; su quest’ultima via si affacciano, oltre a un lato del complesso
Cinque torri, il centro Polifunzionale, il consultorio e una piccola area verde. Il secondo
complesso, come già detto, si affaccia per un lato su via A. da Giussano per poi occupare
l’area racchiusa tra via Cilea e via del Carroccio. I due complessi hanno una conformazione
particolare: il Palazzone ha una forma a “ferro di cavallo”, quasi chiuso su tutti i lati, che gli
ha valso la fama di “fortino” quando negli anni 80’ si combatteva la piaga della droga;; il
secondo complesso è formato da una serie di torri non parallele inserite in un giardino
enorme. In entrambi è presente un centro civico, ormai storico nel Palazzone e di recente
costruzione alle Cinque torri. Le vie storiche del quartiere sono via Giolitti, via A. da
Giussano e via del Carroccio, che infatti ospitano la maggior parte della popolazione:
quest’ultima via ospita le prime case costruite a Sant’Eusebio. Dalla parte di via Giolitti, un
edificio posto all’incrocio con via Risorgimento è utilizzato oggi come sede per la protezione
civile, nonostante negli anni la sua destinazione d’uso sia cambiata con molta frequenza (dalla
scuola popolare agli scout dell’Agesci fino al Marse) rendendo il luogo sempre centrale
rispetto alla vita sociale del quartiere. Accanto ad esso si trova una scuola dell’infanzia,
“Giolitti” che fa parte dell’istituto comprensivo “Zandonai” con sede in via Risorgimento.
L’istituto che fornisce istruzione al quartiere comprende, inoltre, la scuola per l’Infanzia
“Sempione”, la Primaria Zandonai, la Primaria Parini, la Primaria P.co dei Fiori e la scuola
secondaria di I grado Garcia Villas.
Lungo via Risorgimento, avendo alle spalle la strada che si collega con Nova Milanese e
procedendo verso il centro città troviamo sulla destra l’ingresso di via Settembrini e una lunga
fila di appartamenti più recenti; subito dopo si vede la famosa chiesetta che da nome al
quartiere e la parrocchia che con la sua chiesa e oratorio annessi occupa tutto l’isolato
compreso tra via Risorgimento, via Settembrini, via Picasso e via Morandi. Sulla sinistra, di
fianco ai cancelli del Palazzone, si vede il supermercato;; l’angolo tra via Picasso e via
Risorgimento è la sede della cooperativa “Il Torpedone”, alcuni tra gli spazi che sorgono da
quel punto dalla parte di via Risorgimento sono utilizzati per la neonata scuola di musica
Vibe. Di fronte all’incrocio tra la via principale e via Martiri palestinesi si trova la scuola
“Garcia Villas”: all’interno del complesso è ospitata anche la primaria Zandonai che si
29
affaccia sulla via vicina. In Via Martiri Palestinesi si trovano altri due grossi complessi
costruiti dalla cooperativa Auprema, le “Case bianche”. Di fronte a via Zandonai si trova la
sede della Scuola Popolare, uno spazio non molto grande situato su un solo piano. Lungo via
Risorgimento si trovano, oltre alle case, alcuni negozi, tabaccaio, panettiere, pizzeria, bar ecc.
Percorrendo verso est via Zandonai troviamo la già citata scuola primaria per poi spuntare su
via Cilea: verso destra si trova un altro complesso di edifici e, dopo l’incrocio, la sede della
Polizia di Stato;; verso sinistra si torna alle “Cinque Torri” incontrando però, sul lato destro
della strada il campo sportivo Scirea. Di fronte a via Zandonai comincia un’area verde che si
ricollega al cimitero nuovo. In ultimo, è importante citare l’ingresso al parco “Grugnotorto”
che si apre da via Cilea, proprio di fronte allo sbocco di via Giolitti: una strada sterrata porta
al parco Sant’Eusebio e agli orti comunali nonché al terreno di competenza dell’associazione
Legambiente che lo utilizza per attività di diverso tipo.
30
Se finora si è parlato degli edifici che compongono il panorama visivo del quartiere, si passa
ora a descrivere i luoghi centrali del territorio dal punto di vista sociale e relazionale. Con
l’espressione “luoghi significativi” si intendono tutti quegli spazi che producono incontro o
relazione, quelli in cui si prendono decisioni, si attivano conoscenze e si crea aggregazione.
Sono i luoghi sui quali le parti in gioco sono in accordo nel considerare importanti e centrali
per la collettività. Tra questi, a Sant’Eusebio, il più importante è forse il centro polifunzionale
di via A. da Giussano. Dalla sua costruzione nell’ambito del progetto CDQ I, infatti, il centro
è diventato sede di numerose associazioni e realtà differenti diventando in breve tempo un
punto di riferimento per gli abitanti ma anche per chi, dall’esterno, volesse interfacciarsi con
il quartiere. Il centro polifunzionale oggi ospita un consultorio inserito in un più ampio
“Centro Salutistico”, un “Centro risorse per la famiglia” e un “Centro anziani”;; i suoi spazi
vengono usati periodicamente dalle associazioni del territorio per laboratori artigianali
dedicati a tutta la cittadinanza. Situato quasi di fronte al Centro Polifunzionale, il centro
civico delle “Cinque Torri” è diventato luogo di incontro da quando è stato attivato il CDQ II.
Al suo interno è nato un servizio di doposcuola ed è stato utilizzato come sede di attività
ricreative rivolte agli anziani del caseggiato. Settimanalmente ospita il sindacato inquilini
SICET: esso si occupa di fornire assistenza alle famiglie o comunque agli affittuari nel gestire
le spese e le scadenze dettate da ALER nonché di avanzare le richieste a nome del caseggiato.
Lungo via Giolitti troviamo il già citato edificio che ha ospitato negli anni diverse realtà
ed ora è sede della protezione civile; nonostante oggi non rappresenti più un luogo centrale e
davvero significativo sia per la sua destinazione d’uso sia per la sua posizione ormai
decentratata rispetto al quartiere stesso, è importante precisare che è stato qui che hanno
trovato spazio le prime iniziative degli abitanti. Poco più avanti, al numero 8, si trova il centro
civico del complesso “il Palazzone”;; nato con la costruzione dell’edificio, ad oggi (ottobre
2014) risulta chiuso per motivazioni che saranno discusse più avanti (cfr. cap. III).
31
2.2 Storia del quartiere
2.2.1 Da Cinisello al quartiere
S. Eusebio è un quartiere residenziale situato nella periferia nord della città di
Cinisello Balsamo, cresciuto a partire dagli anni ’60 e contraddistinto dalla
presenza incombente di due interventi di edilizia residenziale pubblica, con i
quali è spesso identificato, denominati “il Palazzone” e “le 5 torri” realizzati nel
1974 per dare una risposta alla forte domanda di alloggi indotta dalle ondate di
immigrazione interna. (Bricocoli 2002, 2 )
E’ difficile trattare di una vera e propria storia “del quartiere” in quanto per i primi anni
del dopoguerra molti degli avvenimenti che hanno coinvolto Sant’Eusebio erano strettamente
collegati a Cinisello Balsamo. Cinisello Balsamo, infatti, non era oggetto di distinzioni interne
nell’immaginario di chi scriveva o parlava del paese: collocato alla periferia di Milano negli
anni della grande espansione economica veniva da tutti considerato come “dormitorio”, privo
di qualsivoglia specificità o interesse. Allo stesso modo, Sant’Eusebio era un minuscolo
gruppo di case già lontano e distante dal centro del paese che a sua volta era estremamente
periferico rispetto a Milano. Tra gli anni 50’ e gli anni 70’ si assiste a un espansione
demografica senza precedenti che coinvolge tutte le aree del paese. La maggior parte dei testi
concorda nello stabilire il 1951 come anno di avvio del fenomeno migratorio che avrebbe
cambiato il volto di Cinisello: nel ‘51 l’alluvione del Polesine costringe numerosi profughi a
lasciare i propri paesi di origine per trovare fortuna al nord. Nel 1971, quando dopo quasi
vent’anni si registra per la prima volta un saldo migratorio negativo, il censimento conta
77.4934 unità contro le 15.519 del 1951, un aumento spropositato della popolazione che,
stando ai dati, è attribuibile per il 76% al saldo migratorio positivo14. Durante questi anni
molte persone che risiedevano nelle antiche corti vicine al centro (le “coree”) si spostano per
occupare i palazzi appena edificati, assieme alle famiglie immigrate dal sud e dal nord-est.
Nel 1971 la popolazione residente raggiunge le settantamila unità, la superficie
non edificata è ridotta al 29% del territorio, mentre la densità abitativa, che già
nel '61 era più che raddoppiata rispetto a dieci anni prima, ha quasi raggiunto i
14 "Cinisello Balsamo negli anni della grande immigrazione 1951-1971" di Alessandra Meraviglia, in "Discipline storiche, discipline economico-sociali, scienze del territorio: Cinisello Balsamo nelle tesi di laurea" Cinisello Balsamo, 2004, pag.13
32
valori di Milano. Le ragioni di questa enorme capacità attrattiva stanno nella
posizione strategica occupata dal Comune nella geografia economica del periodo:
ai confini con Sesto San Giovanni e con la Bicocca, Cinisello costituisce infatti
un'importante area di insediamento per la forza lavoro delle grandi fabbriche
metalmeccaniche, chimiche e manifatturiere della zona (la Pirelli, la Breda, la
Falk...)15
Le fabbriche di Sesto san Giovanni e Milano richiamano un’ingente quantità di
manodopera ma pochi dei centri che fanno parte della periferia milanese sono pronti ad
accogliere così tanti lavoratori, a dare una casa alle loro famiglie, a fornire servizi adeguati.
Cinisello e Sant’Eusebio non fanno eccezione e, come già precisato, lo sviluppo del quartiere
avviene in situazione emergenziale: l’urgenza di trovare uno spazio sufficiente ad accogliere
così tante persone fa si che interi quartieri nascano dal nulla passando da qualche decina di
abitanti a migliaia in poco più di un anno.
E’ da questo momento che Sant’Eusebio acquisisce una sua specificità, distinguendosi dal
resto della città (ma anche dagli altri quartieri) per come affronta questa sua distanza dal
centro e le criticità che di volta in volta si presentano: dal momento della sua “esplosione” si
può parlare della sua storia.
2.2.2 Dagli anni 70’ ad oggi: Sant’Eusebio
Circa trent’anni fa [anni 30'], sul territorio dell’attuale quarta Circoscrizione,
c’erano solamente quattro grosse corti agricole: il “Vallo”, il “Nigozza”, la
“Malpensa”, la corte di S. Eusebio e qualche altra casa rurale in via Montegrappa
e in via Corridoni. Attorno a queste corti c’era terra ben coltivata ed irrigata dalle
rogge che portavano l’acqua del Villloresi. Questo equilibrio durava da numerosi
decenni e le uniche notizie, storicamente documentabili, riguardano solamente la
chiesetta di S. Eusebio(…).16
Nato attorno alla chiesetta medievale, di Sant’Eusebio esistono poche informazioni e
15 "Immigrazione e identità locale", Francesco Memo in "Discipline storiche, discipline economico-sociali, scienze del territorio: Cinisello Balsamo nelle tesi di laurea" Cinisello Balsamo, 2004, pag. 27
16 Periodico “La città”, 1978
33
pochi dati. Questo periodo dura fino agli anni 60’-70’ quando l’urgenza delle famiglie senza
casa e le condizioni precarie delle case del centro storico, spingono l’amministrazione a
sollecitare IACP nella costruzione degli alloggi popolari.
I primi edifici popolari vengono eretti nel 64’, ultimati verso la fine di quell’anno, sono
costituiti da 59 alloggi divisi in due complessi di modeste dimensioni, via del Carroccio 14 e
15. Nel 1972 il Comune istituisce i quartieri dividendo il territorio in 10 aree distinte avviando
un processo di decentramento che avrebbe dovuto far “prendere coscienza ai cittadini dei
problemi del territorio”17. Negli anni successivi l’amministrazione si adegua alla normativa
vigente accorpando i quartieri nelle 5 diverse circoscrizioni di cui si è già trattato. Anche se si
tratta di anni più recenti, riguardo le date di costruzione del caseggiato GESCAL non c’è
accordo: mentre alcuni degli abitanti di vecchia data parlano di un arrivo già nel 1974, il
giornale cittadino “la Città” colloca la fine dei lavori nel 1975 e successivamente l’ingresso
delle famiglie. Una cosa certa è che nel luglio del 1974 presso il Palazzetto dello Sport vicino
a Piazza Gramsci si è svolta la prima riunione tra gli aspiranti assegnatari delle case
GESCAL.
"Nel 1975 fu costruito il primo grosso complesso edilizio a carattere popolare in
via Alberto da Giussano-Giolitti, coi suoi 288 appartamenti, distribuiti su 8 piani,
si presentava all'osservatore esterno come qualcosa di separato, di estraneo
rispetto all'ambiente circostante, costituito per lo più da edifici di pochi piani o
addirittura di case vecchie con la tradizionale corte."18
Il caseggiato, che negli anni è stato chiamato con molti nomi (“le GESCAL”, il “Palazzone”
ecc.), venne da subito additato come “ghetto”.
"Tenuto conto del tipo di estrazione sociale della popolazione che doveva
insediarsi, furono in molti parlare di ghetto e a prefigurarsi un abito mentale
ricco di pregiudizi"19
In effetti le 2000 persone circa del caseggiato sono per la stragrande maggioranza immigrati
recenti e meno recenti soprattutto dal Sud e dalle Isole. La collocazione, poi, all'estremo nord
della città, non è certo la più adatta a favorire l'integrazione.
17 Periodico “La città”, 1980. 18 Periodico “La città”, 1978. 19 Periodico “La città”, 1978.
34
Come indicato nella tabella 2.2, nel "Palazzone" erano registrati20 circa 700 bambini al di
sotto dei 14 anni che rappresentavano quasi il 40% della popolazione complessiva. E'
interessante il confronto di questo dato con quello complessivo riferito all'intero comune, il
quale si attesta su un più modesto 22,83%. La distanza tra i due valori spiega con
immediatezza la necessità di servizi per l'infanzia dedicati al quartiere molto più che diretti
all'intero comune. Nel Palazzone la mancanza di parchi giochi, aree verdi, centri per il
doposcuola ma anche edifici scolastici adeguati era molto più sentita proprio per la presenza
massiccia di bambini.
TAB 2.2 Composizione dei nuclei famigliari21 “Palazzone” Cinisello Balsamo Numero famiglie 342 25897 Popolazione totale 1868 80287 Bambini fino ai 14 anni 703 18332 % Bambini fino a 14 anni 37,63% 22,83% N. medio di persone per famiglia 5,46 3,1
Un altro dato salta subito all'occhio: il numero medio di componenti per famiglia era quasi
doppio rispetto a quello dell'intero comune. Ciò evidenzia il carattere popolare del caseggiato,
strutturalmente adatto a ospitare famiglie allargate con i suoi appartamenti molto ampi,
almeno per lo standard odierno: si va da 81mq fino 115 mq per alloggio.
TAB 2.3 Professioni dei capifamiglia22 “Palazzone” Cinisello Balsamo Operai 82,02% 59,07% Impiegati 4,50% 19,57% Imprenditori professionisti 0,30% 1,35% Negozianti 0,87% 5,51% Artigiani 0,87% 1,57% Casalinghe 5,97% 6,32% Pensionati 4% 5,48% Altre 1,47% 1,13% Totale 100% 100%
A questi valori sembra interessante correlare la tabella 2.3 che fornisce un quadro relativo alle
professioni dei capifamiglia. La presenza massiccia di operai e casalinghe, rispetto a Cinisello
20 Dati relativi al 1979, periodico “La città”. 21 Dati relativi al 1979, periodico “La città”. 22 Dati relativi al 1979, periodico “La città”.
35
nel suo complesso, rivela che i criteri seguiti per l'assegnazione degli alloggi rispondevano ad
oggettive necessità. L’amministrazione aveva risolto il problema della casa per moltissime
famiglie permettendo di insediarsi in un nuovo edificio. Nonostante questo, rimangono alcune
perplessità relative alla scelta di costruire un edificio di queste dimensioni e di "riempirlo"
con nuclei famigliari poveri o poverissimi. Prima tra tutti è l'effettiva povertà dei neo-
inquilini, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista relazionale: le
famiglie da poco immigrate fanno fatica a inserirsi nel tessuto sociale della città e a trovare
occasioni di guadagno. La questione alimenta un circolo vizioso: l'assegnazione di alloggi
popolari segue criteri rigidissimi per dare risposta alle famiglie con redditi infimi ma poi
IACP chiede affitti non calmierati e lamenta le inadempienze degli inquilini. Queste
inadempienze nel pagamento degli affitti sono il pretesto per evitare qualsiasi intervento
strutturale sul complesso che, negli anni è andato sempre più degradandosi.
Oltre a ciò si aggiungono le difficoltà date dalla provenienza geografica più disparata
degli abitanti: le difficoltà comunicative si sommano a quelle sopracitate formando uno
spesso "strato" di deprivazione per cui è molto difficile trovare una soluzione immediata. Il
Palazzone è il primo edificio di grosse dimensioni ad essere costruito nel territorio di
Sant’Eusebio;; ad esso seguono, negli anni 80’, ulteriori complessi di case popolari di
proprietà IACP a cui si aggiungono i primi complessi di competenza delle cooperative
edilizie. Sulle cooperative edilizie e sul ruolo molto attivo che hanno giocato nella storia di
Cinisello ci sarebbe da ampliare molto il discorso, ma non sarebbe funzionale ai propositi di
questo elaborato. Dopo l’arrivo delle prime famiglie al Palazzone, il quartiere Sant’Eusebio
incomincia ad acquistare una certa corposità: dal 1960 al 197923 gli abitanti passano “da
poche migliaia” a circa 15000. Don Daniele, il primo parroco di Sant’Eusebio, si trasferisce
nel quartiere tra il 1974 e il 1975 (ma l’insediamento della parrocchia avviene nel 1979), con
la presa di residenza delle famiglie del Palazzone; sfruttando gli spazi delle vecchie cascine
che circondano la chiesetta storica, inizia ad occuparsi del quartiere dando vita alla
parrocchia. Il Consiglio Pastorale, da lui presieduto, si fa carico delle prime richieste
provenienti dalle case popolari appena occupate: mancano gli spazi per i bambini e la struttura
del caseggiato, aperto su tutti i lati, non garantisce la sicurezza dei giovani.
Le prime richieste all’amministrazione sono, infatti, quella della pulizia dei campi che
23 Periodico “La città”, 1981
36
circondano il Palazzone a nord e ad est dai rifiuti e quella di recintare l’edificio per renderlo
sicuro durante il giorno e non accessibile da chiunque di notte. Nel 1976 apre il Centro Civico
di via Giolitti 8 e diventa lo spazio in cui gli inquilini iniziano ad incontrarsi e ad occuparsi
del quartiere. Inizia subito ad essere pressante la questione dell’istruzione: sempre in via
Giolitti si attiva la prima scuola elementare, che però manca di tutto. A partire da degli spazi
adeguati fino all’arredamento di base come banchi e sedie. Nel 1978 nasce il primo Comitato
Inquilini con sede nel centro Civico; esso mantiene i rapporti con il Consiglio Pastorale e
alcuni dei suoi membri sono attivi in entrambe le assemblee. Nel frattempo si susseguono le
manifestazioni in opposizione all’istituto ALER (ex IACP) che continua a trascurare la
manutenzione dei complessi di edilizia popolare: siamo ormai tra il 1980 e il 1981 e il
complesso costruito di fretta quasi 5 anni prima comincia presto ad avere alcuni problemi
strutturali (scale inagibili e ascensori mai stati funzionanti).
Nel febbraio 1987 nasce il MARSE per opporsi al crescente problema della droga. In
quegli anni, non c’è giornale che periodicamente non riporti notizie di cronaca relative allo
spaccio di droga o alle morti sempre più frequenti dei giovani tossicodipendenti. Dall’arrivo
degli inquilini del palazzone è attivo nel quartiere il Centro di Cultura popolare che fornisce
un servizio scolastico per adulti e bambini. Tra gli altri, infatti, acquisisce sempre maggior
rilevanza il problema dell’abbandono scolastico: la scuola elementare e la scuola media di
Sant’Eusebio sono quelle con il più alto tasso di bocciature a cui seguono episodi di
abbandono. Tra le cause c’è sicuramente la poca importanza attribuita alla scuola da parte dei
genitori del quartiere, come riscontra il collettivo del Centro di Cultura Popolare in un articolo
de La città. La scuola è vista come una spesa, peraltro inutile viste le scarse opportunità che
offre agli occhi degli abitanti. Oltre a ciò, è da segnalare tra le cause, l’altissimo turn over dei
maestri e professori delle scuole di Sant’Eusebio: raramente gli studenti riescono ad avere lo
stesso professore per più di un anno e all’inizio di ogni nuovo anno scolastico sono di routine
i disagi causati dalla difficoltà a trovare insegnanti disposti a garantire una presenza
continuativa che superi i tre mesi. La Scuola Popolare tenta di supplire in questo senso
avviando programmi di apprendimento della durata di due anni per coloro che hanno
abbandonato la scuola o per altri motivi non riescono a garantire una presenza continuativa.
Negli anni 80’, parallelamente alla questione dilagante della droga, il Comitato Inquilini
37
“allargato” 24si adopera per il proseguimento annuale delle feste di quartiere. Si cerca di dare
ai giovani un’alternativa al percorso “in discesa” verso la droga fornendo reali opportunità di
integrazione col mondo del lavoro attraverso laboratori di saldatura, falegnameria ecc.
Nel 1989 nasce il progetto “Riprendiamoci il quartiere” che tra gli altri obiettivi mira a
portare un vero e proprio parco nel territorio di Sant’Eusebio, obiettivo ottenuto con
l’istituzione del Parco del Grugnotorto nel 199X. Tra il 1987 e il 1988 sorgono, proprio di
fronte al Palazzone, le Cinque Torri; con i suoi 8 piani per edificio anche questo complesso va
ad aggiungere circa un migliaio di persone al quartiere già straripante. Viene ultimata la
parrocchia (1987-1988) e tutte le funzioni vengono trasferite dalla sede nella Cascina
Cantalupi al vicino nuovo edificio. Sorge quasi contemporaneamente la “questione cascine”:
avendo esaurito la loro funzione sono destinate alla demolizione ma un gruppo di abitanti si
oppone portando come istanza la tutela del patrimonio storico. Si fa sempre più pressante il
problema sicurezza: alcuni abitanti sono intervistati in televisione e in radio per denunciare
l’enorme stato di degrado in cui versa il quartiere dal punto di vista sociale e strutturale. Il 23
marzo 1989 il prefetto si reca nel quartiere e viene accolto nella neonata parrocchia da molti
rappresentanti dell’amministrazione assieme ai cittadini: fa un appello in cui sollecita il
comune a prendere provvedimenti affinché si risolva la “questione sicurezza”. Nel frattempo
nasce il comitato inquilini del complesso “Cinque Torri”, con sede in via del Carroccio, e
comincia a prendere contatti con lo storico Comitato del Palazzone. Nel 1991 Don Marcellino
subentra a Don Daniele nella guida della parrocchia dopo due anni di compresenza. Nel 1992
si comincia a parlare di un progetto di riqualificazione del quartiere (anche se le prime
avvisaglie risalgono alla fine deghi anni 80’), vengono convocati alcuni inquilini del Comitato
del Palazzone assieme ai rappresentanti delle associazioni (Marse, Gad, Cooperativa
Sammamet, Sicet ecc.). Il percorso è lungo e tortuoso perché l’amministrazione non può
affidarsi ai già scarsi fondi comunali e deve cercare altrove. Si guarda con interesse ai
programmi europei Urban che sembrano andare nella direzione sperata: Daniela Gasparini,
assessore alle politiche sociali, si fa carico di seguire da vicino lo sviluppo del progetto
Contratto di Quartiere25. Ciò che permette, infatti, al comune di Cinisello Balsamo di arrivare
in tempo alla presentazione del bando avvenuta nel 1998 è un lavoro sul territorio che dura fin
dal 1994. Non è chiaro quanto di questo lavoro è stato svolto in accordo con i cittadini poiché
24 Comprendente, cioè, tutti gli attori che ruotavano attorno alla parrocchia ma anche le associazioni, il centro cultura popolare ecc. 25 Da ora in avanti CDQ.
38
in questa prima fase l’obiettivo era quello di individuare quali fossero i problemi più urgenti e
decidere come sarebbero stati canalizzati i fondi provenienti dal ministero. Probabilmente
alcuni incontri con soggetti “chiave” ha permesso che si tracciasse un progetto a grandi linee
che si pensava di portare all’attenzione di tutti gli abitanti. Il progetto (CDQ I) concentra
l’intervento sull’area di via Albero da Giussano, soprattutto sul “Palazzone”, con l’intento di
migliorare le condizioni abitative dei residenti mediante interventi di manutenzione, inserire
alloggi sperimentali per particolari categorie di utenza all’interno dello stesso, inserire attività
di servizio sociale e realizzare laboratori finalizzati a promuovere la nascita di imprese. Nel
gennaio del 2000 cominciano le prime riunioni di scala per la presentazione del progetto agli
abitanti, i quali si dichiarano subito contrari al piano della mobilità e alla collocazione del
centro Polifunzionale all’interno del cortile del “Palazzone”. Viene proposta una petizione,
firmata da 150 inquilini, per far desistere il Comune e Aler; la petizione presentata in
Consiglio Comunale ha successo e l’amministrazione decide di farsi carico di una richiesta al
Ministero per una modifica sostanziale del progetto. Da questo momento inizia il lavoro di
negoziato tra le parti: gli abitanti, le associazioni, l’istituzione (che nel frattempo ha creato
l’Ufficio Contratto di quartiere) si incontrano nei Laboratori di quartiere per definire le
proposte condivise che saranno realizzate. Il Palazzone viene ristrutturato, i laboratori partono
e si forma un “coordinamento” sul tema della sicurezza. Nel frattempo vengono pubblicati
nuovi bandi, sono disponibili i fondi per un secondo CDQ che l’amministrazione non esita a
promuovere. L’intervento viene destinato questa volta al complesso “Cinque Torri” anche se
la vicinanza tra i due caseggiati fa si che la centratura sia la medesima area.
Le modalità e le tipologie delle azioni di riqualificazione sono simili a quelle adottate con
il CDQ I tanto che, nella memoria degli abitanti, spesso non si distingue tra i due momenti. Il
secondo progetto, rinnovato nel 2002, viene dichiarato concluso tra il 2009 e il 2010 anche se,
come si vedrà nel cap. III, non tutti i lavori che erano stati messi a bando sono stati ultimati.
39
2.3 Gli attori in campo
Nell’analisi del tessuto relazionale del territorio, vista la pluralità di attori in campo si è
scelto di individuare quattro aree differenti di appartenenza e approfondire il loro percorso di
crescita.
L’obiettivo è quello di fornire un quadro complessivo che tenga conto delle diverse parti
che agiscono sul territorio, delle loro differenze e affinità come della distanza sul piano
politico. Al primo posto va sicuramente l’attore pubblico e l’amministrazione comunale nella
sua prospettiva storica. Nel paragrafo vengono presentati brevemente i risultati elettorali della
circoscrizione 4 confrontati con i dati dell’intero comune.
Si è scelta, inoltre, la parrocchia come punto di riferimento per l’area religiosa e come
catalizzatrice dell’intervento sociale all’interno del quartiere;; l’associazione Marse come
“pioniera” dell’associazionismo, inizialmente collegata all’ambito religioso e
successivamente legata all’amministrazione (da sempre PCI, DS, PD); il Comitato Inquilini
del Palazzone, come primo esperimento di attivismo nel quartiere che ha stimolato la
creazione di comitati simili negli altri caseggiati ALER ma anche in quanto spazio di conflitto
tra diverse appartenenze politiche.
40
2.3.1 L’amministrazione comunale
La lunga tradizione di governo locale delle “sinistre”, la storica base operaia
dell’elettorato, la natura, a partire dagli anni ’50 e ’60, di “città dormitorio” per i
lavoratori delle fabbriche di Sesto San Giovanni e Milano, la storia di
immigrazione dal meridione, una certa attenzione per i servizi sociali, la
preminenza di un’edilizia “cooperativa” fanno della nostra città un luogo più
“vivibile” di molte realtà confinanti, che hanno avuto uno sviluppo differente,
anche in condizioni di partenza simili.26
Il comune di Cinisello Balsamo è stato, dal dopoguerra in poi, sempre legato ad
amministrazioni di sinistra: alla guida della cittadina si sono susseguiti sindaci del PCI e PSI
fino agli anni ’90 e appartenenti a coalizioni di centrosinistra dopo lo scioglimento dei partiti
storici. Come molti altri comuni dell’hinterland, la netta prevalenza operaia ha fatto si che
l’amministrazione rimanesse “rossa” per molti anni, senza grandi difficoltà né situazioni in
bilico (lo dimostra il fatto che si sia potuto insediare un sindaco appartenente al PRC, l’ala
minoritaria e più radicale della coalizione di centrosinistra).
Sant’Eusebio, o più in generale la circoscrizione 4 comprendente anche la zona di
Borgomisto, non si discosta molto dai risultati e dalle percentuali relative all’intero comune: il
PCI si è sempre affermato con un netto distacco sulle altre forze politiche come rileva la
tabella 4. Come mostrano i risultati, le periferie erano per i partiti di sinistra una grossa fetta
del consenso e per certi versi è difficile spiegare perché proprio da esse giungessero
contestazioni all’operato dell’amministrazione. Il predominio istituzionale di formazioni di
sinistra, infatti, in nome della sua vocazione “dal basso” ha sempre cercato di canalizzare le
rivendicazioni popolari facendole proprie; in accordo anche con il sistema bipartitico che
vigeva a livello nazionale, era difficile che le realtà che via via sorgevano sul territorio non
fossero legate al PCI da una parte o a quelle forme di cattolicesimo sociale di cui si faceva
portatrice la DC.
26 Blog a cura della “Scuola Popolare”, www.fatelargo.tk URL consultato in data 12-01-2015
41
TAB 2.4 Sindaco Partito
1970 - 1979 Enea Cerquetti PCI
1979 - 1980 Felice Riccardi PCI
1980 - 1983 Virgilio Canzi PCI
1983 - 1985 Elio Bosio PCI
1985 - 1991 Vincenzo Pozzi PSI
1991 - 1994 Carlo Lio PSI
1994 - 2004 Daniela Gasparini PDS
2004 - 2009 Angelo Zaninello PRC
2009 - 2013 Daniela Gasparini PD
2013 Cristiana Cirelli27
2013 - in carica Siria Trezzi SEL
La stessa esistenza degli episodi di attivazione citati fino ad ora dimostra che queste
azioni di contenimento o di catalogazione dell’iniziativa popolare non sono sempre andate a
buon fine. Nonostante l’amministrazione si proponesse come diretta interpretatrice della
volontà e delle rivendicazioni “popolari” non sempre è riuscita a comprenderne le esigenze o
non ha avuto la volontà per farlo. Ciò che si può rilevare, ripercorrendo la storia del quartiere,
è un certo grado di attendismo. La sicurezza della vittoria sul piano elettorale ha
disincentivato l’amministrazione a occuparsi con costanza del quartiere;; certo, non si può
parlare di totale disinteresse, l’attenzione per le politiche sociali e il forte ridimensionamento
della speculazione edilizia grazie alle cooperative fanno si che il quartiere goda di una
situazione migliore rispetto a molti altri, anche se le difficoltà e le voci critiche rimangono.
Queste “voci critiche”, alcune volte schierate altre volte indipendenti dal meccanismo
partitico hanno dato vita alle mobilitazioni che hanno stimolato un dialogo intenso tra
territorio e istituzione. Come detto poco sopra, la posizione dell’amministrazione di fronte
alle attivazioni è stata altalenante, nonostante si promettessero interventi e migliorie i tempi si
dilatavano puntualmente dando l’impressione, agli abitanti, di vivere in un quartiere
“dimenticato” in cui i rappresentanti dei partiti vengono solamente “a caccia di voti”.
27 Commissario Prefettizio nominato in data 22/01/13.
42
Il primo ampio intervento da parte dell’amministrazione28 si ha con l’avvio del progetto
CDQ: il merito dell’amministrazione in quel caso, era stato l’essersi mossa nei tempi
brevissimi per ottenere il finanziamento, cosa che ha permesso di tradurre in pratica progetti e
iniziative che da tempo esistevano solo sulla carta o nelle idee dei pianificatori. Circa la
posizione assunta dall’attore pubblico nelle mobilitazioni e durante la realizzazione del CDQ
sarà esplicativo il capitolo III e in particolare il paragrafo 3.
TAB 2.529 COMUNE ‘75 CIRCOSCRIZIONE ‘80 CIRCOSCRIZIONE ‘85
PCI 59,15 54,66 50,99
PSDI 2,88 4,32 4,21
PSI 12,39 14,98 17,45
DP 3,74 3,44 4,51
DC 19,74 22,60 22,84
ALTRI 2,1 - -
28 Qui si intende un intervento sul tessuto sociale del quartiere, perché gli interventi strutturali non erano mancati durante gli anni ’80 29 Periodico “La città”, 1985 ;; si è scelto di confrontare i dati comunali e quelli di circoscrizione prima di tutto per motivi di diponibilità (i dati circoscrizionali sono presenti dal 1980, prima di allora è difficile recuperare dati relativi al solo quartiere) e in secondo luogo perché consentono di centrare lo sguardo sulla situazione elettorale del territorio considerato.
43
2.3.2 La parrocchia
Nell’ottobre del 1979, l’oratorio di sant’Eusebio diventa la settima parrocchia di Cinisello
Balsamo, ultima in ordina di tempo. Don Daniele Turconi fa richiesta di essere trasferito e
viene nominato parroco nello stesso anno. Nei mesi seguenti comincia a conoscere il quartiere
incontrandone gli abitanti “casa per casa”;; entrando nei palazzi e nelle case dei neoarrivati,
Don Daniele è uno dei primi, se non il primo a toccare con mano i problemi reali del “nuovo”
quartiere. In poco tempo forma un Consiglio Pastorale, un’assemblea parrocchiale “allargata”:
esso assume la forma di una riunione aperta a chiunque volesse partecipare. La novità più
importante risiede nel fatto che il centro di quelle riunioni fossero il quartiere e i suoi bisogni,
mentre l’aspetto religioso veniva trattato in modo più laterale. L’obiettivo era quello di creare
aggregazione all’interno del territorio, formare e incentivare delle relazioni tra gli abitanti
affinché essi trovassero insieme delle risposte a problemi comuni, ma soprattutto quello di
stimolare una “coscienza” civica. Ogni partecipante era libero di declinare come voleva il
proprio impegno e la propria partecipazione, il messaggio “cattolico” che si cercava di
stimolare era l’idea che occuparsi della comunità (in quel caso intesa come il quartiere) fosse
una parte fondamentale del proprio spirito religioso. Attraverso la mediazione del parroco si
tentava di risolvere, almeno parzialmente i problemi di comunicazione che si avevano tra le
famiglie immigrate dalle diverse regioni del paese; si cercavano di sanare i conflitti sorti a
causa di incomprensioni o di abitudini culturali molto diverse fra loro.
Non è che si capiva eh. Quello era calabrese, quell’altro di fianco
marchigiano, passavi la via e c’erano i veneti…non riuscivi eh, non
riuscivi a capire quello che si dicevano gli altri(…) (T.).
Le riunioni del sabato sera erano anche aggiornamenti continui sulla situazione della
sicurezza e il luogo in cui si prendevano alcune decisioni importanti sia sulla vita sociale del
quartiere che sulle iniziative da realizzare. Il punto focale delle attività ricreative del quartiere
erano le feste annuali e le “infiorate” che si svolgevano ogni anno. Quei momenti erano
estremamente utili anche per creare attenzione su alcune problematiche più sentite, come ad
esempio quella della recinzione del complesso GESCAL, attraverso un contesto di festa.
Le riunioni e le attività avviate dalla parrocchia sono state oltre che luogo di incontro,
strumento di formazione per i partecipanti. Molti dei membri, infatti, sfruttando le
44
competenze e le reti di relazioni formatisi all’interno di quel contesto assembleare hanno dato
vita alle associazioni che negli anni successivi sono state protagoniste sul territorio. La
parrocchia e i suoi spazi, percepiti come luoghi neutri hanno favorito la mediazione degli
conflitti e delle rivalità spesso politiche che sono sorte. Le istanze che venivano portate in
assemblea, infatti, erano spesso in contrasto con l’amministrazione comunale legata alla
sinistra del PCI e ciò rischiava di portare a situazioni di stallo. L’interesse di tutti i soggetti
coinvolti per il quartiere e i suoi bisogni hanno però prevalso, ne sono una dimostrazione le
iniziative portate a termine con successo come le battaglie per la casa, per i servizi o per la
scuola.
La parrocchia, poi, ha trovato nella Scuola popolare (Centro Cultura Popolare) e nel suo
collettivo un interlocutore non oppositivo che ha saputo interpretare le diverse componenti
sociali del quartiere arrivando ad agire con esse e per esse. Il lavoro dell’assemblea
parrocchiale prosegue dal 1979 parallelamente al Comitato Inquilini del complesso Gescal per
tutti gli anni ’80 impegnandosi attivamente per contrastare la “piaga” della droga.
Nel 1992 Don Marcellino subentra a Don Daniele nella guida della parrocchia
mantenendo fede al principio del “cattolicesimo sociale” che fino ad allora era stato centrale.
Anche Don Marcellino si occupa in prima persona del quartiere, incontra le famiglie e crea
occasioni di incontro e discussione che spesso andavano di pari passo con feste e
manifestazioni di tipo religioso. Con l’arrivo del CDQ, la parrocchia diventa uno dei firmatari
e impegna attivamente i suoi membri per la parte sociale del progetto legata ai laboratori e
alle iniziative culturali.
45
2.3.3 Il Marse
Il Movimento Antidroga Rione Sant’Eusebio nasce come gruppo parrocchiale
costituendosi come associazione nel 1987. Nato come risposta al problema della droga, come
testimonia il suo nome, è diventato col tempo un’associazione di promozione sociale che
opera su settori molto eterogenei. Il progetto originario era quello di fornire supporto
immediato e ascolto alle famiglie coinvolte che avessero parenti, figlio o amici
tossicodipendenti: si trattava di portare questo problema alla luce, far si che non si relegasse a
problema famigliare da “nascondere” tra le mura domestiche. Parlare della droga era il primo
passo per creare consapevolezza attorno a un problema che stava ormai entrando a far parte
della quotidianità del quartiere.
“C’è stato un periodo in cui non c’era nessun pudore, li trovavi anche
sulle scale sdraiati, buttati li che la faccia non si riconosceva”(T.)
Certo, i tossicodipendenti non erano ovunque e non tutte le famiglie erano a contatto
diretto con il problema, ma in uno spazio come quello di Sant’Eusebio, dove in pochi
chilometri quadrati vivevano quasi 3000 persone, era difficile che non li si avesse sotto gli
occhi.
I gruppi di ascolto iniziavano a creare informazione attorno al tema, sfruttando le
esperienze di chi ne era già uscito e cercando di sfatare i luoghi comuni e le credenze che
aleggiavano attorno alla questione della droga30. Era un clima la cui pesantezza si respirava
quasi nell’aria:
“Tutti un po’ si sapeva, ma che facevamo, scusa?”(R. L.)
Anche la stampa locale ne da notizia, attraverso notizie di cronaca sempre più frequenti e
le prime interviste, soprattutto alle madri coinvolte. Non mancano episodi di intimidazione,
tentativi di dare fuoco ad alcuni appartamenti e minacce velate. Il 14 luglio del 1988 un
incendio doloso rischia di consumare uno degli appartamenti di via Giolitti 10, all'interno del
complesso GESCAL. E' l'ennesimo atto intimidatorio nei confronti di chi protesta
continuamente per i traffici "alla luce del sole" che avvengono nel Palazzone.
30 C’era chi, spinto dalla disperazione, arrivava a comprare “macchine prodigiose” a prezzi esorbitanti che promettevano un recupero sicuro vendute da chi sfruttava l’ignoranza che esisteva sul tema
46
Il quartiere però reagisce, il Comitato Inquilini organizza un'assemblea a cui partecipano
gli abitanti ovviamente il Marse, ormai formalizzato in associazione da un anno. Vengono
raccolte 492 firme per una petizione diretta al prefetto di Milano, ai carabinieri e al sindaco in
cui si richiede un intervento. Dopo alcuni incontri tra delegazioni di cittadini e forze
dell'ordine si arriva a un primo intervento massiccio nell'area da parte di polizia e carabinieri
che porta all'arresto di alcuni spacciatori.
Anche se di indubbia importanza, il "blitz" non interviene sui fattori primari che causano
il disagio, gli abitanti e le associazioni concordano sull’idea che sia necessaria una pluralità di
interventi. Non ci si può limitare a operazioni di contenimento ed è fondamentale agire sui
contesti che permettono l’espansione continua del mercato della droga. Questo testimonia
l’importanza delle iniziative portate avanti dal Marse fin dalla sua formazione. L’idea di
combattere l’omertà attraverso l’aggregazione era il fulcro delle feste di quartiere: spesso i
concerti si svolgevano nel cortile interno del Palazzone o nelle vicinanze proprio affinché si
potesse “dar fastidio” e fare da deterrente allo spaccio. Negli anni ’90 il problema della droga
si ridimensiona lentamente e questo permette all’associazione di rivolgersi a ambienti e target
differenti. Vengono avviati progetti formativi per le scuole diretti a studenti e famiglie
sull’importanza dell’istruzione, sulle tossicodipendenze e sull’uso delle droghe, sulle nuove
tecnologie e sull’ambiente (i progetti di sensibilizzazione sul tema del verde erano inseriti nel
più ampio dibattito sul nuovo Parco del Grugnotorto, che era in fase di realizzazione). Si
continuano a organizzare eventi aggregativi cercando di coinvolgere diverse fasce di età, si
pone l’attenzione sui giovani con eventi dedicati e tavoli di partecipazione in cui si cercano di
cogliere le esigenze. Attraverso gli eventi e i progetti nelle scuole, il Marse esce dal contesto
di quartiere arrivando a occuparsi di Cinisello Balsamo nel suo complesso, con iniziative su
tutto il territorio.
Ad oggi, molte delle proposte provenienti dall’amministrazione e dei progetti sul
territorio di Cinisello Balsamo portano la firma del Marse anche se rimane l’importanza e la
centralità del quartiere sant’Eusebio visto che la sede legale e la prima sede operativa si
trovano ancora al suo interno.
47
2.3.4 Il Comitato Inquilini
Il Comitato Inquilini nasce formalmente nel 1982: dopo alcuni anni di assestamento si
riesce a garantire una consultazione che coinvolge circa il 90% degli inquilini del caseggiato
GESCAL. Anche se non è corretto parlare fin da subito di un vero e proprio comitato,
bisogna dire che le riunioni tra inquilini e caposcala avvenivano già dall'insediamento nel
1975. In maniera informale, si era utilizzato durante tutto il 1975 e il 1976 lo spazio di via
Giolitti 8 in accordo con IACP. L’istituto, infatti, aveva concesso di tenere aperto il Centro
Civico in attesa che si formalizzasse la costituzione di un Comitato eletto dagli inquilini.
Nell'autunno del 1977 il Comune di Cinisello chiede agli inquilini e allo IACP di poter
usufruire del centro civico per sopperire ai bisogni della vicina scuola "Giolitti": manca infatti
un locale mensa per i ragazzi e le ragazze delle medie. IACP e gli inquilini accettano;
l'amministrazione firma un contratto di durata quadriennale e la mensa si sposta nei locali del
centro civico. Alla scadenza del contratto, nel 1982, il Comune riesce a dotarsi di spazi
alternativi e riconsegna le chiavi allo IACP che però non le cede, come d'accordo, al Comitato
Inquilini adducendo problemi di natura economica.
Seguono una serie di riunioni e petizioni nei confronti dei funzionari che portano IACP a
concordare l'uso della sala con alcune condizioni. Si richiede, prima di tutto, un affitto a
carico degli inquilini del Palazzone, che se nelle intenzioni doveva essere simbolico , nei fatti
arriva alla somma di quasi 3 milioni di lire. In un incontro successivo, grazie alla mediazione
dell'assessore, IACP riconosce la validità e l'importanza del Comitato per coloro che abitano
il quartiere e concorda nel ridurre della metà le spese e di non far pagare l'affitto. Nonostante
alcune perplessità rimangano (molti non sono d’accordo sul corrispondere l’affitto allo IACP
perché ritengono il Centro Civico un diritto degli inquilini del caseggiato), il lavoro del
Comitato incomincia fin da subito.
Il Comitato diventa centrale nella vita sociale del quartiere e come centro di ascolto per
gli inquilini. Gli abitanti di Sant’Eusebio sanno che al centro civico le loro richieste vengono
accolte e che è da li che bisogna partire per affrontare le mancanze del quartiere. Con le sue
riunioni settimanali, il comitato è la culla di quasi tutte le “battaglie” degli abitanti: dalla
recinzione al mercato passando per i trasporti e il parco nel quartiere, il comitato si fa
promotore delle esigenze più quotidiane degli abitanti. Ciò che funziona, infatti, è il suo
48
essere radicato nel territorio di cui vuole occuparsi e il suo essere composto da inquilini del
palazzo: chi più di coloro che vi abitano può preoccuparsi del quartiere?
L’assemblea funziona e viene riconosciuta come portavoce da quasi tutti gli inquilini del
Palazzone: la sua voce critica polemizza con l’amministrazione comunale attraverso le pagine
de La Città fornendo un aggiornamento sulle reali condizioni del quartiere a dispetto dei
proclami elettorali. Si cerca, parallelamente, di sfatare l’aura di degrado che circonda il
quartiere nell’immaginario della città e della nazione. Spesso, infatti, i blitz e le retate hanno
eco anche sulla stampa nazionale e sono l’occasione per alimentare lo stigma che già grava
sulle spalle di tutti gli abitanti. Sant’Eusebio “abitato da balordi di ogni sorta”, “capolinea
della violenza” e “quartiere dormitorio” sono narrazioni ricorrenti in alcuni quotidiani di
stampa locale (e non solo) che il comitato cerca di contrastare attraverso petizioni o iniziative
che possano coinvolgere la cittadinanza e fornire un’immagine finalmente positiva del
quartiere.
Con l’arrivo delle “Cinque torri” inizia a crearsi una rete di contatti tra i vari inquilini dei
diversi complessi IACP: si comincia a proporsi come soggetto unico, strategia che aumenta il
“potere contrattuale” messo in campo durante le discussioni con il Comune o con IACP.
Questa modalità viene messa alla prova con il CDQ che infatti non è indirizzato non a un solo
edificio ma alla riqualificazione di un’area. I risultati sono altalenanti e il CDQ si dimostra
terreno di conflitto anche all’interno dei singoli comitati: la difficoltà di mediare tra le diverse
parti in gioco nel quartiere e l’amministrazione comunale con le sue tempistiche (che per la
destinazione dei fondi erano molto strette) spinge molti degli “storici” contributori a lasciare
il campo. Col procedere dei lavori nascono formazioni alternative ai comitati originari: prima
l’Associazione Inquilini e successivamente il Forum Sant’Eusebio che da quel momento
agiscono per proprio conto.
Le divisioni nate dal CDQ si ripercuotono tutt’oggi: a causa di opinioni discordanti circa
l’utilizzo dello spazio di via Giolitti 8 (lo storico Centro Civico) da parte delle assemblee
contendenti (il Forum e l’Associazione), ALER (ex IACP) decide di chiudere lo spazio fino a
che non si troverà un accordo. Ad oggi non è stata trovata alcuna soluzione e lo spazio risulta
chiuso.
49
Capitolo 3 - Azioni collettive e attivazioni : una ricerca
3.1 Modalità della ricerca empirica
La fase di ricerca è iniziata tra maggio e giugno 2014 protraendosi fino a ottobre dello
stesso anno. Le interviste hanno coinvolto gli attori più legati al quartiere per vari ambiti. Il
progetto iniziale comprendeva alcune interviste ad attori legati all’istituzione, altre tese a
mettere in luce il punto di vista degli operatori delle associazioni e/o comitati del territorio e
in ultimo alcuni colloqui con gli abitanti del quartiere.
Nonostante Sant’Eusebio fosse, per chi scrive, una realtà non totalmente sconosciuta, la
prima difficoltà che si è posta è stata quella di trovare il modo per avvicinare e agganciare gli
abitanti del quartiere. La numerosità di interventi, azioni e indagini sul quartiere durante gli
anni, infatti, ha fatto si che la presenza dell’ennesimo estraneo venuto “a far domande” non
fosse da tutti ben accetta. Per questo motivo si è cercato prima di tutto di stabilire alcuni
contatti con le associazioni che operano sul territorio (MARSE, Il Torpedone, Agesci,
Sammamet) e con le realtà più radicate (la parrocchia e i comitati inquilini).
L’obiettivo era quello di presentare brevemente i fini della ricerca, riassumendoli e
semplificandoli in una “raccolta di memorie” sulla storia sociale di Sant’Eusebio, per poi
ottenere alcuni contatti di abitanti che fossero disponibili alle interviste. Il primo contatto con
le associazioni ha avuto esito molto positivo e aldilà delle aspettative; alcuni degli educatori
che in quei mesi tenevano i rapporti con gli abitanti del vicinato per l’organizzazione della
Festa di Quartiere, hanno da subito accolto positivamente l’idea. Tra i loro progetti, infatti,
rientrava da tempo la possibilità di avviare una ricostruzione della “memoria storica del
quartiere” attraverso le voci e i racconti dei protagonisti che rendesse un po’ più giustizia
rispetto alle narrazioni dei mass media che da sempre alimentano lo stigma del quartiere
“criminale”. In accordo con loro, si è deciso di pubblicizzare un incontro aperto a tutti i
residenti il cui obiettivo dichiarato era la ricostruzione della “linea del tempo di
Sant’Eusebio”. L’incontro ha preso la forma di un focus group in cui si è cercato di dare
forma ai ricordi dei presenti.
L’idea era quella di collocare temporalmente gli eventi significativi del quartiere (costruzione
degli alloggi popolari, arrivo delle famiglie, progressivo insediamento dei servizi, contratto di
50
quartiere, azioni collettive) incrociandoli con i dati ufficiali in possesso delle associazioni. Si
auspicava, inoltre, che dalla discussione emergessero altri nomi di soggetti che avessero avuto
un ruolo importante nel territorio e se su di essi c’era accordo o meno.
L’incontro si è svolto il 15 marzo 2014 presso il Centro Civico 5 Torri, nel cuore del
quartiere Sant’Eusebio, coinvolgendo una decina di persone (9-12) per circa due ore. Il
carattere informale della discussione e le modalità con cui erano stati selezionati i soggetti,
non può che far passare in secondo piano la rappresentatività rispetto al quartiere. Il gruppo
infatti era composto prevalentemente da persone già legate alle associazioni per vari motivi,
molto attive sul territorio e quindi certamente non rappresentative dell’intera popolazione di
Sant’Eusebio. L’obiettivo però, come si è detto, non era già quello di raccogliere direttamente
il vissuto o le opinioni dei presenti, ma di allargare il più possibile il range di contatti. Il
risultato è stato soddisfacente: è stata stilata una “linea del tempo” sommaria e una lista di
persone che i presenti consideravano significative. Da notare, alla luce di questo primo
incontro, la cospicua presenza femminile; le donne sono la maggioranza nel piccolo gruppo di
discussione e tra i nomi della lista contatti. Questo dato sottolinea fin dal principio
l’importanza della componente femminile nella storia di quartiere: come vedremo
successivamente, le donne sono state in molti casi al centro dei processi partecipativi che
hanno interessato Sant’Eusebio. All’incontro è seguita la progettazione della fase successiva;;
ho diviso le persone da intervistare in 5 gruppi che identificavano i diversi ambiti e le diverse
realtà in cui le persone avevano agito. Il primo gruppo comprendeva i soggetti legati alla
parrocchia di Sant’Eusebio e alle associazioni collegate, il secondo coloro che avevano
fondato e portato avanti la Scuola popolare, il terzo includeva i membri dei Comitati Inquilini,
il quarto comprendeva coloro che avevano avviato e seguito il progetto CDQ (I e II) mentre
l’ultimo, più esiguo, era riservato a soggetti istituzionali.
51
3.1.1 Le interviste
Si è scelto di condurre interviste non strutturate per permettere agli interlocutori di
concentrarsi sugli episodi che avevano vissuto più da vicino. L’obiettivo delle interviste,
infatti, oltre ad essere quello di ampliare la conoscenza sul quartiere, è stato quello di entrare
nel vivo delle questioni sollevate durante il focus group iniziale. Agli intervistati veniva
chiesto di tracciare in breve la storia del quartiere ponendo l’accento sulle fasi in cui c’erano
stati conflitti e/o azioni di protesta; in seguito si procedeva ad approfondire gli eventi in cui
ciascun intervistato (e di riflesso l’organismo di cui faceva parte) era maggiormente
coinvolto. Attraverso questa modalità è stato possibile raccogliere diverse testimonianze
relative ai medesimi eventi: sono emerse diverse prospettive e numerose sfaccettature,
impensabili in un racconto da una sola fonte. Man mano che ho proceduto con le interviste, e
le mie conoscenze circa la storia del quartiere sono andate migliorando, è stato possibile
stilare quelle dirette ai soggetti istituzionali e agli attori coinvolti nella progettazione del
CDQ. Ad essi, oltre a un racconto circa la storia e le modalità con cui si è portato a termine il
CDQ a Sant’Eusebio, è stata chiesta una valutazione dell’efficacia e della riuscita del
progetto; con queste domande si intendeva misurare se ci fosse una distanza tra le percezioni
“dall’alto” sulla riuscita del CDQ e le impressioni degli abitanti “dal basso”31.
Alle interviste decise nella fase di progettazione se ne sono aggiunte alcune: nei racconti
degli intervistati spesso sono emersi soggetti e realtà che avevano avuto un ruolo importante
negli eventi del quartiere e che non erano stati considerati. Tra questi ci sono il sindacato
dell’Unione Inquilini e il Consiglio di Circoscrizione. Per entrambi è stato contattato un
rappresentante con la discriminante che fosse stato presente durante gli anni ’80. Dopo la
conclusione di questa fase sono emerse chiaramente quali fossero le vicende più importanti e
centrali nella storia del territorio.
Si è scelto di approfondire tre mobilitazioni attraverso delle interviste mirate ad alcuni
testimoni, sfruttando la rete di contatti che si era creata in precedenza. Le domande di queste
interviste, diversamente dalle altre si concentrano esclusivamente sull’episodio in questione
tralasciando le tematiche già trattate32.
31Vedi appendice. 32 Vedi appendice.
52
3.2 Una schematizzazione degli eventi di attivazione
3.2.1 Cosa si intende con attivazione?
Nel primo capitolo è stato definito in maniera ampia il termine azione collettiva
territorializzata dimostrando come alcune esperienze apparentemente molto lontane
(l’Olivetti a Ivrea e il Centro Sviluppo Creativo di Dolci) abbiano dei caratteri in comune. Ma
cosa si intende con il termine “azione collettiva territorializzata” o “mobilitazione locale ”
quando ci si riferisce al territorio di Sant’Eusebio? Quali sono i caratteri fondamentali delle
attivazioni che si sono susseguite nel territorio?
In primo luogo una forma di mobilitazione locale deve presupporre l’esistenza di uno o
più meccanismi decisionali (Pichierri 2002; Vitale 2007); ci deve essere, cioè, un gruppo di
soggetti che decidono e agiscono con intenzionalità, come si è visto trattando del tessuto
relazionale del quartiere. L’azione collettiva territorializzata, inoltre, si caratterizza per la
presenza di una o più figure catalizzatrici che si fanno promotrici delle istanze che
provengono dal territorio. A Sant’Eusebio esse sono state, oltre alla parrocchia e ai comitati
inquilini (gli “imprenditori morali” più attivi in termini di mobilitazioni), anche le
associazioni del territorio. Il terzo carattere, come accennato nel capitolo II, è la centralità del
territorio nelle mobilitazioni locali: l’attivazione coinvolge abitanti del territorio che si
adoperano per sollevare e risolvere problemi del territorio (Vitale 2007). Nonostante a
Sant’Eusebio molte delle mobilitazioni avessero come fulcro il Palazzone, negli abitanti era
chiara l’idea che ogni rivendicazione era fatta per tutto il quartiere. Essere di “Sante”
significava (e significa ancora) trovarsi di fronte alle stesse quotidiane criticità. L’ultimo dei
caratteri fondamentali degli episodi di mobilitazione a Sant’Eusebio è il fatto che queste
azioni collettive fossero volte a trasformare questioni private, con le quali ogni abitante si
scontrava singolarmente, in problemi pubblici che interessano la collettività nel suo
complesso. Ne è un esempio la “questione casa”: nonostante sia per definizione una questione
privata assume spesso (e non solo a Sant’Eusebio) dimensioni più ampie travalicando il
confine tra pubblico e privato e portando all’attenzione della sfera pubblica una serie di
criticità.
53
Un’azione o mobilitazione può avere connotati differenti a seconda della finalità che si
propone: può assumere la forma di una contestazione, di una rivendicazione o di una
produzione (Vitale, 2007). Si parla di contestazione quando la mobilitazione e i soggetti in
essa coinvolti manifestano il loro disaccordo circa le scelte di attori pubblici o privati; in quel
caso l’attivazione è tesa a stimolare l’attenzione dell’istituzione su un dato tema, ciò può
avvenire tramite un azione di protesta, una petizione, un articolo di giornale.
Nella storia di Sant’Eusebio troviamo questa tipologia nel caso delle proteste dei primi
anni 2000 circa la modifica della viabilità interna al quartiere. In quel caso l’azione è stata una
protesta sotto forma di presidio che aveva l’obiettivo di mettere in chiaro l’opinione degli
abitanti circa le scelte organizzative dell’amministrazione locale. Si parla di rivendicazione
quando alla forma contestativa si aggiunge un qualche tipo di richiesta concernente i
beni/servizi e la loro distribuzione oppure alcuni diritti non garantiti. La differenza tra le due
non è netta ma si può comunque distinguerle: nei casi di rivendicazione, infatti, la
mobilitazione si adopera per stimolare non solo l’attenzione dell’istituzione (o dell’attore
privato in questione) ma anche un suo intervento che migliori la situazione e che fornisca quel
bene, quel servizio o quel diritto. In questo senso si può considerare “rivendicativa” la
mobilitazione degli abitanti del caseggiato GESCAL tra il 1979 e il 1980 volta ad ottenere
una recinzione che circondasse l’edificio. Gli abitanti rilevavano la mancanza di barriere che
circondassero il palazzo, lamentando problemi di sicurezza per i bambini e i giovani che erano
soliti frequentare il cortile. Effettivamente la strada che sorgeva poco lontano era già stata
teatro di incidenti causati dall’eccessiva vicinanza con il cortile sempre molto frequentato;; il
viavai di persone, inoltre, era un pericolo per la sicurezza interna al caseggiato, in quanto era
impossibile controllare chi entrava e usciva e le situazioni di microcriminalità diventavano
insostenibili.
“c'erano 900 bambini da gestire (..) adesso è tutto recintato, prima non lo
era...[questa cosa] ci ha procurato anche dei morti, perché i bambini
venivano fuori, andavano, ti scappavano facilmente e andavano in
strada(..) e queste cose succedevano”(P.D.C.)
L’azione rivendicativa, in questo caso era rivolta nei confronti dell’istituto IACP che in
quanto proprietario dell’immobile avrebbe dovuto provvedere alla recinzione. Dopo una serie
di petizioni, manifestazioni e presidi il palazzo è stato dotato di una siepe e di un cancello.
54
Il quarto carattere, invece, è proprio di quelle mobilitazioni che hanno come obiettivo la
produzione di beni pubblici. L’azione consiste in una vera e propria “prova di sostituzione”
dell’attore pubblico nella quale i cittadini, preso atto dell’assenza dell’istituzione in un dato
ambito provvedono con un’iniziativa autonoma. E’ il caso della pulizia dei campi ad opera dei
cittadini avvenuta negli anni successivi alla costruzione dei caseggiati popolari; per
fronteggiare la situazione di degrado in cui versava l’area appena edificata, alcuni cittadini
coordinati dal parroco, decidono di organizzarsi in piccoli gruppi per pulire e sgomberare i
campi circostanti. In questo caso manca un vero contatto con l’amministrazione, gli abitanti
saltano il passaggio della “richiesta” per passare immediatamente all’azione…probabilmente
c’era la consapevolezza che le tempistiche del Comune sarebbero state eccessivamente lunghe
e non era certo che un intervento avrebbe risolto la situazione.
Oltre a definire i caratteri delle attivazioni è utile procedere a una classificazione che
tenga conto degli aspetti che più differenziano ognuna di esse. In ogni mobilitazione, infatti, è
possibile ritrovare momenti in cui i caratteri sopracitati sono individuabili senza che la
presenza di uno determini l’assenza di un altro: azioni rivendicative che seguono episodi di
contestazione o attivazioni tese alla produzione di servizi che terminano in atti di
rivendicazione ecc. Per classificare le attivazioni ho distinto tra quattro tipologie differenti che
permettono di organizzarle in uno schema coerente.
55
3.2.2 Come si possono classificare le attivazioni?
E’ possibile distinguere le attivazioni/mobilitazioni su due assi fondamentali, il primo che
separa quelle “dall’alto” da quelle “dal basso” e il secondo che divide quelle conflittuali da
quelle consensuali.
Un’attivazione può essere frutto dell’esigenza e delle istanze dei cittadini che identificano
come propria controparte l’attore pubblico. In questi casi si parla di mobilitazioni dal basso.
Quando, invece, è l’istituzione che si attiva in prima persona per coinvolgere la cittadinanza e
renderla partecipe delle politiche urbane si parla di mobilitazioni dall’alto. Sul secondo asse,
invece, le azioni conflittuali sono quelle che presuppongono un disaccordo circa le scelte di
politica urbana e favoriscono il formarsi di una discussione ampia sul tema. In questo caso, le
parti in gioco (che posso essere interne alla cittadinanza o essere distinte tra attore pubblico e
abitanti) si scontrano sulle scelte e negoziano le decisioni. Quando per coloro che si
mobilitano non è chiara la controparte oppure c’è un sostanziale accordo sull’importanza e la
necessità di un intervento, si parla di azioni consensuali e non conflittuali. Sorge però un
problema: esiste una linea che separa una mobilitazione a carattere conflittuale da una
consensuale?
Tendenzialmente no, parlare di “linea” è fuorviante poiché i confini sono labili e tra i due
poli esiste un ampia area ibrida. Una mobilitazione in cui le parti sono riuscite ad accordarsi è
da considerare priva di conflitto mentre se la distanza tra gli attori è tale per cui non esiste
terreno di accordo si sfocia in un conflitto. Il conflitto, solitamente, ha carattere temporaneo e
termina con un accordo consensuale. Non ponendosi un limite temporale per il quale la
discussione è da considerarsi trasformata in un conflitto non è sempre facile stabilire dove e
quando una mobilitazione è diventata conflittuale.
56
Azioni collettive territorializzate/ Mobilitazioni/ Attivazioni
Conflittuali Consensuali
“Dal basso” Questione casa e alloggi
Il mercato “finto” La recinzione per il
“Palazzone” I trasporti e il
dirottamento
Pulizia dei campi La piantumazione dell’area di
via Giolitti/da Giussano Le feste di quartiere
“Dall’alto” Il Contratto di Quartiere
La questione “viabilità”
Questione “stigma” Ristrutturazione della
chiesetta storica
Tra le attivazioni conflittuali “dal basso” troviamo la questione “casa”, l’episodio del mercato
finto del 1985, i presidi contro l’abbandono scolastico, il dirottamento del pullman ATM nel
1978 e le proteste per la recinzione delle GESCAL. La questione casa e alloggi si ripropone in
modo costante fin dalla nascita del quartiere. Il problema riguarda due aspetti complementari:
le richieste degli inquilini circa una maggiore attenzione di Aler nella manutenzione degli
edifici e la questione del diritto alla casa. Anche se sembrano temi diversi e non collegati
esiste un filo conduttore che li unisce. Come si è accennato nel secondo capitolo le case
popolari costruite a Sant’Eusebio nel 1976 rispondevano alla situazione emergenziale in cui si
trovava il comune di Cinisello: gli operai immigrati d diverse parti d’Italia per fornire
manodopera alle fabbriche milanesi e sestesi avevano bisogno di case, il prima possibile. I
criteri per l’assegnazione erano molto severi e, effettivamente, le famiglie che si insediarono
nei palazzi appena costruiti godevano di situazioni economiche ben poco favorevoli. Il rischio
di trovarsi di fronte a situazioni di morosità era alto e, infatti, esse non tardano a mancare. La
risposta dell’istituto competente33 era rivolta in due direzioni, mentre da un lato si attivavano
gli sgomberi degli alloggi “morosi”, dall’altro si evitava qualunque intervento manutentivo
con la motivazione che mancavano i soldi degli affittuari “morosi”. La situazione è stata quasi
sempre di stallo, perché gli inquilini si attivavano per difendere coloro che ricevevano
l’ordine di sgombero per “morosità involontaria” e questo forniva ad Aler la motivazione (o il
pretesto) per non intervenire su nessun edificio. Le iniziative e le proteste si sono susseguite
33 Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) fino al 1996, poi Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (ALER).
57
per anni e i rapporti tra inquilini e Aler non sono mai stati dei migliori. La difficoltà nel
gestire la questione casa era (ed è tuttora) dovuta anche alla diversa appartenenza politica
delle istituzioni che vi sono adibite (l’istituto privato e l’amministrazione comunale). Molte
richieste vengono rimbalzate tra gli enti poiché non essendo sempre chiare quali siano le
competenze, spesso le istanze rimangono disattese.
“perché ti vai a scontrare con un comune di sinistra e un'Aler di destra...si
fanno la guerra tra di loro, chi ci va di mezzo è la gente”(P.D.C.)
Altri conflitti sono nati più recentemente quando si è riaperta la questione casa e sgomberi.
Ancora oggi non è chiaro quanti degli alloggi siano occupati per “morosità involontaria” e
quanti invece per scelta ben precisa: ciò porta a diversi contrasti tra chi vorrebbe un completo
ripristino della legalità e lo sgombero degli insolventi e chi invece protesta perché Aler e il
comune tengano conto delle situazioni di evidente difficoltà. In un contesto simile si colloca
la mobilitazione ad opera del Comitato Inquilini del Palazzone per ottenere la recinzione che
si è accennata poco sopra. In entrambe è presente il carattere marcatamente conflittuale: nelle
mobilitazioni per la casa si è arrivati a confronti diretti con le forze dell’ordine, per la
recinzione si sono fatte manifestazioni e presidi davanti alle sedi delle istituzioni.
Tra le mobilitazioni consensuali “dal basso” troviamo l’episodio già citato della pulizia
dei campi. L’esigenza di “rendere vivibile” il quartiere era tra le prime e le più importanti
degli abitanti appena insediati: l’area circostante le case popolari era poco curata e spesso
piena di rifiuti sia a causa della distanza dal centro città e dai suoi servizi sia perché le recenti
costruzioni avevano prodotto parecchio materiale di scarto che era stato abbandonato nelle
vicinanze. Nelle intenzioni di Don Daniele l’obiettivo era quello di rendere agibili i campi che
circondavano il quartiere (dove più tardi sarebbe sorto il parco del Grugnotorto e il campo
sportivo) per permettere ai giovani di avere un luogo in cui trovarsi. L’episodio rientra nelle
attivazioni consensuali poiché tra l’amministrazione e la parrocchia (promotrice assieme ad
alcuni soggetti del Comitato Inquilini del palazzone) erano sostanzialmente in accordo sulla
necessità di “riqualificare” l’area… ciò che mancava erano i fondi da destinare. Ciò ha
stimolato l’attivazione dei cittadini che, coinvolti dalla parrocchia in un clima di festa e quasi
di “gioco” si sono adoperati per sistemare i campi. La modalità ricorda alcune iniziative più
recenti ad opera di Legambiente (“Puliamo il mondo”) che coniugano l’aspetto del “gioco” a
una denuncia, tra le righe, delle mancanze dell’attore pubblico. Direttamente collegato, anche
58
se distante nel tempo, è l’episodio che ha avuto come risultato la piantumazione dell’area di
fianco il complesso GESCAL. Sull’onda di una rinnovata attenzione per l’ambiente, nel 1985
parte l’iniziativa “Riprendiamoci il quartiere”;; è in questo periodo che alcuni cittadini si
organizzano per iniziare a piantare degli alberi nella zona laterale rispetto al Palazzone.
Nonostante ci fosse già un progetto a cura dell’amministrazione, i cittadini scelgono di
muoversi subito con l’intento di velocizzare attraverso un’azione simbolica la creazione del
parchetto che si vede tutt’oggi. Dalla fine degli anni 70’ fino ad oggi si susseguono le feste di
quartiere. Questi eventi, che vedono la partecipazione della cittadinanza ma anche di tutte le
numerose realtà presenti sul territorio, hanno avuto, nel tempo, numerose funzioni.
Inizialmente l’obiettivo degli organizzatori era quello di creare aggregazione all’interno del
quartiere e stimolare l’appartenenza al territorio:
“Facevamo le feste perché non c’era niente”(S.B.)
La festa in quartiere era certamente un modo per dare spazio ai giovani, per i quali non
esistevano strutture, ma anche per incontrarsi tra inquilini, riscoprendo quelle tradizioni che
ogni emigrato si portava dietro dalla propria regione di provenienza, come l’“infiorata”. Negli
anni successivi le feste acquisiscono una nuova valenza. Dagli anni ‘80 con l’acuirsi del
problema della droga, il Palazzone diventa “il maggior centro di spaccio dell’hinterland
milanese”: la sua conformazione a ferro di cavallo nasconde il cortile interno agli occhi della
strada e la recinzione appena costruita non permette alle forze dell’ordine di entrare
facilmente, tanto che l’area sembra quasi una “zona franca”. Gli abitanti del quartiere
decidono di rispondere alla situazione cominciando a tenere manifestazioni, concerti e mostre
all’interno del cortile;; si tratta quindi, di un’occupazione pacifica che serve da deterrente ai
traffici che avvengono ogni giorno.
“Se mettevamo il palco o venivano le bande c’era un sacco di casino,
magari non veniva sempre tanta gente ma sicuramente quelli non
potevano spacciare, gli davamo fastidio”(S.B.)
“Qualcuno era stato anche minacciato, dicevano”(S.B.)
L’ultima funzione si collega alla “questione stigma” che nello schema proposto sopra si
colloca tra le attivazioni consensuali dall’alto. Le feste, col tempo sono diventate la risposta
degli abitanti allo stigma che gravava sul quartiere, delle occasioni per poter mostrare alla
59
città e all’esterno, che sant’Eusebio non è solo il “ghetto” di Cinisello frequentato da
“balordi”:
“Sant’Eusebio non è per forza un covo di criminali, siamo gente
perbene…lavoriamo eh…poi certo che qualcuno che approfitta c’è, la
criminalità è un problema eh…però non si può dire che siamo tutti
uguali”(G.D.C)
Gli abitanti rivendicavano l’esistenza di un territorio vivo:
“si parlava sempre degli arresti e delle violenze, parlavano i
giornali…però gli articoli quando organizzavamo le feste o denunciavamo
i problemi del quartiere non li pubblicavano mai, mai una parola”(A.)
Le feste di quartiere sono nate come un’attivazione dal basso e si sono trasformate in una
questione trasversale che è difficile collocare in modo univoco nello schema. Partite dai
cittadini hanno finito per coinvolgere anche l’istituzione, anch’essa contraria all’immagine
degradante del quartiere che si andava formando. E’ difficile stabilire se si tratti di
mobilitazioni consensuali o conflittuali perché, se da un lato tutti i soggetti coinvolti
sembravano d’accordo nel promuovere questo tipo di eventi, dall’altro si andavano a
danneggiare coloro che dello spaccio e dell’illegalità ne vivevano.
Tra le mobilitazioni consensuali “dall’alto” ho inserito quegli episodi (come le petizioni e
le proteste contro la stigmatizzazione del quartiere) che, pur non provocando un conflitto tra
istituzione e abitanti, hanno dato vita ad azioni dei cittadini. E’ il caso scoppiato verso la fine
degli anni 80’ riguardante la ristrutturazione della chiesetta storica. C’era un sostanziale
accordo tra cittadinanza e rappresentanti comunali circa l’importanza dell’edificio e della sua
ristrutturazione ma l’amministrazione aveva fatto sapere che non sarebbe riuscita a farsi
carico delle spese. Passano alcuni anni in cui la situazione rimane in stallo, viene fatta una
valutazione dei danni e degli interventi strutturali necessari, la cifra necessaria per la
ristrutturazione ammonta a circa 500 milioni di lire.
Nel 2003, un fondo comune tra Regione, Provincia e Amministrazione Comunale
permette di iniziare la pensare all’intervento di ristrutturazione; i fondi destinati dalle
istituzioni, però, non bastano ed è fondamentale il contributo dei singoli abitanti del quartiere:
60
sollecitati dal parroco (Don Marcellino), molti cittadini decidono di fare un prestito per
sovvenzionare i lavori che verrà restituito col tempo una volta terminata la chiesa. Questa
iniziativa ha molto successo e si raggiunge ben presto il tetto prefissato, grazie anche ad
alcune associazioni del comune di Cinisello che offrono gratuitamente la manodopera la
chiesetta viene ultimata34.
Attraverso questi esempi si è definito con maggior chiarezza cosa si intende con la
classificazione sopracitata e con i suoi due assi. Questo secondo paragrafo ha trattato
brevemente alcune delle mobilitazioni che hanno avuto luogo nel quartiere senza però
scendere nello specifico; si è scelto di individuare tre attivazioni che sono state maggiormente
significative, sia per l’importanza che hanno nei ricordi degli intervistati sia perché hanno
coinvolto la quasi totalità del quartiere nelle sue varie realtà. Tra questi episodi rientrano il
dirottamento del pullman ATM e la protesta per l’ottenimento della fermata, l’episodio del
mercato “finto” creato dagli abitanti per rivendicare un vero mercato dentro il quartiere e il
Contratto di Quartiere con tutte le sue implicazioni. Essi verranno trattati e approfonditi nel
paragrafo III.
34 Periodico “La città”, 1989
61
3.3 Mobilitazioni e conflitti, alcuni approfondimenti
3.3.1 Entrare a far parte della città: la questione trasporti e il dirottamento del 1978
L’episodio del dirottamento del pullman di cui si è accennato nei capitoli precedenti ha
avuto luogo nel 1978. Siccome non è stato possibile trovare testimonianze scritte (giornali
locali, archivi comunali ecc.) che facciano esplicito riferimento all’accaduto, per le date e lo
svolgersi dei fatti ci si baserà esclusivamente sui racconti degli intervistati. Uno di loro, G.D. ,
è stato uno dei promotori dell’azione e si trovava fisicamente sul mezzo al momento del
dirottamento. Prima di arrivare al dirottamento del 78’ però bisogna fare qualche passo
indietro nella storia del quartiere arrivando addirittura negli anni che precedono la costruzione
del Palazzone, quando le poche case che si vedevano si trovavano lungo via Risorgimento o
nella nuova via del Carroccio.
All’inizio degli anni ’70 le case IACP di via del Carroccio35 erano state ultimate da quasi
tre anni e ospitavano già alcune centinaia di persone; a quel tempo il quartiere praticamente
non esisteva ancora e non c’erano mezzi in grado di raggiungere il centro…il pullman partiva
da p.za Costa, appena prima della piazza centrale. Non si può parlare di un singolo
“dirottamento” perché le richieste di prolungare la corsa fino alla zona di Borgomisto e
Sant’Eusebio erano molto frequenti; molti dei giovani del quartiere, approfittando delle corse
serali meno frequentate erano soliti chiedere “con le buone o con le cattive” che il pullman li
portasse fino ai confini della cittadina. L’episodio che ha avuto più impatto mediatico è quello
che ha visto la partecipazione di alcuni militanti dell’organizzazione extraparlamentare Lotta
Continua;; l’organizzazione era in quegli anni molto attiva nella zona 4, forte dell’appoggio
delle famiglie operaie che si stavano insediando nelle case popolari mettono in atto il primo
dirottamento del pullman che porta il mezzo fino all’interno della zona 4. Questa prima
azione ha come risultato il prolungamento della linea dalla fermata di p.za Costa alla fermata
di via Cilea 30, davanti alla sede della Polizia di Stato.
L’episodio avviene nel qualche anno prima che si iniziasse la costruzione del caseggiato
GESCAL e fa si che il dirottamento del 1978 non abbia nulla a che fare col primo. Le persone
intervistate circa il secondo episodio spesso confondono i due momenti e li sovrappongono,
oppure non ne conoscono la distinzione. Nonostante ciò, l’avvenimento più presente nei
35 I numeri 20 e 21.
62
ricordi degli abitanti è quello avvenuto dopo l’insediamento nel Palazzone, quando il
quartiere ha cominciato a riempirsi e ad avere una propria identità, ed è per questo che
l’approfondimento riguarda il secondo dirottamento.
Nei mesi che precedono l’azione ha luogo un dibattito tra abitanti e amministrazione che
si svolge durante le assemblee di circoscrizione: il Comune dice di aver già effettuato un
prolungamento della linea e che ogni ulteriore modifica richiede dei permessi provinciali e
una richiesta formale all’ATM, cosa che non farà perché si tratta di un tragitto breve e poco
importante. I cittadini rispondono che il quartiere sta diventando sempre più grande e il
Palazzone, ormai ultimato, è stato completamente occupato portando a un aumento della
popolazione residente di circa 1800 unità in meno di un anno: la maggior parte di queste
persone, spiegano gli abitanti, lavora nelle fabbriche di Sesto San Giovanni ed è costretta a
muoversi tutte le mattine a piedi per il tratto che separa i caseggiati del quartiere dalla fermata
più vicina. Un altro problema era la cattiva condizione stradale: mancavano i marciapiedi e un
vero ciglio della strada tanto che il tragitto a piedi diventava spesso una camminata nel fango.
“Abbiamo fatto tante riunioni…le assemblee al consiglio di
circoscrizione, ma non si concludeva nulla…in Comune dicevano che
modificare il percorso di una linea ATM era un’operazione complessa che
al momento non potevano fare”
Le assemblee continuano ma non si riesce a trovare una soluzione… “Non capivamo
perché un prolungamento di un chilometro o due su una linea che già esisteva poteva essere
un problema” spiega G. D. L’amministrazione comunale, di fronte all’insistenza degli
abitanti che nonostante i continui rifiuti non è venuta a mancare, cambia strategia deputando il
mancato prolungamento della linea non più a problemi burocratici ma a un’imprecisata
direttiva dell’ATM stessa. Gli autisti, ribattono i rappresentanti comunali, hanno paura di
entrare nel quartiere perché la linea prevedrebbe anche un servizio notturno…visti i numerosi
casi di vandalismo e microcriminalità nel quartiere, soprattutto dopo la costruzione del
Palazzone, non sono disposti a rischiare l’incolumità dei propri dipendenti per garantire il
servizio.
“..era offensivo dire che qua si aveva paura ad entrare perché eravamo
gente che lavorava, padri di famiglia..”
63
Davanti ai rifiuti del Comune, alcuni inquilini del Palazzone decidono che è necessaria
un’azione forte per convincere l’istituzione ad agire: si decide di “dirottare” il pullman ATM
che ha il capolinea alla fermata di via Cile. L’azione è organizzata nel cortile del caseggiato
con modalità molto poco strutturate: non c’è un’assemblea vera e propria ma l’idea del
dirottamento emerge dai continui incontri degli inquilini nei pressi del Palazzone (gli operai,
quasi esclusivamente uomini, che si ritrovavano nel cortile alla fine dell’orario di lavoro). Si
decide di dividersi in due gruppi distinti, il primo che salirà sul pullman alla penultima
fermata e il secondo che salirà una volta raggiunto il capolinea di via Cilea.
Il pomeriggio del dirottamento tutto procede bene: il primo gruppo di una quindicina di
persone sale sul pullman e lo occupa completamente…una volta arrivati al capolinea un
secondo gruppo più ristretto sale e chiede al conducente di portare il pullman davanti al
Palazzone.
“Gli ho detto <<Senti guarda che oggi succede questo. Evita di fare
scenate perché non c’entri niente…basta che ci porti fino a là in fondo e
siamo tutti contenti>> Non volevamo far male a nessuno ma bisognava
usare toni forti che se no quello chiamava la polizia…che infatti stava li a
un passo”(G.D.)
Dopo pochi attimi di tensione l’autista accetta di prolungare la corsa fino al caseggiato
GESCAL. I manifestanti ordinano all’autista di avvisare il deposito dell’avvenuto
dirottamento e in pochissimo tempo davanti al Palazzone si dispiegano le forze dell’ordine.
“Dopo due minuti erano arrivati lì tutte le forze di Cinisello, Sesto e
Monza! Non ti dico cosa c’era qui davanti[ in via A. da Giussano, di fronte
al Palazzone]”(G.D.)
I manifestanti scendono dal pullman mentre nel frattempo, sotto il Palazzone, sono arrivate
altre persone, incuriosite dall’accaduto. Dopo poco arriva anche il Sindaco che prova a
dialogare con i manifestanti ma la situazione si è già scaldata e cominciano ad arrivare le
prime manganellate. Il Sindaco Cerquetti decide di dare la sua parola affinché la fermata
venga costruita dove richiedono gli abitanti e dopo poco tempo la manifestazione si disperde
senza ulteriori tensioni. Il primo cittadino riconosce che l’assenza dei servizi di base a
64
Sant’Eusebio è un problema importante e centrale se si vuole evitare che situazioni di questo
tipo possano ripetersi…
“Tutti quanti qua, senza servizi, senza niente…è una polveriera”(L.)
La soluzione, infatti, arriva in fretta…dopo qualche giorno, e siamo nel giugno 1978, viene
disposto il prolungamento della linea fino alla fermata che esiste ancora oggi: il capolinea
della 728 è situato in via A. da Giussano 5 tra il Palazzone e le Cinque Torri.
Dall’analisi della mobilitazione emerge, prima di tutto, l’esistenza di nuovi spazi
decisionali che si slegano o agiscono parallelamente alle realtà che sono state considerate
finora. Le “riunioni di cortile” in cui si organizza l’azione del dirottamento non sono ancora il
Comitato Inquilini, che negli anni successivi sarà il portatore naturale delle istanze del
caseggiato nonché l’interlocutore principale dell’amministrazione, ma una realtà autonoma. In
verità non è corretto parlare di riunioni intendendo con questo termine delle assemblee
convocate per uno scopo che prendevano decisioni in merito perché un’organizzazione di
questo tipo non esisteva. Nello stesso modo in cui ci si incontrava al bar per bere qualcosa, ci
si incontrava in cortile per chiacchierare.
“Eravamo li ognuno per conto suo, un po’ per caso…si chiacchierava e
veniva fuori che eravamo tutti incazzati per ‘sta cosa…e poi io ho detto una
bella cosa << E se andiamo a sequestrare il pullman e lo portiamo
qua?>>”(G.D.)
Anche se le informazioni su queste riunioni informali sono scarse, sembra che alcuni dei
partecipanti fossero quelli che successivamente avrebbero dato vita al C.I. e sostenuto le sue
battaglie. Questi incontri, dunque, possono essere considerati una sorta di base per la
costruzione di un soggetto più strutturato che avrebbe preso forma negli anni seguenti: le
“riunioni di cortile” hanno fatto si che si sviluppasse una discussione attorno ai temi del
quartiere, che gli inquilini e gli abitanti iniziassero a pensare come agire per valorizzare e
migliorare il proprio territorio.
65
3.3.2 La domanda di servizi e occasioni di socialità, il caso del mercato “finto”
Alla fine degli anni 80’ si ripropongono le questioni riguardanti i servizi di base che
ancora mancano nel quartiere. Durante l’ultimo decennio è aumentata esponenzialmente
l’edilizia ad opera delle cooperative e il quartiere è cresciuto in dimensioni accogliendo un
numero sempre maggiore di persone. Praticamente al centro del quartiere viene costruito un
piccolo supermercato che dovrebbe supplire alle esigenze dei caseggiati circostanti che però
gli abitanti non ritengono sufficiente e sono costretti a spostarsi in altre zone della città.
“Quello che era una volta la Despar e oggi è il Punto Simply non lo
vedevano molto bene perché per loro[gli abitanti] era solo un
negozio”(C.P.)
Probabilmente, essendo il quartiere costituito da immigrazione proveniente da contesti di
paese, gli abitanti vedevano nel mercato non solo un luogo dove fare acquisti (come potevano
essere i negozi) ma anche un’occasione di socialità e di incontro. L’esigenza viene espressa
inizialmente dal Comitato Inquilini36 del palazzone che come già precisato era il luogo in cui
già da tempo esisteva un’idea dell’attività politica e sociale che trascinava, oltre agli inquilini
anche il resto degli abitanti (5 torri e altre case popolari). Hanno luogo una serie di incontri tra
il CI e l’amministrazione comunale e di assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza in cui si
chiede espressamente l’istituzione di un mercato rionale nel territorio di sant’Eusebio che
fosse accessibile agli abitanti. Si propone di utilizzare il grosso parcheggio antistante al
palazzetto che ospita la polisportiva, affacciato su via Cilea.
Il comune, nelle figure del sindaco Pozzi e dell’assessore al commercio Di Biase, è restio
a promettere l’arrivo del mercato e spiega le sue motivazioni: il mercato creerebbe oltre al
disagio e al probabile congestionamento del traffico nell’area coinvolta, anche situazioni di
degrado e sporcizia la cui pulizia sarebbe di competenza comunale, che spiegano, non ci si
può permettere;; la questione dell’igiene poi, spiegano, può essere risolta costruendo un
mercato coperto che però non può essere ubicato a sant’Eusebio. Inoltre il comune lamenta la
difficoltà a trovare dei privati interessati a fare il marcato perché la cattiva reputazione di cui
gode il quartiere in quegli anni (siamo nel periodo in cui la questione della droga è all’ordine
36 Da qui in poi CI.
66
del giorno, e con essa il problema della criminalità) sono da deterrente e non è possibile
istituire un mercato che non abbia una varietà merceologica adeguata per questioni legislative.
“il comune diceva che non si trovava nessuno che voleva venire a fare il
mercato da noi perché avevano paura, e anche se si trovavano non si
poteva fare un mercato solo di alimenti o di vestiti perché c’erano delle
leggi particolari”(C.P.)
Probabilmente, tra le motivazioni omesse c’erano questioni economiche riguardo allo
sfruttamento dei terreni ancora liberi sia nel quartiere sia fuori. L’inizio degli anni 90 coincide
con la comparsa dei primi centri commerciali e parecchie amministrazioni si trovavano di
fronte alla scelta di dover destinare alcuni spazi, solitamente esterni alla città alla costruzione
di questi. In un contesto come questo la creazione di un nuovo mercato poteva sembrare
anacronistica e poco lungimirante visti i profitti che avrebbero potuto generare i centri
commerciali.
“Ci si sentiva un po’ presi in giro da queste motivazioni”(C.P.)
Durante gli incontri i rappresentanti del comitato inquilini “danno battaglia”
all’amministrazione chiedendo che venga rispettata la volontà del quartiere e che si faccia di
tutto affinché anche Sant’Eusebio possa avere il suo mercato.
“Chiedevamo conto dei voti che avevano preso da NOI ”(C.P.)
Dopo qualche tempo, nel gennaio del 1990, il comitato inquilini decide che è necessario
pensare a un’azione che possa smuovere le acque visto l’immobilismo del consiglio comunale
e i continui rinvii della Giunta. Inizialmente si pensa di presidiare le sedute del Consiglio
comunale e, cercando di acquisire un po’ di visibilità tramite i giornali cittadini, far si che la
richiesta del quartiere venga accolta. Dopo alcune discussioni sull’utilizzo di questa modalità
che a parecchi sembrava ormai inutile visto che la partecipazione si faceva sempre più scarsa
e la gente stava perdendo interesse si decide di cambiare completamente approccio.
67
“Mi ricordo ancora quando quella signora, P. F. è venuta fuori dicendo
<< Ma perché non ci facciamo invece un bel scherzo a
quest’amministrazione qua? Il mercato ce lo facciamo noi da soli>>… e
noi, che all’inizio non avevamo capito, le dicevamo che era pericoloso,
che avremmo preso delle multe, che non era il caso di far arrivare i
caramba e prendersi una denuncia per ‘sta roba”(C.P.)
Si fa strada l’idea di uno scherzo, un mercato senza vere merci ma con prodotti di cartapesta e
bancarelle finte che viene subito accolta dai partecipanti al comitato. Si incomincia ad
organizzarsi cercando di preparare tutto per far coincidere la giornata con l’imminente
carnevale. Il comitato inquilini coinvolge alcune famiglie nella realizzazione delle bancarelle
che procede per tutto gennaio mentre altre persone si occupano di attaccare manifesti per il
quartiere. L’invito che vi si leggeva sopra, parlava della “grande inaugurazione” del mercato
di Sant’Eusebio a cui avrebbero presenziato sia il sindaco che gli assessori.
La manifestazione è organizzata per un sabato di febbraio (1990) nel parcheggio davanti
al campo da calcio in via Cilea, il luogo che per i richiedenti sarebbe stato il più adatto a
ospitare il mercato. Anche la scelta della data è importante, primo perché il sabato era il
giorno che si proponeva per istituire il mercato rionale visto che a Cinisello mancava proprio
quel giorno, secondo perché per il lunedì successivo era previsto un consiglio comunale. Fin
dalle prime ore della mattina cominciano ad arrivare parecchie persone, tutte convinte dagli
annunci e tutte in attesa di fare la spesa; i rappresentanti del comitato, ognuno dietro una delle
bancarelle finte, cominciano a spiegare ai passanti e ai curiosi quali siano le motivazioni dello
scherzo e quali le richieste che si facevano al comune con questo gesto. In breve la piazza si
trasforma in un assemblea aperta che ospita quasi trecento persone, si discute, ci si confronta
e si spiega agli abitanti del quartiere perché il mercato è un luogo tanto importante per il
territorio. Le forze dell’ordine non tardano ad arrivare, seguite dopo breve tempo anche
dall’assessore Di Biase;; incominciano a discutere con gli organizzatori intimando di
sgomberare l’area e lamentandosi per l’utilizzo di tali modalità di protesta che potrebbero
trasformarsi in problemi di ordine pubblico. In quegli istanti gli organizzatori annunciano
l’arrivo del sindaco e viene allestito un piccolo spazio provvisto di microfono per ascoltare il
primo cittadino. Tutta la piazza rimane di stucco quando dalla macchina preparata per
l’occasione esce un membro del comitato, vestito in tutto e per tutto da sindaco. Il discorso
del sindaco finto è l’occasione per spiegare nuovamente le ragioni della protesta:
68
“eravamo consapevoli che ottenere il mercato non era semplice e che la
situazione non poteva dipendere solo dal comune, ma chiedevamo che
almeno si muovessero, che si dessero una mossa senza scuse…perché
sapevano bene che i voti li prendevano, da noi…”(C.P.)
Dopo il breve discorso del “sindaco” la manifestazione si scioglie e ci si da appuntamento alle
successive assemblee.
“ci hanno applaudito, c’è stato un applauso ed è finita li…fortunatamente
non si è arrabbiato nessuno”(C.P.)
Il lunedì successivo è previsto un Consiglio Comunale: durante le interrogazioni che
precedono l’ordine del giorno, il capogruppo del PSI, Sergio Torsani fa presente
all’assemblea che c’è stata questa manifestazione. Torsani riconosce la valenza positiva del
gesto, l’originalità della protesta e l’alto senso civico dei partecipanti che sono riusciti a
trasformare in festa una rivendicazione che poteva essere un semplice presidio. Oltre al
mercato in sé infatti, la manifestazione è stata la prova che il mercato, come rivendicavano gli
abitanti, può realmente diventare un’occasione di socialità e di incontro. Quella stessa sera
viene messa all’ordine del giorno la delibera del Consiglio Comunale per l’istituzione di un
mercato rionale nel territorio della circoscrizione 4, la zona di Sant’Eusebio;; l’area proposta è
quella indicata nei mesi precedenti dai cittadini. Dopo qualche mese (tra maggio e giugno
1990) il mercato arriva a Sant’Eusebio.
La vicenda, che ha avuto molta eco sui giornali locali dell’epoca, ha visto contrapporsi il
comitato inquilini all’amministrazione in una contesa che si è giocata quasi totalmente sul
piano mediatico. Non si è arrivati a una fase critica nella quale l’amministrazione ha dovuto
cedere per uscire da una situazione conflittuale come può essere una manifestazione o un
presidio ma il tutto si è svolto in modo pacifico e quasi seguendo il suo corso naturale. Gli
abitanti si sono resi conto che “prendere in giro” l’amministrazione della quale sono sempre
stati considerati il bacino elettorale naturale avrebbe avuto un effetto più significativo di
un’azione diretta.
69
3.3.3 Il Contratto di Quartiere “Sant’Eusebio”
L’esperienza del Contratto di Quartiere nasce come strumento di intervento in un’area da
tempo considerata una delle più problematiche della città; una situazione di degrado edilizio e
urbanistico, l’assenza e/o il malfunzionamento dell’impianto dei servizi, la mancanza di
iniziativa d’impresa ecc. alimentano un alto grado di marginalità sociale.
Per i promotori si trattava di ripensare un quartiere nel quale si concentrava l’80% degli
edifici di edilizia residenziale popolare37 rispetto all’intero territorio di Cinisello Balsamo. Si
avverte l’esigenza di una forma di intervento nuova, almeno per l’epoca, che focalizzi la sua
attenzione, oltre che sui contenuti specifici, anche sulla creazione di un “processo strutturato
di partecipazione” (Pasqui et al. 2004). I Contratti di Quartiere, infatti, prendono il via nel
1998 su iniziativa del Ministero dei Lavori Pubblici con l’intento dichiarato di “ innescare,
con particolare riferimento agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, processi di
trasformazione di quegli ambiti trascurati, per lo scarso interesse degli operatori immobiliari,
da operazioni di ristrutturazione urbanistica, sovrapponendo agli interventi edilizio-
urbanistici misure orientate all'incremento occupazionale e alla riduzione del disagio
sociale”38 ma con la consapevolezza che il coinvolgimento degli abitanti e la loro
partecipazione attiva nella riqualificazione era indispensabile alla riuscita del progetto. Nel
1999, il Comune di Cinisello Balsamo è uno dei primi a beneficiare dei fondi stanziati dal
Ministero a favore del CDQ, si tratta di circa 17 miliardi di lire a cui si aggiunge un
finanziamento ALER (7 miliardi), un contributo da parte dell’amministrazione comunale (3,4
miliardi) e un contributo regionale (1,2 miliardi) per un totale di quasi 30 miliardi di lire.
Il progetto si struttura su 4 assi: miglioramento delle condizioni fisiche degli alloggi,
progettazione inserimento di servizi con funzioni di carattere sociale, localizzazione di
laboratori per attività artigianali al fine di favorire l’avvio di nuove imprese, coinvolgimento
degli abitanti e miglioramento dell’immagine del quartiere (Armondi et al. 2008). Questa
traccia, formulata secondo i parametri e i vincoli dettati dal bando ministeriale, è quella che
viene proposta in prima istanza ai cittadini e alle realtà del territorio che diventano così i
37 “Nel quartiere S.Eusebio si concentra l’80% dell’edilizia residenziale pubblica della città. Infatti degli 800 alloggi di proprietà Aler, 650 sono collocati qui, così come dei 300 alloggi comunali, 235 sono ubicati nel quartiere.” http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/ 38 http://www.mit.gov.it/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Contratti di Quartiere.
70
primi firmatari del CDQ39. Nonostante “coinvolgimento” e partecipazione” fossero tra le
parole chiave del progetto, la tempistica molto ristretta a cui era necessario adattarsi per
vincere il bando fa in modo che la discussione dello stesso con gli abitanti e i soggetti locali
sia quasi inesistente. La scelta, poi, di considerare le realtà esistenti sul territorio come
singolarità operanti ognuno su binari diversi ha causato nelle fasi successive diversi conflitti
tra gli abitanti del quartiere, tra chi avesse firmato e chi invece si era rifiutato; tutto ciò però
non teneva conto del fatto che ogni realtà, ogni soggetto e ogni associazione era stata
interpellata (e poco) su singoli aspetti dell’intervento e non sull’interno progetto. Bisogna
però sottolineare che senza l’attivismo e la “lungimiranza” della già citata Sindaca Gasparini
non ci sarebbe stato nessun finanziamento: l’aver ristretto i tempi e aggirato le lungaggini
burocratiche è ciò che ha permesso al comune di Cinisello di rientrare tra i 46 vincitori del
bando (Armondi et al. 2008), pur con un progetto che almeno nella fase iniziale aveva ben
poco di partecipativo.
Superata questa fase iniziale, il Comune comincia ad individuare i soggetti deputati ad
occuparsi del CDQ. Esistono due differenzi opzioni percorribili dall’amministrazione che
partono da presupposti diversi e sottendono un’idea diversa del rapporto amministrazione-
cittadini: la prima prevede di affidare il progetto agli uffici comunali competenti secondo
un’organizzazione più centralizzata mentre la seconda opta per un ufficio istituito ad-hoc che
abbia il CDQ come unico impegno. La scelta ricade sulla seconda opzione, ci permette di
slegare il CDQ dall’essere un progetto “del Comune”, un qualcosa di altro e di estraneo al
quartiere che ha una sua autonomia. Questa scelta ha almeno due conseguenze sul piano
dell’efficacia complessiva dell’intervento, se da un lato l’esistenza di una task force permette
di proporre un’organizzazione molto centrata sull’obiettivo e sulle sue implicazioni pratiche
(Armondi et al. 2008), dall’altro la mancanza di una legittimazione chiara agli occhi degli
abitanti può porre alcuni limiti; inoltre la forte centratura sul risultato è uno dei motivi che
hanno reso il CDQ molto meno incisivo sul lungo periodo, come si vedrà più avanti.
Individuato il gruppo organizzativo si procede a definire con più precisione gli interventi che,
come già detto, si suddividono sui quattro assi.
39 Amministrazione Comunale di Cinisello B., Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, Regione Lombardia, Ministero dei Lavori Pubblici - CER, CNA, Agenzia Sviluppo Nord Milano, Agesci, Amici del Grugnotorto, Comitato Inquilini Sant'Eusebio, Circoscrizione 4, Cooperativa Il Torpedone, Cooperativa Sammamet, Croce Rossa Italiana, Gruppo Accoglienza Disabili (Gad), Movimento Anti-droga Rione S. Eusebio (Marse), Parrocchia, Si.ce.t (sindacato inquilini).
71
Per la parte relativa alla riqualificazione viene pensato un piano mobilità, un programma
che consenta lo spostamento degli inquilini per scale affiche possano partire gli interventi
manutentivi leggeri (messa a norma degli impianti, migliorie negli spazi comuni ecc.) e quelli
“pesanti” di frazionamento degli alloggi più ampi. Parallelamente viene attivato un tavolo a
cui partecipano Aler, Comune e Commissariato per far fronte alle situazioni di illegalità e
trovare una soluzione ai numerosi casi di morosità. Sul versante dell’inserimento dei servizi
viene proposta la costruzione di alcuni spazi ad uso sociale all’interno del Palazzone, in
particolare: uno spazio interno alla struttura destinato alla neonata Associazione Inquilini e al
SICET, uno spazio destinato ad ospitare una nuova “portineria sociale”, uno spazio ricavato
dai frazionamenti riservato per una comunità alloggio per anziani non autosufficienti e un
nuovo edificio esterno collocato nel cortile del complesso e affacciato su via A. da Giussano
che in qualità di Centro Polifunzionale avrebbe accolto una serie di servizi e iniziative assenti
nel quartiere (centro per le famiglie, attività per i giovani, sportello postale e centro socio-
sanitario). Lungo il terzo asse si collocano gli interventi tesi a promuovere lo sviluppo di
nuove imprese: utilizzando gli spazi già previsti per il centro Polifunzionale si prevede
l’attivazione di laboratori artigianali che sfruttino le competenze e l’esperienza degli attori
locali. Lungo il quarto e ultimo asse, infine, si trovano le azioni di coinvolgimento degli
abitanti: dai questionari agli inquilini alle riunioni di scala, dalla rivista “Ci riguarda” alle
feste e gli incontri pubblici. Durante questa fase di ridefinizione del progetto in cui il gruppo
di coordinamento (composto da Aler, Comune e consulenti esterni facenti parte dell’Ufficio
CDQ) incomincia a incontrare gli inquilini nascono i primi conflitti. In questo caso, a
differenza delle mobilitazioni citate precedentemente la situazione conflittuale coinvolge
diversi attori e non si risolve in una discussione tra istituzione da una parte e abitanti
dall’altra. Il fulcro della disputa è, inizialmente, un problema di rappresentatività: alla prima
riunione nella quale viene presentato il progetto emerge che una buona parte dell’inquilinato
È totalmente in disaccordo con l’idea di base che era stata presentata al bando, soprattutto
per la parte riguardante il piano mobilità. Nonostante il Comitato Inquilini fosse tra i firmatari
del progetto iniziale, la maggior parte degli inquilini non ne è a conoscenza e si oppone
categoricamente al piano mobilità. Bricocoli, architetto del gruppo di coordinamento, in un
articolo pubblicato successivamente, scrive:
72
“[All’inizio della riunione] Racconto: il programma ministeriale[…]gli obiettivi
generali di intervento sul quartiere […] gli interventi di manutenzione ordinaria e,
infine, aiutandomi con una sezione della scala in cui abitano i presenti, gli
interventi di frazionamento sugli alloggi.” (Bricocoli 2002, 2)
“Poi, dopo l’illustrazione del progetto: fuoco e fiamme, il caos. In un attimo il
clima si surriscalda, la gente urla, si sovrappongono gli interventi.” (Bricocoli
2002, 2)
Il clima di scontro si ritrova anche nei racconti degli intervistati:
“…per noi quella gente li non esisteva, e quindi l'abbiamo attaccata[le
istituzioni, il sindaco] l'abbiamo messa a conoscenza della drammaticità
del[la situazione nel] quartiere” (P.D.C.)
Quella firma, che il CI ha messo sul CDQ viene vista dagli altri abitanti coinvolti come un
“tradimento”:
“quando il comitato inquilini, c'ero dentro anche io ma poi sono uscita, ha
firmato la proposta del comune, l'inquilinato si è chiesto: come avete
potuto mettere una firma su quello che ci stanno proponendo?”
Da questo momento il CI viene associato all’amministrazione e viene accusato, assieme
agli altri firmatari, di aver incentivato e permesso che un progetto di queste dimensioni
venisse approvato senza il parere dell’inquilinato. P. D.C, abitante del Palazzone, promuove
una raccolta di firme per opporsi al CI e dare voce a coloro che criticano il progetto:
“io faccio una raccolta di firme, facciamo una petizione contro questo
progetto che era stato imposto”
“ci siamo messi contro tutti gli altri firmatari, e l'inquilinato ha dato fiducia
a noi”
Dall’altra parte, i rappresentanti del CI lamentano il comportamento scorretto
dell’amministrazione che aveva posto il piano mobilità come condicio sine qua non affinché
il CDQ partisse mettendoli nella scomoda posizione di dover accettare a scatola chiusa
73
l’intero progetto. Al momento della presentazione sembrava che il CI avesse contribuito
attivamente alle scelte e supportasse l’amministrazione anche se, come già visto, la fase
iniziale aveva coinvolto solo marginalmente i firmatari e mai sui contenuti specifici.
“Noi riportavamo semplicemente quello che le istituzioni ci dicevano, e
che poi però si sono rimangiati facendoci fare la figura delle cretine” (A.
& R.)
“…quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto in buonafede…” (A. & R.)
Le divisioni vengono superate quando il gruppo di coordinamento sceglie di adottare una
linea più morbida e accetta di rivedere il progetto iniziale per fare si che lo spostamento degli
inquilini scala per scala avvenga in maniera meno “traumatica”. Si sceglie di adottare un
piano mobilità “dolce” secondo un modello “a macchia di leopardo” che invece di svuotare
contemporaneamente intere scale permette di trasferire un numero limitato di nuclei
famigliari via via resisi disponibili degli appartamenti già ristrutturati nello stesso Palazzone
(Armondi et al. , 2008).
Questa soluzione è frutto della mediazione operata dalle altre realtà coinvolte, dal
sindacato inquilini alla parrocchia e alle associazioni di quartiere senza però dimenticare che
le azioni di avvicinamento messe in atto da gruppo di coordinamento hanno giocato un ruolo
fondamentale. I “geometri del Comune” (Bricocoli, 2002), infatti, incominciano a girare casa
per casa per spiegare il progetto alle singole famiglie ascoltando le loro questioni e le loro
istanze: in questo modo si riesce a trovare in molti casi un terreno d’incontro fertile che
permette di stabilire un rapporto di fiducia tra gli inquilini e i responsabili del CDQ. Questo
rapporto di fiducia congiuntamente con la strategia del gruppo di coordinamento di
considerare singolarmente le situazioni dei nuclei familiari permette al progetto di iniziare e
successivamente di ridurre sensibilmente i casi di abusivismo e morosità (alcune famiglie
decidono spontaneamente di recuperare i pagamenti mancati).
Con il procedere del progetto si presenta un secondo problema: gli inquilini del
Palazzone non sono d’accordo circa la collocazione del nuovo edificio destinato ad ospitare il
centro Polifunzionale. Tra le motivazioni del rifiuto c’è la preoccupazione che uno spazio
aperto al pubblico all’interno del cortile possa essere un problema di sicurezza perché, come
si afferma durante e riunioni “non si sapeva chi entrava se stava tutto aperto”. Inoltre gli
74
inquilini contrari, che dopo l’episodio del piano mobilità si sono costituiti in associazione
(Associazione Inquilini) staccandosi dal CI, lamentano la mancanza di spazi verdi e di aree
destinate ai bambini: il Centro Polifunzionale occuperebbe tutta l’area interna al “ferro di
cavallo” del Palazzone saturando completamente gli spazi.
D’altra parte il Comune ribatte che il Centro, se costruito all’interno del Palazzone, possa
aumentare la sua efficacia perché creerebbe aggregazione, occuperebbe un’area degradata e
fornirebbe a molti un motivo per recarsi a Sant’Eusebio. Tra le motivazioni omesse c’era
probabilmente un’esigenza di controllo: una struttura pubblica all’interno di un cortile che,
dalla costruzione della recinzione era diventato suolo privato e quindi più difficilmente
penetrabile dalle forze dell’ordine. L’opposizione dell’associazione in questo caso è molto
forte e l’amministrazione alla fine si fa carico di rivedere il progetto originale presentandone i
cambiamenti al Ministero: il Centro Polifunzionale viene costruito al di fuori del cortile,
sempre in via A. da Giussano ma di fianco al Palazzone. Con lo spostamento del Centro
Polifunzionale si esaurisce la fase conflittuale relativa al progetto, gli interventi strutturali
vengono ultimati e il CDQ I si conclude.
Sul versante dei rapporti tra le realtà operanti sul territorio la situazione iniziale ha subito
modifiche importanti: il CI che per parecchi anni era stato il “centro operativo” del quartiere
perde buona parte della sua rappresentatività, nasce l’Associazione Inquilini come alternativa
ai rappresentanti del comitato e diventa l’interlocutore naturale dell’amministrazione. Con la
“fine” del CI escono di scena, o vengono ridimensionati, alcuni soggetti che durante le
mobilitazioni raccontate nei paragrafi precedenti erano state il fulcro dell’attivismo di
quartiere. Non è un avvicendamento conflittuale, se non nella fase iniziale del CDQ, ma più
che altro un “passo indietro” da parte di coloro che per troppi anni erano stati al centro di
quasi tutti gli avvenimenti centrali.
“Un po’ mi ero stancato…che facciano un po’ anche gli altri” (C.P.)
La forma che sostituisce il CI è però costituita formalmente in associazione e allo scadere
del mandato del primo presidente è necessario eleggere una figura sostitutiva. La
presidentessa uscente, Pina Del Conte si candida nuovamente come rappresentante ma il
risultato delle elezioni premia il nuovo candidato Domenico Dal Pianta. In disaccordo con il
75
risultato delle elezioni, la signora Dal Conte esce dall’Associazione Inquilini e dà vita a una
nuova realtà, il Forum Sant’Eusebio.
Anche se non c’è nessuna appartenenza politica dichiarata, molti degli intervistati
reputano che la scissione sia stata causata da divergenze sul piano politico: si ritiene che
l’Associazione Inquilini sia attualmente legata alla destra mentre il Forum sia in qualche
modo connesso all’amministrazione comunale di sinistra. Questa separazione, che permane
tutt’oggi, è stata causa di nuovi contrasti circa l’utilizzo dello spazio destinato al Centro
Civico del Palazzone. Aler, dopo aver ricevuto molte lamentele da entrambe le parti che
denunciavano l’uso improprio dello spazio, ha deciso di chiuderlo fino a che non si troverà un
accordo sulla gestione.
76
Conclusioni
Per concludere il discorso sul quartiere sant’Eusebio si è scelto di individuare tre
questioni fondamentali trattate nel corso dell’elaborato cercando di rapportarle al territorio
preso in esame: le attivazioni “dal basso”, un confronto tra esse e le politiche pubbliche e una
valutazione dell’efficacia della partecipazione come strumento d’intervento.
Prima di approfondire la tematica delle mobilitazioni informali è bene chiedersi quali
siano le premesse che hanno consentito la nascita di questo tipo di azioni. Su cosa si basano
queste esperienze? Chi le sostiene? Si può chiamarla comunità?
Se per comunità si intende un luogo in cui prevale la presenza di legami primari, relazioni
solide che esulano dal contesto famigliare arrivando a comprendere una parte più ampia del
territorio in cui si vive e abita, Sant’Eusebio non può non essere considerato un quartiere dove
il concetto di comunità funziona. Tra i fattori che concorrono alla formazione di una comunità
c’è certamente l’alto grado di omogeneità sociale tra gli abitanti che caratterizza tutta la prima
fase di crescita del quartiere. Negli anni di espansione demografica del Comune si è scelto di
destinare l’area a nord della città a spazio di contenimento per tutte le situazioni di disagio e
rischio povertà, e questo ha fatto si che si concentrasse in uno spazio relativamente ristretto,
un gruppo di persone che condividevano diversi aspetti della loro vita. La provenienza
regionale dal Sud Italia, l’altissima percentuale di operai, la presenza di famiglie numerose e
la comunanza di tradizioni40 hanno fatto si che gli abitanti si trovassero tutti di fronte a
problematiche ed esigenze simili e scoprissero gli uni negli altri la legittimazione per portare
avanti le battaglie. Certo, non si può dire che la comunità sia nata come conseguenza naturale
dell’essere lì, stipati nei palazzoni Aler con poche possibilità di uscita e integrazione con il
resto della città;; il merito va attribuito anche all’azione di alcune figure catalizzatrici che
hanno posto le basi per l’avvicinamento tra gli abitanti e una progressiva presa di coscienza
della propria condizione fino a una consapevolezza del proprio potere. Fondamentale è stata
l’azione della parrocchia, della scuola popolare, dei comitati e dei rappresentanti di ognuna di
queste realtà perché hanno saputo fare del quartiere l’oggetto d’interesse degli abitanti e
quindi della comunità. La necessità di fare “fronte comune” nelle rivendicazioni ha fatto si
che si trovasse una sintesi tra appartenenze diverse. Alle assemblee, infatti, partecipavano
40 Cfr. Cap. II
77
persone che sono riuscite a trovare un punto d’incontro nell’occuparsi dei problemi concreti
del quartiere. “Non si discuteva di politica, si faceva politica” spiega un intervistato, “perché
l’importante era FARE”, arrivare alle persone dove l’istituzione mancava, creare delle reti di
sostegno, in poche parole, costruire il quartiere. Un pensiero di un intervistato esemplifica al
meglio il clima che si respirava e che per alcuni versi si respira ancora a Sant’Eusebio:
“[…] Il problema di ognuno diventava il problema di tutti, la soluzione
di ognuno diventava la soluzione di tutti…perché poi comunque queste cose
sono concatenate…eravamo tutti in questo indirizzo, tutti in questa modalità
di…idea (…) e comunque anche oggi funziona, c’è…non è come prima, se
ne facevano di più eh però siamo un po’ diversi dagli altri quartieri…qui la
gente rispondeva e risponde ancora”
L’esistenza dei caratteri fondamentali della comunità si somma ai fattori che hanno
stimolato e suscitato le mobilitazioni di cui si è trattato nel capitolo III. Ripensando a Dolci e
alle modalità con cui si sono svolte le azioni di cui è stato protagonista, si ritrovano a
Sant’Eusebio alcune analogie. Il carattere essenzialmente non violento delle attivazioni e la
ricerca di modalità creative per le proteste, come accade ad esempio nel caso del mercato,
sono temi che pongono l’esperienza di Sant’Eusebio in continuità rispetto a quella siciliana.
Le mobilitazioni, infatti, hanno avuto il pregio di avviare discussioni su temi che non erano in
discussione portando nell’arena decisionale questioni che ne erano state escluse per i motivi
più vari. Come a Partinico, la voce tornava agli abitanti, gli “ultimi” che cercano di far valere
un punto di vista e un territorio considerato “marginale”. Ciò che si rivendicava era la
possibilità di avere voce in capitolo nelle scelte che riguardavano il quartiere non solo come
soggetti passivi chiamati a esprimere una preferenza sull’operato dell’amministrazione ma
come parte attiva e centrale.
Sant’Eusebio ha rivendicato per anni il proprio status di quartiere come soggetto facente
parte a tutti gli effetti della città di Cinisello: le battaglie per i collegamenti e i servizi, la lotta
alla condizione stigmatica di “ghetto” sono gli esempi più lampanti che consentono che si
parli di comunità. Ciò che è mancato, analogamente a quanto accaduto in Sicilia, è stato un
dialogo costruttivo con i soggetti istituzionali: le forme di intervento predisposte da Aler e
Amministrazione comunale per il quartiere erano quasi sempre risposte alle criticità che via
via si presentavano e mai iniziative innovative frutto di un’analisi della situazione di bisogno
78
in cui versava il territorio. Anche qui a Sant’Eusebio, almeno per questa prima fase informale,
si può sostenere che gli abitanti abbiano fatto per il quartiere molto più di quanto è riuscita a
fare l’istituzione.
Una seconda tematica riguarda il rapporto tra le mobilitazioni dal basso e il progetto
“ibrido” del CDQ: cosa è cambiato? Dove sono finiti i protagonisti della fase “informale”?
Paragonando la situazione attuale, dopo il CDQ, con la situazione precedente durante la quale
le attivazioni erano frutto dell’iniziativa popolare emergono numerosi cambiamenti: quando,
infatti, l'amministrazione si inserisce non più come controparte ma come parte attiva
nell'arena decisionale, vengono modificati alcuni meccanismi che vigevano da tempo.
L’evento più significativo verificatosi durante il CDQ coincide con il dibattito circa il
piano mobilità e gli interventi strutturali al Palazzone. Senza entrare nel merito del conflitto,
che è già stato trattato nel capitolo III, mi soffermerò sul “passaggio di consegne” avvenuto
tra i soggetti protagonisti della fase informale e quelli che li hanno sostituiti. La questione del
piano mobilità ha messo in dubbio la rappresentatività del CI in quanto interlocutore
privilegiato dell’amministrazione e ha dimostrato l’esistenza di attori fino a quel momento
slegati da ogni appartenenza che però pretendevano di esercitare il loro potere decisionale.
Questo, oltre a determinare l’uscita di scena di alcune figure, ha cambiato la natura del
rapporto tra i centri decisionali “informali” e l’istituzione. Sono entrate in gioco appartenenze
politiche e partitiche che durante la fase informale erano rimaste fuori dal contesto: mentre
prima mancava un vero conflitto all’interno del quartiere e c’era un sostanziale accordo circa
l’obiettivo delle rivendicazioni e la modalità delle proteste, con il CDQ si sono manifestate le
prime divisioni. La rete tra le associazioni, i comitati e gli abitanti che si era formata negli
anni precedenti non è “sopravvissuta” al CDQ.
Riprendendo lo schema visto nel cap. III, quindi, si può confrontare il tipo di conflitto che
ha caratterizzato le prime mobilitazioni con quanto successo durante il progetto partecipato.
Inizialmente il conflitto sorgeva tra abitanti che si ponevano come soggetto unico e
l’istituzione vertendo sul tema della richiesta di servizi;; successivamente sono comparse delle
figure nuove all’interno del macro-gruppo che hanno ampliato il conflitto e lo hanno aperto a
più parti. L’arrivo dell’attore istituzionale, l’avvio di un progetto “dall’alto” ha comportato
una democratizzazione della discussione sui temi del quartiere e la scoperta delle esigenze di
una parte di popolazione che non era riuscita a trovare ascolto nelle realtà presenti.
79
Sul lungo termine invece, quella che da un lato era sicuramente una vittoria, ha dato vita a
meccanismi di affiliazione che hanno ridotto le probabilità di risoluzione del conflitto e
causato situazioni di immobilismo. Questi meccanismi inoltre hanno fatto si che alcune realtà,
ancora oggi, abbiano ampio spazio di manovra e supporto da parte dell'amministrazione
nonostante non sempre sia verificata la loro reale rappresentatività. Dall’altro lato, invece,
esistono realtà che si pongono in contrasto con le scelte comunali oppure, più semplicemente
come voce critica e del dissenso, senza però avere lo stesso potere decisionale e senza godere
di un canale privilegiato con l'amministrazione.
L’ultimo tra gli obiettivi dichiarati dell’elaborato è quello di fornire una valutazione,
seppur parziale, della partecipazione come strumento di intervento nei progetti di
riqualificazione urbana. Il CDQ è stato certamente efficace nel modificare la percezione che il
quartiere aveva dell’apparato istituzionale: è riuscito a cambiare l’idea di un’amministrazione
lontana dai bisogni del territorio e vista spesso come “avversaria”. Con il CDQ
l’amministrazione ha messo in discussione alcune delle sue modalità di azione;; il ruolo non è
più quello di soggetto che accetta passivamente le rivendicazioni “dal basso”, che soddisfa le
richieste nel momento in cui esse sono oggetto di protesta ma quello di amministrazione
portatrice di iniziative che cerca di mettersi in posizione di ascolto verso il quartiere. Il CDQ
ha dimostrato certamente che il Comune stava iniziando a comprendere l’ampiezza delle
criticità del quartiere e non era possibile ridurre il “disagio” a una questione di ordine
pubblico. Il progetto è riuscito nel dare una voce alla popolazione, un canale ufficiale di
contatto:
“il CDQ ci ha aiutato moltissimo, perché prima non si poteva avere nessun...non si
poteva interloquire con le istituzioni e neanche con i padroni di casa [Aler] […] [il CDQ]ha
aperto questo canale di comunicazione” (P.D.C.)
Bisogna riconoscere l’efficacia che il CDQ ha avuto sul territorio e sulla zona delle case
popolari senza però tralasciare di guardare con occhio critico alle sue conseguenze sul medio
e lungo periodo. Se, infatti, il progetto ha portato sensibili miglioramenti durante la sua
attuazione e negli anni subito successivi ad oggi rimangono aperte molte delle questioni che il
CDQ si era proposto di risolvere. La più visibile è certamente la questione sicurezza e il
problema della microcriminalità che ancora pesano a molti degli abitanti che vivono nel
quartiere: nonostante i tavoli, le assemblee, le riunioni ecc. la sensazione di impotenza di
80
fronte ai traffici che avvengono nel cortile è rimasta grande e difficile da estinguere. Sembra,
infatti, che le reti di relazioni creatisi attraverso il CDQ non siano riuscite a funzionare al
meglio dopo la fine del progetto; il forte orientamento al risultato, che in quel caso era la
riqualificazione del Palazzone e l’avvio di strutture di supporto, non ha permesso che le realtà
coinvolte trovassero ulteriori obiettivi.
Un secondo appunto va fatto prendendo in esame il progetto complessivo e valutandone
le premesse: il tema della partecipazione, proposto come valore improrogabile e naturalmente
positivo ha alcuni punti deboli che non possono essere tralasciati. L’avvio di un progetto che
prevede gli abitanti come parte attiva ha messo in luce il fatto che un processo partecipativo si
struttura durante il suo corso, modificandosi per mediare tra esigenze e istanze di gruppi
differenti. Non è possibile pensare ad un progetto partecipativo in cui sia coinvolta la
popolazione e considerare essa stessa come un unicum, un soggetto omogeno. Bisogna
considerare che ci si può trovare davanti a punti di vista diversi, visioni differenti che possono
mettere in crisi la rappresentanza del gruppo che si è posto come interlocutore, come nel caso
del CI a Sant’Eusebio. In questo caso l’errore che non ha permesso un’efficacia a lungo
termine del progetto, è stato probabilmente quello di aver considerato come consolidate le
realtà che già agivano nel quartiere e di conseguenza fare troppo affidamento su di esse e sul
loro operato.
Il CDQ, infine, se da una parte ha avuto il merito di aprire la discussione a realtà
differenti, allo stesso tempo ha finito per distanziarle. Un esempio è il modo in cui è stato
affrontato il problema del riscaldamento durante il recente inverno; il disaccordo tra le parti,
Associazione Inquilini e Forum Sant’Eusebio, ha fatto si che si arrivasse davanti ad Aler
senza una richiesta unitaria, cosa che non ha giovato a una risoluzione del problema in tempi
brevi.
Queste conclusioni, data la complessità dei temi trattati e la quantità di implicazioni che
bisogna affrontare quando ci si appresta a studiare un territorio, non hanno certamente la
pretesa di essere esaustive. Si è scelto di condurre la ricerca empirica attraverso un metodo
qualitativo che, per forza di cose, è fondato su una selezione e una scelta delle voci degli
abitanti. Non è possibile escludere di aver tralasciato dei fattori complementari all’analisi,
opinioni che ampliano il discorso sui temi del quartiere e potrebbero mostrare ulteriori
sfaccettature dello stesso argomento.
81
Ma, anche se non si può parlare di quadro esaustivo della questione, sicuramente il caso
Sant’Eusebio fornisce un contributo significativo al dibattito tra partecipazione e politiche
sociali. Si è fornita una possibile spiegazione dell’alto grado di attivismo di cui è stato
protagonista il quartiere attraverso lo strumento concettuale della comunità vista come rete di
attori. Questo ha permesso di guardare al CDQ con uno sguardo diverso, un approccio più
concentrato sulle relazioni tra gli attori che sui risultati tangibili del progetto. Inoltre,
l’utilizzo di uno schema che sintetizza al suo interno le dicotomie classiche di politiche
dall’alto/dal basso e mobilitazioni conflittuali/consensuali ha permesso di sistematizzare gli
eventi del quartiere in un quadro coerente.
Oggi, molti degli eventi che prima erano considerati solo come sporadiche manifestazioni
di piazza, acquisiscono una propria specificità e vengono inclusi nella narrazione delle
politiche sociali del quartiere. Individuando i caratteri che le accomunano e le rendono azioni
significative si è riusciti a fornire un substrato di argomentazioni che conferma la non
casualità delle proteste. Viene così a delinearsi una linea d’azione ben precisa, un percorso di
crescita in cui si sono create reti e relazioni tra gli abitanti con il fine di agire sul proprio
territorio, non singole rivendicazioni disgiunte ma una critica unitaria e coerente ai processi di
cambiamento della città.
82
Appendice
Grafici e dati p.83
Mappa di Cinisello Balsamo e Sant’Eusebio p.85
Tracce delle interviste p.86
86
Tracce delle interviste
Abitanti del quartiere
- Mi parli di Sant’Eusebio, che tipo di quartiere era secondo lei? La distanza quartiere-centro era
sentita? Com’era il quartiere, quando è nato?
- Alcuni abitanti parlano dell’enorme degrado in cui versava il quartiere diversi anni fa...In cosa è
cambiato il quartiere in questi anni? La situazione è migliorata? Grazie a chi? Che cosa è stato fatto?
- Mi racconta delle mobilitazioni a cui lei ha partecipato? Chi le coordinava? Dove?
- C’era qualcuno che non era d’accordo con le proteste e non le supportava? Come si agiva in quei
casi? Qual era il risultato di queste azioni di protesta? E oggi? Ci sono ancora? Perché si/no?
- Qual è il suo giudizio sull’efficacia del CDQ? Ha migliorato la situazione nel quartiere?
Attori privilegiati/Responsabili CDQ
(Ha vissuto a Sant’Eusebio? Cosa ne ricorda?)
- Cos’è il CDQ? Può raccontarmi la storia del progetto? Cosa ci si aspettava dal CDQ?
- Quali erano i soggetti coinvolti? Dove si decideva? Da parte di chi venivano le proposte? Ci sono
stati conflitti? Quanto sono durati? Quali idee sono prevalse?
- Il CDQ ha realmente migliorato il quartiere? In che modo?
- Cosa ha lasciato il CDQ dal punto di vista materiale?
- Cosa ha lasciato il CDQ dal punto di vista relazionale e sociale?
- Cosa è successo prima? Chi era tra gli organizzatori e poi non ha partecipato? Per quale motivo? Chi
faceva cosa? Come vi eravate messi d’accordo? In quanto tempo? In che luogo?
- Quali erano gli obiettivi dell’azione? C’era qualcuno che non era d’accordo con questa modalità?
87
Bibliografia
AA. VV. (1978-1995) La Città, periodico di informazione, Cinisello Balsamo.
Alasia, F. e Montaldi, D. (1960) Milano Corea. Inchiesta sugli immigrati, Milano, Feltrinelli.
Armondi S., Briata P. e Pasqui G. (2008), Qualità dell’abitare e nuovi spazi pubblici, esperienze di rigenerazione urbana a Cinisello Balsamo, Santarcangelo di Romagna, Maggioli.
Bagnasco, A. (1999), Tracce di comunità, Bologna, Il Mulino.
Bertoncin, M. e Pase, A. (2006), Il territorio non è un asino. Voci di attori deboli, Milano, Franco Angeli.
Borlini, B. e Memo, F. (2008), Il quartiere nella città contemporanea, Milano, Bruno Mondadori.
Bricocoli, M. (2002), “Uno sporco lavoro di quartiere”, Animazione Sociale n.3, Gruppo Abele.
Calvaresi, C., Longo, A. e Pasqui, G. (2004), Governare la trasformazione urbana. Riflessioni, scenari, buone pratiche nell’esperienza di Cinisello Balsamo, Comune di Cinisello Balsamo.
Cooke, B. e Khotari U. (2001), Participation: The New Tyranny?, London, New York, Zed Books.
Dolci, D. (1956), Banditi a Partinico, Bari, Laterza.
Dolci, D. (1974), Esperienze e riflessioni, Bari, Laterza.
Dolci, D. e Barone, F. (a cura di) (2007) Una rivoluzioni non violenta, Milano, Terre di Mezzo.
Dolci, D. (1956), Processo all'articolo 4, Torino, Einaudi.
Forrest, R. e Kearns, A. (2001), “Social cohesion, Social Capital and the neighborhood”, Urban Studies vol. 38.
Gans, H. (1966), “La comunità urbana e il suo modo di vivere” in Balbo, L. e Martinotti, G. Metropoli e sottocomunità, Padova, Marsilio.
Giddens, A. (1994), trad. it Le conseguenze della modernità, Bologna, Il Mulino, (ed. or. 1990).
88
Granovetter, M. (1973), “The strength of weak ties”, American Journal of Sociology, Vol. 78, No. 6 pp.1360-1380, trad. it. (1998).
Hickey, S. e Mohan G. (2005), Participation: From Tyranny to Transformation?: Exploring New Approaches to Participation in Development, London, New York, Zed Books.
Inkeles, A. e Smith, D.H., (1974), Becoming modern: individual change in six developing countries, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.
Lefebvre, H. (1996), Writing on Cities, Oxford, Blackwell.
Mannarini, T. (2004), Comunità e partecipazione. Prospettive psico-sociali, Milano, Franco Angeli.
McKenzie, R.D. (1921), “The neighbourhood: a study of local life in the city of Columbus”, The American Journal of Sociology vol.27.
Memo, F. (2004), “Immigrazione e identità locale” in L.S. Pelissetti, T. Danna (a cura di), Cinisello Balsamo nelle tesi di laurea, Cinisello Balsamo, Centro di Documentazione Storica del Comune di Cinisello Balsamo.
Meraviglia, A. (2004), “Cinisello Balsamo negli anni della grande immigrazione 1951-1971" in L.S. Pelissetti, T. Danna (a cura di), Cinisello Balsamo nelle tesi di laurea, Cinisello Balsamo, Centro di Documentazione Storica del Comune di Cinisello Balsamo.
Olivetti A. (1960) Città dell’uomo, Milano, Edizioni di Comunità.
Olivetti A. e Saibene A. (a cura di) (2014) Il mondo che nasce: dieci scritti per la cultura, la politica, la società, Ivrea, Edizioni di Comunità.
Park R.E., Brurgess, E.W. e McKenzie, R.D. (1967), trad. it. Pizzorno, A. (a cura di), La città, Milano, Comunità, (ed. or. 1925).
Pichierri, A. (2002), La regolazione dei sistemi locali. Attori, strategie, strutture, Bologna, Il Mulino.
Popple, K. (1995), Analysing Community Work: Its Theory and Practice, Buckingham, Open University Press.
Sgroi, E. (2000), “Città ed esclusione sociale: riparliamo di comunità”, in Guidicini, P. Pieretti, G. e Bergamaschi, M. (a cura di), L’urbano, le povertà. Quale welfare. Possibili strategie di lotta alle povertà urbane, Milano, Franco Angeli.
Simmel, G. (1995), trad. it. Jedlowski, P. (a cura di), La metropoli e la vita dello spirito, Roma, Armando Editore, (ed. or. 1903).
Soavi, G. (2001), Adriano Olivetti: una sorpresa italiana, Milano, Rizzoli.
Tonnies, F. (1963), trad. it. Comunità e società, Milano, Edizioni di Comunità, (ed. or. 1887).
Tosi, S. (2004), Azione locale nella crisi del welfare state, Milano, Libreria Culp.
89
Vitale, T. (2007), In nome di chi? Partecipazione e rappresentanza nelle mobilitazioni locali, Milano, Franco Angeli.
Willmott, P. (1989), Community Initiatives. Patterns and prospects, London, Policy Studies Institute.
Wirth, L. (1998), trad.it L'urbanesimo come modo di vita, Roma, Armando Editore, (ed. or. 1938).
Young, M. e Willmott, P. (1957), Family and Kinship in East London, Glencoe, IL, The Free Press.
Zucca, E. (2003 ca.), Cinisello Balsamo 1945-1960, Dalla liberazione alla nuova identità cittadina, Cinisello Balsamo, Non edito (bozza finale).
Sitografia
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/
http://www.danilodolci.org/
http://www.fondazioneadrianolivetti.it/
http://www.istat.it/
http://www.openstreetmap.org/
https://fatelargo.wordpress.com/