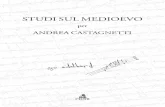Il De gestis Porsenne di Leonardo Dati: Montepulciano, gli Etruschi e un’idea di identità...
-
Upload
uniecampus -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Il De gestis Porsenne di Leonardo Dati: Montepulciano, gli Etruschi e un’idea di identità...
BIBLIOTECA DELL’ «ARCHIVUM ROMANICUM»Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia
425
ARCHITETTURAE
IDENTITA LOCALI
II
a cura di
HOWARD BURNS e MAURO MUSSOLIN
LEO S. OLSCHKI EDITOREMMXIII
ISSN 0066-6807
ISBN 978 88 222 6325 4
B.A.R.
I
Vol. 425
LEO S.
OLSCHKI
AR
CH
ITE
TT
UR
AE
IDE
NT
ITA
LO
CA
LI
–II
I saggi qui proposti hanno inteso integrare tre ele-menti socio-culturali raramente analizzati in recipro-ca relazione nella tradizione di studio sia storico-ar-chitettonica, sia storico-letteraria. Questi elementi sipossono sintetizzare in tre parole chiave: «architettu-ra», «antico», «identita».Architettura: da intendersi come espressione com-plessa e articolata di esigenze di una comunita urba-na, come prodotto di risultanze storiche e culturali dicarattere generale e/o particolare, come sistema diauto-rappresentazione simbolica nel tessuto urbanoe nei monumenti che da quel tessuto ‘emergono’.Antico: da intendersi come necessario sguardo re-trospettivo a una tradizione fondante reale o ‘in-ventata’.Identita: cittadina, regionale, statale, creata attraver-so l’architettura, che soddisfa, mediante la continuitao discontinuita con il passato piu o meno recente, unbisogno di riconoscimento di se nei luoghi simbolicidella citta.L’approccio multidisciplinare ha consentito, conl’ottimizzazione e l’affinamento delle metodologiedi studio, di affrontare il rapporto fra i tre elementi,in una prospettiva di reale interesse nazionale e ge-nerale.
In coperta: JOHN RUSKIN, Portale della Badia Fiesola-na, The Ruskin Library at Lancaster University(U.K.).
LUCIA BERTOLINI
IL DE GESTIS PORSENNE DI LEONARDO DATI:
MONTEPULCIANO, GLI ETRUSCHI
E UN’IDEA DI IDENTITA REGIONALE
1. La fortuna degli Etruschi nel Rinascimento e stata riassunta qualche an-no fa da Giovannangelo Camporeale in un intervento che riordina con effica-cia le conquiste di carattere erudito, letterario, archeologico e storico-artisticoche fra XV e XVI secolo hanno diversamente orientato lo studio dell’anticopopolo:1 un discorso, quello del primo e secondo Umanesimo e poi del Rina-scimento, che, dovendo fare i conti con testimonianze letterarie fino ad unacerta data ignote o malnote (si pensi a Livio nel Trecento o a Dionigi di Ali-carnasso nel Quattrocento) e con l’episodicita (e in parte le difficolta interpre-tative) dei ritrovamenti, rimane spesso o parziale (cosı anche la ricostruzionesu base filologico-letteraria di Leonardo Bruni)2 o fantastico (dovendo in granparte confidare nella ‘costruzione’ di apocrifi di Annio e poi di Egidio da Vi-terbo); un discorso che solo grazie ai ritrovamenti sempre piu consistenti delXVI secolo3 si avviera verso i decisivi progressi compiuti dalla grande erudi-
1 G. CAMPOREALE, La scoperta degli Etruschi nel Rinascimento, «Atene e Roma», XLVIII, 2003,pp. 145-165.
2 Non posso qui soffermarmi su singoli episodi che testimoniano l’autorevolezza della linea fi-lologica impostata da Leonardo Bruni, con l’Historia Florentini populi e il De origine urbis Mantuaein particolare, ma desidero almeno segnalare l’importante contributo di M. BULGARELLI, Architettu-ra, retorica e storia. Alberti e il tempio etrusco, in Leon Battista Alberti: architetture e committenti, Attidel Centenario della nascita di L.B. Alberti, 12-16 ottobre 2004, a cura di A. Calzona et al., Firenze,Leo S. Olschki 2009, II, pp. 663-684.
3 Per le notizie letterarie di tali scoperte cfr. P. SUPINO MARTINI, Un carme di Lorenzo Vitellisulle origini troiane di Corneto, «Italia medioevale e umanistica», XV, 1972, pp. 347-354; per altretestimonianze letterarie quattrocentesche, ma successive, cfr. G. CAMPOREALE, La scoperta degli Etru-schi nel Rinascimento cit., pp. 147-149; per il XVI secolo M. MARTELLI, Un passo di Ugolino Verino,una collezione, un ‘castellum’ etrusco, «Prospettiva», XV, 1978, pp. 12-18 e EAD., Un disegno at-tribuito a Leonardo e una scoperta archeologica degli inizi del Cinquecento, «Prospettiva», X, 1977,pp. 58-61.
— 91 —
zione settecentesca.4 Il tratto di questa storia che interessa il Quattrocento e ilCinquecento e stato analizzato sui versanti storico-artistico, archeologico, let-terario e storico da studiosi quali Andre Chastel, Robert Weiss e Giovanni Ci-priani:5 dalle confuse notizie sulle prime ‘visite’ alle necropoli etrusche, alleprecoci ed entusiastiche ‘imitazioni’ di antichi modelli, fino alle collezioni di‘etruscherie’ che si inaugurano con il XV secolo. E vero che l’interesse pergli Etruschi aveva preso avvio fin dal Duecento con la Composizione del mon-do di Restoro d’Arezzo, ma e altrettanto vero che l’effettiva rinascita d’interes-se avviene con quel che chiamerei l’impossessamento, da parte dei letterati fio-rentini del Trecento e del primo Quattrocento, della memoria etrusca;impossessamento che corrisponde (ben al di la dell’ubiquita con l’antico po-polo che potevano vantare Arezzo e Siena) ad un progetto politico in granparte eterodiretto,6 ma non privo di puntuali connotati identitari come assicu-rano prodotti meno noti e dunque di rado annessi al dossier.
2. In effetti una voce poco ascoltata di questa vicenda e quella di Leonar-do di Piero Dati (1408-1472), partecipante di primo livello all’episodio coro-nario, sodale di lungo corso di Leon Battista Alberti e prolifico umanista delquale gli studiosi hanno ripreso ad interessarsi, affiancando numerosi prege-voli contributi all’unico lavoro d’insieme a tutt’oggi esistente sull’umanista fio-rentino.7
4 Per l’antiquaria ‘etrusca’ fra Cinque e Settecento e ancora molto utile Siena: le origini. Testi-monianze e miti archeologici, catalogo della mostra, Siena, dicembre 1979-marzo 1980, a cura diM. Cristofani, Firenze, Leo S. Olschki 1979.
5 A. CHASTEL, Arte e umanesimo a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico. Studi sul Rinasci-mento e sull’umanesimo platonico, Torino, Einaudi 1964 [ed. orig. Paris, Presses Universitaires deFrance 1959], in particolare il capitolo Il museo etrusco e l’«etruscan revival», pp. 99-110; R. WEISS,La riscoperta dell’antichita classica nel Rinascimento, Padova, Antenore 1989 (ed. orig. Oxford, BasilBlackwell 1969); G. CIPRIANI, Il mito etrusco nel Rinascimento fiorentino, Firenze, Leo S. Olschki1980 (e ora dello stesso, Il mito etrusco: un modello politico, «Letteratura e arte», IX, 2011,pp. 97-106).
6 Come dimostrato da G. CIPRIANI, Il mito etrusco nel Rinascimento fiorentino cit.; aggiungereiche l’assunzione da parte di Giovanni Villani, Coluccio Salutati, Leonardo Bruni della memoria etru-sca entro una tradizione fissa nella sostanza (seppur variabile nei dettagli) riguardo le origini romanedella citta del Fiore non mi pare esaurirsi nella alternativa fra un modello di regime repubblicanoprima (per insistenza sulla dodecapoli), monarchico poi (mediante l’esaltazione del mito di Porsen-na); l’interpretazione politica vale anche per la formazione di un’immagine di Firenze spendibile al-l’interno della citta, funzionale a creare consenso per le scelte che la classe dirigente fiorentina (primae durante la supremazia dei Medici) stava attuando e avrebbe attuato in politica estera. Cfr. L. BER-
TOLINI, I Fiorentini, gli Etruschi e il mare Adriatico, in Custodi della tradizione e avanguardie del nuo-vo sulle sponde dell’Adriatico. Libri e biblioteche, collezionismo, scambi culturali e scientifici, scritturedi viaggio fra Quattrocento e Novecento, Atti del Convegno internazionale di Studi, Pescara 25-28maggio 2005, a cura di L. Avellini e N. D’Antuono, Bologna, CLUEB 2006, pp. 17-27.
7 F. FLAMINI, Leonardo di Piero Dati poeta latino del secolo XV, «Giornale storico della lette-
LUCIA BERTOLINI
— 92 —
Di questo personaggio, senz’altro miglior poeta che non storico, e rimastoin ombra il De gestis Porsenne regis Etruscorum Clusinorumque (o, per dirlacon un titolo apocrifo ma molto aderente al contenuto, il Libellus de UrbisClusii excidio deque Montis Politici clara origine), la cui bibliografia novecen-tesca fa regolare riferimento al nome di Ingrid Rowland, che di questo scrittosi e occupata a piu riprese a partire dal 1989.8 Alla Rowland si deve un cen-simento delle testimonianze manoscritte (cinque codici della redazione origi-nale datiana e un volgarizzamento), l’individuazione di un rifacimento (di Lo-renzo Griffoli, conservato in un sesto manoscritto latino ora a Londra)pressoche coevo alla fattura del Dati, l’illustrazione della fortuna del testo an-che presso personaggi che hanno significativamente contribuito alla nascitadella etruscologia moderna (un codice e di mano di Sigismondo Tizio, un al-tro fu di proprieta del grande collezionista poliziano Pietro Bucelli, le cui anti-chita etrusche entrarono a far parte delle collezioni granducali per il tramite diLuigi Antonio Lanzi).9
ratura italiana», XVI, 1890, pp. 1-107, a cui si aggiunga, per le vicende propriamente biografiche, R.RISTORI, Dati, Leonardo, in DBI, 33, 1987, pp. 44-52 e J.-F. CHEVALIER, Leonardo Dati [Dati Leonar-do (1408-1472)], in Centuriae latinae, II, Cent une figures humanistes de la Renaissance aux Lumieres.A la memoire de Marie-Madeleine de La Garanderie, Geneve, Droz 2006, pp. 259-263. Per i rapportidel Dati con l’ambiente mediceo cfr. L. BOSCHETTO, Intorno a Giovanni Tortelli, Leonardo Dati eLapo da Castiglionchio il giovane. Da una lettera di Roberto Martelli a Lorenzo de’ Medici, «Medioevoe Rinascimento», XVI, 2005, pp. 15-29. All’edizione dello Hiempsal a cura di Berrigan (J.R. BERRI-
GAN, Leonardo Dati: Hiensal tragoedia. A critical edition with translation, «Humanistica Lovanien-sia», XXV, 1976, pp. 84-145) devono essere ora sostituite quella a cura di Aldo Onorato (L. DATI,Hyempsal, a cura di A. Onorato, Messina, CISU 2000) e quella a cura di J.-F. Chevalier (Trois tra-gedies humanistes: Achilles d’Antonio Loschi, Progne de Gregorio Correr, Hiensal de Leonardo Dati,Texte etabli et traduit par J.-F. Chevalier, Paris, Les Belles Lettres 2010; si veda anche F. STOK, LaHiensal tragoedia di Leonardo Dati, in L’officina del teatro europeo, I, Performance e teatro di parola,Atti del convegno di studi «Lo sperimentalismo nella storia del teatro occidentale», a cura di A. Gril-li, A. Simon, Pisa, Edizioni Plus-Universita di Pisa 2001, pp. 73-88). Anche altre opere hanno di re-cente suscitato l’interesse degli studiosi: e fresca di stampa l’edizione L. DATI, Trophaeum Anglari-cum, Textkritische Edition heraugegeben von Th. Lindner, Wien, Praesens Verlag 2011 (conl’indicazione di altri contributi dello stesso studioso). Sulla versione metrica delle favole esopichee tornata a piu riprese Rosanna Mazzacane (In margine alle «Favole» di Leonardo Dati, in Favolistilatini medievali e umanistici XIV, a cura di F. Bertini e C. Mordeglia, Genova, Tilgher 2009, pp. 165-183 e In appendice alle Favole di Leonardo Dati, «Maia», LXIII, 3, 2011, pp. 571-578).
8 Cfr. I. ROWLAND, Due «traduzioni» rinascimentali dell’«Historia Porsennae», in Protrepticon.Studi in memoria di Giovannangiola Secchi Tarugi, a cura di S. Prete, Milano, Istituto Francesco Pe-trarca 1989, pp. 125-133; EAD., L’Historia Porsennae e la conoscenza degli Etruschi nel Rinascimento,«Studi umanistici Piceni/Res publica litterarum», IX, 1989, pp. 185-193; EAD., Il mito di Porsenna:leggenda e realta, in Il mito nel Rinascimento, a cura di L. Rotondi Secchi Tarugi, Milano, NuoviOrizzonti 1993, pp. 391-407; EAD., Pio II, l’urbanistica e gli esordi dell’etruscologia, in Enea SilvioPiccolomini. Arte, Storia e Cultura nell’Europa di Pio II, Atti dei Convegni Internazionali di Studi2003-2004, a cura di R. Di Paola, A. Antoniutti, M. Gallo, Roma, Edizioni Associazione CulturaleShakespeare and Company2-Libreria Editrice Vaticana 2006, pp. 369-375.
9 L’elenco ordinato dei mss. in I. ROWLAND, Pio II, l’urbanistica e gli esordi dell’etruscologia cit.,p. 375, nota 25; per il rifacimento del Griffoli in particolare EAD., Due «traduzioni» rinascimentali
— 93 —
IL DE GESTIS PORSENNE DI LEONARDO DATI
Il De gestis Porsenne di Leonardo Dati, che senza remore possiamo inscri-vere nel gustoso capitolo dei falsi rinascimentali,10 muovendo dalla guerra ro-mana di Porsenna (fonte principale il II libro degli Ab urbe condita liviani)giunge, con disinvolta celerita, al 188 a.C. L’invenzione narra l’«infoelicem ex-peditionem Porsenne regis quam contra Romanos permovit» (III 2)11 del 507a.C., ma anche, a seguito di cio, un’inverosimile distruzione di Chiusi per ope-ra dei Gabini; sconfitti in campo aperto, paventando l’aggressione alla cittanella quale sono rientrati, su proposta di Porsenna i Chiusinati abbandonanoa se stessa l’abiecta plebs di Chiusi e si trasferiscono su un’altura poco distante,il mons Mercurii; sancita la pace definitiva con i Romani, all’accampamento difortuna creato ex tempore per sfuggire ai Gabini (l’attuale Rocca poliziana) sisostituisce, per consapevole e unanime decisione, una splendida urbs razional-mente organizzata dal punto di vista spaziale e sociale. La nuova civitas (cheda urbs montis Mercurii si chiamera Mons Politicus, insomma Montepulciano),depurata delle scorie del popolaccio, tutta nobile e ricca, sebbene fondata suun «crudum et inconsultum [...] facinus ac indignum Porsenna rege» (VI 5), edestinata a sorte favorevole.
L’invenzione, a detta dell’autore stesso, non sarebbe sua. Nella letteranuncupatoria a papa Pio II il Dati ricorda che, trovandosi a Montepulcianopresso l’amico di Curia Angelo Grasso,12 egli ha letto un «libellus lingua pa-tria conscriptus» (II 2) conservato in «vetustissima cyrographa» (II 6) ritrovaticasualmente quasi nel periodo stesso in cui altrettanto casualmente era stataritrovata un’urna etrusca la cui iscrizione diceva contenesse le ceneri dell’an-tico autore.13
cit.; per il Tizio EAD., Due «traduzioni» rinascimentali cit., p. 126 e EAD., L’Historia Porsennae cit.,p. 189 con le note corrispondenti; infine per il manoscritto posseduto da Pietro Bucelli EAD., Due«traduzioni» rinascimentali cit., pp. 126-127. Sulle collezioni di Pietro Bucelli e da vedere G. PAO-
LUCCI – D. PASQUI, Il gentiluomo erudito. Pietro Bucelli collezionista di antichita, Montepulciano, Edi-tori del Grifo 1989.
10 Solo per un eccesso di cautela si puo continuare ad esprimere il dubbio che il Dati abbiautilizzato fonti leggendarie precedenti, del resto mai documentariamente addotte dagli studiosi; lenotizie relative alla storia della fondazione da parte di Porsenna di Montepulciano, tutte successiveal nostro testo, sono ad esso riconducibili con sufficiente verosimiglianza.
11 Qui e in seguito citero il De gestis Porsenne secondo la mia edizione provvisoria (dalla qualeprovengono la divisione in capitoletti e paragrafi).
12 «Cum nuper Montem Politicum animi gratia petiissem ibique vir gravis et doctus AngelusCrassus, hospes meus, quicum summa mihi olim in romana Curia familiaritas fuerat, in sermonemincidit antiquitatum illius preclari oppidi multaque narravit quae primum pro fabellis habebam acrisu mihi potius quam auribus digna videbantur» (II 1).
13 Quel che riferisce il Dati a proposito dell’urna marmorea ritrovata mi pare avere qualche det-taglio di troppo per essere considerato esclusivamente frutto di invenzione: «Tum Angelus vehemen-ter animum meum confirmavit: ait enim divinitus, paucis antea lapsis annis, evenisse ut in idem fere
LUCIA BERTOLINI
— 94 —
Al Dati dunque sarebbe spettato solo l’onere di tradurre un testo (tantomalconcio da essere verso la fine indecifrabile) redatto, nella finzione lettera-ria, da C(aio) Vibenna, un Etrusco che, ormai vecchio («Gravis aetas mea no-straeque reipublice labores dudum me retardarunt, quominus ut decebat,tuae voluntati in conscribenda nostre urbis historia satisfacerem» III 1), scriveal concittadino Achilles Trecchus la storia di eventi a cui non ha assistito diret-tamente, ma la cui notizia ha tratto da fonti fantasiosamente inventate, eppureesplicitamente citate. Una storia che narrando la fondazione di Montepulcia-no da parte di antichi Chiusinati mira ad esaltarne le maggiori e piu importan-ti famiglie e l’assetto urbano (oggi solo in parte verificabile, come si vedra piuavanti), cosı come il paesaggio piu recondito e meno noto della val di Chiana edella val d’Orcia (qui chiamate, con rinominazione allitterante o etimologiz-zante, solo apparentemente fantastica, vallis Plana e vallis Ursa). Un puntodi vista, quello dell’antico autore etrusco, tanto suggestivo da rappresentare(nel breve come nel lungo periodo) il sentimento di identita di Montepulcianoe dei luoghi contermini: per il primo Cinquecento si ricordera la statua di Por-senna che «per Monte Pulciano» fece Andrea Sansovino,14 per l’Ottocento
tempus et historia huiusmodi inter vetustissima cyrographa casu reperta sit et urna marmorea a qui-busdam fossoribus in qua sculpta essent verba haec: DIIS MANIBUS SACRUM C. VIBENNE MAX. PP.; etpreter omnem spem inventa, apparuerit urnam vero in sacello quodam aliquandiu stetisse in mini-sterium aque sacre, qua populus aspergi solet; post, negligentia hominum imperitorum seu forsanab Observantibus Fratribus qui locum inhabitant, curiosa suapte sapientia, non dicam superstitione,disruptam et alio delatam ut iam ignoret quonam loco iaceat» (I 6-8). La menzione del sacellum abi-tato dai frati dell’Osservanza rinvia al convento di San Francesco di Montepulciano che ebbe vitabreve (assegnato all’Osservanza nel 1440, era gia stato abbandonato da quei frati nel 1445, il chepotrebbe spiegare la dispersione dell’oggetto negli anni in cui il Dati scriveva); cfr. A.M. AMONACI,Conventi toscani dell’Osservanza francescana, Firenze-Cinisello Balsamo, Regione Toscana GiuntaRegionale-Silvana Editoriale 1997, p. 57. Le ricerche archeologiche recenti non confermano le originietrusche di Montepulciano (anche G. SECCHI TARUGI, La tradizione delle origini etrusche di Monte-pulciano, «Studi etruschi», s. II, XXVIII, 1960, pp. 339-345 segnalava rinvenimenti modesti nei din-torni; cfr. inoltre Etruschi e Romani ad Acquaviva di Montepulciano, a cura di A. Minetti, Montepul-ciano, Comune di Montepulciano 1997), mentre l’attribuzione a Montepulciano del gentilizioetrusco vipi, femminile vipia o vipinia sostenuta da Anton Francesco Gori al momento di recensirele iscrizioni in caratteri latini di Montepulciano (Inscriptiones antiquae Graecae et Romanae in Etru-riae Urbibus [...] exstantes, Pars Secunda, Florentiae, Typis Iosephi Manni 1734, pp. 425-434: 428)dipendera, come mi fa notare Enrico Benelli, dalla presenza a Montepulciano della gia citata colle-zione Bucelli, costituita pero da acquisti da varie citta etrusche (Chiusi, Sarteano e Chianciano). Laformulazione dell’iscrizione (con la dizione DIIS MANIBUS SACRUM) denuncia una datazione all’etaimperiale come ancora una volta mi informa Enrico Benelli che ringrazio del prezioso aiuto presta-tomi in questa fase della ricerca.
14 G. VASARI, Vita di Andrea di Monte San Savino, in Le vite de’ piu eccellenti pittori scultori earchitettori nelle redazioni del 1550 e 1568, testo a cura di R. Bettarini, commento secolare a cura diP. Barocchi, 6 voll., Firenze, Sansoni-S.P.E.S. 1967-1987, II, p. 122: «In Arezzo fece il disegno dellacasa di Messer Pietro astrologo peritissimo, e di terra una figura grande per Monte Pulciano, cioe unre Porsena, che era cosa singulare, ma non l’ho mai rivista dalla prima volta in poi, onde dubito nonsia male capitata» (il brano e solo nell’ed. del 1568). Il timore del Vasari era fondato se fin dal XVIIsecolo della statua colossale restava soltanto la testa (ora conservata presso la famiglia Avignonesi di
— 95 —
IL DE GESTIS PORSENNE DI LEONARDO DATI
(e oltre) bastera citare la Guida di Ersilio Fumi (cosı come le guide turisticheche ancora oggi si vendono nella cittadina toscana).15
3. E attraverso questo identitario punto di vista che leggiamo la fondazio-ne di Montepulciano come una citta ideale e assistiamo alla ricontestualizza-zione delle poche notizie, di ascendenza letteraria (sulla scorta principale delDe re aedificatoria albertiano), che il Dati possiede sull’arte etrusca: l’insisten-za sulla cinta muraria,16 il labirinto di Porsenna che Alberti aveva ripreso daPlinio e che in questi anni verra riproposto anche dal Filarete,17 e soprattuttola statuaria che l’Alberti dice essere stata inventata dagli Etruschi,18 notiziaquest’ultima che da luogo nel libellus datiano alla menzione prima di una sta-tua di Porsenna (con tanto di iscrizione) che nell’antichita avrebbe campeggia-to sulla piazza di un oppidum fondato dalla famiglia degli Avignonesi,19 poi diuna statua della madre di Porsenna voluta dai Berardini, antagonisti degli Avi-gnonesi, nel loro castellum20 e infine una statua funeraria del re posta propriodavanti al suo mitico labirinto.21
Montepulciano); cfr. R. BARTALINI, Andrea di Domenico Mucci detto il Sansovino [...], Testa di Por-senna 1515-1520, in Umanesimo e Rinascimento a Montepulciano, a cura di A. Sigillo, Montepulcia-no, Editori del Grifo 1994, pp. 133-134.
15 E. FUMI, Guida di Montepulciano e dei Bagni di Chianciano, Montepulciano, Cartoleria e li-breria Fumi e Caleri 1894.
16 L.B. ALBERTI, L’architettura (De re aedificatoria), Testo latino e traduzione a cura di G. Or-landi, Introduzione e note a cura di P. Portoghesi, Milano, Il Polifilo 1966 (d’ora in poi De re aed.),VII II, p. 539: «Moenibus veteres, praesertim populi Etruriae, qudratum eundemque vastissimumlapidem probavere [....]. Visuntur et vetusta oppida cum Etruria tum et Vilumbriae tum et apudHernicos lapide astructa praegrandi incerto et vasto, quod mihi quidem opus vehementer probatur;quandam enim prae se fert rigiditatem severissimae vetustatis, quae urbibus ornamento est. Ac velimquidem eiusmodi esse urbis murum, ut eo spectato horreat hostis et mox diffidens abscedat».
17 Si veda la Naturalis historia pliniana XXXVII 91-93; De re aed. VIII III, p. 683; A. AVERLINO
DETTO IL FILARETE, Trattato di architettura, Testo a cura di A.M. Finoli, L. Grassi, Introduzione enote di L. Grassi, Milano, Il Polifilo 1972, pp. 36-37. Sul labirinto di Porsenna si veda la bibliografiacitata da G. CAMPOREALE, La scoperta degli Etruschi nel Rinascimento cit., p. 151 (per la fortuna fi-gurativa di questo monumento p. 156) e M. SORDI, Il monumento di Porsenna a Chiusi e un errore ditraduzione del Filarete, in Tradizione dell’antico nelle letterature e nelle arti d’Occidente. Studi in me-moria di Maria Bellincioni Scarpat, Roma, Bulzoni 1990, pp. 235-239.
18 De re aed. VII XVI, p. 655: «Sed omnium, ni fallor, egregius fuit usus statuarum. Ornamentoenim veniunt et sacris et prophanis et publicis et privatis aedificiis, mirificamque praestant memoriamcum hominum tum et rerum. Et profecto praestantissimo ingenio quicunque is fuit, qui eas adinveneritstatuas, una cum religione ortas arbitrantur, et statuarum inventores Etruscos fuisse praedicant».
19 «[...] supra plateam erexerunt statuam Porsenne regis adiecto versu huiusmodi: Porsenne re-gis quem conspicis extat imago» (IV 10). L’attuale collocazione del frammento sansoviniano (cfr. nota14) potrebbe dunque non essere casuale e corrispondere alla volonta della famiglia Avignonesi diesaudire, mediante una commissione, l’auspicio indirettamente formulato dal Dati.
20 «[...] edificarunt castellum, videlicet Castelionum Provedine, et colonis compleverunt atqueibidem statuam erexerunt Provedine matris Porsenne regis» (IV 16).
21 «Itaque factum est erecta quoque statua secus eius tumulum ornatissimum propter excellen-
LUCIA BERTOLINI
— 96 —
Oltre a queste episodiche notizie attinenti alle arti, il Dati ci informa del-l’assetto urbano e architettonico della citta fondata, a suo dire, dagli Etruschi.Tutte le principali famiglie fuggite da Chiusi partecipano con Porsenna allespese necessarie per la costruzione della cortina muraria (i nobili infatti «de-creverunt, si regi placet, eorum sumptibus montem muro cingere, cuius lati-tudo tris, altitudo triginta cubitos equabiliter pateat» X 15) dopo che il re hapredisposto, con materiali e maestranze, la nuova edificatio («Magna igiturvim auri rex impendit in construundis fornacibus ad calcem et lateres exco-quundos; conquesti sunt architecti boni ac eiusmodi artifices, iam vero calciset laterum ingenti copia comparata» X 14). Il muro di cinta di duemila passida luogo a quattro porte,22 nello spazio frapposto fra i due assi viarı che lecollegano23 a due a due, proprio in cima al monte, si trova una gran piazza,sui cui angoli sorgono una chiesa, il palazzo del re e quelli delle due maggiorifamiglie; le quattro strade, che a partire dagli angoli della piazza suddividonoin opposta direzione i due assi principali, marcano quattro quartieri dove abi-teranno i nobiles (Porta Titonia), i divites populares (Porta Regia), i plebei opi-fices (Porta Cumana), e rispettivamente i servi (Porta Calbinia).24 «Iam Mer-curii montem cincto muris ac patriciis, popularibus, opificibus et ministris
tis Laberynthi faciem, sculptis his verbis: Hac cynis obtegitur Porsenne regis in urna, anno ætatis suæLXXXV» (XI 2). Di un’altra iscrizione («Porsennae cinis hac tegitur quam cernitis urna» = CorpusInscriptionum Latinarum XI, 260*) da notizia Sigismondo Tizio; cfr. Siena: le origini cit., p. 119 eI. ROWLAND, L’Historia Porsennae cit., p. 187 e note 21-22.
22 Per la datazione delle tre cinte murarie di Montepulciano cfr. D. PASQUI, Porta a Prato, o diGracciano, in Umanesimo e Rinascimento a Montepulciano cit., pp. 39-40. Il Dati pare riferirsi (ov-viamente all’atto di rendicontare una situazione arcaica) alla cinta del XII secolo, limitando la suadescrizione all’insediamento del Sasso; in questa fase della ricerca mi limito alle identificazioni menoipotetiche, riservandomi di tornare con maggiore documentazione sulla planimetria poliziana desu-mibile dalla descrizione del Dati.
23 Dei due assi viarı ricordati dal Dati, quello costituito oggi da via San Donato e via dei Ricci eben riconoscibile; meno chiaro se per l’altro il Dati faccia riferimento alla via interna, oggi effettiva-mente tangente piazza Grande costituita dalle attuali via Fiorenzuola vecchia e via Talosa o non piut-tosto all’attuale Corso (costituito da via dell’Opio, via di Voltaia e via di Gracciano nel Corso); l’in-certezza dipende in gran parte dal piu tardo insediamento di palazzo Del Monte Contucci che haridisegnato i confini di piazza Grande verso est.
24 Cfr. supra la nota 22; data l’incertezza su collocazione e denominazione delle antiche porte diMontepulciano (cfr. I. CALABRESI, Montepulciano e il suo territorio nel Medio-Evo, in S. BENCI, Storiadi Montepulciano, rist. anastatica della seconda edizione [In Fiorenza, Per Amador MassiMDCXLVI] con appendici e un indice glossario a cura d’I. Calabresi, P. Tiraboschi, Verona, L’Ar-co dei Gavi edit. 1968, pp. 273-302) mi limito a segnalare che Porta Titonia prende il nome dal Pog-gio di Totona, a sud della citta (gia nominata nello Statuto del 1337; cfr. I. CALABRESI, Montepulcianoe il suo territorio cit., p. 291: «forse quella [porta] che poi si chiamo semplicemente ‘‘di Collazzi’’ oquella di San Donato, rifatta nel 1794»), e che Porta Calbinia assuona con l’ancora esistente Portadella Cavina (sulla quale cfr. I. CALABRESI, Montepulciano e il suo territorio cit., pp. 290-291); PortaRegia e forse l’attuale Porta del Paolino, delimitante a nord la contrada di Talosa, dal Dati chiamataTolosa.
— 97 —
IL DE GESTIS PORSENNE DI LEONARDO DATI
habitatoribus repleto, iam regione ad culturam exposita, cum patricii deliciis,populares divites civili vite, ac si supra centum annos loco mansissent, dede-rentur. Exultans rex eum montem non Mercurii sed Politicum appellandumcensuit immutavitque numisma ac totam novæ rei publice gubernationem pa-triciis demandavit» (X 54-55).
La Montepulciano descritta dal Dati e una citta che solo con certa cautela(e comunque a patto di ulteriori approfondimenti) puo essere intravista nel-l’assetto cittadino attuale, in particolare per quanto riguarda la conformazionedi piazza Grande:
In primo eius cornu templum erexit ornatissimum et Mercurio dedicavit, in alte-ro ingens palatium altitudinis sexaginta cubitorum, adiuncta turri centum cubitos ela-ta, condidit. Ibi quoque Avineonensiis et Berardinis edificandum iussit: norat enimutriusque familie potentiam ac emulationem presagivitque eas certatim quam magni-ficentius edificaturas, proinde plateam pulchriorem fore. Quod subsecutum est: utra-que enim palatium struxit amplissimum, altum quinquaginta cubitos, ornatum auro,signis eminentibus, ne civilia palatia sed regia viderentur. Valde rex admodum gloria-tus est, portam quoque palatii sui usque culmen turris illustravit argento et auro pu-rissimo (X 21-25).
Attualmente sui lati della piazza poliziana si affacciano, oltre il Palazzo Co-munale a ovest, edifici di fattura posteriore:25 a sud il duomo, iniziato alla finedel Cinquecento, di Ippolito Scalza (spostato a meridione rispetto all’antica col-locazione della precedente chiesa di Santa Maria),26 a est il palazzo Del MonteContucci27 e il contiguo palazzo Sinatti, a nord il palazzo Nobili Tarugi. Di quel
25 Per l’attuale configurazione della piazza cfr. P. GRIFONI – R. DALLA NEGRA, I palazzi Tarugi eSinatti sulla Piazza Grande di Montepulciano, «Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura»,XXVII, 169-174, 1982, pp. 93-106; M. COZZI, Antonio da Sangallo il Vecchio e l’architettura del Cin-quecento in Valdichiana, Genova, Sagep Editrice 1992, p. 66; le voci, a varia firma, contenute inUmanesimo e Rinascimento a Montepulciano cit.; P. ZAMPA, Antonio da Sangallo il Vecchio. Da Firen-ze e Roma alla provincia toscana, in Storia dell’architettura italiana. Il primo Cinquecento, a cura diA. Bruschi, Milano, Electa 2002, pp. 240-253.
26 Purtroppo il Dati ci dice ben poco sull’aspetto del templum dedicato a Mercurio, cioe la vec-chia pieve di S. Maria, triabsidata e con disposizione est-ovest, sulla quale e da vedere D. PASQUI (conla collaborazione di R. PIZZINELLI), La Pieve di Santa Maria, in Il tempo della citta. L’evoluzione diPiazza Grande nei secoli, introduzione di M. Russo, Montepulciano, Editori del Grifo 1987, pp. 11-20. Dalla ragionata ricostruzione del Pasqui si deduce una collocazione dell’antico templum molto piuavanzata verso il centro della piazza (che doveva avere dimensioni inferiori a quelle dell’attuale piazzaGrande; cfr. nota seguente).
27 L’area oggi occupata da palazzo Contucci Del Monte era a stretto ridosso delle absidi dellapieve di S. Maria secondo la ricostruzione proposta da D. PASQUI, La Pieve di Santa Maria cit., p. 13;diversa la ricostruzione planimetrica di I. CALABRESI, Montepulciano e il suo territorio nel Medio-Evo,in S. BENCI, Storia di Montepulciano cit., in particolare p. 280, le tavole fuori testo fra p. 280 e p. 281e pp. 467-468.
LUCIA BERTOLINI
— 98 —
che il Dati pote certamente vedere28 resta dunque solo il Palazzo Comunale,che, come sappiamo dagli studi di Howard Saalman, e nella facciata e nella rior-ganizzazione interna delle vecchie strutture due e trecentesche opera di Miche-lozzo.29
Il Palazzo Comunale di Montepulciano e «ingens palatium altitudinis se-xaginta cubitorum, adiuncta turri centum cubitos elata» (caratteristica que-st’ultima che, attestando il compimento della Torre, consente di datare il testodi Leonardo Dati a dopo il 1461):30 ma quel che ci importa qui e come quelPalazzo, che da poco aveva assunto per volonta di Cosimo i tratti del fioren-tino Palazzo Vecchio (secondo le parole di Saalman: «a kind of symmetrizedtravertine copy of the Florentine Palazzo Vecchio»),31 diventato agli occhi delnostro umanista il palazzo dell’antico re di Chiusi, assuma un’ombra etruscache si riverbera sul fiorentino Palazzo Vecchio, e dunque su tutto il passatoarchitettonico trecentesco toscano, riletto come espressione di un linguaggiolocale, toscano perche etrusco.
4. Ingrid Rowland ha attribuito l’input primario per la scrittura del De ge-stis Porsenne alle mire encomiastiche dell’autore, desideroso di aver appan-naggi ulteriori da Pio II a cui effettivamente il testo e dedicato,32 poiche nellalettera nuncupatoria al Piccolomini (che pero non compare per esempio nelMagl. XXIII 29) il Dati, facendo seguito alla finzione di cui abbiamo parlato,ricorda che nella storia da lui ritrovata e tradotta si fa menzione di un Bacchus
28 Di origini piu antiche (XIV secolo) e il palazzo Bellarmini che pero non affaccia su piazzaGrande; cfr. F. ROTUNDO, Palazzo Bellarmini, in Umanesimo e Rinascimento a Montepulciano cit.,pp. 87-90. Per le alterazioni subite nel XVI e XVII secolo dal fianco sud del Palazzo del Podestacfr. H. SAALMAN, The Palazzo Comunale in Montepulciano. An Unknown Work by Michelozzo,«Zeitschrift fur Kunstgeschichte», XXVIII, 1965, pp. 1-46: 34, nota 32 e R. PIZZINELLI , Piazza Gran-de nel XIV secolo, in Il tempo della citta cit., pp. 24-25. Sul campanile della pieve di S. Maria, forseancora in costruzione alla data di scrittura del De gestis Porsenne, cfr. H. SAALMAN, The Palazzo Co-munale in Montepulciano cit., p. 28; R. PIZZINELLI, Torre Campanaria della Pieve di S. Maria, in Uma-nesimo e Rinascimento a Montepulciano cit., pp. 104-106, che sulla base di documenti d’archivio raf-forza la datazione di Saalman (fra il 1460-61, l’avvio dei lavori, e il 1476) e D. PASQUI, La Pieve diSanta Maria cit., pp. 13-14.
29 Resta fondamentale a questo proposito H. SAALMAN, The Palazzo Comunale in Montepulcia-no cit.; per la datazione del rifacimento della facciata (1443-1452) cfr. in particolare le pp. 23-26 (peri documenti su cui la ricostruzione di Saalman si basa cfr. le pp. 38-40).
30 Per le date della Torre (1458-1461) cfr. H. SAALMAN, The Palazzo Comunale in Montepulcia-no cit., pp. 27-28; si avverta infatti che i documenti n. 35 e seguenti pubblicati dal Saalman si riferi-scono al contenzioso relativo al pagamento da parte del comune di Montepulciano di un lavoro che ildocumento n. 34, del 22 gennaio 1461, dichiara ormai portato a termine.
31 H. SAALMAN, The Palazzo Comunale in Montepulciano cit., p. 11.32 I. ROWLAND, Due «traduzioni» rinascimentali cit., p. 125; EAD., L’Historia Porsennae cit.,
p. 185; EAD., Il mito di Porsenna cit., p. 399; EAD., Pio II, l’urbanistica e gli esordi dell’etruscologiacit., p. 369.
— 99 —
IL DE GESTIS PORSENNE DI LEONARDO DATI
Piccolhomineus. Non mi pare che al dato documentario vada attribuito un va-lore dirimente. Quella dedica non riesce infatti, da sola, a spiegare la costru-zione del libellus datiano: per un verso il ruolo del supposto antico Bacco Pic-colomini e marginale (non tale insomma da assorbire in toto l’invenzione), peraltro verso il tentativo di ricondurre all’identita etrusca un personaggio comeil Piccolomini (che invece rivendicava per la propria famiglia origini a suo sen-tire ben piu nobili, troiane e romane)33 pare addirittura fuor di luogo. Il testorisulta invece piu comprensibile quale scrittura di un mito di fondazione all’in-terno di un revival etrusco della cittadina toscana, magari sostenuto da qual-che occasionale rinvenimento.34
C’e da chiedersi allora perche, su sollecitazione di qualche amico origina-rio di Montepulciano (primo fra tutti quell’Angelo Grasso cui l’autore dichia-ra essere legato da grande amicizia) e magari in riferimento a qualche scopertaarcheologica fra Chiusi e Montepulciano, il sacerdote di origine fiorentina sisia disposto ad esaltare una citta non sua. Montepulciano era in quegli anninell’ambito di influenza fiorentina e della citta del Fiore costituiva una rocca-forte a sud di Siena, importantissima nel conflitto che ormai da secoli oppo-neva la citta ghibellina alla guelfa; ma in questi stessi anni (come la lettera alPiccolomini ricorda) il panorama culturale del Dati e quello della Curia, all’in-terno della quale riveste cariche sempre piu importanti a partire dal papato diCallisto III, e destinate, soprattutto con Paolo II piuttosto che con il Piccolo-mini, ad incrementarsi. Proprio per questo (e nonostante che la posizione del-l’umanista rispetto al potere mediceo sia stata di recente meglio valutata nelladiacronia),35 mi pare difficile che l’operazione pseudo-etrusca di Leonardo
33 E.S. PICCOLOMINI PAPA PIO II, I Commentarii, edizione a cura di L. Totaro, Milano, Adelphi1984 (nuova edizione ampliata, Milano, Adelphi 2004), IV 39, pp. 804-806; dichiara infatti il Picco-lomini agli oratori romani che lo avevano raggiunto a Viterbo per sollecitarne il rientro nell’Urbe:«Flentem [...] et admodum dolentem flentes ipsi et vehementer dolentes Urbem reliquimus, quaepatria nostra est non minus quam Senae. Nam domus Picolominea, quae nos peperit, olim ex RomaSenas migravit, sicut Aeneadum nomen ac Silviorum in familia nostra frequens ostendit». Per il per-petuarsi di tale tradizione nei secoli successivi cfr. Siena: le origini cit., p. 119. Se la destinazione alpapa di un prodotto del curiale Dati non e gia di per se contestualmente giustificata, bastera ricor-dare come proprio in questi anni, piu precisamente intorno al 1460, Francesco Patrizi aveva messoper iscritto la rivendicazione dell’ascendenza romana di Siena con il De origine et antiquitate Sene dicui il De gestis Porsenne potrebbe essere la risposta da parte di una citta a lungo contesa (e per certiperiodi sottomessa) alla repubblica senese. Su Francesco Patrizi cfr. F.C. NARDONE, Francesco Patriziumanista senese, Empoli, Ibiskos 1996 e F. NEVOLA, Francesco Patrizi: umanista, urbanista e teorico diPio II, in Pio II Piccolomini. Il papa del rinascimento a Siena, Atti del convegno internazionale di stu-di, 5-7 maggio 2005, a cura di F. Nevola, Siena, Alsaba grafica, 2009, pp. 179-196.
34 Si ricordera del resto che a pochi anni prima (1454) risale la visita alle tombe di Tarquinia daparte di Lorenzo Vitelli, da questi menzionate in un carme inviato a Francesco Filelfo; cfr. supra nota 3.
35 L. BOSCHETTO, Intorno a Giovanni Tortelli, Leonardo Dati e Lapo da Castiglionchio il giovanecit., pp. 20-22.
LUCIA BERTOLINI
— 100 —
Dati possa essere spiegata come espressione propagandistica di intenti politicifiorentini.
E possibile, invece, che il Dati abbia consapevolmente assunto proprioquella prospettiva identitaria regionale alla quale abbiamo accennato pocofa in rapporto all’architettura del Palazzo Comunale di Montepulciano. Il li-bellus datiano e, come si e visto, una pseudo traduzione; da quale lingua ori-ginale sia stato tradotto e stato discusso da Ingrid Rowland e da Renzo Ristoriche oscillano fra l’ipotesi che il falso costituisca l’effettiva versione latina dalvolgare (o, secondo Ristori dal «latino della decadenza») di qualche leggen-da36 e l’alternativa che esso invece si candidi quale (incredibile, ma non im-porta!) traduzione dall’etrusco.37 In realta, all’autore, le due alternative nondovettero apparire polari come risultano a noi moderni, se si attribuisce il giu-sto peso all’ambiente frequentato da Leonardo Dati un ventennio prima a Fi-renze. In occasione dell’evento spettacolare che aveva riunito, di fronte a unfolto pubblico, vari dicitori sul palchetto di Santa Maria del Fiore a discettaredi amicizia, Niccolo della Luna, sodale ed amico del Dati,38 aveva dato fuoriuna prosa di esaltazione dell’iniziativa certatoria, nella quale si registra noncerto una sconfessione filologicamente agguerrita della teoria vincente relativaalla fondazione romana di Firenze, quanto semmai l’affermazione (tanto inge-nua quanto eccentrica) che il superstrato romano non aveva potuto cancellare,a Firenze e nella Toscana tutta, il sostrato etrusco.39 Si conservi ai due terminidi ‘super-’ e ‘sostrato’ l’accezione strettamente linguistica, giacche il discorsodi Niccolo della Luna proprio sul piano linguistico si svolgeva, salutando nelCertame coronario il riscatto, in una sede pubblica resa qualificata dalla pre-senza della Curia, del volgare toscano come contrapposto alla lingua latina,cioe della lingua etrusca dei giorni presenti contrapposta a quella lingua anticadel Lazio che ancora una volta tentava la sopraffazione (stavolta a seguito del-la spinta che Cosimo il Vecchio aveva data alla linea dell’umanesimo latino).
36 Ma vedi supra la nota 10.37 R. RISTORI, Dati Leonardo cit., p. 48; I. ROWLAND, Due «traduzioni» rinascimentali cit.,
p. 127; EAD., Il mito di Porsenna cit., pp. 401-402; EAD., Pio II, l’urbanistica e gli esordi dell’etrusco-logia cit., p. 370.
38 Per le lettere intercorse fra il della Luna e il Dati cfr. Leonardi Dathi [...] Epistolae XXXIII,recensente L. Mehus, Florentiae, Ex novo Typographio Jo. Pauli Giovannelli 1743, pp. XVIII-XXVIII
(di Niccolo a Leonardo; per la lettera di accompagnamento della prosa certatoria cfr. pp. XXVII-XXVIII) e pp. 1-2 (epistola I, di Leonardo a Niccolo).
39 La prosa del della Luna e edita in De vera Amicitia. I testi del primo Certame coronario, edi-zione critica e commento a cura di L. Bertolini, Modena-Ferrara, Franco Cosimo Panini Editore-Isti-tuto di Studi Rinascimentali 1993, pp. 495-496; per la sua interpretazione, qui riassunta, vedi L. BER-
TOLINI, I Fiorentini, gli Etruschi e il mare Adriatico cit., pp. 20-22.
— 101 —
IL DE GESTIS PORSENNE DI LEONARDO DATI
Alla luce di questa supposta identita di lungo corso – fra latino antico e recen-te da un lato e fra etrusco e toscano dall’altro – va letta (io credo) l’ambiguitalinguistica del testo del Dati che puo essere considerato tradotto dall’etruscoperche tradotto dal volgare (o viceversa).40 Accanto all’identita locale che ilDe gestis Porsenne esprime, tutta cittadina e apparentemente indotta da occa-sionali sollecitazioni amicali, affiora la fede in una identita regionale che negliEtruschi antichi trovava piena soddisfazione per il presente e, come bene hadimostrato Giovanni Cipriani nel volume piu volte ricordato, per il futuro. Daqui forse occorre ricominciare a rileggere la preistoria (non certo la storia) delmito etrusco nel Rinascimento.
40 Alla luce di queste idee linguistiche dovra essere interpretata quella che abbiamo definito ri-nominazione allitterante o etimologizzante della toponomastica e onomastica dell’Etruria: le formevolgari, testimonianza dell’antica lingua etrusca, vengono rese trasparenti dal punto di vista del signi-ficato tramite la loro traduzione in latino.
LUCIA BERTOLINI
— 102 —