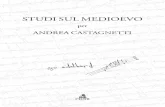STANO, S. (ed.) (2015) Lexia 19-20 "Cibo e identità culturale / Food and Cultural Identity"
Il fenomeno etnico tra identità, Stato e conflittualità
Transcript of Il fenomeno etnico tra identità, Stato e conflittualità
Prof.ssa Simona Epasto
Il fenomeno etnico tra identità, Stato e conflittualità
Sono trascorsi quasi cento anni da quando il sociologo ed economista Max Weber, in Economia e
Società, pubblicato postumo, aveva profetizzato la graduale scomparsa dei vincoli basati sulla
differenziazione etnica e culturale, processo stimolato dalla creazione di legami universali che si
sarebbero imposti ed avrebbero determinato il superamento dei particolarismi che avevano
caratterizzato i secoli precedenti (Weber, 1922). Appare evidente, tuttavia, all’alba del terzo
millennio, come accanto ai fenomeni di mondializzazione e globalizzazione si assista ad una
riscoperta delle identità etniche, religiose e di gruppo, nell’ottica di un individualismo di massa che
pone sempre più all’attenzione il problema delle minoranze etniche e del crescente ruolo sociale e
politico che esse rivestono; a tutt’oggi, infatti, non esiste compagine statale che non contenga in sé
una o più minoranze etniche, religiose o linguistiche, ma ciò che sorprende maggiormente, è
l’ascesa di un revival etnico che non conosce né confini né orizzonti. Il problema delle minoranze ,
pertanto, si innesta sul già instabile concetto di Stato, i cui confini, la cui sovranità e legittimazione,
vengono attaccati simultaneamente da forze sovrannazionali, transnazionali e subnazionali.
A livello esegetico è importante sottolineare come lo stesso concetto di minoranza non sia univoco;
se etimologicamente corretto potrebbe sembrare il criterio quantitativo che prende in considerazione
il rapporto numerico tra le componenti della popolazione di uno Stato, individuando come
minoranza una parte di essa etnicamente, linguisticamente o culturalmente distinta rispetto al
gruppo demograficamente più consistente, in realtà esso è palesemente discutibile, se si considerano
le posizioni politicamente dominanti di gruppi numericamente inferiori come ad esempio i bianchi
in Sudafrica o gli hutu in Ruanda; a ciò si aggiunga che, quantitativamente, il concetto di minoranza
si estende da piccole comunità all'interno degli Stati, come nel caso degli albanesi in Italia, sino a
gruppi numericamente sostenuti, quali ispanici o afroamericani negli USA.
Altresì discutibile appare il criterio antropologico che fa riferimento esclusivamente al sostrato
etno-culturale, in quanto qualsiasi comunità potrebbe essere minoranza, anche quelle che si
innestano perfettamente nel panorama socio-nazionale. Gli studiosi di scienze sociali sottolineano
ancora come la componente fondamentale della etnicità, lungi dall’essere oggettiva e reale, è
squisitamente soggettiva e psicologica, quale senso di identità e di appartenenza percepita dai
gruppi di individui, che diventa contrapposizione nel caso di conflitti (Connor, 1995).
C’è chi poi ha avanzato la validità di un criterio geodemografico che conferisce importanza al
rapporto tra la comunità ed il territorio, ma di fatto, ciò escluderebbe lo status di minoranza a
popolazioni non stanziali quali ebrei, tuareg, zingari, che pur non avendo un legame specifico con
uno spazio territoriale, mantengono una coesione culturale, religiosa, etnica ed uno stile di vita che
li differenzia dalle altre geocomunità (Lizza, 2008).
Sicuramente più equilibrata e, dunque, parzialmente condivisibile, è la definizione elaborata in uno
studio effettuato su commissione delle Nazioni Unite dal giurista Francesco Capotorti, che
mescolando fattori oggettivi e soggettivi, sociologici ed antropologici, definisce minoranza etnico-
linguistica un gruppo numericamente inferiore rispetto al resto della popolazione di uno Stato, in
posizione non dominante, i cui membri possiedono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche
che li differenziano dal resto della popolazione e manifestano un sentimento di solidarietà che mira
a salvaguardare i tratti culturali propri del gruppo (Capotorti, 1992; Lizza, 2008). Capotorti fa anche
riferimento a presupposti sia spaziali sia temporali, nel senso che la popolazione minoritaria è parte
della popolazione stabilmente residente dello Stato; anzi, deve essere legata da tradizioni ben
radicate ad una precisa porzione del territorio statale.
In quest’ottica, il concetto di minoranza appare al contempo geografico, politico e statistico; il solo
dato quantitativo, però, appare necessario ma non sufficiente, essendo fondamentale fare
riferimento a differenze culturali riconoscibili, siano esse la posizione geografica, la storia o le
caratteristiche del gruppo che lo rendono differente dal resto della popolazione.
Anche la definizione di Capotorti non è esente da critiche e la difficoltà di arrivare ad una
definizione univoca dipende, come ben evidenzia Lizza, dalla variabilità in relazione al contesto
dell’elemento unificante di differenziazione; l’appartenenza etno-culturale, infatti, non è un aspetto
isolato, ma dipende dal contesto territoriale e culturale entro cui ci si differenzia dal resto della
popolazione (Lizza, 2008). Le stesse identità, dunque, sono interessate da fenomeni rilevabili su
diverse scale: individuale, locale, regionale, nazionale, continentale e planetaria (Fouberg, Murphy,
de Blij, 2010). E’ evidente, pertanto, come la complessità del fenomeno etnico sfugga a definizioni
classificatorie, investendo vari campi del sapere, con la necessità, dunque, di adottare diversi
schemi teorici per l’analisi di fenomeni tanto differenziati nel tempo, nello spazio e nella struttura.
Il problema delle minoranze, se posto in relazione al concetto di Stato unitario, può dar esito a
spaccature che via via possono determinare conseguenze territoriali a seconda del grado di coesione
dello stesso; minore il grado di coesione, maggiore sarà la possibilità che si arrivi a rotture
territoriali, come testimoniano i recenti avvenimenti nel continente europeo, dove, negli anni
Settanta, ad indici di coesione altissimi di Ungheria e Polonia (96), si contrapponevano indici medi
in Cecoslovacchia (51) e ancor più bassi in Jugoslavia (25), che consentono di comprendere i
diversi risvolti politico-territoriali seguiti alla rivoluzione di velluto ed alla guerra nei Balcani
(Lizza, 2008).
Il panorama geopolitico diviene ancora più complesso, poi, se si dà uno sguardo alla storia più
recente; dopo la fine della guerra fredda che vedeva contrapposto l’intero globo in due blocchi
allineati con URSS e USA, con a margine solo i paesi del Terzo Mondo parzialmente estranei al
conflitto, la rinascita delle rivendicazioni etniche ha subito un incremento esponenziale in ogni parte
del mondo; dai territori dell’ex Unione Sovietica, agli Stati nati dopo lo sfaldamento dei regimi
comunisti, dalle tensioni etnico tribali nel continente africano (Sudan, Liberia, Nigeria e Ruanda, ne
sono solo alcuni esempi), alle rivendicazioni all’interno dei paesi più sviluppati, fino alle spaccature
conseguenti alle missioni Nato in medio-oriente, ovunque i confini dello Stato vengono minacciati
da rivendicazioni più o meno accese che, oltre ad intaccare i cardini dell’organizzazione territoriale
interna, creano destabilizzazione nell’ambito della politica internazionale.
Paradossalmente, infatti, il conflitto bipolare, dividendo il mondo, lo unificava, subordinando a sé
ogni frattura ideologica, etnica e religiosa; la caduta delle ostilità tra capitalismo statunitense e
comunismo sovietico, lungi dal consegnare alla storia pace e stabilità, ha determinato, a contrario,
una proliferazione della conflittualità molto più frammentata e complessa che, proprio nelle
determinanti etno-locali, ha trovato spesso la sua fonte di alimentazione. Il fenomeno che Rosenau
negli anni Novanta spiegò con la teoria della turbolenza, all’alba del III Millennio, sembra
caratterizzare la ripoliticizzazione di gruppi etnico-culturali che si innestano come forze trasversali
all’interno della compagine statale, creando identità parziali che attaccano i già deboli organismi
nazionali (Lizza, 2008).
Quando il diritto alla autodeterminazione dei popoli, principio di diritto internazionale elevato a
principio fondamentale dalla Carta delle Nazioni Unite, sfocia nell’etnocentrismo e nello scontro
tribale, il contemperamento tra gli interessi delle diverse comunità etniche non è di semplice
attuazione; tale principio contiene, infatti, una forza dirompente, essendo dotato di una portata
potenzialmente illimitata che crea non pochi problemi di contemperamento tra nazionalismo ed
autodeterminazione, col rischio di cadere in una spirale di rivendicazioni violente non meno di
quelle conseguenti alle politiche nazionaliste dei secoli scorsi (Epasto, 2005).
La situazione del Kosovo è emblematica in tal senso: territorio serbo già parte della Jugoslavia
prima della guerra dei Balcani, ha avviato una guerriglia armata fin dalla crisi iugoslava ad opera
della comunità albanese che costituisce ad oggi, dopo la fuga della popolazione serba, ben il 92%
della popolazione. Dopo l’intervento della Nato e la fine dell’amministrazione delle Nazioni Unite,
nel 2008 il Kosovo ha proclamato la propria indipendenza ottenendo il riconoscimento da molti
Stati europei e dagli Stati Uniti, nonché, nel 2010, dalla Corte Internazionale di Giustizia che l’ha
valutata non contraria al diritto internazionale, nonostante la Serbia continui a non riconoscerne la
secessione. Le problematiche legate al riconoscimento della sovranità del Parlamento Kosovaro si
sono sentite anche all’interno del mondo sviluppato; nell’ambito dell’Unione Europea, fortemente
contrari sono, ad esempio, Stati come Grecia e Spagna, preoccupati per l’innescarsi di
rivendicazioni all’interno della loro compagine statale ad opera delle minoranze etniche; paure,
queste, condivise anche da Russia e Cina, che temono la possibilità che ciò crei effetti a catena nel
loro territorio.
Sta di fatto che il comportamento della stessa comunità internazionale dinnanzi alle rivendicazioni
etniche, appare tutt’altro che uniforme; pronti a riconoscere l’autoproclamazione del Kosovo,
negano, ad esempio tale possibilità ai territori georgiani dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia. Ma il
problema etnico in Kosovo appare più complesso di quanto non si possa immaginare; il nuovo
Stato, infatti, non ha una identità etnica definita e distinta, in quanto l’etnia albanese si sente legata
a quella dell’Albania e per nulla autonoma rispetto ad essa; a ciò si aggiunga che, nello spazio
territoriale kosovaro, mancano almeno le tre municipalità del Kosovo orientale che si trovano nella
Serbia meridionale, per cui la autoproclamazione d’indipendenza, tra riconoscimenti e non, di fatto,
più che chiudere una pagina di storia, ne apre una ben più complessa e di difficile soluzione 1.
Il problema delle minoranze etniche, che si manifesta in modo violento in Asia ed Africa, dunque,
accomuna tutti i popoli del globo, ivi compresi i territori più sviluppati in cui, però, si articola in
maniera parzialmente diversa e mette costantemente sotto tensione territorio e sovranità, cardini
dello stato moderno.
1 Limes, Rivista italiana di geopolitica, Kosovo, non solo Balcani, n.2/2008.
Guy Heraud classifica la tendenza all’autonomia delle minoranze secondo una scala composta da
cinque gradini: auto-affermazione, come volontà di dichiarare la propria esistenza ed
eventualmente la propria autodeterminazione (Corsi); auto-definizione, come diritto ulteriore al
riconoscimento di un proprio territorio (Palestinesi); secessione, come nel caso dell’Irlanda del
Nord o del Kosovo; auto-organizzazione, come facoltà di dotarsi di apparati giudiziari e
amministrativi propri (Galles); autogestione, come facoltà di amministrarsi autonomamente come
per gli altoatesini (Heraud, 1966; Lizza, 2008).
La tendenza all’autonomia è correlata alla percezione della identità etnica, che Salvi distingue in
quattro livelli: debole percezione di una specificità culturale, come nel caso dei bretoni; percezione
di una diversità rispetto al resto della popolazione, come nel caso dei sardi e, me lo si consenta, dei
siciliani; percezione di diversità ed opposizione, come per i Baschi; percezione di diversità ed
opposizione unita a misure di ostilità, come nel caso dell’Irlanda del Nord (Salvi, 1975).
Ciò che si può trarre da tali distinzioni è che l’etnicità, al di là di classificazioni definitorie,
rappresenta una percezione di appartenenza in cui l’elemento psicologico-soggettivo, pur suffragato
da un comune sostrato storico-culturale, rimane la componente essenziale. In questa prospettiva, il
concetto di etnia e di razza spesso si confondono, essendo per entrambe fondamentale il richiamo ad
una origine comune.
Il complesso rapporto tra etnie, razze e lingue è stato oggetto di studio del genetista italiano Cavalli
Sforza, riconosciuto come uno dei più autorevoli studiosi di genetica della popolazione, il cui lavoro
è caratterizzato da un approccio multidisciplinare che combina genetica, archeologia, linguistica e
demografia storica, ricostruendo la storia e la geografia dei popoli, attraverso le tracce rinvenute nei
geni dell’uomo moderno (Cavalli Sforza, 1996; Cavalli Sfroza, 2007); attraverso lo studio della
distribuzione geografica delle mutazioni genetiche, egli racconta la storia della diversità umana
superando il tentativo di classificare la specie umana in razze, anche in considerazione della
instabilità del concetto e della gradualità delle variazioni delle stesse (Cavalli Sforza, 1997).
Negando l’esistenza di razze, le differenziazioni rinvenibili nei tratti genetici e somatici, dunque,
vengono ricondotte esclusivamente all’adattamento geografico ambientale.
In questa prospettiva, il concetto di razza non è che frutto di costruzione ideologica e rappresenta un
esempio perfetto di come si costruiscano le identità che, a differenza dell’etnia o della cultura
locale, secondo Fouberg et al., sono assegnate ed imposte da vincoli esterni, storici e sociali
(Fouberg, Murphy, de Blij,2010). Accade spesso, infatti, che gruppi contrapposti, ricorrano alla
giustificazione etnica proprio quando presunte differenziazioni razziali non giustificano differenze
tra gruppi omogenei: è il caso, per esempio, dell’Ulster, della Spagna, della ex-Jugoslavia e dello
stesso Ruanda, in cui popolazioni somaticamente omogenee si scontrano portando la
differenziazione etnica come giustificazione.
Nonostante gli ovvi distinguo da fare tra razza ed etnia, è innegabile comunque, come nella
stragrande maggioranza dei casi i caratteri immateriali delle etnie si accompagnano a particolari
tratti somatici o peculiarità fisiche che, tuttavia, rappresentano delle mere coincidenze non
essendovi nessun altro legame rinvenibile, né un nesso causale tra discendenza genetico-razziale ed
appartenenza etnica (Cerreti, Fusco, 2007).
Volendo rinvenire le cause dei conflitti etnici, esse possono essere ricondotte a fattori politici,
religiosi, economici, culturali e demografici. In particolare, il nesso tra rivendicazioni etniche ed
economia, spesso sottovalutato nel pensiero scientifico, appare oggi evidente non solo nei paesi
meno sviluppati, ma all’interno dello stesso “Primo Mondo”. Buona parte delle minoranze etniche
si trova, infatti, in condizione di inferiorità economica più o meno accentuata, rispetto al resto della
popolazione dello Stato, il che costituisce un ulteriore incentivo per far fronte comune ed ottenere,
oltre al riconoscimento, migliori condizioni di vita.
Ancora una volta i conflitti in Irlanda del Nord forniscono uno spunto di riflessione: genericamente
ricondotti a contrasti religiosi, linguistici e culturali, hanno nella inferiorità economica e sociale
della comunità irlandese rispetto a quella inglese, la propria causa scatenante (Lizza, 2008). Lo
stesso dicasi per la comunità francese in Canada, che conta un attivo movimento separatista in
Quèbec e per quella degli Inuit, che hanno visto riconosciuto nel 1999 il proprio Territorio
autonomo di Nunavut, lasciato all’autogoverno del popolo di etnia eschimese (Lizza, 2008).
Motivazioni economiche unite alle diversità etnico-religiose, sono poi alla base della crescente
instabilità del territorio ceceno, a maggioranza islamica e ricco di petrolio, che nel 1991 ha
dichiarato la propria indipendenza non riconosciuta dal governo di Mosca e che, insieme alle altre
repubbliche caucasiche russe (Dagehstan, Inguscezia, Ossezia e Cabardino-Balcaria) è tutt’ora
teatro di azioni di guerriglia violentemente sedate dall’esercito russo, nonostante il formale ritiro
delle truppe nel 2009. C’è chi, di contro, non riconosce la valenza dei fattori economici quali cause
scatenanti i conflitti etnici: per Connor, ad esempio, le discriminazioni economiche possono agire
esclusivamente come fattori rinforzanti ma non determinanti una conflittualità che si basa sull’etnia
(Connor, 1995).
Lizza distingue ancora tra conflitti politici, aventi ad oggetto i poteri dello Stato, conflitti politico-
culturali, qualora riguardino la storia e la memoria manipolate dal potere politico, geosociali, come
le lotte di classe e quelle conseguenti alle deportazioni territoriali, religiosi e socio-economici, che
attengono principalmente alle risorse alimentari ed energetiche (Lizza, 2008).
Quali che siano le cause scatenanti, sta di fatto che le società contemporanee, ricche o povere,
appaiono sempre più frammentate nel loro interno dalla riscoperta di identità di gruppo, etniche,
religiose e culturali, di cui è necessario attenzionare il crescente ruolo sociale, per fornire adeguate
risposte politiche che garantiscano la sopravvivenza dei gruppi minoritari attraverso una
integrazione che, lungi dal portare alla omologazione assimilante, consenta la preservazione di
lingua, cultura, religione ed ambiente in cui vivono, consentendo, altresì, la possibilità di progredire
socialmente ed economicamente. Crescono esponenzialmente, infatti, nel mondo, i popoli dichiarati
in pericolo di estinzione dalle organizzazioni internazionali: tuareg, azeri, armeni, peruviani,
moquitos, indios, curdi, somali, sono solo alcune delle etnie che, a causa di violente repressioni,
persecuzioni, guerre etniche, rischiano di scomparire.
Le problematiche relative a curdi ed armeni sono un esempio della complessità dei problemi e della
difficoltà delle soluzioni. I primi, disseminati tra Turchia, Iraq, Iran, Siria ed Armenia, dopo aver
ottenuto formalmente il diritto all’autodeterminazione nel 1918 nonché, col trattato di Sevres del
1920, l’impegno per la creazione di un Kurdistan indipendente, furono dimenticati dalle potenze
occidentali e divennero oggetto di deportazioni, persecuzioni, massacri, nonché di tentativi più o
meno forzati di assimilazione ai popoli degli stati di appartenenza; il Kurdistan turco, continua ad
essere terreno di scontro tra i miliziani del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan) e l’esercito
turco, sconfinando sovente in territorio iracheno ove costituisce, stante il vuoto di potere, uno dei
più pericolosi focolai di tensione nel medio oriente. Il supporto che i curdi iracheni forniscono ai
ribelli attivi in territorio turco, continua, inoltre, a determinare scontri crescenti con lo Stato turco
che, soprattutto in vista del ritiro delle truppe U.S.A., teme il formarsi di una autonoma identità
curda.
La diaspora armena, similmente a quella curda, è stata alimentata soprattutto dalle persecuzioni e
dalle stragi operate dall’impero ottomano dalla fine del XIX secolo e dai movimenti kemalisti tra la
Prima e la Seconda Guerra Mondiale. La dispersione del popolo armeno si è diretta soprattutto negli
U.S.A., in Georgia e Azerbaijan, poi in Francia, Libano, Siria e Argentina; comunità armene
numerose sono comunque ancora presenti nelle grandi città dell’Europa mediterranea (Dagradi,
2006). Oggi, l’Armenia, ex repubblica dell’Urss, proclamatasi indipendente nel 1991, riavvicinatasi
politicamente alla Turchia in tempi molto recenti, continua ad essere teatro di scontri col vicino
Azerbaijan per il controllo del Nagorno-Karabah, territorio azero a maggioranza armena.
Ma nessun continente è esente da fermenti etnici più o meno violenti; il continente africano, patria
di tribalismi, anche come conseguenza del recente passato coloniale, è scosso al suo interno da
scontri che vanno dalla Nigeria al Sudafrica, dal Ruanda al Marocco, dal Burundi all’Uganda,
passando attraverso Sudan, Algeria, Tanzania, Congo ed Egitto. Anche i recenti avvenimenti in
Libia, sembrano per molti condurre ad un futuro in cui il sistema tribale sarà determinante per
l’equilibrio del potere, spezzato proprio dalla rottura del patto tribale siglato tra Gheddafi e gli
esponenti delle tribù nord-Africane (Moisseron, 2011); a ciò si aggiunga che tutta la regione, scossa
dalle rivoluzioni che dalla Tunisia si propagano sino all’Egitto, è teatro di grande instabilità politica
e geopolitica, dinnanzi alla quale lo stesso mondo arabo appare diviso e nella quale riemergono,
prepotentemente, le antiche rivalità, prima fra tutte quelle tra sciiti e sunniti.
L’Europa occidentale è scossa dai fermenti dei paesi baschi, dei catalani, dell’Ulster e, pur se con
minore risonanza, degli indipendentisti corsi ed altoatesini; l’Asia, d’altra parte, si dibatte tra le
tensioni mediorientali in Israele, Libano, Iran, Pakistan, Yemen, Afganistan e Siria e le
problematiche di Timor Orientale e Borneo in Indonesia, passando attraverso il Caucaso e le
repubbliche ex-sovietiche, teatro di pesanti scontri tra etnie diverse, magistralmente e
volontariamente mescolate dall’impero comunista nel tentativo di controllarne lo spirito
indipendentista; la stessa America settentrionale, dal Canada al Messico del Sud, trema sotto le
rivendicazioni etniche e conosce revival di comunità, come quelle nere negli Stati Uniti, da tempo
integrate nel tessuto sociale dei luoghi.
L’appartenenza a gruppi etno-culturali, dunque, lungi dall’essersi attenuata come previsto da
Weber, sembra essere tornata agli onori della cronaca, spesso come reazione inconscia ad un mondo
globalizzato ed omologante ed alle forme di stato accentratore che tende a schiacciare le diversità,
in nome di una unità spesso inesistente.
Nella connotazione identitaria dei gruppi etnici rientra sovente la lingua, che rappresenta uno dei
principali catalizzatori di coesione tra gli individui, nonché elemento fondamentale della cultura
locale e motore propulsore delle diversità delle minoranze comunemente indicate, infatti, come
minoranze etno-linguistiche. Il geografo Roland Breton, sottolineando l’interconnessione tra spazio
linguistico e spazio geografico, evidenzia come, a tutt’oggi, si assista ad una proliferazione dei
conflitti linguistici, nonché all’utilizzo di vere e proprie politiche linguistiche determinanti la
scomparsa di gruppi minoritari (Breton, 1991). Sotto un profilo geopolitico, è innegabile come la
lingua, elemento di identificazione di luoghi, territori e culture e strumento di potere utilizzato,
soprattutto in passato, per la assimilazione dei popoli conquistati, possa rappresentare un ulteriore
elemento di conflittualità tra etnie e gruppi appartenenti alla stessa compagine statale. Tale valenza
nell’ambito dei contesti post-coloniali e nelle società multietniche è semplice da cogliere; ma
l’utilizzo dell’arma linguistica nell’ambito di conflitti culturali e politici, è rinvenibile anche nel
mondo sviluppato, come testimoniano le problematiche connesse al bilinguismo in Canada o all’uso
dello spagnolo negli Stati Uniti; appare impossibile negare, d’altronde, la valenza della dimensione
linguistica tra le condizioni che alimentano, ad esempio, la spaccatura in Belgio tra nord
neerlandofono e sud francofono o le rivendicazioni di baschi e catalani in Spagna. Accade inoltre,
che la contrapposizione etnica venga amplificata da scelte politiche, come in Slovacchia, dove
l’approvazione nel 2010 della legge che limita fortemente l’utilizzo delle lingue diverse dallo
slovacco, ha aumentato il malcontento della minoranza ungherese, che costituisce il 10% della
popolazione totale.
Al pari della lingua, la religione, catalizzatrice di unità tra gli individui e potente fattore di
identificazione, nel secolo della globalizzazione e della crisi delle grandi ideologie, sembra
assumere una valenza politica sempre più spiccata, ponendosi sempre più frequentemente alla base
dell’intensificarsi dei conflitti e delle tensioni cui si assiste in tutto il mondo. In Europa, ad esempio,
alla tradizionale connotazione etnico-religiosa delle ostilità nell’area balcanica, si è aggiunta quella
delle ex repubbliche sovietiche, della Turchia, della Macedonia e dell’Ucraina, per non parlare dei
conflitti potenziali in Ungheria, Slovacchia, Romania, ma anche in Italia e Francia, che riguardano
il delicato problema dei rom.; ma ovunque, dagli scontri etno-tribali africani, a quelli politico-
religiosi mediorientali, il globo è attraversato da un revival etnico-religioso, ove i fondamentalismi
trovano nuovi proseliti, nel vuoto lasciato dalla politica, dall’economia, dalla deterritorializzazione
e dalla modernizzazione (Lizza, 2009).
Il panorama geopolitico multietnico globale, viene poi arricchito ulteriormente da quelle minoranze
per così dire spontanee, formate dai gruppi di immigrati.
La mobilità territoriale rappresenta uno dei fenomeni più tipici ed antichi delle società umane; la
stessa diffusione della specie homo sulla superficie terrestre è stata determinata proprio dalle grandi
migrazioni avvenute in epoca preistorica dal continente africano agli altri territori, in
corrispondenza di esplosioni demografiche o alla ricerca di nuove risorse. Il mosaico di popoli del
mondo rappresenta, dunque, il risultato di spostamenti volontari o coatti, di colonizzazioni, esodi e
diaspore che si sono succeduti nei millenni a ritmo variabile in tutti gli spazi geografici del globo
(Dagradi, 2006), ma che oggi, sospinti dalla globalizzazione culturale, economica e delle
comunicazioni, diviene un fenomeno mondiale. L’arrivo di gruppi di individui spesso consistenti
provenienti da realtà geoculturali, geopolitiche e geoeconomiche differenti, comporta
irrimediabilmente una modifica nelle realtà sociali, economiche e culturali delle regioni di arrivo,
con un impatto non semplice e spesso segnato da fenomeni di intolleranza; quanto maggiori sono,
infatti, le distanze culturali, religiose, sociali e di stile di vita tra i gruppi ospitati e quelli ospitanti,
tanto superiori sono le possibili reazioni di rigetto da parte delle popolazioni autoctone, che possono
dar vita a discriminazioni consentite dalla legge, con veri e propri oneri imposti agli immigrati, con
discriminazioni indirette o con semplici atteggiamenti di ostilità (Barbina, 2005).
Ovunque, pertanto, le problematiche connesse con la integrazione degli immigrati facendo salva
l’omogeneità dello Stato ed il rispetto dell’identità degli immigrati, sono oggetto di specifiche
politiche in materia, cui si aggiunge il rilievo crescente che esse assumono nella agenda
internazionale. L’evoluzione dell’approccio politico-legislativo alle problematiche connesse alle
grandi migrazioni internazionali, d’altronde, dipende non solo dall’incrementarsi del fenomeno in
tempi recenti, ma anche dalla percezione e dall’impatto emotivo che esse hanno suscitato nei paesi
di arrivo e in quelli di partenza (Boggio, De Matteis, Memoli, 2008).
Dall’analisi politico-territoriale effettuata è possibile, a livello esemplificativo, classificare i gruppi
etnici in base al contesto politico e geopolitico in cui si trovano, che contribuisce a determinare
tanto la connotazione ideologica, quanto la tendenza all’autonomia e la percezione di diversità che
essi assumono. Nell’ambito dei Paesi multietnici e multinazionali per definizione, i gruppi etnici
fondano la propria identità sulla lingua, come in Svizzera o in Belgio, sulla religione, si pensi a
sikh, musulmani e indù in India, sulla nazionalità, come nei territori dell’ex blocco sovietico, e sulla
razza, come nel caso del Sudafrica. Negli Stati che non si autodefiniscono multietnici, di contro, tra
cui rientrano, ad esempio, i paesi africani, la Turchia, il Giappone, ma anche molti Stati occidentali,
le minoranze spesso si concentrano in una dimensione territoriale regionale, quali Bretoni e Corsi in
Francia ad esempio, o basano la propria specificità su connotazioni razziali, come nelle comunità
afroamericane negli States, o su discriminanti religiose, si pensi ai copti in Egitto recenti
protagonisti di atti di persecuzione violenta, o, infine, linguistiche e tribali, come i berberi in
Algeria o le tribù in Libia. Molto spesso accade che un’etnia minoritaria in uno Stato corrisponda a
quella maggioritaria in un altro: gli ungheresi in Romania, i Turchi in Bulgaria, gli ispanici negli
Stati Uniti sono solo esempi più eclatanti di tale situazione peculiare.
Per comprendere appieno come tutti i fenomeni finora accennati contribuiscano a determinare
quella che unanimemente è riconosciuta come crisi del concetto di Stato, è necessario analizzarne le
ripercussioni sugli elementi essenziali delle organizzazioni politiche e sociali nazionali: territorio,
popolo e sovranità. La globalizzazione ha determinato il crollo delle barriere e dei confini nazionali,
innescando processi di deterritorializzazione che riguardano non solo l’economia, ma la stessa
politica; persino la politica militare, dopo i recenti avvenimenti, cambia in relazione ai mutamenti di
conflitti derivanti da una minaccia, quella del terrorismo transnazionale, che travalica i confini
territoriali. Al contempo, però, la consapevolezza che la sussidiarietà risponda alle esigenze di
comunità infrastatali caratterizzate da interessi omogenei, implica la devoluzione di buona parte dei
poteri dello Stato a Regioni, Province ed organizzazioni territoriali geograficamente più limitate. Da
un lato, dunque, i territori nazionali risultano costituiti da molti spazi; dall’altro ed allo stesso
tempo, uno stesso spazio può attraversare trasversalmente più territori.
Ma la globalizzazione, oltre che fenomeno economico e politico, è un fenomeno sociale e culturale
che determina profondi mutamenti anche nel concetto di popolo. Il principale fattore di
cambiamento può ricollegarsi alla mobilità transnazionale delle professioni, causa di nuovi processi
migratori. Le diverse identità dei popoli, così faticosamente e spesso violentemente costruite,
riscoperte, esaltate nei secoli precedenti, si mescolano fra loro, si giustappongono, si fondono o
tentano affannosamente di coesistere all’interno degli stessi territori. Si vengono a creare, così,
nazioni plurietniche, in cui religioni, costumi, lingue, culture, identità profondamente diversi
coesistono e pongono continui problemi che la politica degli Stati nazionali si trova a dover
affrontare.
I fenomeni di deterritorializzazione e lo smembramento delle rigide identità dei popoli,
conseguenza inevitabile dei processi di interdipendenza globale, incrinano, dunque, il tradizionale
concetto “geocentrico” dello Stato. Ma è la proliferazione di centri politici, economici, etnici e
sociali differenti, a ridimensionare la sovranità, potere fondamentale dello Stato-Nazione. Il
coinvolgimento progressivo negli ultimi quarant’anni della società civile nei processi politici, è
sicuramente uno dei fenomeni più dirompenti di trasformazione dei poteri; le componenti,
distinguibili in organizzazioni religiose e sociali, organizzazioni per i diritti civili e organizzazioni
per la tutela e la preservazione delle culture locali e dei gruppi etnici, hanno ridisegnato il panorama
politico e territoriale, trascendendo i confini geografici degli Stati nazione (Rifkin, 2005).
Sta di fatto che la gestione delle minoranze è un problema sostanzialmente politico, che riguarda,
però, elementi ideologici di difficile valutazione ed implica una valutazione di ordine culturale che
può oscillare tra due atteggiamenti estremi di protezionismo e relativismo culturale ed
abolizionismo o integrazione/omologazione delle diversità culturali (Cerreti, Fusco, 2007); in
questa prospettiva, le caratteristiche di ogni singola etnia, assumono una rilevanza notevole
nell’ambito della geografia politica ed economica e della geopolitica, in quanto in grado di
influenzare gli equilibri territoriali delle singole regioni del pianeta.
Nel quadro degli assetti geopolitici mondiali, il desiderio di identità porta all’esaltazione, spesso
esasperazione, delle peculiarità etnico-culturali in un nuovo mondo in cui, secondo Huttington, i
conflitti più profondi non sono generati dagli scontri socio-economici, ma tra gruppi appartenenti ad
etnie e culture diverse ed all’interno delle stesse civiltà, tra gruppi tribali ed etnici (Huttington,
2000). Le posizioni di Huttington, profondamente criticate soprattutto in considerazione delle
semplificazioni con cui definisce le frontiere delle civiltà contrapposte (Ramonet, 2008), a mio
parere, nascondono una verità provocatoria di fondo che non può che essere sotto gli occhi di tutti;
al di là di valutazioni di merito circa i valori espressi da civiltà ed etnie, un revival delle componenti
etno-culturali, delle peculiarità degli aspetti delle singole civiltà, è oggi in proliferazione continua in
tutto il globo, ivi compreso il mondo sviluppato ed occidentale che sembrava, all’indomani della
fine del conflitto bipolare, lanciato verso un universalismo dai più definito omologante.
Il nuovo mondo globale e globalizzato, nonostante sia caratterizzato dalla sparizione di confini e da
una elevata mobilità, si rivela, pertanto, lontano dall’idea di cosmopolis sostenuta da filosofi e
pensatori universalisti, ma è sempre più caratterizzato da individualismi di massa che ne scuotono le
fondamenta e ne ridisegnano i contorni geografico-territoriali, con una escalation di violenza e di
contrapposizione che fa tremare Stati, Nazioni, confini e territori, e consegna al nuovo millennio,
l’arduo compito di identificare spiegazioni e trovare soluzioni adeguate che preservino lo Stato,
tutt’ora considerato come la cellula fondamentale dell’organizzazione politica, ma lo rendano una
realtà multiculturale in cui la coesistenza tra etnie, religioni, lingue e culture diverse, venga sancita
ufficialmente e garantita inequivocabilmente sotto il profilo politico, economico e sociale, in modo
da eliminare ogni residua conflittualità tra i popoli.
BIBLIOGRAFIA
Agew J., 2003, Fare geografia politica, FrancoAngeli, Milano.
Angeli A., Salvini S., 2007, Popolazione e sviluppo nelle regioni del mondo, Il Mulino, Bologna.
Annuario economico e geopolitica mondiale, Stato del mondo 2003, Hoepli Editore, Milano, 2003.
Atlan C.T., 1995, Ethnos e civiltà, identità etnica e valori democratici, Feltrinelli, Milano.
Atlante Geopolitico Mondiale, 2002, Regioni, Società, Economie, Conflitti, Touring Editore,
Milano.
Bauman G., 2003, L’enigma multiculturale. Stati, etnie, religioni, Il Mulino, Bologna.
Bernardi U., 2004, Culture e integrazione. Uniti nella diversità, FrancoAngeli, Milano.
Boggio F., De Matteis G., Memoli M., 2008, Geografia dello sviluppo, Utet, Torino.
Breton R., 1991, Geografia delle lingue, Marsilio Editore, Venezia.
Calendario Atlante De Agostini, 2011, Istututo Geografico De Agostini, Novara, 2010.
Capotorti F., 1992, Il regime delle minoranze nel sistema delle Nazioni Unite e secondo l’art. 27 del
Patto sui diritti civili e politici, in “Rivista internazionale dei diritti dell’uomo”, 1992, pp. 107 ss
Casari M., Corna Pellegrini G., Eva F., 2003, Elementi di geografia politica ed economica, Carocci,
Roma.
Cassese S., 2001, La crisi dello Stato, Laterza Editore, Bari.
Cavalli Sforza L.L., 1996, Geni, popoli, lingue, Adelphi, Milano.
Cavalli Sforza L.L., 1997, Storia e geografia dei geni umani, Adelphi, Milano.
Cavalli Sforza L.L., 2007, Il caso e la necessità, Di Renzo Editore, Roma.
Cerreti C., Fusco N., 2007, Geografia e minoranze, Carocci, Roma.
Chiodi G.M., 2002, Europa, universalità e pluralismo delle culture, Giappichelli, Torino.
Claval P., 1996, Geopolitica e geostrategia, Zanichelli, Bologna.
Connor W., 1995, Etnonazionalismo: quando e perché emergono le nazioni, Dedalo, Bari.
Corna Pellegrini G., 2004, La terra degli uomini, Carocci, Roma.
Corna Pellegrini G., 2010, Paesi e popoli nel mondo, UTET, Torino.
Cotesta V., 1999, Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e società multiculturale,
Laterza, Bari.
Dagradi P., 2006, Geografia della popolazione, Patron Editore, Bologna.
Epasto S., 2007, Europa e Unione Europea tra pensiero politico, territorio e dinamiche
geopolitiche, EDAS, Messina.
Epasto S., Aspetti, temi e problemi di geografia culturale in Europa, in Rivista Vega, anno I, n.2
(agosto 2005).
Epasto S., 2005, Un momento pregnante nella affermazione delle identità culturali in Europa: il
nazionalismo, le sue origini, la sua evoluzione, la complessità dei suoi aspetti, in Quaderni per la
ricerca geografica, Edizioni Sfameni, Messina.
Facchi A., 2001, I diritti dell’Europa multiculturale, Laterza, Roma-Bari.
Ferrarotti F., 2003, La convivenza delle culture, Edizioni Dedalo.
Fouberg E.H., Murphy A.B., de Blij H.J., 2010, Geografia umana, Zanichelli, Bologna.
Giorda C., Scarpocchi C., 2010, Insegnare la geopolitica, Carocci, Roma.
Heraud G., 1966, Popoli e lingue d’Europa, Ferro edizioni.
Huntington S.P., 2000, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, Milano.
Kellas J.G, 1999, Nazionalismi ed etnie, Il Mulino, Bologna.
Kymlicka W., 1999, La cittadinanza multiculturale, Il Mulino, Bologna.
Limes, Rivista italiana di geopolitica, Il grande tsunami, n.1/2011.
Limes, Rivista italiana di geopolitica, Kosovo, non solo Balcani, n.2/2008.
Lizza G., 2008, Geopolitica, UTET, Torino.
Lizza G., 2009, Scenari geopolitici, UTET, Torino.
M. Kaldor M., 1999, Le nuove guerre, Carocci, Roma.
Marcon G., 2000, Dopo il Kosovo, Asterios Editore, Trieste.
Moisseron J., 2011, Libye. La rupture du pacte tribal, Liberation, 24.02.1011
Ortica P., Saija M. (a cura di), 2001, La guerra del Kosovo e la Questione balcanica, Rubbettino
Editore, Catanzaro.
Ramonet I., 2008, Geopolitica del caos, Asterios Editore, Trieste.
Rifkin J., 2004, Il sogno europeo, Mondadori, Milano.
Salvi, S., 1975, Le lingue tagliate, Rizzoli, Milano.
Smith A.D., 1984, Il revival etnico, Il Mulino, Bologna.
Smith A.D., 1998, Le origini etniche delle nazioni, Il Mulino, Bologna.
Smith A.D., 2000, Gruppi etnici, nazioni e nazionalismo, in Treccani 2000, Eredità del Novecento,
Roma.
Weber M., 1922, Economia e Società, Edizioni di Comunità, Milano, 1999.
















![Alter Ego. Identità e alterità nella società mediale contemporanea [vol.2]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631dc0fadc32ad07f3073c96/alter-ego-identita-e-alterita-nella-societa-mediale-contemporanea-vol2.jpg)