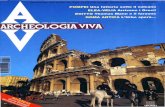BARBARA VISENTIN, Identità signorili e sistemi di gestione tra età longobarda e normanna. Le terre...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of BARBARA VISENTIN, Identità signorili e sistemi di gestione tra età longobarda e normanna. Le terre...
ArNoSARCHIVIO NORMANNO-SVEVO
Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIIIdel Centro Europeo di Studi Normanni
Texts and Studies in Euro-Mediterranean World during XIth-XIIIth Centuries
of Centro Europeo di Studi Normanni
3
2011/2012
Miscellanea Claudio Leonardi
Centro Europeo di Studi NormanniAriano Irpino
ArNoSARCHIVIO NORMANNO-SVEVO
Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII del Centro Europeo di Studi Normanni
COMITATO SCIENTIFICO
G. Arnaldi, Th. Asbridge, P. Bouet, M. Caravale, G. Coppola, F. Delle Donne, M. D’Onofrio, H. Enzensberger, S. Fodale, C.D. Fonseca,
J. France, G. Galasso, V. Gazeau, E.C. van Houts, Th. Kölzer, C. Leonardi (†), O. Limone, G.A. Loud, J.M. Martin, E. Mazzarese Fardella, F. Neveux,
M. Oldoni, F. Panarelli, A. Paravicini Bagliani, A. Romano, V. Sivo, W. Stürner, A.L. Trombetti, H. Takayama, S. Tramontana
SEGRETERIA DI REDAZIONEL. Russo, T. De Angelis
COMITATO DI DIREZIONEA. Cernigliaro, E. Cuozzo, E. D’Angelo, O. Zecchino
© 2012 Centro Europeo di Studi Normanni
ISSN: 2036-7759ISBN: 978-88-98028-00-9
Fulvio Delle Donne, Le iscrizioni del mausoleo di Boemondo d’Al-tavilla a Canosa
Francesco Panarelli, Le origini del monastero femminile delle SS. Lucia e Agata a Matera e la famiglia di Maione di Bari
BarBara visentin, Identità signorili e sistemi di gestione tra IX e XII secolo. Le terre del Castrum Iufuni e la Trinità di Cava
lamia HaDDa, Il bassorilievo di Mahdiya. Vicende storico-artistiche tra Ziridi e Normanni nel Mediterraneo medievale (XI-XII sec.)
mario r. ZeccHino, Recenti ritrovamenti di monete medievali in Irpinia
Benoît Grévin, Un dictator peut en cacher un autre… À propos de la lettre «Expectantes expectavimus-noscitis emanasse» et de la jeunesse de Pierre de la Vigne
teoFilo De anGelis, Note propedeutiche all’edizione del libro VI del cosiddetto Epistolario di Pier della Vigna
Fulvio Delle Donne, Su un codice stravagante del cosiddetto Epistola-rio di Pier della Vigna: Innsbruck, Universitäts-bibliothek, 400
rosanna lamBoGlia, Aspetti della guerra del Vespro: il biennio 1296-1298 nella prospettiva di Federico III, re di Sicilia, e di Ruggero di Lauria
Giovanni coPPola - carmine meGna, Due castelli medievali in ter-ra d’Irpinia: Avella e Summonte
Recensioni e schede
7
19
33
59
69
89
105
113
121
153
179
arnos 3 (2012)
sommario
IDENTITÀ SIGNORILI E SISTEMI DI GESTIONE TRA ETÀ LONGOBARDA E NORMANNA.LE TERRE DEL CASTRUM IUFUNI E LA
TRINITÀ DI CAVA
BarBara Visentin
L’abbazia di Cava, con le trasformazioni avvenute soprattutto in età normanna, offre una prospettiva forse periferica, ma senz’altro signifi-cativa per la ricostruzione del processo di dissoluzione dell’ordinamento pubblico carolingio, che rappresenta uno dei temi più rilevanti del dibat-tito storiografico. Nel corso della metà del IX secolo, in quasi tutte le regioni dell’Europa occidentale, comprese nei confini della grande co-struzione carolingia, si evidenziano difficoltà di conduzione dell’appara-to statale, di gestione delle forme di successione ereditaria e di esercizio del controllo e della difesa militare sulle terre imperiali.
Cambiamenti evidenti segnano la crisi dalla quale prende forma la creazione di un mondo nuovo, dotato di grande dinamismo e caratte-rizzato da una propria specificità, nel quale il cardine degli assetti po-litico-istituzionali, socio-economici e insediativi diviene la signoria ru-rale1. Nuclei di potere autonomi a carattere locale, variamente indicati dalle fonti come dominatus, potestas, consuetudo, districtus, traggono vigore dallo scardinamento dell’ordinamento pubblico ed esercitano il potere attraverso la disponibilità di un consistente contingente militare e di un cospicuo patrimonio fondiario2. La profonda trasformazione giunge a compimento nella seconda metà dell’XI secolo, determinando in molti
1 Per una panoramica generale sulla nascita della signoria si veda la lezione di s. CaroCCi, Signori, castelli, feudi in Storia Medievale, Roma 1999, pp. 247-267 e la bibliografia citata.
2 Cfr. G. taBaCCo, Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano, Torino 1976, pp. 189-206.
BarBara Visentin34
casi un’evoluzione del grande patrimonio fondiario secondo un percorso insieme economico e politico che, dalla semplice signoria fondiaria, lo converte in quella comunemente definita signoria di ‘banno’3.
In questo quadro s’inseriscono le vicende dell’antico Ducato di Be-nevento, dove il primo sentore di tale frammentazione appare manifesto nella spartizione della contea di Capua che i discendenti del gastaldo-conte Landolfo mettono in campo, arrivando perfino, tra l’879 e l’882, a sancire una duplicazione della sede vescovile della città4. Nel Mezzogior-no longobardo del IX secolo munirsi di una fortezza significa dichiarare apertamente la propria volontà di autonomia, mostrare di possedere i mezzi militari per conquistarla e dare prova di essere politicamente ac-corti per amministrarla. Beni fondiari, nuclei abitati, eserciti si organizza-no intorno a castra già esistenti o di nuova fondazione, permettendo ad ognuno dei beneficiari di dar vita alla propria ‘signoria territoriale’, la cui salvaguardia mina talvolta i principi di sopravvivenza della propria gens5. Frutto di questo stesso processo di evoluzione delle istituzioni pubbli-che è la vicenda del dominatus loci di Giffoni che, inserito nel panorama complesso del Principato di Salerno, presenta tempi e modi differenti di affermazione, ricoprendo un ruolo importante nel cambiamento radica-le della scena politica tra XI e XII secolo.
3 Nel primo caso il dominus era chiamato ad esercitare un possesso esclusivamente circoscritto alla terra, mentre nel secondo il dominio del signore, relativo questa volta ad un distretto ben definito nei suoi confini, prevedeva anche il diritto di coercizione e di comando nei confronti dei subiecti e costituiva, dunque, un potere fortemente territoria-lizzato. Nel secolo X definire ‘bannale’ un potere significava essenzialmente voler sotto-lineare il carattere pubblico di alcune emergenti forze locali al fine di legittimarle. Cfr. a. BarBero - C. FruGoni, Dizionario del Medioevo, Bari 2008, pp. 26-27.
4 Cfr. erChemperto, Historia Langobardorum Beneventanorum, ed. G. Waitz in M.G.H., Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum, Hannover 1964, pp. 231-264, cc. 40, 46, pp. 250, 254.
5 Cfr. n. Cilento, Le origini della Signoria capuana nella Langobardia minore, Roma 1966, p. 26, si veda anche taBaCCo, Egemonie sociali, pp. 171-179. Per approfondire il contesto capuano si rimanda a B. Visentin, Strategie politiche nella Capua longobarda: la difficile divisione della sede vescovile, «Nuova Rivista Storica» 91/2, 2007, pp. 447-458; id., La nuova Capua longobarda. Identità etnica e coscienza civica nel Mezzogiorno altomedievale, Manduria - Bari - Roma 2012. Di parere differente sono M. del treppo, Medioevo e Mezzogiorno: appunti per un bilancio storiografico, proposte per un’interpretazione, in Istituzioni e società nella storia d’Italia. Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo, cur. G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 265-268, e V. lorè, Uno spazio instabile. Capua e i suoi conti nella seconda metà del IX secolo, in Les élites et leurs espaces. Mobilité, rayonnement, nomination (du VI au XI siècle), cur. P. Depreux - F. Bou-gard - R. Le Jan, Turnhout 2007, pp. 341-359.
35Identità signorili e sistemi di gestione tra età longobarda e normanna
Nella primavera del 1052 Guaimario IV e suo fratello Paldolfo cado-no vittime di una violenta congiura, aprendo ufficialmente la crisi politi-ca del Principato e rendendo necessaria una sostanziale ristrutturazione degli ambiti territoriali gravitanti immediatamente intorno alla capitale. Qualche anno prima Guaimario aveva intrapreso la divisione del patri-monio familiare, mettendo fine all’unità patrimoniale, quale elemento fondante della solidarietà e dell’unità dinastica, promuovendo un’artico-lazione familiare del potere principesco e, di fatto, autorizzando le comu-nità monastiche esistenti ad impegnarsi in operazioni di concentrazione dei loro patrimoni fondiari6.
Il tentativo, però, di affermare la propria autorità attraverso la pre-senza di membri illustri della familia, ai quali sono destinate porzioni consistenti del patrimonio fondiario del principe o importanti funzioni pubbliche, ha vita breve e l’esperienza longobarda si avvia inesorabil-mente al tramonto7. I contesti di Capaccio e Giffoni consentono, tutta-via, di rintracciare gli eventi che segnano la vita di due rami della famiglia principesca, capaci di affermare la loro presenza, ben oltre la conquista normanna, all’interno di importanti centri fortificati, posti a controllo delle terre orientali dell’antico Principato longobardo8. La loro soprav-vivenza segna la nascita di importanti signorie locali, gravitanti attorno ad un castello dove, al riparo di una cinta fortificata, vivono la familia del dominus, i suoi fideles e gli homines subiecti, ai quali risultano concesse le terre circostanti.
Il potenziamento della fisionomia locale del potere, fondato su un controllo efficace del territorio e dei suoi abitanti, coincide con la fon-dazione di una delle più estese signorie fondiarie, l’abbazia della SS. Tri-nità di Cava, e con il momento di massimo ampliamento dell’orizzonte
6 Cfr. h. taViani Carozzi, La principauté lombarde de Salerne (IXe-XIe siècle). Pouvoir et société en Italie lombarde méridionale, II, Roma 1991 [Collection de l’École Française de Rome, CLII], pp. 857-865; 1079.
7 V. lorè, L’aristocrazia salernitana nell’XI secolo in Salerno nel XII secolo. Istituzioni, so-cietà, cultura, Atti del Convegno Internazionale Raito di Vietri sul Mare, Auditorium di Villa Guariglia 16-20 giugno 1999, cur. P. Delogu e P. Peduto, Salerno 2004, pp. 61-102, in particolare pp. 74-76, e id, Monasteri, principi, aristocrazie. La Trinità di Cava nei secoli XI e XII, Spoleto 2008, p. 25.
8 Per una storia più dettagliata dell’insediamento di Capaccio vecchia si rimanda a p. deloGu, Storia del sito, in Caputaquis Medievale, I, Salerno 1976, pp. 23-32 e per le relazioni con la SS. Trinità di Cava al recente saggio di B. Visentin, Poteri territoriali e affermazioni monastiche tra XI e XIII secolo: il dominatus loci di Capaccio e la SS. Trinità di Cava, «Rassegna Storica Salernitana» 57, giugno 2012, pp. 45-78.
BarBara Visentin36
patrimoniale della neonata comunità. Nel 1025 il principe di Salerno Guaimario III e suo figlio Guaimario IV danno vita all’atto di nascita del patrimonio monastico cavense, concedendo un ampio territorio, ri-cadente nella valle Metelliana e gravitante attorno alla grotta Arsicia, al fondatore della Trinità, Alferio principi eiusdem civitatis in magna familiaritate coniunctus est9.
Tra la seconda metà dell’XI e per tutto il XII secolo i monaci di Cava si mostrano capaci di tessere le fila di rapporti nuovi, ridisegnando gli orientamenti della loro strategia di affermazione, per inserirsi negli spazi che la conquista normanna crea. Questa alternanza costante tra adesione al vertice dell’ordinamento pubblico ed effettiva autonomia del mona-stero diventerà uno dei caratteri distintivi della storia della Trinità10. La dilatazione degli ambiti territoriali apre dinanzi all’abbazia cavense nuovi e fecondi orizzonti economici, culturali e spirituali dando vita, tra il 1070 e il 1180, ad un’intensa attività patrimoniale. Chiese, monasteri e posse-dimenti vari entrano nella proprietà monastica e consegnano la Trinità di Cava al rango di signoria fondiaria, a capo della quale siede l’abate, entrato definitivamente nella società del potere. Egli offre protezione e tutela agli uomini che abitano le sue terre, è un dominus a tutti gli effetti, capace di conciliare le esigenze dell’anima con quelle della sicurezza della propria persona e dei propri beni.
Il patrimonio acquisito proviene, nella maggior parte dei casi, da do-nazioni di principi longobardi, prima, di duchi e conti normanni, dopo, scaturite dall’esigenza di rimediare ad una vita peccaminosa e allo smar-rimento che il mistero della morte provoca o determinate dalla necessità di assicurare l’ufficio liturgico nelle chiese rurali e di ottemperare al prin-cipio riformatore che i laici non dispongano delle res ecclesiae11. Non man-
9 Si vedano le Vitae Quatuor Priorum Abbatum Cavensium, ed. l. Mattei Cerasoli, Bo-logna 1941 (Rerum Italicarum Scriptores, tomo VI, parte V), p. 5 e Codex Diplomaticus Ca-vensis, edd.. m. Morcaldi - m. Schiani - S. De Stefano - P. Piazzi, Milano - Pisa - Napoli 1873-1936, V, doc. 764, da questo momento citato come CDC. Per la rapida espansione cavense si rimanda anche al lavoro di p. Guillaume, Essai historique sur l’abbaye de Cava d’après des documents inédits, Badia di Cava 1877, pp. 50-52, da questo momento citato come Guillaume, Essai; G. Vitolo, Insediamenti cavensi in Puglia, Galatina 1984; B. Visentin, Il monachesimo dei grandi spazi aperti. I Cavensi in Lucania, Puglia e Calabria (secc. XI-XII), in Riforma della Chiesa, esperienze monastiche e poteri locali. La Badia di Cava e le sue dipendenze nel Mezzogiorno dei secoli XI-XII, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Badia di Cava dei Tirreni (SA), 15-17 settembre 2011, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, Firenze, in corso di stampa.
10 lorè, Monasteri, principi, aristocrazie, p. 24.11 Cfr. Vitolo, Insediamenti cavensi, pp. 12-14.
37Identità signorili e sistemi di gestione tra età longobarda e normanna
cano, inoltre, carte di concessione di vescovi e arcivescovi, come di pri-vati cittadini laici ed ecclesiastici, e privilegi illustri di sovrani e pontefici.
La costruzione di questo complesso edificio patrimoniale appare, nel suo realizzarsi, quasi un ininterrotto lavoro di sperimentazione, innestato nel solco della corrente riformatrice e segnato dall’esperienza cluniacen-se come dalle difficili contingenze politiche di questi anni12. L’autorità principesca mostra con chiarezza i segni di una crisi pesante e irrever-sibile, segnata dalla perdita progressiva delle sue prerogative pubbliche, mentre il monastero cavense assume i caratteri di una signoria fondiaria, affrancandosi da qualsiasi controllo e giocando un ruolo politico auto-nomo13. Un’assoluta uniformità di gestione s’instaura in tutta la congre-gazione, priori provenienti direttamente da Cava subentrano alla morte degli abati in carica nei monasteri assorbiti14 e ad essi spetta l’ammini-strazione dei beni del priorato, condotta secondo le direttive ricevute dall’abate, il quale interviene personalmente nella vita delle dipendenze, «visita i fratelli e li invita con paterne ammonizioni ad operare meglio», come aveva scritto l’abate cluniacense Odilone. Il rapido sviluppo che la Trinità conosce in questi anni si muove, tuttavia, su due binari, da un lato il vuoto di potere che segna il passaggio dal dominio longobardo all’e-tà normanna, dall’altro, le spinte innovative che provengono dall’ascesa delle identità signorili, legate all’universo politico locale all’interno del quale si muovono le acquisizioni cavensi.
Un dominatus loci nelle terre del Picentino
La prima notizia dell’esistenza di un insediamento fortificato nel ter-ritorio di Giffoni si legge in una carta del 976, che ricorda l’appartenenza di alcune porzioni delle cappelle di San Giorgio, in finibus Stricturie, e di Santa Maria, que edificata est intus castello de Iufuni, alla chiesa salernitana dei Santi apostoli Matteo e Tommaso15. I ruderi del castello, che ancora dominano il borgo di Terravecchia16, rivelano chiaramente la posizio-
12 Cfr. quanto ha scritto G. m. Cantarella, I monaci di Cluny, Torino 1993, pp. 179-255.
13 lorè, Monasteri, principi, aristocrazie, pp. 36-37.14 Emblematica la vicenda della chiesa salernitana di San Massimo, cfr. B. ruGGie-
ro, Principi, nobiltà e Chiesa nel Mezzogiorno longobardo. L’esempio di san Massimo di Salerno, Napoli 1973.
15 CDC, VIII, p. 51, a. 1057.16 Il complesso fortificato comprende una prima cinta muraria, relativa alla difesa
del solo fortilizio, databile al XIII secolo e munita di merlature, feritoie e torrette, e una
BarBara Visentin38
ne strategica della fortificazione, sorta a controllo dei percorsi viari che consentono, a nord, l’accesso alla valle del fiume Sabato, in direzione dei centri di Avellino e Benevento, mentre a sud, aprono l’ingresso alla città di Salerno e lo sbocco sul mare. Un castrum strategico, dunque, che risulta dotato anche di una cappella intitolata alla Vergine, in virtù della quale l’immagine della fortezza sembra coniugarsi con quella di un castello di popolamento, un receptum destinato a proteggere gli homines che abitano le terre circostanti e ad immagazzinare riserve alimentari per il sostenta-mento della corte salernitana17.
A commissionare la costruzione della chiesa dei SS. Matteo e Tom-maso era stato il conte Pietro, figlio di un certo Landolfo, la cappella privata era sorta intorno al 970, nel quartiere dell’Orto Magno, un’area piuttosto estesa posta all’estremità orientale della città di Salerno, non lontano dall’insula episcopalis. La fondazione aveva occupato terre confi-nanti con altri beni della famiglia, incamerati dal nonno di Pietro, il conte Alfano, attraverso una donazione che il principe Gisulfo I aveva indiriz-zato a suo favore. È probabile allora che la carta del 976 rappresenti il completamento della dotazione di cui Pietro correda la sua cappella, il San Giorgio di Stricturia, posto ai piedi del castello di Giffoni, e la cap-pella di Santa Maria, edificata all’interno della rocca castri, dovevano essere rientrate a pieno titolo nel patrimonio della famiglia comitale, ma nel 976 le divisioni ereditarie le presentano già frazionate in diverse sortiones.
Il terreno su cui Pietro edifica la sua chiesa all’interno della città gli appartiene, lo ha probabilmente ereditato insieme agli altri possedimenti fondiari che erano toccati al padre Landolfo, tra i quali potrebbero ri-conoscersi anche le proprietà situate fuori dalle mura urbiche, nel ricco contado salernitano, in loco Stricturia. Il vecchio conte Alfano sarebbe così il fondatore delle cappelle di San Giorgio e di Santa Maria che, al mo-mento della sua morte, avvenuta nell’anno 971, sarebbero state ripartite tra i tre figli Alfano, Pietro e Landolfo. Il conte avrebbe edificato due
seconda cortina di mura, destinata a proteggere il borgo antico e dotata di 12 torri circo-lari con base scarpata, tipiche delle fortificazioni di età angioina. Cfr. m. r. d’amBrosi, Terravecchia di Giffoni V. Piana storia e immagine architettonica di un borgo fortificato, «Progetto» 3, dicembre 1991, pp. 61-64.
17 p. touBert, Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell’Italia medievale, cur. G. Sergi, Torino 1995, pp. 37-39. Seguendo la proposta di Pierre Toubert, i modelli di fortificazioni presenti in quegli anni appaiono sostanzialmente tre: il castrum di popola-mento, i castelli strategici e recepta, le strutture fortificate con duplice funzione, difensiva ed economica.
39Identità signorili e sistemi di gestione tra età longobarda e normanna
chiese nell’ambito di pertinenza di una fortificazione, atto che necessa-riamente va ricondotto ad una concessione dell’autorità principesca18.
È ipotizzabile allora che lo stesso castrum di Giffoni gli fosse stato affidato da Gisulfo I e, a tale riguardo, sembra non trascurabile una no-tizia riportata da Alessandro Di Meo circa la concessione che il giovane principe avrebbe fatto, nell’anno 943, ad un non meglio precisato conte di Giffoni, del gastaldato di Sanseverino, unitamente alle piazzeforti di Montoro e Serino19. Non è compito agevole stabilire se il conte ricordato dall’erudito del Settecento possa identificarsi con Alfano o tantomeno ri-salire al lignaggio a cui Alfano appartiene20, non vi è dubbio però sul rilie-vo singolare della figura del conte, uomo capace e fidato, vicino al princi-pe e a lui particolarmente devoto, al quale non è improbabile che Gisulfo I abbia deciso di assegnare il castello di Giffoni e, successivamente, il controllo di uno dei gastaldati più importanti del Principato, punto ne-vralgico delle comunicazioni lungo l’asse Benevento-Avellino-Salerno21.
Dopo il 976 un lungo periodo di silenzio delle fonti non consente di rintracciare notizie ulteriori sulla roccaforte quod Iufuni dicitur, fino a quando nel 1097 Guaimario (II), filius benigne recordationis domni Guaimari, qui fuerat filius domni Guidonis ducis, filii domni Guaimarii principis, non dona al monastero della SS. Trinità di Cava buona parte dei suoi possedimenti
18 Cfr. F. Cusin, Per la storia del castello medievale, «Rivista Storica Italiana» serie V, 4, 1939, pp. 491-542. Sulle tesi degli storici del diritto italiani di questo periodo si veda la discussione di touBert, Dalla terra ai castelli, pp. 27-30.
19 a. di meo, Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli nella mezzana età, V, Napoli 1785, n. 5. Il Di Meo potrebbe aver mutuato l’informazione da quello che lui spesso in-dica come l’Annalista salernitano, da non confondere con l’Anonimo salernitano autore del Chronicon, ma da riconoscere in Francesco Maria Pratilli (1689-1763) che Nicola Ci-lento definiva:«il falsario della storia dei longobardi meridionali». La mancata menzione della fonte, però, da cui il Di Meo trae la notizia, che qualora si tratti del Pratilli viene nella maggior parte dei casi indicata, lascia aperto qualche spiraglio che lo storico abbia derivato l’informazione dalla lettura di un documento forse oggi perduto e che, dunque, la si possa ritenere autentica.
20 Un gran numero di conti con lo stesso nome si rintracciano a Salerno sul finire del secolo X, anche il padre della principessa Gemma, sposa di Gisulfo I, si chiamava Alfano. Cfr. m. sChipa, Storia del Principato longobardo di Salerno in F. hirsCh - m. sChipa, La Longo-bardia meridionale (570-1077), Roma 1968, p. 168, e taViani Carozzi, La principauté, p. 764.
21Si potrebbe riconoscere nel conte di Giffoni, ricordato da Di Meo nell’anno 943, il conte Alfano. La già menzionata donazione ad Alfano di un terreno all’interno delle mura salernitane, nel quartiere dell’Orto Magno, potrebbe costituire un indizio del rappor-to intercorso tra il principe Gisulfo ed Alfano.
BarBara Visentin40
in loco Stricturie22. Tra le diverse pertinenze elencate dal notaio, si fa riferi-mento anche ad una via que ducit ad castellum nostrum quod Iufuni dicitur e ad un’ecclesia Sancti Georgii, que constructa est in pede de ipso nostro castello Iufuni. L’atto non lascia dubbi, il castellum appartiene alla famiglia del giovane Guaimario, discendenza diretta del principe salernitano Guaimario III del quale Guido, conte di Conza e duca di Sorrento, è figlio cadetto. Il nome del duca Guidone richiama alla memoria gli anni difficili che il Principato di Salerno attraversa tra il 1047 ed il 1052, durante i qua-li Guaimario IV procede alla divisione del patrimonio familiare con i suoi due fratelli e, nel 1052, cade vittima di una violenta congiura, che punta ad azzerare i vertici della gens principesca di Salerno. Nei quat-tro istrumenti di divisione che si conservano Guaimario IV, Paldolfo e Guido si spartiscono i territori in finibus Lucaniae, in loco Muntoro, de loco Rota, in loco Felecta, de loco Propiciano, de loco Tusciano23, non menzionando in alcun modo il castrum Iufuni e le terre del locus Stricturia24. Rientrano nel patrimonio di Guaimario IV soltanto terreni localizzati nella parte nord-occidentale del territorio del Picentino, concernenti i distretti di San Cipriano, Filetta e Prepezzano, lasciando immaginare che Giffoni e il suo castello appartenessero ancora alla famiglia del conte Alfano. L’unità dinastica sembra ulteriormente minacciata da una simile divisio-ne, tuttavia il frazionamento del patrimonio doveva presentarsi come l’ultima speranza di tenere sotto controllo l’evolversi degli avvenimenti25, consentendo una gestione più efficace del territorio.
Indizi interessanti si rintracciano, inoltre, in una carta del 1091, quando Guaimarius (I) qui vocor de Iufuni, filius bone recordationis domni Gui-donis ducis, stanco di una vita fatta di violente lotte fratricide, offre al monastero cavense una parte considerevole dei suoi possedimenti, chie-dendo in cambio di vestire l’abito monastico e di ricevere sepoltura nello stesso cenobio, per sé e per suo figlio26. Il signore di Giffoni, mosso da un bisogno di spiritualità che non trova spazio nella confusione della società salernitana della fine dell’XI secolo27, si mostra particolarmente generoso, trasferendo nel patrimonio della Trinità alcune terre nelle lo-calità di Passiano e Balnearia, nei pressi dell’abbazia, e le sue quote di un
22 Archivio della Badia della SS. Trinità di Cava dei Tirreni (da ora in avanti citato come AC), D 9: gennaio 1096 e 13: marzo 1097.
23 Cfr. quanto riporta taViani Carozzi, La principauté, pp. 857-861.24 Cfr. CDC, VII, pp. 102 e ss.; pp. 94 e ss.25 Cfr. taViani Carozzi, La principauté, pp. 861-865. 26 AC, C 29.27 a. VauChez, La spiritualità dell’Occidente medievale, Milano 19932, pp. 49-55.
41Identità signorili e sistemi di gestione tra età longobarda e normanna
sesto delle chiese salernitane di San Massimo, Sant’Andrea e Santa Maria de domno28, del monastero di Sant’Andrea, sorto a super porta Radeprandi, e della chiesa rurale di San Nicola de Laneo.
Guaimario (I) è, quindi, il signore di quelle terre che, almeno fino al 1049, sono appartenute presumibilmente agli eredi del conte Alfano, i quali figurano tra i promotori della congiura contro il principe Guai-mario IV. Traspare in controluce, a questo punto, l’ipotesi di un trasferi-mento di poteri sul territorio di Giffoni, dalla famiglia di Alfano a quella del conte Guido, padre di Guaimario (I), cronologicamente riferibile al quarantennio che intercorre tra il 1049, anno delle ultime due spartizioni fondiarie del patrimonio principesco, e il 1091, data della prima atte-stazione di Guaimario a Giffoni. Tutta la vicenda pare ruotare intorno al fatidico 1052, trucidati gli autori della congiura, i loro beni risultano probabilmente confiscati e non sono estranee a questa sorte anche le terre, le cappelle ed il castello posseduti in loco Stricturia dai discendenti di Alfano. In questo momento di grande disordine generale sarebbe av-venuta l’assegnazione del futuro dominatus loci di Giffoni a Guido, l’unico sopravvissuto alla furia omicida dei congiurati.
La famiglia del conte Alfano, dimostratasi per il passato fermamente legata alla prima dinastia principesca salernitana, doveva essersi lasciata irretire da pericolose ambizioni di grandezza, delle quali pare comin-ciasse ad avere sentore già Guaimario III. Se si considera, infatti, il nu-mero consistente di chiese private che il principe edifica ai margini del territorio di Stricturia29, sembra potersi cogliere in esse un primo tenta-tivo di controllo del potentato di Giffoni. L’assenza di attestazioni non permette di conoscere in quali termini il locus Stricturia viene affidato a Guido, si tratta con ogni probabilità del frutto di un accordo preventivo, intercorso tra il conte di Conza e i Normanni, grazie al quale l’ultimo principe longobardo di Salerno, Gisulfo II, ottiene il controllo del Prin-cipato. Alla metà dell’XI secolo un ramo della famiglia principesca saler-nitana si avvia ad assumere atteggiamenti di tipo signorile, controllando un territorio altamente produttivo, circondato su tre lati da alture che lo dotano di importanti difese naturali e protetto, in direzione della fascia
28 La S. Maria inter muro et muricino, poi S. Maria de domno, fondata dalla seconda dina-stia principesca poco dopo l’insediamento del capostipite Giovanni nel 983. Su S. Maria cfr. p. deloGu, Mito di una città meridionale, Napoli 1977, pp. 144-147, e taViani Carozzi, La principauté, passim.
29 Si tratta delle fondazioni principesche di S. Giovanni nel casale Pariti di Filetta, di S. Cipriano nel cuore dell’omonimo centro tra i monti Picentini e di S. Vito nel distretto del locus Tuscianus.
BarBara Visentin42
pianeggiante, dal fortilizio del monte Castello. Giffoni offre così tutti i presupposti per dar vita ad una dominazione territoriale, al castrum si uniscono la solida base fondiaria, la popolazione numerosa che ne abita le terre e il riconoscimento di dominus fatto a Guido30.
La descrizione puntuale dei confini, riportata nella carta del 1097, consente di indicare a grandi linee l’ambito di influenza del potentato. Le terre in esame si estendono a destra e a sinistra del medio corso del fiume Picentino, dall’altura dell’Arenella, il pede dearenola ubi ad cru-cem dicitur, al Rio Secco, il ribum quod Constantii dicitur, lungo il quale veris tempus aqua decurrit. L’estremo limite settentrionale è segnato dalla colla que dicitur badumaiore, il Varco della Colla, che ancora oggi si eleva quale confine naturale della Stricturia, nel cuore dei Monti Picentini, mentre a Mezzogiorno, propinquo flubio Calabra, l’attuale corso d’acqua del Calàuro, abbondano le coltivazioni di olivo. I declivi collinari e le aree pianeggianti ospitano vigneti pregiati, cereali e variegati arbores fructiferi31, menzionati in loco Calabra, a suptus ecclesie Sancti Georgii32, e ubi ad Sanctam Mariam et Derrupata dicitur, le Ripe del Salvatore, fino a raggiungere la strada diretta alle chiese di San Giorgio e di San Liberatore, a super valle de Calabrano, in prossimità della quale correre il limite meridionale33.
Una miriade di insediamenti sparsi caratterizza la geografia di queste terre, una fitta rete economico-politico-religiosa ne controlla gli homines subiecti, trovando i suoi principali punti di riferimento in un sistema di ecclesiae propriae, legate al diffondersi dei poteri signorili34. Nel dominatus
30 Cfr. AC, D 9: gennaio 1096 e 13: marzo 1097: «… termino quod olim suprascriptus dominus Guido, abus meus figere iusserat».
31 Si veda B. Visentin, Destrutturazione tardo antica e riorganizzazione altomedievale nelle terre del Picentino (secc. VI-XI), «Schola Salernitana. Annali», 3-4, 1998-1999, pp. 243-249.
32 Non lontano dalla stessa località va collocata anche la zona ubi ad Arcu dicitur, nei documenti della seconda metà del XII secolo, infatti, le terre sulle quali sorge la chiesa di S. Giorgio vengono dette in contrada Arco. Cfr. a. BalduCCi, L’archivio diocesano di Salerno, Salerno 1959-1960, p. 22, n. 59; p. 30, n. 90. Il toponimo ad arcu potrebbe conservare il ricordo di un antico edificio di età romana legato, con molta probabilità, al vicino inse-diamento di piazza Umberto I; i resti di tale struttura dovevano risultare ancora visibili tra XI e XII secolo.
33 Per una ricostruzione di quelli che probabilmente furono, tra X ed XI secolo, i limiti del distretto amministrativo del locus Stricturia si rimanda a Visentin, Destrutturazione tardo antica, pp. 226-237.
34 Per tali considerazioni si veda in generale G. taBaCCo, L’Alto medioevo, in G. taBaCCo - G. G. merlo, Medioevo, Bologna 1989, pp. 214-215. Il risultato è quello di una sostanziale patrimonializzazione della giurisdizione, che rende ormai del tutto in-sufficiente definire tali forme di potere semplici ‘signorie rurali’ e guadagna loro il titolo
43Identità signorili e sistemi di gestione tra età longobarda e normanna
loci di Giffoni si contano in questa fase almeno tre ‘chiese private’, luoghi di culto e di assistenza religiosa di proprietà del conte, attraverso i quali la cura animarum viene strettamente controllata. Ciascuna cappella è dotata di un ampio beneficium, al cui interno spesso ricadono altre fondazioni re-ligiose indicate con il titolo di obedientiae. È in questo complicato sistema che andrà ben presto ad inserirsi la SS. Trinità di Cava, alla quale i signori di Giffoni e le donne della famiglia rivolgeranno la loro generosa atten-zione, offrendo tra il 1091 e il 1148 buona parte delle chiese rientranti nel loro patrimonio.
Nella stessa traditio del 1097 è riportata l’attestazione di un’oleara per-tinens hominibus iufunensibus … subiectis e di un’ecclesia Sancti Adiutoris, obe-dientia prefate ecclesie Sancti Michaelis, quam iufunensi homines a nobo fundamine construxerant35, segni evidenti della natura eterogenea tipica delle signorie di ‘banno’. In un’età in cui mulini, forni, frantoi e palmenta per il vino sono proprietà del dominus e rappresentano costruzioni di grande inte-resse economico, sulle quali vengono imposti canoni salati36, Guaimario (II) non sembra rivendicare alcun tipo di censo sull’oleara di Giffoni, mostrando forse l’avvenuta redazione di una qualche convenzione con gli homines iufunenses, volta a sancire la riduzione degli oneri signorili.
Nel 1114, infine, Guaimario (II) muore senza eredi e nel suo lascito testamentario sembra identificarsi un’altra traccia del rapporto che il do-minus ha instaurato con i suoi sudditi e della presenza, tra la popolazione rurale, di gruppi sociali privilegiati, capaci di contenere il potere signo-rile. Il conte stabilisce che la grande abbazia cavense ottenga il casale cilentano di Selifone e all’arcivescovo di Conza spetta l’intero castello di Oliveto, con tutti i suoi uomini, stabilendo che questi ultimi conservino la condizione di liberi37. La scomparsa di Guaimario segna l’estinzione
più complesso di ‘signorie territoriali di banno’. Sulle questioni inerenti i poteri di banno si veda in generale G. serGi, Villaggi e curtis come basi economico-territoriali per lo sviluppo del banno, in Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali, cur. G. Sergi, Torino 1993, pp. 17-20.
35 Per quanto concerne la localizzazione della cappella di Sant’Adiutore non è pos-sibile fornire alcun tipo di indicazioni, se non che doveva trovarsi nella parte centro-settentrionale del dominatus. L’edificio, comunque, non pare essersi conservato e quella dell’anno 1097 rimane l’unica menzione della chiesa.
36 taBaCCo, L’Alto medioevo, p. 211.37 Inserto del 1114 in AC, F 28: 1125. Sul documento pesa un sospetto di falsità per
il quale si veda m. Galante, Un esempio di diplomatica signorile: i documenti dei Sanseverino in Civiltà del Mezzogiorno d’Italia, pp. 291-292, nota n. 52. Sulla gestione di torchi, palmenta, mulini e altro si rimanda a taBaCCo, L’Alto medioevo, p. 211.
BarBara Visentin44
della linea maschile della famiglia, da questo momento Giffoni ricade sotto il controllo dei signori di Eboli e, in un inserto del 1116, viene ricordato un tale visconte di Roberto, signore di Eboli, che presiede al castrum di Giffoni, acquisito probabilmente dal dominus delle terre eboli-tane per via ereditaria, avendo preso in moglie Mabilia, sorella di Guai-mario (II)38.
Le dipendenze cavensi di San Michele e di San Vincenzo: episodi differenti di gestione fondiaria.
La trasformazione dell’aristocrazia longobarda, mostrata nel conte-sto particolare della signoria di Giffoni, offre con chiarezza l’immagine di una società in rapida evoluzione. A caratterizzarla è un atteggiamento costantemente in bilico tra il senso di appartenenza cittadina, che la gens del conte Guido sente forte per il suo legame diretto con il principe di Salerno, e la nascita di un’identità signorile, tra proprietà della terra e do-minio sugli uomini, quest’ultimo del tutto assente nelle concessioni che i signori di Giffoni effettuano sullo scorcio dell’XI secolo39.
Questo mescolarsi complesso di elementi tradizionali e spinte nuo-ve, nate dalla dissoluzione del dominio longobardo, facilita e accelera l’ascesa di vescovati ed enti monastici, ai quali viene concesso un numero sempre più consistente di diritti e beni fondiari, fino a farne importan-ti centri di potere40. Le fasi di questo processo appaiono ben delineate nella fortunata parabola di vita che interessa l’abbazia della SS. Trinità di Cava, tra la seconda metà dell’XI e per tutto il XII secolo il monastero si dimostra capace di incamerare un territorio molto ampio e di costruire un articolato network fatto di chiese, terre e comunità monastiche latine ed italo-greche, all’interno del quale i rapporti tra ‘centro’ e ‘periferia’, la loro capacità di comunicare e di interagire, le interferenze delle diverse componenti esogene, divengono fondamentali41.
38 AC, XXII 4: 1125.39 Il castrum di Capaccio presenta un’evoluzione assai simile a quella evidenziata per
il centro di Giffoni, per un approfondimento dell’ingresso cavense sulle terre del domina-tus caputaquensis si rimanda Visentin, Poteri territoriali, pp. 45-78.
40 Cfr. lorè, Monasteri, Principi, Aristocrazie, p. 38 e le indicazioni bibliografiche contenute nelle note, che sottolineano il ruolo analogo svolto dai monasteri dell’Italia centro-settentrionale tra X-XI secolo.
41 Zentrum und Netzwerk. Kirchliche Kommunikationem und Raumstrukturen im Mittelal-ter, cur. G. Drossbach - J. Schmidt, Berlin 2008 (Scrinium Friburgense 22). In questa direzione si muovono le ricerche di Gert Melville e della sua scuola, cfr. G. melVille, Razionalità del sistema e successo dei domenicani nell’Europa medievale, in La memoria ritrovata.
45Identità signorili e sistemi di gestione tra età longobarda e normanna
Uno straordinario cammino di irradiazione del sistema cavense, nel quale si contano almeno quattro momenti significativi, il primo riferibile agli anni tra il 1025 e il 1078, nel corso dei quali l’abbazia guadagna una parte considerevole dei beni che il palatium salernitano possiede nel Ci-lento, mentre sullo sfondo matura l’indebolimento del potere principe-sco e l’azione riformatrice della Chiesa entra nella fase del suo maggior vigore42. Il 1079 inaugura il secondo momento dell’espansione cavense e fino al 1123 la Trinità accoglie nel proprio patrimonio circa 100 di-pendenze disseminate in tutta l’Italia meridionale43. Si precisano i termi-ni dell’appartenenza a Cava di alcune importanti comunità monastiche, quali quelle di Sant’Arcangelo di Perdifumo e di San Magno44, nel Ci-lento, mentre Roberto il Guiscardo e sua moglie Sichelgaita stabiliscono pubblicamente che gli uomini dipendenti dai cenobi cavensi del Cilento siano in tutto soggetti all’abate della Trinità45.
L’interesse manifestato dal ceto dirigente, longobardo prima e nor-manno poi, nei riguardi della Trinità di Cava permette all’abbazia di acquisire aree di controllo lungo alcune precise vie di comunicazione, attraversate da percorsi viari importanti e impreziosite da piccoli anco-raggi alle foci dei fiumi46. Ai monaci della Trinità non sfugge il valore
Pietro Geremia e le carte della storia, cur. F. Migliorino - L. Giordano, Catania 2006, pp. 15-58; F. CyGler - J. oBerste - G. melVille, Aspekte zur Verbindung von Organisation und Schrift-lichkeit im Ordenswesen. Ein Vergleich zwischen den Zisterziensern und Cluniazensern des 12.-13. Jahrhunderts, in Viva vox und ratio scripta. Mündliche und schriftliche Kommunikationsformen im Mönchtum des Mittelalters, cur. C. m. Kasper, Münster 1997 (Vita regularis 5), pp. 205-280, e C. andenna, Le forme della comunicazione negli ordini religiosi del XII e XIII secolo: periferia, sottocentri e filiazioni, in Die Ordnung dei Kommunikation und die Kommunikation dei Ordnungen im mittelalterlichen Europa, I, Netzwerke: Klöster und Orden im 12. und 13. Jahrhundert, cur. C. Andenna - K. Herbers - G. Melville (Aurora 1), in corso di pubblicazione.
42 Si veda a tale riguardo taViani Carozzi, La principauté lombarde de Salerne, pp. 1054-1059, e CDC, IX, nn. 126 e 127, pp. 369-374.
43 Si veda il lavoro di Guillaume, Essai, pp. 50-52.44 La copiosa documentazione conservatasi per i due monasteri, infatti, ricorda la
presenza di un priore a Sant’Arcangelo a partire dal 1082, cfr. AC, XIII, 119 e XV, 70, 82: Disideo, presbiter et prior del monastero dal 1082 al 1096, mentre, negli stessi anni, l’abbazia di S. Magno trasforma il titolo del proprio abate Abalsamus in quello di priore, cfr. AC, XIII, 63: marzo 1079; 70: dicembre 1078; 71, 72, 73: aprile 1079/1082; 84: novembre 1079; XIV, 5: aprile 1084. Si veda anche il privilegio pontificio di Urbano II AC, C, 35 bis: settembre 1089 e 21: ottobre 1089.
45 AC, B, 13: 1080; 33: 1083. Sul monastero di San Magno si rimanda al lavoro di G. Vitolo, Il monastero in Mille anni di storia San Mango Cilento, cur. F. Volpe, Napoli 1994, pp. 55-67.
46 Cfr. quanto ha scritto circa i vari fronti dell’espansione cluniacense Cantarella, I monaci di Cluny, pp. 179-255, e anche id., È esistito un «modello cluniacense»?, in Dinamiche
BarBara Visentin46
politico-economico che il controllo di questi snodi territoriali esprime e la rete dei priorati sembra articolarsi proprio lungo strategici canali di co-municazione, attraverso i quali l’abbazia si apre a proficue relazioni com-merciali e culturali. Si prediligono le vie d’acqua dell’Agri e del Sinni, del Tanagro e del Calore cilentano, le valli fluviali del Mingardo e dell’Alento così come quelle, più prossime a Salerno, del Tusciano e del Picentino. In questi anni in cui Cava è un ‘castello del cielo’ in rapida costruzione, Guaimario (I) di Giffoni provvede alla stipula della sua prima cartula of-fertionis a favore della Trinità. L’autunno del 1091 inaugura la presenza cavense sul territorio di Stricturia, costituendo la prima testimonianza esplicita di un dominio signorile sul territorio di Giffoni47.
Tra il 1124 e il 1171 l’abbazia entra nella terza fase della sua irradia-zione patrimoniale, la curva delle acquisizioni si mantiene alta e l’esigen-za di esercitare una tutela più efficace sui numerosi piccoli insediamenti, monastici e non, sorti lontano dalla Trinità, caratterizza in questi anni la gestione delle proprietà, improntata ad una maggiore centralizzazione dell’assetto organizzativo48. L’ultimo periodo della grande espansione cavense si attesta tra il 1172 e il 1194, dando avvio ad una brusca fase calante delle acquisizioni, destinate ad arrestarsi quasi completamente nel corso del XIII secolo, per lasciare il posto ad un’attività di consolida-mento e difesa della proprietà.
In questa rete ampia di possedimenti si rintracciano alcuni contesti che presentano particolari elementi di problematicità e criteri di evolu-zione propri, consentendo di individuare le differenti modalità di ge-stione adottate da Cava. Il caso della chiesa di San Michele Arcangelo di Giffoni è, a tale riguardo, un esempio chiaro dei rapporti che la SS. Tri-nità di Cava intrattenne con i poteri territoriali locali affermatisi nell’area meridionale dell’antico principato di Salerno, essendo direttamente lega-ta alle vicende che interessarono l’avamposto militare del castrum Iufuni.
Nel 1092 Guaimario (II), presente l’anno prima accanto al padre nella cartula offertionis con la quale i due avevano chiesto di vestire l’a-bito monastico e di essere sepolti nell’abbazia cavense, conferma alla Trinità la concessione della sua quota del patrimonio principesco nel Cilento49. Cinque anni più tardi, nel gennaio del 1097, un’altra donazione
istituzionali delle reti monastiche e canonicali nell’Italia dei secoli X-XII, Atti del XXVIII Conve-gno del Centro di Studi Avellaniti, Fonte Avellana 29-31 agosto 2006, cur. N. D’Acunto, Verona 2007, pp. 61-85, e id., I monaci di Cluny, Torino 1993.
47 AC, C 29.48 Cfr. Vitolo, Il monastero in Mille anni di storia San Mango, pp. 65-66.49 AC, C 32.
47Identità signorili e sistemi di gestione tra età longobarda e normanna
non meno importante delle precedenti porta nel patrimonio monastico la dipendenza cilentana di San Matteo ad duo flumina50, edificata nel punto di confluenza dei fiumi Alento e Palistro, alle cui foci erano sorti due dei tre antichi porti di Velia, e una serie di chiese poste all’interno della signoria di Giffoni51.
Guaimario (II), filius benigne recordationis domni Guaimarii, pro salute ani-me, consegna nelle mani del venerabilis abbas Pietro l’ecclesiam Sancti Micha-elis, sorta in loco Stricturie, ubi Padudiccle dicitur, in pede montis quod Oraturus dicitur52. La chiesa è accompagnata da omnibus ipsis rebus in quibus constructa est e da tutte le sostanze che, in eadem ecclesia, il suprascriptus genitor suus aveva offerto, ovvero il beneficium destinato alla chiesa da Guaimario (I), probabilmente al momento della fondazione. L’acquisizione della dipen-denza di San Michele rappresenta una fase significativa nel potenzia-mento del patrimonio cavense, la chiesa porta con sé una consistente dotazione fondiaria, concentrata nella parte settentrionale del dominatus,
50 Agostino Venereo la ricorda come l’ecclesia parrochialis S. Mathaei ad duo flumina in Lucania … matrix oppidi Casalicii, olim matrix casalis S. Mathaei ad duo flumina, cum monasterio sub titulo prioratus et custodiae, cfr. a. Venereo, Dictionarium Archivii Cavensis, manoscritto, vol. II, pp. 231, 434, da ora in avanti citato come Venereo, Dict., che talvolta la confonde con la cappella di S. Matteo sub arce di Capaccio, cfr. Venereo, Dict., vol. I, p. 183; vol. II, pp. 434, 491. Sulla scia di Venereo anche G. talamo atenolFi, I testi medievali degli atti di S. Matteo l’Evangelista, Roma 1958, p. 49 confonde le due cappelle di S. Matteo, scrivendo: «La chiesa (nella quale il monaco Atanasio pose la reliquia di san Matteo nel 954) era nella contrada «ad duo flumina» così chiamata per la vicina confluenza del Palistro con l’Alen-to, sulla riva destra di quest’ultimo nella pianura sotto Velia detta la «subarce», e si trovava poco lontana dai possessi del Sacro Palazzo recentemente concessi all’Ordine di san Benedetto in persona dell’abate Giovanni, forse lo stesso di cui è parola nella ‘translatio’, là dove sorse più tardi l’abbazia di S. Maria di Torricella (CDC, I, 232). Dal racconto della ‘traslatio’ parrebbe che la chiesa della deposizione fosse stata affidata al monaco Atanasio dal vescovo pestano Giovanni, dal quale la chiesa dipendeva, sì che questi direttamente vi si reca e vi convoca il rettore. Ancora alla diocesi pestana apparteneva la chiesa nel 1054, quando il vescovo Amato rinunziò per 5 libbre d’argento ai diritti della curia in favore di Teodora di Tuscolo, figlia di Gregorio console e duce dei Romani, e nipote di papa Benedetto IX. Questa, vedova di Pandolfo di Salerno, conte di Capaccio e signore di quei luoghi, aveva ricostruito la chiesa stessa … col centenario del ritrovamento … Circa due anni più tardi, nell’aprile 1072, per disposizione di Gisulfo II … la chiesa col circostante territorio fu donata alla congregazione … cavense che vi costituì l’abbazia di san Matteo ad duo flumina … Poco lungi è la marina, detta ora di Casalvelino».
51 AC, D 9: gennaio 1096 e 13: marzo 1097.52 La cappella di S. Michele potrebbe essere sorta ai piedi del colle Menaturo, a
nord-est del castello di Terravecchia, ipotizzando la derivazione dell’attuale toponimo dall’antico mons quod Oraturus dicitur.
BarBara Visentin48
non lontano da quello che il giovane Guaimario definisce castellum no-strum quod Iufuni dicitur.
Alle terre si aggiungono, inoltre, altre tre fondazioni religiose, l’ec-clesia Sancti Adiutoris, edificata dagli stessi iufunensi homines … ubi Oratu-rum dicitur e indicata quale obedientia prefate ecclesie Sancti Michaelis53, l’antica chiesa di San Giorgio, sorta ai piedi del castello e ricordata tra i beni dei domini di Giffoni già nel 97654, e quella di San Liberatore, que edificata est a super valle de Calabrano, ciascuna cum omnibus ad eam pertinentibus55. La Trini-tà ha incamerato in una sola volta un importante circuito di chiese rurali gravitante attorno alla dipendenza dell’Arcangelo e legato al controllo di un territorio ricco di ulivi, vigne, alberi da frutto, castagni e uomini, con i quali i monaci instaurano vincoli spirituali ed economici. Il punto di convergenza di questa ‘rete’ sembra rimanere, almeno nei primi anni del XII secolo, la chiesa di San Michele, l’unica menzionata tra le di-pendenze, apud oppidum Geffuni, che il pontefice Pasquale II conferma al monastero cavense nell’agosto del 110056. Ad essa si affianca nella bolla di Eugenio III, emessa nella primavera del 1149, la chiesa di San Gior-
53 Cfr. anche Venereo, Dict., vol. I, p. 15v. Sulla gestione di torchi, palmenta, mulini e altro si rimanda a taBaCCo, L’Alto medioevo, p. 211.
54 Cfr. Per la chiesa di San Giorgio si conserva ancora il toponimo ‘San Giorgio Vec-chio’ alle falde del versante orientale del monte Castello, dove oggi sorge la nuova chiesa di San Giorgio. In questa zona si scorgono anche i ruderi di un edificio quadrangolare dalle modeste dimensioni, nelle cui murature si leggono almeno due fasi costruttive: la prima, poggiante direttamente sulla roccia, è costituita da pietre di fiume, malta, tufi grigi di provenienza locale e laterizi; la seconda, invece, interessa quello che rimane dell’elevato e consente di riconoscere una copertura realizzata con una volta a crociera, sostenuta da quattro colonnine inserite negli angoli dell’edificio. All’interno dell’ambiente, inoltre, sono visibili lacerti di affreschi, forse trecenteschi, che possono essere messi in relazione con la seconda fase costruttiva. Lo spessore delle murature poggianti direttamente sulla roccia, la pianta perfettamente quadrata dell’edificio ed il punto in cui i ruderi sorgono, lascerebbero pensare ad una torre del castello, posta a guardia della pianura circostante e delle vie di comunicazione che dovevano solcarla, in particolare la via que ducit ad castellum nostrum, quod Iufuni dicitur nei pressi della località ubi ad arcu dicitur dove appunto sorge la chiesa di San Giorgio. L’esistenza di affreschi sulle pareti interne, però, non si concilia con una simile ipotesi ma sembrerebbe favorire l’idea della presenza di una chiesa, po-trebbe darsi, allora, che le strutture dell’ambiente dopo una prima destinazione, siano state restaurate per essere adattate ad un nuovo uso.
55 Per l’ubicazione delle cappelle e l’identificazione dei toponimi ricordati nel do-cumento si rimanda ancora a Visentin, Destrutturazione tardo antica, pp. 268-270, e alla tavola IV, p. 278.
56 AC, D 26, 29 e p. F. Kehr, Regesta Pontificum Romanorum, Italia Pontificia, 10 voll., VIII, 324, nr. 19, da questo momento citato come Kehr, IP.
49Identità signorili e sistemi di gestione tra età longobarda e normanna
gio57 e, nel gennaio del 1168, il privilegio di Alessandro III riporta per la prima volta l’indicazione di un’ecclesiam Sancti Georgii e di un monasterium Sancti Michaelis58.
È probabile che l’abbazia abbia potenziato, nel corso del XII secolo, il numero dei monaci presenti sul territorio del castrum Iufuni, arrivando a costituire una piccola comunità monastica attorno alla chiesa di San Michele59, nucleo di centralizzazione degli interessi cavensi sul territorio, e conferendo alla chiesa di San Giorgio una dignità maggiore rispetto alle altre soggette al monastero dell’Arcangelo60. Nell’agosto del 1169, infatti, la vendita di una terra in loco Stricturia, ubi proprie curtis dicitur, viene curata dal monaco Alferius, praepositus monasterii Sancti Michaelis Archangeli de Gifono … et ecclesiae Sancti Georgii, così come la permuta di due terreni nella stessa località e la concessione del diritto di passaggio per i monachi et alii homines, qui in ipse ecclesia fuerint, fatta a Cava dai coniugi Florio e Gemma, nella primavera del 117161.
Alferio è, dunque, il preposito del monastero di San Michele e della chiesa di San Giorgio, almeno fino al 1173 quando, in una cartula venditio-nis, risulta menzionato semplicemente quale monachus ecclesiae Sancti Mi-chaelis Archangeli, lasciando immaginare che nel frattempo la prepositura della chiesa di San Giorgio sia stata separata da quella del monastero di San Michele e magari assegnata ad un altro confratello62. Il beneficium del-la chiesa dell’Arcangelo rientra nel patrimonio cavense fino al 1548, data in cui il Venereo ricorda per l’ultima volta la dipendenza, riportandone la concessione in fitto, mentre per le obbedienze che da essa dipendono l’unica notizia che si rintraccia, prima del XVI secolo, risale al luglio del 1225, quando la chiesa di San Giorgio in pertinentiis castri Gifoni, in casali
57 AC, H 7: maggio del 1149, e Kehr, IP, VIII, 325, nr. 23.58 AC, H 50 falso e P 24: transunto del marzo 1399 – H 51: transunto – I 1: tran-
sunto e Kehr, IP, VIII, 326, nr. 26.59 Cfr. anche Venereo, Dict., vol. I, p. 42r. che la indica con la qualifica di ecclesia cum
monasterio sub titulo prioratus.60 Il Venereo la cita con la qualifica di ecclesia S. Georgii de Gifono, in casali Valle, … cum
monasterio sub titulo prioratus, cfr. Venereo, Dict., vol. II, pp. 222v-223r.61 Cfr. AC, XXXIII 33; 35: agosto 1169; 103: maggio 1171.62 AC, XXXIV 73: agosto 1173, nella vendita di una terra il monaco Alferio, pre-
cedentemente indicato come prepositus monasterii S. Michaelis Archangeli e, contemporane-amente, della cappella di S. Giorgio, viene semplicemente menzionato quale monachus ecclesiae S. Michaelis Archangeli.
BarBara Visentin50
quod la Valle dicitur, viene concessa per 29 anni al chierico Gualterio de Salerno63.
L’afflusso cospicuo di ricchezze nei già consistenti patrimoni di cui erano dotate le chiese ed i monasteri salernitani può, dunque, facilmente inquadrarsi nel contesto di trasformazione generale che seguì all’indoma-ni della conquista normanna. Per ciò che concerne, invece, i destinatari di tali donazioni, va detto che fin dagli ultimi anni del secolo X si era dato inizio ad un processo di progressiva acquisizione di capitali, soprattutto fondiari, da parte di alcuni enti ecclesiastici salernitani particolarmente interessati alle terre del Picentino. È questo il caso delle chiese urbane di fondazione principesca come Santa Maria de domno e S. Massimo64, dei monasteri intitolati ai Santi Angelo e Sofia65, a San Nicola de palma66 e a San Giorgio67, e delle cappelle private dedicate a San Martino ulter flubio
63 AC, LII 108.64 CDC, I, p. 176. La notizia più antica che si possiede a tale proposito risale al 919
ed interessa il locus Pulianus, all’interno del quale il presbitero Valperto dona tutti i beni di sua proprietà alla chiesa salernitana di S. Massimo. Per più di un secolo, poi, non si rin-tracciano altre testimonianze, fino a quando nel 1034 l’abate di S. Massimo non è chiama-to a definire i confini dei suoi possedimenti con un tale Disio di Propiciano, attestando tra le terre di pertinenza della chiesa salernitana anche zone site nell’attuale Comune di Prepezzano. CDC, VI, p. 6. Si fermano a queste le indicazioni che le fonti documentarie, comprese tra X ed XI secolo, forniscono per la fondazione principesca di S. Massimo, una simile esiguità di informazioni non permette, dunque, un discorso molto articolato sulla disposizione delle proprietà della chiesa nella valle del Picentino.
65 deloGu, Mito di una città meridionale, p. 141, note n. 120 e n. 121; in proposito si veda anche taViani Carozzi, La principautè, pp. 742-746. A cominciare dall’anno 1023 il monastero di S. Sofia si trova citato in qualità di possessore di alcune terre site in loco Campiliano CDC, IV, p. 10. Altre terre possedute in Campiliano dai monasteri salernitani di S. Angelo e S. Sofia sono attestate negli anni 1041, 1044, 1049 e 1058; CDC, VI, p. 160; p. 161; p. 254; VII, p. 117; l. Cassese, Pergamene del monastero benedettino di San Giorgio (1038-1698), Salerno 1950, p. 11 da adesso citato come P.S.G.; CDC, VIII, p. 62; p. 81. e in loco Silia cfr. CDC, V, p. 179, a. 1023; p. 157, a. 1028; p. 166, a. 1029; VII, p. 173, a. 1052. e fino al 1040 non si rinviene associato a quello di S. Angelo. Nel 1049 i due con-venti posseggono terre a Bespanicus CDC, VII, p. 118. mentre quasi dieci anni più tardi un certo Bonifacio restituisce a Maraldo, abate di S. Sofia, tutte le sue proprietà in loco Iufuni ubi Segeti dicitur CDC, VIII, p. 81.
66 CDC, IX, p. 243.67 Cassese, P.S.G., p. XXXI. Il monastero femminile di S. Giorgio di Salerno prope
muros veteris palatii, doveva possedere un consistente numero di terre a Faiano, come atte-stano due atti rispettivamente degli anni 1037, cfr. l. pennaCChini, Pergamene Salernitane, Salerno 1941, p. 23, a. 1008, per la ridatazione di questo documento al 1037 si veda m. Galante, Per la datazione dei documenti salernitani di epoca longobarda. Note ed osservazioni, «Ras-
51Identità signorili e sistemi di gestione tra età longobarda e normanna
Lirino68 e agli apostoli Matteo e Tommaso, sul limite orientale della città di Salerno69. Illuminante sembra essere, allora, il caso della fondazione principesca salernitana di Santa Maria de domno che, realizzata sul finire del X secolo inter murum et muricinum, conosce nel corso dell’XI una mas-siccia acquisizione di terre, a potenziamento delle cospicue sostanze di cui è stata dotata fin dall’inizio dal principe Giovanni.
Nell’anno 994 Dumnellus presbiter et abbas ecclesie Sancte Marie, quem ... domnus Iohannes princeps et domna Sichelgaita principissa uxor sua ... construsse-runt ... inter muro et muricino, si industria per scambiare alcune terre in locum Bespanicum, erga flubio Pecentino, con altre nella stessa località ma coniuntum cum rebus nostra, al fine di costruirvi un mulino70. Da questo momento in poi l’abate di Santa Maria de domno diviene una figura ricorrente nelle transazioni concernenti il territorio in esame, nel 997 è ancora Dumnello a fare le veci della chiesa nella quale officia e a ricevere, da Amatus pre-sbiter et notarius, ... inclita sortione ... de ecclesia Sancti Symeonis et casis in locum Martorano, Stricturie finibus71. La chiesa di San Simeone doveva costituire un donativo di particolare importanza, se Santa Maria de domno fu così interessata a percepirne il pieno possesso e, a distanza di appena due anni, lo stesso Dumnello compare dinanzi al giudice Adenolfus per rice-verne la restante metà, insieme a pannos, munimen, ferrum, siricum, aurum et argentum72.
Le pertinenze della cappella di Santa Maria all’interno del distretto di Stricturia si presentano, così, piuttosto estese e ben documentate, in
segna degli Archivi di Stato» 2-3, pp. 370-372, e 1042, cfr. m. Galante, Nuove pergamene del monastero femminile di S. Giorgio di Salerno. I (993-1256 ), Altavilla Silentina 1984, p. 9.
68 La chiesa intitolata a S. Martino, localizzata fuori dalle mura della città di Saler-no, ulter flubio Lirino, era stata dotata, invece, di un patrimonio che comprendeva alcune pertinenze all’interno della città di Salerno ma che per la maggior parte si estendeva tra i territori degli attuali Comuni di Giffoni e di Montecorvino Rovella; la chiesa viene, infatti, menzionata per la prima volta in tre carte dell’anno 986 come dominus di terre situate in loco Campiliano, taViani Carozzi, La principautè, p. 738. CDC, II, p. 229; p. 231; p. 232. La chiesa di S. Martino sull’Irno è ricordata ancora in qualità di dominus per terre in Campiliano nell’anno 1010, cfr. CDC, IV, p. 173.
69 taViani Carozzi, La principautè, p. 764. CDC, VIII, pp. 51, 297: In un lungo istru-mento del 1064, infine, che definisce una serie di scambi di terre, alla cappella vengono riconosciute proprietà in loco Propiciano, ubi Monte de Spelengaru dicitur, in loco Selecta (Felecta) ed in loco sancto Cipriano.
70 CDC, III, p. 20.71 Ivi, p. 76.72 Ivi, p. 98.
BarBara Visentin52
due carte rispettivamente del 99873 e del 99974 vengono addirittura men-zionate sei diverse località, purtroppo oggi non tutte rintracciabili, che contengono terre appartenenti alla chiesa salernitana. I possedimenti si concentrano, in modo particolare, tra i casali di Martoranus ad est e di Cor-reianus ad ovest, entrambi compresi in finibus Stricturie, interessando anche l’Aqua Argenza, l’attuale corso d’acqua del Rienna, nei pressi del quale sorge la chiesa di San Vincenzo, dipendenza di Santa Maria de domno nel 1141 e, successivamente, obbedienza cavense. Non mancano attestazio-ni di terre appartenenti a Santa Maria anche in altri punti del territorio in-dagato, è il caso di un atto risalente all’anno 1000, nel quale Lisoprando, filius quondam Iannelgari, commuta delle proprietà con Dumnello, presbiteri et abbati pro pars ecclesie Sancte Marie, in locum Propiciano75, mentre nell’anno 1002 è ancora un contratto di pastinato a fornire indicazioni circa due pe-cie de terra campensis che la chiesa di Santa Maria de domno possiede in locum Bespanicum ulter flubio Pecentino76.
Il caso della chiesa di San Vincenzo, però, rientrante nelle terre di pertinenza del castrum Iufuni, offre la possibilità di mettere a fuoco un contesto particolare, segnato dalla presenza di una cella vulturnense fin dai primi anni del IX secolo, transitata nel patrimonio fondiario della cappella principesca di Santa Maria de domno e, solo alla metà del XII secolo, confluita nella congregazione cavense. La stessa situazione do-cumentaria caratterizza in modo diverso le vicende della chiesa di San Vincenzo, le carte superstiti si presentano infatti piuttosto dettagliate per ciò che riguarda le vicende anteriori all’ingresso nel raggio d’azione della Trinità, ma purtroppo assai carenti per il periodo in cui la cappella rientra tra le dipendenze di Cava.
La prima menzione della chiesa risale all’anno 819 e si rintraccia in una conferma dell’imperatore Ludovico I al monastero di San Vincenzo al Volturno, nella quale vengono ricordate, tra le altre, la cellam Sancti Georgii infra Salernitanam civitatem, la cellam Sancti Vincencii in fluvio Tusciano, la cellam Sancti Vincencii in fluvio Tensa e la cellam Sancti Valentini in fluvio Bisentino, nella quale sembra potersi riconoscere quella che diventerà la
73 Ivi, p. 89.74 Ivi, p. 90.75 CDC, III, p. 105.76 CDC, IV, p. 7; VI, p. 139: 1040. Terre site nelle località di Bespanicus e di Giffoni
sono, anche, ricordate in un inserto del 1041, riportato in un documento più tardo del 1054, cfr. CDC, VII, p. 223. La chiesa di S. Maria de domno possedeva, inoltre, terre a Campiliano, a tal proposito cfr. CDC, IX, p. 62, a. 1066.
53Identità signorili e sistemi di gestione tra età longobarda e normanna
chiesa di San Vincenzo77. Bisogna aspettare l’anno 962 per avere ancora notizia della cella Sancti Valentini in fluvio Vixentino78, il diploma è emanato da Ottone I e va ad inserirsi in quel clima di ristrutturazione generale che interessa il cenobio di San Vincenzo al Volturno tra il 940 e il 960. L’im-peratore ribadisce nuovamente la giurisdizione del cenobio sulle celle del Tusciano e del Tensa, nonché su quelle di San Giorgio di Salerno e di San Valentino sul Picentino, tuttavia, nel 983, l’abate vulturnense torna a chiedere la ratifica imperiale per il possesso di alcuni beni, tra i quali compaiono ancora la cappella et cella infra Salernitanam civitatem in honore Santi Georgii constructam, la cellam Sancti Vincencii in fluvio Vixentino, la cellam Sancti Vincencii in fluvio Tusciano e la cellam Sancti Vincencii in fluvio Tensa79. Il diploma indica, per la prima volta, la cella sul Picentino come dedicata a San Vincenzo e la nuova attestazione lascia pensare ad una corruzione del nome da parte del copista oppure ad una nuova dedicazione del com-plesso, avvenuta nel corso dei ventun’anni che intercorrono tra l’ultima notizia della presenza di una cella di San Valentino lungo il Picentino e la prima indicazione della stessa intitolata a San Vincenzo.
A distanza di alcuni anni, nel giugno del 1141, si rintraccia la de-scrizione dettagliata delle terre all’interno delle quali sorge l’ecclesia Sancti Vincentii, nel frattempo passata tra le pertinenze della chiesa salernitana di Santa Maria de domno80. L’occasione è data dalla composizione di una lite, intercorsa tra un tale Soldanus e Iohannes, presbiter ecclesie Sancte Marie que dicitur de domno, circa i limiti di alcuni possessi fondiari, all’interno dei quali era stata edificata la chiesa di San Vincenzo. Le indicazioni to-ponomastiche fornite nell’atto dal notaio Pietro rimandano alle località di San Vincenzo e Cellara, nell’attuale Comune di Giffoni Valle Piana, dove il torrente Rienna incontra il fiume Picentino, incipiendo a coniunctione posteriore nominati rivi cum flumine, e dove i resti dell’antica chiesa sembrano potersi riconoscere inglobati in una masseria del XVIII secolo81. I con-tadini del posto chiamano questa zona la cappella vecchia di San Vincenzo, di fronte alla quale, su una piccola altura, ricordano la presenza dell’aia
77 Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni, ed. V. Federici, I, Roma 1925 (Fonti per la storia d’Italia, LVIII), p. 232, da adesso citato come Chron. Vult.
78 Chron. Vult., II, p. 127.79 Chron. Vult., II, p. 247.80 AC, XXV 21.81 Nella fabbrica attuale si nota un semplice arco molto interrato che conserva
ancora un affresco, probabilmente settecentesco, raffigurante l’Annunciazione con in primo piano l’Angelo e la Vergine Maria e sul fondo la figura di un santo monaco, san Vincenzo, con la Palma del martirio nella mano destra.
BarBara Visentin54
di San Vincenzo e, non molto distante, anche una fontana porta il nome del santo. La breve distanza, poi, che intercorre tra la cappella vecchia di San Vincenzo e la chiesa di Sant’Ambrogio, nel Comune di Montecorvino Rovella, il cui ciclo pittorico presenta analogie con gli affreschi realizzati nel monastero alle fonti del Volturno, alla metà del IX secolo82, estende alle terre sulle quali sorge il Sant’Ambrogio l’area di dominio della chiesa di San Vincenzo sul Picentino.
Possedimenti piuttosto vasti che si sviluppano dalla cella di San Vincenzo alla chiesa di Sant’Ambrogio, sulle sponde del Rienna, per un estensione di due chilometri circa, comprendendo zone particolarmente fertili e ricche di corsi d’acqua, confluite prima tra le pertinenze della chiesa principesca di Santa Maria de domno e successivamente, tra il 1149 e il 1168, nel vasto patrimonio dell’abbazia cavense. Nel maggio del 1149, infatti, la bolla pontificia di Eugenio III cita, tra le numerose dipendenze confermate alla SS. Trinità, solo l’ecclesia Sancte Marie de domno83, mentre vent’anni più tardi Alessandro III, nel gennaio del 1168, riporta nuova-mente la conferma e l’esenzione da ogni autorità secolare e religiosa per la chiesa salernitana, ma in questa occasione Santa Maria de domno è ri-cordata cum cellis suis, tra le quali ci sarebbe la cella/chiesa di San Vincen-zo84. L’ipotesi verrebbe confermata anche dal Venereo, il quale nel suo Dictionarium Archivii Cavensis riporta che la chiesa venne concessa a Cava, confirmata et exempta da Alessandro III nel gennaio del 1168, ricordando inoltre che il beneficium della stessa rientra nel patrimonio abbaziale fino al 154885.
82 Per l’architettura, il ciclo di affreschi e la datazione della chiesa di S. Ambrogio si vedano i saggi di p. peduto - d. mauro, Il Sant’Ambrogio di Montecorvino Rovella, «Rassegna storica salernitana» 7, 1990, pp. 15-23; paCe, La pittura medievale in Campania, p. 245, e B. Visentin, Salerno ed il Tusciano in età longobarda: quattro esempi di pittura altomedievale, «Schola Salernitana. annali» 5-6, 2000-2001, pp. 157-195. Per le decorazioni pittoriche del San Vincenzo Maggiore si rimanda a r. hodGes - F. marazzi - J. mitChell, Il San Vincenzo Maggiore di IX secolo, in r. hodGes et alii, San Vincenzo al Volturno, scavi 1994. La scoperta del San Vincenzo Maggiore, «Archeologia Medievale» 22, 1995, pp. 59-67; J. mitChell, The display of script and uses of painting in longobard Italy in Testo ed immagine nell’Alto medioevo, Settimana del Cisam XLI, Spoleto 1994, pp. 940-945.
83 AC, H 7 e Kehr, IP, VIII, 325, nr. 23.84 AC, H 50 falso e P 24: transunto del marzo 1399 – H 51: transunto – I 1: tran-
sunto e Kehr, IP, VIII, 326, nr. 26.85 Venereo, Dict., vol. II, p. 222v.
55Identità signorili e sistemi di gestione tra età longobarda e normanna
L’epilogo
La crisi politica del Principato di Salerno e la conseguente ristruttu-razione degli ambiti territoriali rappresentano i due parametri di fondo sui quali maturano e si muovono, da un lato, l’esperienza del dominatus loci di Giffoni, dall’altro, la nascita e la rapida espansione della grande abbazia cavense.
Alla metà dell’XI secolo mentre un ramo cadetto della famiglia prin-cipesca salernitana, sopravvissuto alla furia omicida del 1052, assume atteggiamenti di tipo signorile, controllando un territorio strategico e ric-co, la SS. Trinità di Cava, guidata dal venerabilis abbas Pietro, mette a punto un sistema accentrato, sul modello di quello cluniacense, assicurando protezione efficace a tante piccole comunità locali che, diversamente, avrebbero incontrato maggiori difficoltà di sopravvivenza. In entrambi i casi si tratta di importanti signorie locali, la prima gravitante attorno ad un castellum, nel quale vivono il dominus e i suoi fideles, e al quale fanno ri-ferimento gli homines subiecti che popolano le terre circostanti; la seconda legata alla santa societas dei monaci, a capo della quale siede l’abate, dive-nuto ineludibile protagonista della società del potere, capace di conciliare le esigenze dell’anima con quelle del mondo.
Cava e Giffoni svolgono un ruolo per nulla marginale nel cambia-mento della scena politica meridionale tra XI e XII secolo, il conte di Conza, Guido, riceve il territorio di Stricturia, ben consapevole delle po-tenzialità che un castello come quello di Giffoni nasconde e inaugura un ricompattamento di ambiti micro-territoriali, forte del titolo di dominus che ha guadagnato86.
Cuore e fulcro del territorio del Picentino, Giffoni diviene la sede di un vasto e complesso dominatus loci, all’interno del quale sorgono le chiese private di San Michele Arcangelo e di San Liberatore che, insie-me a quelle di San Giorgio e di Santa Maria nel castello, permettono un confronto con le cappelle delle signorie territoriali incastellate87. Una presenza così numerosa di chiese appartenenti al dominus loci rappresenta, però, un caso singolare, segno di quell’incremento demografico che in-
86 L’esistenza di una famiglia comitale a Giffoni viene ulteriormente confermata da un atto del 1301 nel quale si legge: terra Gifoni ... fuit olim per celebris quippe quae ab ipso Longobardorum tempore suos comites habuit. Cfr. Syllabus membranarum ad Regiae Siclae Archivum pertinentium, II, Neapoli 1845, p. 60.
87 Cfr. C. Violante, Le strutture organizzative della cura d’anime nelle campagne dell’Italia centrosettentrionale (secoli V-X) in Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’Alto medioeve: espansione e resistenze, Settimane di studio del Cisam, Spoleto 1980, p. 1149.
BarBara Visentin56
teressa l’ultima età longobarda e tutta l’età normanna e, probabilmente, determina nei casali di Giffoni una concentrazione di individui notevole, rendendo necessaria l’edificazione di più cappelle che provvedano alla cura animarum e insieme ad un controllo puntuale degli homines.
La complessità dei diritti signorili esercitati da Guido e dai suoi eredi sulle terre di Giffoni si mostra con chiarezza nella menzione della chie-sa di Sant’Adiutore e dell’oleara, pertinentes hominibus iufunensibus, ai quali non sembra richiesto alcun censo per l’utilizzo del frantoio88. I caratteri originari di queste presenze, apparentemente inspiegabili, vanno forse ricercati in quella che da sempre fu la natura degli arimanni longobardi, uomini liberi anche nel rapporto con il loro dominus, al quale li lega un giuramento di fedeltà e mai una sottomissione di tipo servile. Simili con-cetti sono alla base della gens longobarda e fanno parte di quel bagaglio di tradizioni che ha costituito il nerbo vitale della loro idea di popolo, elementi fondamentali per i quali difendere la propria dignità di uomo e l’unità della stirpe89.
Nella società meridionale del Mezzogiorno medievale alla SS. Trinità di Cava spetta un ruolo assai più multiforme, dal quale emerge una pre-senza cavense poderosa e consistente. L’abbazia pone problemi di carat-tere istituzionale e organizzativo, quali il peso ricoperto nell’ambito della riforma della Chiesa e i rapporti intercorsi tra il monastero e i vescovi; problemi di ordine più strettamente religioso, legati all’incidenza che i monaci ebbero nell’organizzazione della cura animarum, e problemi di ca-rattere politico-sociale, come le relazioni che la Trinità intrattenne con le aristocrazie territoriali. La documentazione presa in esame fornisce una messe copiosa di dati, notizie, elementi, capaci di attestare il ruolo essen-ziale svolto dai monaci e la fortuna toccata alla congregazione cavense tra la fine dell’XI e l’intero XII secolo. Questo straordinario cammino di irradiazione del sistema cavense sembra dettato da fattori molteplici90, il calcolo politico è uno di questi ma ad esso vanno aggiunte le condizioni
88 AC, D 9.89 Per un inquadramento generale sulla natura e sul valore delle tradizioni del po-
polo longobardo si veda s. Gasparri, La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane, Spoleto 1983.
90 A proposito dell’infondatezza di un antagonismo tra il monachesimo latino e quello greco nel Mezzogiorno monastico medioevale e del desiderio di latinizzazione perseguito dai Normanni si veda anche lo studio di G. Vitolo, La latinizzazione dei mo-nasteri italo-greci del Mezzogiorno medievale. L’esempio di S. Nicola di Gallocanta presso Salerno in s. leone - G. Vitolo, Minima Cavensia. Studi in margine al IX volume del Codex Diplomaticus Cavensis, Salerno 1983, pp. 75-92.
57Identità signorili e sistemi di gestione tra età longobarda e normanna
in cui versano la vita religiosa e le istituzioni ecclesiastiche di base, la necessità di garantire il regolare svolgimento della liturgia nelle chiese, l’azione riformatrice condotta da vescovi e pontefici nelle terre del Mez-zogiorno, il modello di profonda spiritualità offerto dagli abati cavensi e la forza della preghiera di cui i monaci si fanno promotori.































![E]E!DH - RERO DOC](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63233b14f3cd44b80906ba12/eedh-rero-doc.jpg)