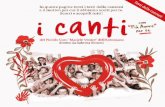Omogeneità costituzionale europea e identità nazionali: un processo di integrazione circolare tra...
Transcript of Omogeneità costituzionale europea e identità nazionali: un processo di integrazione circolare tra...
di Giulia Caponi, Valentina Capuozzo, Ilaria Del Vecchio e Alice Simonetti
Omogeneità costituzionale europea e identità nazionali: un processo di integrazione circolare tra valori
costituzionali europei e teoria dei controlimiti
2 4 D I C E M B R E 2 0 1 4
2 | federalismi.it |n. 24/2014
Omogeneità costituzionale europea e identità nazionali: un processo di integrazione circolare tra valori
costituzionali europei e teoria dei controlimiti*
di Giulia Caponi
Università degli Studi di Firenze
Valentina Capuozzo Dottoranda di ricerca in “Diritto dell’economia e tutela delle situazioni soggettive”
Università di Napoli Federico II
Ilaria Del Vecchio Dottoranda di ricerca in Discipline giuridiche
Università degli Studi Roma Tre
Alice Simonetti Dottoranda di ricerca in “Scienze giuridiche
Università degli Studi di Firenze
* Il contributo rientra tra i lavori inviati in risposta alla Call for papers di federalismi “Valori comuni e garanzie costituzionali in Europa” ed è stato sottoposto ad una previa valutazione del Direttore della Rivista e al referaggio dei Professori Cassetti, Curti Gialdino, Gui, Miccù e Ridola. Il presente lavoro nasce da un confronto tra le Autrici nell'ambito del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi”, di cui sono state allieve per l'anno 2014. Il paragrafo 1 è di Ilaria Del Vecchio, il 2 di Giulia Caponi, il 3 di Valentina Capuozzo, il 4 di Alice Simonetti e le conclusioni (§5) sono il frutto di riflessioni congiunte.
3 | federalismi.it |n. 24/2014
Sommario: 1. Il binomio omogeneità costituzionale europea e identità nazionali quale
presupposto di una koinè europea. 1.1. Il mutato assetto istituzionale. 1.2. L'omogeneità
costituzionale e il riconoscimento normativo dei cc.dd. valori costituzionali comuni. 1.3. Il
concetto di identità nazionale degli Stati membri e la teoria dei cc.dd. controlimiti. 1.4. Basi per
una nuova prospettiva. 2. La teoria dei controlimiti in Europa, due casi discussi: Germania e
Repubblica Ceca. 2.1 La decisa presa di posizione del Bundesverfassungsgericht: è davvero un
limite all’integrazione europea? 2.2. Da Karlsruhe a Brno: un diverso modo di intendere la teoria
dei controlimiti? 3. Diritti fondamentali e identità europea nella prospettiva della Corte
costituzionale italiana. 3.1. L'evoluzione giurisprudenziale della teoria dei controlimiti. 3.2. La
complessa articolazione delle fonti: Corte costituzionale e CEDU. 3.3. La costruzione teorica alla
prova dell'esperienza: quale il ruolo della Corte nell'ambito della tutela multilivello dei diritti
fondamentali. 4. Analisi della prassi delle istituzioni UE, con particolare riferimento alla Corte di
Giustizia e l'art. 7 TUE come garante politico dei valori comuni nel dialogo tra istituzioni UE e
Stati membri. 4.2. Giurisprudenza in tema di omogeneità delle tradizioni comuni e dei livelli di
tutela. 4.3. La Corte di Giustizia e le identità costituzionali degli Stati membri. 4.4. Carta di Nizza
e CEDU e la loro influenza sulla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo. 5. Conclusioni.
1. Il binomio “omogeneità costituzionale europea-identità nazionali” quale presupposto
di una koinè europea
Già prima del Trattato di Lisbona, un’attenta dottrina individuava nella dialettica “omogeneità
europea-identità nazionali” non il limite ma piuttosto il fondamento del processo di
costituzionalizzazione europeo 1 . Tale dottrina legittimava il percorso volto ad una Multilevel
Constitution2 sulla base del processo di integrazione tra i Trattati, da un lato, e le Costituzioni degli
Stati membri dall’altro3.
A più di un decennio di distanza, nonostante le profonde modificazioni subite dall’ordinamento
europeo si è reso partecipe, ci pare utile prendere le mosse proprio da quei due estremi dialettici
1 Cfr. V. ATRIPALDI, Verso un trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, in V. ATRIPALDI- R. MICCÙ, L’omogeneità costituzionale nell’Unione Europea, Padova, 2003, pp. 3 ss. 2 Si v., primo a coniare il termine, I. PERNICE, Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-making revisited?, in Comm. Mark. Law Rev., 1996, p. 703 ss. Per una dottrina critica sull’istituto cfr. M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. Cost., 51, 2006, pp. 1643-1668. 3 Cfr. V. ATRIPALDI, Sul processo di costituzionalizzazione dell’UE, in Rivista di Studi politici internazionali, 2002, p. 642.
4 | federalismi.it |n. 24/2014
per indagare lo stato di evoluzione della c.d. koinè costituzionale4.
1.1 Il mutato assetto istituzionale
Il background europeo che segnava i primi anni del nuovo millennio era senz’altro diverso da
quello odierno. Molti erano gli spunti che inducevano a sperare in una imminente “svolta” nel
sistema istituzionale. Difatti, la proclamazione a Nizza della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea5 e la preparazione del Trattato che istituiva una Costituzione per l’Europa,
costituivano senza dubbio una grossa accelerazione nel passaggio da un’Unione europea solo
economica ad una Unione politica6, creando non poca aspettativa nei commentatori dell’epoca7.
Oggi i presupposti non sono più gli stessi. Due gli avvenimenti di maggior rilievo. Da una parte è
a tutti noto il fallimento del c.d. Trattato costituzionale, sottoscritto a Roma nel 2004, non
ratificato da Francia e Paesi Bassi a seguito dei referendum popolari con esito negativo e, infine,
definitivamente abbandonato nel 2009. D’altro canto, però, il valore giuridico vincolante della
Carta dei diritti fondamentali è stato finalmente riconosciuto e l’accantonato testo costituzionale
è quasi totalmente trasfuso nel Trattato di riforma dell’Unione europea, approvato a Lisbona nel
2007 ed entrato in vigore a partire dal 1° dicembre 2009.
Non si può dunque ritenere definitivamente archiviato il processo costituzionale europeo quanto
piuttosto instradato in un diverso, sicuramente tortuoso, percorso.
1.2 L’omogeneità costituzionale e il riconoscimento normativo dei cc.dd. valori
costituzionali comuni
Primo termine della dicotomia proposta è il principio di omogeneità costituzionale8.
4 Alla koinè costituzionale è dedicata un’intera collana, edita da Giuffré, diretta da R. BIFULCO - G. DEMURO – M. OLIVETTI – N. LUPO – M. CARTABIA – M. RUOTOLO – A. BOGDANDY – M- MADURO. 5 Per la dottrina che vedeva la Carta come parte integrante del processo di costituzionalizzazione si v. L.S. ROSSI, Carta dei diritti come strumento di costituzionalizzazione dell’ordinamento comunitario, in Quad. Cost., 2002, 566; contra A. PACE, A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea? Appunti preliminari, in Giur. Cost., 2001, 193 ss. il quale riteneva la Carta un mero testo unico solo in alcune parti innovativo. 6 A. CELOTTO - G. PISTORIO, L'efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (rassegna giurisprudenziale 2001-2004), in Giur. it., 2004, pp. 427 ss. 7 Si v. C.A. CIAMPI, discorso Presidente della Repubblica a Lipsia il 6 luglio 2000, in http://www.quirinale.it/qrnw/statico/ex-presidenti/ciampi/dinamico/discorso.asp?id=12719, «European integration is now moving beyond the economic and monetary dimensions alone to become a genuine bond of democratic solidarity. This process (…) requires a European Constitution». 8 Si v. R. MICCÙ, Il principio di omogeneità nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea, in V. ATRIPALDI- R. MICCÙ, L’omogeneità costituzionale nell’Unione Europea, Padova, 2003, pp. 49-133 e ID., Proteggere la democrazia. Rinnovare il “contratto sociale” europeo, in federalismi.it, 3, 2014. L’A. individua due diverse
5 | federalismi.it |n. 24/2014
La richiamata dottrina pre-Lisbona individuava quale quadro normativo di riferimento gli artt. 6,
par. 1 e 7 del Trattato sull’Unione europea9: il primo positivizzava l’omogeneità come principio
ordinamentale dell’Unione europea e il secondo prevedeva un procedimento politico di sanzione
contro lo Stato membro qualora avesse violato i contenuti della omogeneità costituzionale.
Oggi l’impianto normativo è confermato ed arricchito nella versione consolidata del Trattato
sull’Unione europea. Oltre al riconoscimento espresso dei diritti fondamentali previsto dall’art. 6,
par. 1 TUE -il quale richiama la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e le
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri- e al “garante politico” costituito dal
meccanismo di censura e da quello sanzionatorio ex art. 7 TUE10, oggi il neoistituito art. 2 TUE
dichiara solennemente che l'Unione si fonda su valori che sono comuni agli Stati membri11.
La base giuridica cui ancorare la tutela dei diritti fondamentali in Europa è dunque tripartita. La
fonte non è solo la Carta dei diritti fondamentali, con la rinnovata natura giuridicamente
vincolante, ma anche la CEDU, alla quale si dichiara espressamente di aderire, e ai «principi
generali del diritto dell’Unione di cui fanno parte i diritti garantiti dalla CEDU e quelli risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri»12.
Ma qual è la portata e l’utilizzo effettivo delle tradizioni costituzionali comuni dal momento che
alla Carta viene attribuito lo stesso valore giuridico dei Trattati e la CEDU è da sempre ritenuta
«portatrice di uno jus commune tra gli Stati membri in materia di diritti fondamentali»?13.
È noto che i diritti fondamentali, in quanto tali, hanno una natura tendenzialmente universale in
base alla quale ben si prestano ad essere protetti più a livello internazionale che nel ristretto
ambito locale. Partendo da questo presupposto, risulta evidente che la posizione della Corte di
Giustizia è privilegiata nel poter attribuire una portata sovranazionale alla tutela dei diritti
fondamentali, individuando il rispetto di quei diritti quale parametro di giudizio ed andando così a
componenti dell’omogeneità, la componente sostanziale rintracciabile nella base comune di valori condivisi e quella istituzionale costituita da un assetto costituzionale posto a garanzia della stessa omogeneità. 9 Cfr. V. ATRIPALDI, Verso un trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, cit., pp. 8 ss. 10 Cfr. C. SANNA, Commento all’art. 7 TUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell'Unione Europea, Milano, 2014, pp. 70-78 dove si parla di «procedura di pre-allarme» per il meccanismo previsto dall’art. 7, par. 1 TUE e di «procedura sanzionatoria» per quello previsto dall’art. 7, par. 2 TUE. 11 Si ritiene che l’art. 2, comma 1 TUE sia «l’enunciazione del progetto politico volto a delineare un “Unione di valori”» (L. FUMAGALLI, Commento all’art. 2 TUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell'Unione Europea, cit., p. 14. 12 Cfr. B. GUASTAFERRO, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale. Tensioni costitutive e giunture ordinamentali, Milano, 2013, p. 170. 13 V. B. GUASTAFERRO, cit., p. 173.
6 | federalismi.it |n. 24/2014
ricompattare il giudizio di legalità costituzionale14.
Problema prioritario appare, dunque, l’individuazione delle stesse tradizioni comuni dal momento
che la Corte di Giustizia, nello scrutinio sul rispetto dei diritti fondamentali, svolge un ruolo non
dissimile da quello delle Corti costituzionali nazionali senza avere però un parametro di
riferimento certo15.
L'identificazione dei valori costituzionali comuni 16 sembrerebbe, prima facie, esigere una
valutazione comparatistica dei diritti fondamentali protetti nei singoli Stati membri, tanto più che
la Carta all’art. 52 richiede che i diritti fondamentali risultanti dalle tradizioni locali siano
interpretati in armonia con quest’ultime (comma 4) e che sia tenuto pienamente conto delle
legislazioni e delle prassi nazionali (comma 7).
La giurisprudenza della Corte di Giustizia sembra, però, non seguire alla lettera tale approccio
metodologico. Essa non compie una indagine analitica dei vari ordinamenti ma fa riferimento
nella maggior parte dei casi ad uno specifico ordinamento da prendere a modello della tradizione
costituzionale17.
L’individuazione del patrimonio comune europeo cede il passo alla scelta del patrimonio dei
diritti dello Stato che meglio si adatta alla soluzione del caso concreto all'esame della Corte18.
Non si può non costatare come le difficoltà operative di individuazione delle tradizioni
costituzionali, la maggiore fruibilità dei diritti enucleati da Carta e Convenzione e il più ampio
margine di manovra lasciato alla Corte di Lussemburgo dalle stesse abbia marginalizzato, fino ad
oggi, il ruolo delle tradizioni comuni relegandole in una posizione residuale e di poco conto.
Nell’ottica di chi scrive, la prassi seguita dalla Corte, benché giustificata da ragioni di ordine
pratico, non può essere avallata, tanto più se la si voglia inserire in un percorso volto al
consolidamento di un processo di integrazione costituzionale.
Non bisogna dimenticare, infatti, che accanto all’attitudine “universalizzante” dei diritti
fondamentali basata sul “nucleo duro” della dignità umana deve coesistere ed essere preservata
14 In questo senso v. B. GUASTAFERRO, cit., pp. 183-184. L’A. parla di vera e propria «estensione della legalità sovranazionale attraverso il rispetto dei diritti fondamentali» (p. 160). 15 Come rilevato acutamente da G. MORBIDELLI, Corte costituzionale e Corti Europee: la tutela dei diritti (dal punto di vista della Corte di Lussemburgo), in Dir. proc. amm., fasc. 2, 2006, pp. 286 ss. 16 Non a caso in questa sede si preferisce parlare di valori o di enunciazioni di principio piuttosto che di regole autoapplicative o clausole operative in senso proprio. 17 Si v., ad es., sent. 9 novembre 1995, Atlanta, causa C-465/93 dove, ai fini della definizione del diritto alla tutela giurisdizionale, si fa riferimento alla Legge fondamentale tedesca (art.19, comma 4). 18 Cfr. A. BALDASSARRE, La Carta europea dei diritti, in http://static.luiss.it/semcost/europa/carta/. G. MORBIDELLI, loc. ult. cit., ritiene che «in assenza di una tradizione costituzionale uniforme, la Corte tende a privilegiare quella che maggiormente è in sintonia con l’interesse comunitario».
7 | federalismi.it |n. 24/2014
anche la dimensione storico-culturale degli stessi. L’esigenza di andare oltre i confini dell’ordine
legale nazionale non deve travolgere le peculiarità storico-sociali locali19. Quello a cui si deve
mirare è una omogeneità che esprima affinità costituzionali e non una mera uguaglianza di forme
insensibile alle molteplici realtà di cui l’Unione si compone.
In altre parole, la vocazione pluralistica dell’Unione europea si andrebbe progressivamente
snaturando se quella ricchezza, costituita dalla specificità delle tutele apprestate dai singoli Stati,
fosse completamente bypassata a favore di un non meglio identificato valore comune20.
1.3 Il concetto di identità nazionale degli Stati membri e la teoria dei cc.dd. controlimiti
L’identità nazionale, come preannunciato, intende essere la seconda lente di ingrandimento dalla
quale analizzare lo stato di integrazione dei valori costituzionali nell’Unione europea.
Il progetto di Costituzione europea, benché all’art. I-6 codificasse la prevalenza del diritto
comunitario sul diritto degli Stati membri21, d’altro canto sanciva, all’art. I-5, il rispetto da parte
dell’Unione dell’identità nazionale dei singoli Stati insita nella loro struttura fondamentale, politica
e costituzionale.
Con il Trattato di Lisbona si è messa da parte l’affermazione solenne della primautè del diritto
comunitario22, ora previsto nella Dichiarazione n. 17 avente senza dubbio forte valore politico ma
non lo stesso valore giuridico dei Trattati23, mentre si è confermato e ampliato l’ossequio alle
identità nazionali da parte dell’Unione.
L’art. 4, par. 2 TUE, oltre a sancire per la prima volta esplicitamente il principio di eguaglianza
degli Stati membri24, richiama la c.d. clausola sul rispetto delle identità nazionali, già introdotta dal
Trattato di Maastricht ma arricchita oggi di una diversa lettura.
La versione originale della clausola era contenuta nell’art. 6 TUE pre-Lisbona ed era strettamente
19 Attenta a questo duplice natura è M. CARTABIA, Europe and Rights: Taking Dialogue Seriously, in European Constitutional Law Review, 5, p. 20, la quale afferma «We must not (…) forget the ambivalent nature of fundamental rights». 20 Cfr. M. CARTABIA, “Unita nella diversità”: il rapporto tra la Costituzione europea e le Costituzioni nazionali, in Dir. un. eur., 3, 2005. 21 Fino ad allora dichiarato solo in via pretoria. Per la prima affermazione della primazia del diritto comunitario si v. Sent. 15 luglio 1963, causa 6/64, Costa c. ENEL. 22A. CELOTTO - T. GROPPI, Diritto UE e diritto nazionale: primauté vs. controlimiti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2004, p. 1309 ss. 23 Il principio della primazia è stato «derubricato», in quanto scompare dal testo del Trattato e viene relegato alla Dichiarazione n. 17. Cfr. A. CELOTTO, La primauté nel Trattato di Lisbona, in A. LUCARELLI - A. PATRONI GRIFFI (a cura di), Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi Studi sulla Costituzione europea, Napoli, 2009; ID., Primauté e controlimiti nel Trattato di Lisbona, in A. CELOTTO, Scritti sul processo costituente europeo, Napoli, 2009, pp. 84 ss. 24 V. M. CARTABIA, Commento all’art. 4, par. 2 TUE in A. TIZZANO (a cura di), cit., p. 23.
8 | federalismi.it |n. 24/2014
connessa alla garanzia dei diritti fondamentali.
La nuova collocazione e la formula più ampia portano a valutare la clausola, nella versione
odierna, non solo come garanzia dei diritti fondamentali e come tutela del pluralismo di cui si
caratterizza l’ordinamento europeo 25 ma anche come argine all’incessante espansione delle
competenze dell’Unione26.
Intendere le identità nazionali quali «scelte di valore espresse dalle Costituzioni nazionali»27 porta
a ritenere compiuta l’“europeizzazione” dei controlimiti nazionali e dunque la possibilità di
interpretare diversamente il classico istituto, nato nella giurisprudenza delle Corti costituzionali al
fine di preservare un nucleo essenziale di principi e diritti fondamentali sui quali si assumeva
fondarsi l’identità costituzionale nazionale28.
I controlimiti, difatti, originariamente posti quale limite esterno al processo di integrazione29,
diventano oggi interni al sistema sovranazionale grazie alla sopracitata clausola e per questo
potenziale punto nodale del processo di integrazione tra ordinamenti.
Se sul piano teorico l’art. 4, par. 2 TUE potrebbe aprire le strade alla valutazione del rispetto dei
controlimiti da parte della stessa Corte di Giustizia, prospettandosi addirittura l’ipotesi
paradossale del rinvio pregiudiziale alle Corti nazionali da parte del giudice di Lussemburgo30, dal
punto di vista pragmatico, ancora una volta la giurisprudenza della Corte di Giustizia sembra non
cogliere la potenzialità espansiva offerta dall’art. 4, par. 2 TUE.
Sulla base della clausola in esame, inoltre, la Corte di Lussemburgo potrebbe essere chiamata a
giudicare la validità degli atti comunitari. Nonostante, ad oggi, tale competenza non sia mai stata
25 Così era interpretata la clausola nella versione originaria. Cfr. M. CARTABIA, op. ult. cit., p. 24 la quale sottolinea come solitamente l’identità di un ordinamento giuridico è basata sui valori fondamentali dello stesso, l’ordinamento giuridico europeo avendo una natura composita, non può che fondare i propri valori sulle identità dei singoli Stati membri. 26 L’esigenza di proteggere il nucleo centrale di funzioni Statali è stata avvertita in sede di Convenzione durante i lavori preparatori del Trattato costituzionale. Cfr. B. GUASTAFERRO, Beyond the Exceptionalism of Constitutional Conflicts: The Ordinary Functions of the Identity Clause, in Yearbook of European Law, 2012. 27 Cfr., sebbene riferito al precedente art. I-5 Tr. Cost., M. CARTABIA, “Unità nella diversità”: il rapporto tra la Costituzione europea e le Costituzioni nazionali, cit. 28 L’espressione, coniata da P. Barile agli inizi degli anni settanta, indica i principi supremi e i diritti inalienabili della persona umana i quali non possono essere violati neppure dal diritto comunitario nonostante le limitazioni di sovranità riconosciute ex art. 11 Cost. 29 Così A. CELOTTO - T. GROPPI, cit., p. 1377 in cui si parla di «rigurgito di orgoglio nazionale» nell’accezione più estrema della teoria. 30 Questa possibilità è sostenuta da A. RUGGERI, Trattato costituzionale, europeizzazione dei "controlimiti" e tecniche di risoluzione delle antinomie tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici), in AA. VV., Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle costituzioni, Atti del Convegno annuale del 'Gruppo di Pisa'. Capri, 3-4 giugno 2005, Milano, 2006, p. 846 s. L’ A. constata anche che l’ipotesi del rinvio pregiudiziale inverso è fortemente improbabile dal momento che l’istituto non è previsto dal Trattato.
9 | federalismi.it |n. 24/2014
esercitata dal momento che la Corte non è mai pervenuta all’annullamento di atti normativi
europei per mancato rispetto delle identità nazionali, non si deve sottovalutare la portata che tale
“avocazione” a livello europeo può avere: le eventuali violazioni dei controlimiti nazionali da
parte di atti comunitari non sarà più esclusivo appannaggio delle Corti costituzionali nazionali
ma, ex art. 4, par. 2 TUE sarà invocabile dinnanzi alla Corte di Lussemburgo alla quale spetta
anche, in maniera tutt’altro che secondaria, il bilanciamento con gli altri diritti tutelati dall’Unione.
1.4 Basi per una nuova prospettiva
Si ritiene che l’equilibrio tra “unità” e “diversità” sia, a seguito dell’abortito tentativo di
Costituzione europea, spostato a vantaggio della differenziazione e che l’integrazione europea sia
ormai avviata verso un costituzionalismo asimmetrico31.
È indubbio, ad esempio, che rispetto alla secca affermazione della primazia del diritto europeo
senza ammissione di riserva alcuna32 la previsione, oggi espressa nei Trattati, del rispetto delle
identità nazionali e della tutela delle tradizioni giuridiche degli Stati membri in generale lascia
intravedere una incrementata attenzione dell’Unione nei confronti dei patrimoni nazionali e nella
tutela del pluralismo statale.
Può dunque dirsi completato il processo di integrazione europeo? Nell’odierno quadro
economico-politico possiamo ritenere soddisfacente l’impostazione “flessibile” della
partecipazione europea?
Per rispondere a queste domande il prosieguo del lavoro tenterà di mettere in luce i punti di forza
e le carenze del processo di integrazione europeo dal punto di vista delle Corti.
La scelta di prediligere la chiave di lettura giurisprudenziale non è casuale ma motivata dalla
convinzione che, come si avrà modo di dimostrare, nella situazione contingente l’unico
strumento di integrazione effettiva possa essere il dialogo fra Corti. Si partirà dalle Corti che più
di altre hanno sviluppato un atteggiamento difensivo nei confronti dell’integrazione tout court, per
passare alla tortuosa e plurifasica esperienza italiana per finire con la giurisprudenza dei giudici
europei.
31 Cfr. A. CANTARO, Le “filosofie” dell’integrazione sovranazionale, in A. CANTARO (a cura di), Il costituzionalismo asimmetrico dell’Unione. L’integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona, Torino, 2010, p. 17 s. 32 Cfr. Sent. 15 luglio 1963, causa 6/64, Costa c. ENEL dove si affermata che la primautè del diritto comunitario trovasse riscontro nell’art. 189 (ora 249) TCE e che questa disposizione «sarebbe prima di significato se uno stato potesse unilateralmente annullarne gli effetti con un provvedimento nazionale che prevalesse sui testi comunitari».
10 | federalismi.it |n. 24/2014
2. La teoria dei controlimiti in Europa: due casi discussi, Germania e Repubblica Ceca.
L’ampliamento della tutela dei diritti fondamentali con la tecnica dell’“integrazione mediante il
diritto” da parte della Corte di Giustizia ha contribuito a contrario a rafforzare il principio di
identità nazionale e di sovranità degli Stati Membri nell’attività delle Corti costituzionali, inteso
come reazione al pericolo di un’estensione sia legislativa che giurisprudenziale dell’ambito di
applicazione del diritto dell’Unione. Sarebbe errato, però, ritenere che questa riaffermazione dei
valori e identità nazionali si sia esplicata soltanto a partire dall’ iter che ha portato all’approvazione
del Trattato di Lisbona perché in realtà le pronunce che qui saranno esaminate sono il risultato di
un lento ma costante percorso affine per tempistica a quello dell’integrazione europea 33 .
Un’ulteriore precisazione è opportuna: la teoria dei controlimiti, pur avendo un nucleo comune a
tutti gli Stati, è per sua natura adattabile alle tradizioni, sensibilità e valori di ciascuno dei Paesi
componenti l’Unione e al fine di evidenziare tanto le somiglianze che le differenze è quindi
opportuno analizzare le esperienze più significative a tal riguardo.
2.1 La decisa presa di posizione del Bundesverfassungsgericht: è davvero un limite
all’integrazione europea?
I rapporti fra il Tribunale costituzionale federale tedesco e l’ormai ex Comunità Economica
Europea durante gli anni Sessanta e primi anni Settanta si contraddistinguevano per la piena
esaltazione del diritto comunitario come ordinamento autonomo rispetto a quello interno. Infatti
il giudice tedesco si dichiarava incompetente a verificare la compatibilità delle norme comunitarie
con quelle interne perché emanate da un ordinamento, istituito con un Trattato, a cui sono
devolute parti della sovranità statale. Questo procedimento era consentito dalla Legge
Fondamentale34 che implica il riconoscimento dell’ordinamento comunitario come autonomo e
sovrapponibile a quello interno. Spetta al giudice ordinario valutare la compatibilità della norma
interna con quella sovranazionale perché il principio del primato è giustificato dalla natura
dell’ordinamento comunitario che non interferisce con le competenze interne dello Stato in
ragione del principio di attribuzione35.
Questa apertura all’ordinamento sovranazionale è stata considerevolmente ridotta nella sentenza
33 L.VIOLINI, La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul Trattato di Lisbona, in Quad. cost. n. 4, 2009 ,pag. 591. 34 Art. 24, comma 1 «La Federazione può trasferire con legge diritti di sovranità a organizzazioni intergovernative». 35 Quando detto è espresso chiaramente nella sentenza 9 giugno 1971. Per maggiori dettagli v. M.R. DONNARUMMA, Il processo di costituzionalizzazione dell’UE e la tensione dialettica fra giurisprudenza Corte UE e giurisprudenza Corti costituzionali nazionali , in Riv. Dir. Pubbl. Comp., 2010, pag. p. 406 ss. P. CEDE, Report on Austria and Germany in G. MARTINICO , O. POLLICINO (a cura di), The National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws, European Law Publishing, 2010, p. 57 ss.
11 | federalismi.it |n. 24/2014
Solange I del 29 maggio 197436 dove il Bundesverfassungsgericht ha affermato la sua competenza a
conoscere della violazione dei diritti fondamentali da parte di un atto comunitario derivato. Per la
prima volta il giudice federale esercita un controllo nei confronti degli atti comunitari,
successivamente riaffermato nel Lissabon Urteil, dovuto alla constatazione che la Comunità fosse
priva di un catalogo di diritti e che il Parlamento europeo non potesse incidere efficacemente
nella loro tutela visto la sua funzione meramente consultiva. Per questo, il Tribunale
costituzionale federale si è dichiarato competente fin tanto che (“solange”) la CE non si fosse
dotata di adeguati meccanismi di tutela dei diritti. Il suo è un approccio rigoroso: prima deve
compiere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, prospettandole le perplessità rilevate in
ordine alla compatibilità dell’atto dell’Unione con i diritti fondamentali tutelati dalla LF e solo
dopo la eventuale risposta negativa, svolgere la sua valutazione.
Il giudice tedesco sembra tornare sui suoi passi con la successiva e altrettanto famosa Solange II
del 22 ottobre 1986 dove riconosce che la Comunità ha incrementato la tutela dei diritti a livello
giurisprudenziale, garantendo una protezione almeno equivalente a quella degli ordinamenti
nazionali37. Nondimeno, però, qualora il livello di tutela dovesse arretrare, il Tribunale si riserva di
estendere nuovamente il controllo sul rispetto dei diritti fondamentali. Infatti il trasferimento di
competenze dagli Stati alla CE si deve arrestare quando tocca i principi giuridici sui quali si basa
la Legge Fondamentale consacrata ai diritti fondamentali38.
Dello stesso tenore è la decisione Maastricht Urteil che consente alla Germania di ratificare il
Trattato CE poiché la tutela dei diritti in Europa è considerata sufficientemente estesa da
individuare un catalogo di diritti implicito39 , derivante non solo dal Trattato ma anche dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia. In questo modo è stata consentita l’introduzione dell’art.
23 LF 40 che consente espressamente l’adesione della Germania all’Unione europea,
36 Per ulteriori approfondimenti v. P. CEDE op. ult. cit., M.R. DONNARUMMA, op. ult. cit. Per una specificazione del controllo sui diritti fondamentali v. P. FARAGUNA, Limiti e controlimiti nel Lissabon-Urteil del Bundesverfassungsgericht: un peso, due misure, in Quad. cost., n.1,2010, p. 82. 37Alcuni Autori hanno espresso perplessità su tale affermazione, sostenendo che il parametro valutativo inerente alla protezione equivalente sia eccessivamente ampio e astratto. Per approfondimenti v. P. CEDE, op. ult. cit. 38 M.R. DONNARUMMA., op. ult. cit. 39 Questo catalogo diverrà esplicito con l’approvazione della Carta di Nizza del 2000, ora equiparata ex art. 6 par.1 TUE ai Trattati con riguardo agli effetti giuridici. 40Art. 23 1 co: “Per la realizzazione di un'Europa unita la Repubblica federale di Germania collabora allo sviluppo dell'Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal Bundesrat, trasferire diritti di sovranità. Per l'istituzione dell'Unione Europea, per le modifiche delle norme dei trattati e per le regolazioni analoghe, mediante le quali la
12 | federalismi.it |n. 24/2014
distinguendola dalle altre organizzazioni internazionali. La necessità di una “tutela equivalente” è
così sentita da parte del legislatore federale che, in omaggio a Solange II, recepisce questo
parametro come fatto-presupposto dei rapporti fra Germania e Unione europea.
Questo percorso di integrazione europea ha subito una battuta di arresto, a detta di molti
commenti41 formulati all’indomani della pronuncia, con la decisione del 30 giugno 2009 (c.d.
Lissabon Urteil), quando il Bundesverfassungsgericht si è trovato a decidere sulla legittimità della legge
di esecuzione e di revisione costituzionale in relazione ad alcune disposizioni della LF a seguito
della ratifica del Trattato42. Con questa pronuncia, il Tribunale sostiene che il Trattato di Lisbona
consente l’ultima estensione possibile delle competenze dell’Unione. Il giudice costituzionale
tedesco considera l’Unione europea come “una comunità giuridica fondata sul diritto
internazionale, permanentemente supportata dalla volontà degli Stati membri”43, un’Associazione
di Stati (Staatenverbund), la cui opera è legittimata in virtù del principio di attribuzione44. Sono gli
Stati membri i Padroni dei Trattati e pertanto è vietata dalla stessa Legge Fondamentale
l’estensione delle competenze dell’Unione tramite il principio Kompetenz-kompetenz 45 . Qualora
l’Unione non rispettasse questo principio, la Germania, proprio perché è uno dei Padroni dei
Trattati, potrebbe legittimamente esercitare il diritto di recesso (art. 50 TUE) come extrema ratio.
Gli Stati hanno delegato parte della loro sovranità in specifiche materie ma in ogni caso le Corti
costituzionali nazionali non hanno mai abdicato al controllo ultra vires che valuta il rispetto di un
atto dell’Unione delle competenze specificamente attribuite. Poiché è un ordinamento derivato,
non può imporre a sua volta agli Stati il principio Kompetenz-kompetenz a suo favore dal momento
presente Legge fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica l'articolo 79, secondo e terzo comma”. 41 Fra i commenti più critici cfr. S. CASSESE, Trattato di Lisbona: la Germania frena. L’unione europea e il guinzaglio tedesco, in Giorn. Diritto Amministrativo, n.9, 2009; M.P. CHITI, Am deutschen Volke, in Gior. Diritto Amministrativo, n. 9/2009 dove l’A. afferma che in questa decisione il Tribunale Federale non ha tenuto conto dei cinquanta anni di storia del processo di integrazione europea. L. VIOLINI, op. ult .cit, dove riprende la osservazione fatta da Ipsen nei confronti del ragionamento del Tribunale Federale che vuole imporre all’Unione un’omogeneità parametrata sulla propria Costituzione. N. VEROLA, Volk, patriottismo parlamentare e sovranità . Osservazioni sulla “Lissabon Entscheidung” della Corte Costituzionale tedesca in www.astrid.ue, 2010 dove si esorta a leggere la sentenza in chiave conservativa. 42 Si trattava di due ricorsi individuali e due conflitti fra organi aventi ad oggetto la presunta illegittimità della legge di esecuzione, della legge di revisione e della legge di rafforzamento dei poteri del Bunderstrat e Bunderstag negli affari europei nei confronti degli artt. 23 1 co. e 38 1 co. LF. 43 R. DICKMAN, Integrazione europea e democrazia parlamentare secondo il tribunale federale tedesco in www.federalismi.it , n. 14/2009. 44 Art. 5 par. 2: “ In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione appartiene agli Stati”. 45 Cfr. par. 233 lett. d della decisione. Il principio Kompetenz-kompetenz consente la competenza ad estendere autonomamente la propria competenza.
13 | federalismi.it |n. 24/2014
che vi è l’art. 4.2 TUE che tutela l’identità nazionale di questi, assunta a principio fondamentale
dell’ordinamento tedesco. Infatti essa esprime il principio democratico che osta ad una delega in
bianco dei poteri legislativi all’Unione perché verrebbe violato il diritto di voto dei cittadini
tedeschi e il loro diritto all’autodeterminazione visto che le istituzioni europee hanno un grave
deficit democratico che impedisce a ciascun voto di avere peso uguale. Pertanto è necessario che vi
sia un controllo di identità nazionale (Identitaskontrolle46) per evitare lesioni da parte dell’Unione a
questo nucleo di principi fondamentali espressamente richiamati dalla “clausola di eternità” ex art.
79, comma 3 LF. In sostanza, il giudice tedesco applica i limiti della revisione costituzionale ai
rapporti esterni con un ordinamento sovranazionale47, utilizzando l’art. 38, comma 1 . LF in
combinato disposto con l’art. 20, comma 1 e art. 79, comma 3 come parametri. Ciò gli consente
di estendere l’ambito di applicazione della teoria dei controlimiti. Nel caso di violazione, gli atti
europei saranno inefficaci e tale valutazione spetterà al solo Tribunale costituzionale federale48.
Nonostante il punto di vista fermo del giudice costituzionale tedesco, una parte della dottrina49
non ha ritenuto che vi potesse essere pericolo per l’esistenza dell’Unione ma tutt’al più un
cambiamento di prospettiva verso una maggiore considerazione e valorizzazione del ruolo degli
Stati membri: da «uniti nella diversità» a «diversi nell’unità»50. La stessa UE con la disposizione
dell’art. 12 TUE51 incrementa i poteri dei Parlamenti nazionali nel controllo sulle attività della ex-
Comunità. Una valorizzazione dell’identità nazionale sia interna alle istituzioni sovra-nazionali
che esterna, compiuta sia a livello legislativo sia giurisprudenziale.
Questo assetto però non è stato definitivo. Il supremo giudice tedesco, infatti, è ritornato sulla
46 Par. 240-241 della sentenza. 47 Ci sono state molte critiche a questa equiparazione. Cfr.:S. CASSESE, op. cit, dove giudica l’utilizzo di questa clausola “ funzionalmente distorto” perché originariamente il suo utilizzo era volto per scongiurare derive dittatoriali mentre ora è impiegata come parametro di costituzionalità degli atti dell’Unione. Altro dubbio sulla correttezza dell’equiparazione riguarda le conseguenze della violazione: nei confronti di una legge di revisione costituzionale, si ha nullità radicale mentre nei confronti di un atto dell’Unione solo inefficacia. Per maggiori approfondimenti, v. P. FARAGUNA, op. cit. 48 Numerose sono state le perplessità relative all’applicazione concreta di questo controllo. Cfr. P. FARAGUNA, op. ult. cit., dove l’A. ritiene che prima il Tribunale federale dovrebbe fare rinvio alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, sottoponendole il contrasto, e solo in caso di risposta negativa, possa esercitare lei stessa il controllo di identità. Dello stesso avviso, V. BALDINI, Il Trattato di Lisbona e il rispetto del limite dell’identità costituzionale. La “sentenza-Lisbona” del Bundesverfassungsgericht ed i limiti ad uno sviluppo secundum Constitutionem dell´ordinamento sovranazionale in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2010. 49 Questi A. sostengono che questi controlimiti, nonostante l’affermazione del Tribunale costituzionale volta al loro ampliamento, avranno lo stesso destino loro riservato nel passato: avranno un valore solo teorico e non pratico. Cfr. S. GAMBINO, op. ult. cit.; A. RANDAZZO, La dei controlimiti riletta alla luce del Trattato di Lisbona: un futuro non diverso dal presente?, in www.Diritticomparati.it, 2011. 50 S. GAMBINO, Identità costituzionali nazionali e Primautè eurounitaria, in Quad. Cost. n. 3, 2012, par.2. 51 L’art. 12 TUE valorizza il principio di sussidiarietà che insieme al principio di attribuzione esprime la natura derivata dell’Unione.
14 | federalismi.it |n. 24/2014
questione nella decisione del 6 luglio 2010 (Honeywell) 52 , precisando e ridimensionando le
affermazioni contenute nella decisione precedente che avevano sollevato un dibattito in dottrina
in merito all’applicazione concreta del controllo. Così nei casi di presunta violazione dell’identità
nazionale ad opera di un atto europeo, deve esserci sempre l’interpretazione favorevole al diritto
europeo (Europarechtsfreundlichkeit) che impone un previo rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia per segnalare il presunto contrasto53. In sostanza, è una sorta di ultimatum per il giudice
dell’Unione di dare all’atto un’interpretazione costituzionalmente orientata54. Dalla sentenza in
esame, però, risulta una sorta di «tolleranza all’errore»55 che consente di restringere il controllo
tedesco ai soli casi di violazione sufficientemente qualificata 56 che comportino una modifica
strutturale sulla distribuzione dei poteri. Si vuole evitare che per ogni inezia vi sia una sostituzione
immediata della valutazione della Corte di Giustizia con quella del Tribunale costituzionale
federale.
Questa ipotesi di rinvio pregiudiziale si è verificata per la prima volta il 14 gennaio 2014, quando
il giudice costituzionale tedesco ha sollevato la questione57, per la parte che ci interessa, sulla
presunta non conformità all’art. 5 par. 1 TUE della delibera del Consiglio europeo della BCE
sull’acquisto illimitato dei titoli dei debiti sovrani sui mercati secondari
(Outright Monetary Transactions-OTM del 6 settembre 2012). Questo atto, infatti, lederebbe il
principio di attribuzione perché invaderebbe il settore della politica economica-finanziaria
52 La sentenza prende le mosse dal ricorso di un datore di lavoro che non poteva risolvere un rapporto perché le norme rilevanti erano stare dichiarate in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori sull’età prevista in una direttiva non entrata in vigore in Germania ma espressiva di un principio generale dell’Unione. Così, a detta del ricorrente, ci sarebbe stata una lesione del diritto di libertà negoziale ex art. 2 e 12 LF. 53 La Corte non ha rinunciato alla tesi degli Stati Padroni dei Trattati perché si riserva sempre l’ultima parola concedendo però la cortesia della pregiudizialità alla Corte di Giustizia. Cfr: M.A. ASERO, L’Europa delle Corti riparte da Kalsruhe? Alcune note sul sì Europarechtsfreundlichkeit della Corte costituzionale tedesca nelle sentenze Lisbona e Honeywell, www.europeanrights.eu, 2010. 54 F. FONTANELLI, All’s well that’s ends in Honeywell , in www.diritticomparati.it, 2010. 55 F. FONTANELLI, op. ult. cit. 56 R. CAPONI, La tutela delle identità nazionali degli Stati Membri dell’UE nella cooperazione tra le corti: addio ai «contro-limiti»? , In Riv. Dir. UE, n. 4,2011. 57 Il giudizio è stato instaurato con ricorso diretto da parte di 43.000 cittadini e con conflitto di attribuzione fra organi sollevato da una frazione del partito Die Linke. I ricorrenti lamentavano il comportamento dei due rami del Parlamento che non si erano opposti all’adozione delle misure di contrasto alla crisi attuative delle decisioni della BCE. Ciò si sarebbe tradotto nella violazione dell’art. 38 1 co. LF sul diritto di voto che in combinato disposto con l’art. 20 1 co. e art. 79 3 co. LF consente di attivare il controllo di identità. Sotto il primo profilo, compatibilità delle norme di attuazione del Trattato sul Meccanismo Europeo di Stabilità, il Tribuna rigetta il ricorso perché la competenza in materia di bilancio non è trasferibile all’Unione perché la correlata valutazione dei rischi deve essere compiuta dal Parlamento nella sua interezza, senza possibilità di delegarla neppure ad un’articolazione dell’ Assemblea.
15 | federalismi.it |n. 24/2014
riservato ai singoli Stati, comportandone la sua qualificazione come atto ultra vires nonché lesivo
del diritto di voto dei cittadini tedeschi perché sottrarrebbe le decisioni in materia di bilancio al
Parlamento federale. La Corte di Giustizia si deve ancora pronunciare sul ricorso, ma la scelta del
Tribunale di ricorrere allo strumento ex art. 267 TFUE potrebbe esprimere la volontà di porre
in essere un dialogo diretto con il giudice dell’Unione, visto come unico mezzo per portare avanti
il processo di integrazione58. Sembra, pertanto, che il giudice tedesco non abbia rinunciato alla
leale collaborazione con la sua controparte europea messa in dubbio, forse, dall’approccio
rigorosamente nazionalista che traspare dal Lissabon Urteil ma che, già con la sentenza Honeywell, è
tornato ad essere principio ispiratore dei reciproci rapporti.
2.2 Da Karlsruhe a Brno: un diverso modo di intendere la teoria dei controlimiti?
La teorizzazione dei controlimiti da parte della Corte costituzionale ceca si distingue nelle
modalità e nell’ incisività, sia teorica che effettiva, rispetto alla concezione messa a punto da
Karlsruhe ma, come vedremo, nel nucleo fondamentale essenzialmente coincidono. La
Repubblica Ceca ha aderito all’ordinamento sovranazionale molto più tardi rispetto allo
Germania che fa parte degli Stati Fondatori fin dalla stipula del Trattato CECA. Infatti solo con
la Legge costituzionale n. 395/2001 l’ordinamento ceco si è aperto al contesto internazionale,
consentendo il suo ingresso in ordinamenti internazionali e la sua sottoposizione al diritto
internazionale59.
Nel 2004 vi è stata l’adesione all’Unione ma è solo con le sentenze Sugar Quota III dell’8 marzo
200660 e Caso Eaw61 (2006) che la Corte costituzionale ceca ha posto dei “paletti” nel suo rapporto
con l’Unione. L’ordinamento eurounitario ha natura derivata sotto entrambi i profili, formale e
58 G. RIVOSECCHI, Il Meccanismo Europeo di Stabilità e il Fiscal Compact tra Karlsruhe e Lussemburgo, in Quad. cost. n.2, 2014, pag. 427. Cfr: E. OLIVITO, Atto primo: Il Bundesverfassungsgericht rinvia alla Corte di giustizia su OMT e poteri della BCE. Un’occasione per il futuro dell’Unione europea?, in www.costituzionalismo.it n. 3, 2013. 59Art. 10 CC: “I trattati internazionali promulgati, ratificati con l’assenso del parlamento ed ai quali la Repubblica ceca è vincolata, sono parte dell’ordinamento giuridico; se un trattato internazionale stabilisce diversamente rispetto alla legge, si applica il trattato internazionale”. Art. 10°: “Con un trattato internazionale alcune competenze degli organi della Repubblica ceca possono essere trasferite ad organizzazioni od organi internazionali”. Ci sono stati dibattiti in dottrina se l’effettiva apertura all’Unione sia stata fatta con l’art. 10 o con l’art. 10A. Per maggiori approfondimenti v. M. BOBEK, D. KOSAI, Report in Czech Republic and Slovakia in G. MARTINICO, O. POLLICINO ( a cura di) The National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws, European Law Publishing, 2010 pagg. 119 ss. 60 La vicenda riguardava l’entità delle quote di produzione di zucchero che erano disciplinate dalla normativa comunitaria che, a detta dei parlamentari ricorrenti, ledeva il divieto costituzionale di non limitare l’attività imprenditoriale. 61 La sentenza si occupa di un caso di mandato di arresto europeo e del divieto di estradizione ex art. 14 par.4 della Costituzione ceca.
16 | federalismi.it |n. 24/2014
sostanziale: il primo riguarda i poteri della sovranità mentre il secondo attiene alle componenti
sostanziali del potere statale. La delega che gli Stati hanno fatto consente la loro sottoposizione
all’Unione nel settore economico ma potrebbe essere ritirata se questi poteri fossero esercitati
non rispettando la tutela dei diritti fondamentali e i capisaldi dello Stato. In ogni caso, secondo il
giudizio della Corte, al momento dell’emanazione delle due sentenze il livello di protezione dei
diritti fondamentali nell’Unione non era inferiore al livello di tutela previsto nell’ordinamento
nazionale. Con queste decisioni il giudice costituzionale, pur assicurando la piena compatibilità
del Trattato alla Costituzione, tenta di delineare una sorta di controlimiti nei confronti
dell’ordinamento sovranazionale.
Lo stesso giudice tornerà sulla questione in occasione dell’adesione al Trattato di Lisbona con
due pronunce successive, meglio note come Lisbona I del 26 novembre 200862 e Lisbona II dell’11
marzo 200963, che sono ancora oggi l’espressione più completa della concezione che la Corte ceca
ha dei rapporti fra ordinamento interno e Unione. In entrambe la Corte rigetta i ricorsi perché in
astratto l’ordinamento eurounitario non contrasta con i fondamenti democratici dell’ordinamento
nazionale né con il principio Kompetenz-kompetenz e di sussidiarietà. Sarà dunque possibile solo un
controllo ex post in concreto se sussistono realmente ipotesi di violazioni dei suddetti principi, ma
non in astratto, mediante l’utilizzo della Costituzione e dell’intero ordine costituzionale come
parametri. Lo stesso ragionamento si può applicare ai diritti umani: il livello di protezione loro
offerto dall’Unione è totalmente compatibile con quello previsto nella Costituzione ceca. Nel
caso in cui in concreto ci fosse una violazione, spetterà alla Corte costituzionale applicare il livello
più alto di tutela previsto fra i due ordinamenti64. La sovranità rileva non come fine ma come
mezzo per raggiungere gli scopi della Costituzione e perciò fondamentali sono le modalità
62 Il ricorso era promosso dal Senato che sosteneva che l’art. 10 Cost. non consentisse all’Unione, mediante il TUE e TFUE, di violare la vera essenza dell’ordinamento democratico ceco, espressa nella tutela dei diritti fondamentali, né di cambiare i requisiti dello Stato di diritto come previsti dal combinato disposto dell’art. 9 par. 2 e art. 1 par.1 Cost. Fra i molti motivi di ricorso, l’organo legislativo deputato alla ratifica riteneva che la struttura dell’Unione, come delineata da Lisbona, fosse simile ad uno Stato federale in special modo nella classificazione delle competenze dove si riserva in alcuni settori poteri esclusivi. 63 Il ricorso era stato fatto da alcuni senatori che sostenevano l’incompatibilità dei Trattati per l’intero con i principi dello Stato di diritto, principio democratico e dello Stato sovrano e democratico espressi negli art. 1 1 co e art. 2 1 co. Cost. ceca. 64 “Prima vista there is no conflicting provision in the CFREU; in contrast, the catalog of rights in the CFREU is fully comparable to the set of fundamental rights and freedoms protection in the CR on the basis of the CFRF; even the petitioner did not raise any questions in this regard. The Constitutional Court found that in the present situation the European institutional provision of the standard of protection for human rights and fundamental freedoms is compatible with the standard provided by the constitutional order of the CR. In the event of a conflict of sources governing the rights and freedoms of individuals under the CFREU and the CFRF the applying bodies will naturally proceed according to the one that provides individuals the higher standard of protection”.
17 | federalismi.it |n. 24/2014
concrete di esercizio delle competenze dell’Unione nella valutazione di un possibile conflitto con
l’ordinamento interno. Il Trattato di Lisbona non ha causato nessuna modifica nel concetto di
integrazione europea ormai consolidato e neppure nella qualifica dell’Unione come
un’organizzazione peculiare di diritto internazionale65. La nozione di controlimiti elaborata dalla
Corte ceca presuppone una teoria della sovranità in divenire che esprime fiducia nelle
interpretazioni euroconformi che le impediscono di predeterminare in astratto le competenze
sottratte al giudice comunitario oltre a prevedere un controllo di conformità delle norme
dell’Unione a tutto l’ordine costituzionale, non solo alla Costituzione, per l’impossibilità dei
Trattati di rientrare nella gerarchia delle fonti interne66. Questo controllo comporterebbe la c.d
relativizzazione del primato perché non indica i criteri su cui le decisioni future devono basarsi.
In conclusione, come il Tribunale federale tedesco ha introdotto il controllo di identità nazionale,
a Brno la Corte costituzionale ceca ha previsto a tutela dell’ordine costituzionale un controllo ex
post sugli atti dell’Unione. Sotto il punto di vista teorico, il controllo del giudice ceco potrebbe
sembrare meno penetrante vista la sua genericità nell’indicazione dei parametri rispetto al
controllo di identità nazionale ma, paradossalmente, proprio questa sua indeterminatezza dota la
Corte ceca di un potere discrezionale amplissimo sulla configurabilità di volta in volta del
parametro conferente. Indipendentemente dalle differenze di struttura e di modalità, però,
entrambi gli approcci esplicano la medesima volontà di affermare un principio del primato che
vuole ancora garantire la prevalenza del diritto dell’Unione sul diritto interno ma al contempo la
sua forza applicativa sarà ridotta dall’allargamento della sfera di influenza degli Stati ad opera delle
Corti nazionali67.
Dopo questa breve panoramica su come i controlimiti vengano intesi in due delle giurisprudenze
costituzionali più significative a riguardo, possiamo adesso esaminarne la loro portata come
elaborata dalla Corte costituzionale italiana.
65 “[..]the Constitutional Court summarized that the Treaty of Lisbon changes nothing on the fundamental concept of current European integration, and that, even after the entry into force of the Treaty of Lisbon, the Union would remain a unique organization of an international law character”. 66 F. VECCHIO, Corte di giustizia e tribunali costituzionali nazionali secondo la prospettiva della Corte costituzionale ceca, in www.diritto.it, 2010. 67 F. VECCHIO, op. ult. cit., la definisce come modello a zolle tettoniche dove i giudici, malgrado l’acquiescenza apparente all’esproprio delle competenze da parte della Corte di Giustizia, ogni minima variazione può causare rilevanti scosse all’intero assetto degli equilibri.
18 | federalismi.it |n. 24/2014
3. Diritti fondamentali e identità europea nella prospettiva della Corte costituzionale
italiana
3.1 L'evoluzione giurisprudenziale della teoria dei controlimiti
Parlare dei diritti fondamentali significa riferirsi al «tratto empirico più importante dei moderni
stati costituzionali di diritto»68, la cui tutela rappresenta una delle finalità irrinunciabili da essi
perseguite69. Ecco il motivo per il quale non può suscitare stupore il fatto che l'accettazione dei
principi dell'effetto diretto e del primato delle norme dell'Unione, tappa essenziale del percorso
nazionale di integrazione europea, sia stata resa possibile, soprattutto in questo campo, soltanto
attraverso l'«assicurazione» che in Europa «i singoli non avrebbero perso alcuna delle garanzie
previste»70 dalla Costituzione nazionale.
In questa chiave va letta l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale italiana sul tema, tutta
improntata da quella «paradossale contraddizione»71 tra primauté europea e controlimiti nazionali
in cui la costante della protezione dei diritti fondamentali assurge a «imperativo al contempo
giuridico e politico»72. L'analisi degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., impalcatura costituzionale di
quel percorso volto alla creazione di un'identità comune, evidenzia chiaramente come essi
forniscano «solo una fotografia parziale dello status quo»73, che tace rispetto a quell'esigenza di
salvaguardare il “nucleo duro” dei principi e diritti fondamentali dell'ordinamento, esigenza che
trova invece risposta «nella sede della decisione giudiziale»74.
È in un percorso giurisprudenziale, infatti, che si sostanzia quel «cammino comunitario» 75
nell'ambito del quale «si è venuto (...) costruendo il senso e il contenuto dei diritti fondamentali»
68 L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 1. Teoria del diritto, Roma-Bari, 2007, p. 724. 69 Cfr. in tal senso anche M. CARTABIA - J.H.H. WEILER, L'Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali, Bologna, 2000, p. 217 in cui si parla della protezione dei diritti fondamentali come "una condicio sine qua non della democrazia costituzionale e dello stato di diritto dell'epoca contemporanea." 70 Ibidem, p. 218. 71 Così A. CELOTTO - T. GROPPI, Diritto UE e diritto nazionale: primauté vs controlimiti, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, n. 1/2004, p. 1309 la contraddizione si riferisce al contrasto tra la tendenza "al ravvicinamento e all'unificazione dei diritti nazionali" da un lato e al fatto che "dall'altro, ciascuno dei diritti nazionali pone condizioni e limiti propri ... all'efficacia del diritto UE". 72 Cfr. M. CARTABIA - J.H.H. WEILER, L'Italia in Europa, cit., p. 218. 73 Così A. CELOTTO - T. GROPPI, Diritto UE e diritto nazionale cit., p. 1342. 74 Così S. STAIANO, I diritti fondamentali nelle giurisprudenze costituzionali e nelle prospettive dell'Unione europea, in M. SCUDIERO (a cura di), Il diritto costituzionale comune europeo. Principî e diritti fondamentali, Napoli, 2002, p. 815 in cui si sottolinea che "tale lavorío giurisprudenziale ha incontrato l'opera della Corte di giustizia, e si è accompagnato, sovrapposto, confrontato con essa, traendone e fornendo ad essa strumenti e moduli interpretativi." 75 Così P. BARILE, Il cammino comunitario della Corte, in Giur. cost., 1973, pp. 2405 e ss.
19 | federalismi.it |n. 24/2014
in chiave europea, opera di costruzione in cui è stato determinante il ruolo di sorveglianza della
Corte costituzionale76, la cui prima traccia è rinvenibile nella sentenza n. 98 del 1965 con la quale
viene messa in luce per la prima volta l'esistenza di norme costituzionali italiane in ogni caso
resistenti al diritto dell'Unione77.
Nell'ottica di questo primo orientamento, sviluppato poi nelle sentenze nn. 183/1973 e
170/1984, in cui la Corte rimarca il ruolo svolto dal suo sindacato, di argine alla sovranità delle
norme dell'Unione nel caso di violazione da parte di queste ultime dei «principi fondamentali del
nostro ordinamento costituzionale, o (dei) diritti inalienabili della persona umana»78, la garanzia
dei controlimiti viene a rappresentare null'altro che una clausola di salvaguardia di sistema79 di difficile
attuazione. Questo perché la Corte aveva stabilito che l'oggetto del suo sindacato avrebbe
dovuto essere esercitato non sulle singole norme comunitarie, ma sulla legge di esecuzione del
Trattato, il che avrebbe aperto la difficile questione degli effetti di un'eventuale sentenza di
illegittimità. Quali le conseguenze: la semplice inapplicabilità in Italia di singole norme europee o
la più radicale revoca dell'adesione italiana all'Unione?80
Questa logica di extrema ratio81 viene abbandonata nel 1989, quando, con la sentenza n. 232, la
Corte muta orientamento e amplia la sua potestà di controllo affermandosi competente a
sindacare «qualsiasi norma del Trattato, così come essa è interpretata ed applicata dalle istituzioni
e dagli organi europei»82 .
In questo modo, quindi, «lascia intendere» che «la competenza che si è riservata è utilizzabile» e
76 Cfr. S. STAIANO, I diritti fondamentali cit., pp. 820-822. 77 Nel caso di specie, ad essere contestata era la giurisdizione esclusiva della Corte di Giustizia sui ricorsi contro i provvedimenti dell'Alta autorità comunitaria. Ebbene, dopo aver sottolineato che quello dell'allora CECA fosse da considerarsi "ordinamento del tutto distinto da quello interno", la Corte costituzionale rileva che gli effetti esplicati su quest'ultimo in tanto sono possibili in quanto non arrechino "pregiudizio del diritto del singolo alla tutela giurisdizionale" perché trattasi di uno dei diritti "inviolabili dell'uomo, che la Costituzione garantisce all'art. 2" (Cfr. sentenza n. 98 del 16 dicembre 1965 al p.to 2 del Considerato in diritto). 78 Cfr. sentenza n. 183 del 18 dicembre 1973 al p.to 9 del Considerato in diritto; cfr. anche il p.to 7 del Considerato in diritto della sentenza n. 170 del 5 giugno 1984. 79 Cfr. A. CELOTTO - T. GROPPI, Diritto UE e diritto nazionale cit., p. 1347. 80 Cfr. sul punto A. CELOTTO - T. GROPPI, Diritto UE e diritto nazionale cit., pp. 1344 e 1345; A. CELOTTO, Fonti comunitarie e Corte costituzionale. Le norme comunitarie come "parametro" e come "oggetto" nei giudizi costituzionali, Roma, 2000, pp. 136 e ss. 81 Cfr. ancora A. CELOTTO - T. GROPPI, Diritto UE e diritto nazionale cit., p. 1344. 82 V. il p.to 3.1 del Considerato in diritto della sentenza n. 232 del 13-21 aprile 1989; in particolare cfr. M. CARTABIA, Nuovi sviluppi nelle “competenze comunitarie” della Corte costituzionale, in Giur. Cost., 1989, pp.1014 e 1015; R. CAPONI, La tutela della identità nazionale degli Stati membri dell’U.E. nella cooperazione tra le corti: addio ai “controlimiti”?, in Il Diritto dell’Unione Europea, n. 4/2011, p. 917.
20 | federalismi.it |n. 24/2014
non «meramente retorica» 83 , anzi, ne sottolinea il peso: l'oggetto del suo sindacato è ormai
«onnicomprensivo» e la determinazione del parametro (di cosa debba intendersi, cioè, per
principi fondamentali) «è in larga misura affidata al suo apprezzamento»84.
Tuttavia, attraverso l'analisi delle successive pronunce che mantengono la stessa linea
interpretativa, chiudendo sempre con l’infondatezza o l’inammissibilità della questione per
irrilevanza85, è possibile constatare come la Corte, una volta consolidate in astratto le proprie
competenze, non le abbia applicate in concreto.
Questa la situazione fino alla recente sentenza n. 238 del 2014, con la quale per la prima volta la
Corte costituzionale italiana si serve, apertamente e inequivocabilmente, della dottrina dei
controlimiti nell'iter logico che la conduce al dispositivo.
La decisione non arriva senza preavviso; già nel 2012, infatti, nelle argomentazioni della sentenza
n. 264, la Corte ha fatto riferimento al limite costituzionale, utilizzandolo da argine rispetto al
diritto CEDU 86 . Nella pronuncia, resa nell'ambito della complicata vicenda delle “pensioni
svizzere”, la Corte ha rilevato che è il giudice delle leggi l'unico «tenuto a valutare come ed in
quale misura l'applicazione della Convenzione da parte della Corte europea si inserisca
nell'ordinamento costituzionale italiano»87, perciò, anziché adeguarsi alla normativa CEDU in
materia, ha ritenuto legittima la legislazione nazionale.
Con la sentenza 238 del 2014, invece, ad essere in discussione è la norma internazionale
consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti
iure imperii, come interpretata dalla CIG nella sentenza del 3 febbraio 2012 che pareva aver messo
il punto alla nota questione “Ferrrini”.
Il caso vide la luce nel 1994, quando il signor Ferrini, deportato in Germania e costretto alla
schiavitù nel periodo 1943-1945, chiese al Tribunale di Firenze la condanna dello Stato al
risarcimento dei danni subiti. Mentre il Tribunale e la Corte d'Appello di Firenze non accolsero la
domanda sulla base del principio di diritto internazionale dell'immunità degli Stati sovrani dinanzi
83 M. CARTABIA, Nuovi sviluppi nelle “competenze comunitarie”cit., p.1015. 84 Ibidem, p. 1016. 85 Si veda in particolare l’ordinanza n. 454 del 13 dicembre 2006 tenendo conto che la Corte aveva ribadito questo orientamento anche in precedenza, attraverso alcuni obiter dicta resi nell'ambito di pronunce in cui non era stata chiamata a sindacare norme dell’Unione in relazione ai controlimiti. Cfr. ad es. le sentt. nn. 168 dell’8 aprile 1991, 117 del 23 marzo 1994, 509 dell’11 dicembre 1995, 126 del 17 aprile 1996, 93 del 26 marzo 1997. 86 Cfr. in tal senso G. SCACCIA, «Rottamare» la teoria dei controlimiti?, in Quad. cost., n.1/2013, p. 145; B. RANDAZZO, Il caso Costa e Pavan c. Italia: la bulimia della Corte dei «desideri», in Quad. cost., n. 2/2013, p. 462. 87 Cfr. la sentenza n. 264 del 19 novembre 2012 al p.to 4.1 del Considerato in diritto, in cui la Corte sottolinea altresì che si tratta di «operazioni volte non già all'affermazione della primazia del dell'ordinamento nazionale, ma alla integrazione delle tutele».
21 | federalismi.it |n. 24/2014
alla giurisdizione di ogni altro Stato, la Corte di Cassazione, con la storica sentenza n. 5044 del
2004, resa a Sezioni Unite, statuì che l'immunità degli Stati per gli atti di imperio non opera
quando sono in discussione crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Sennonché la Germania, dinanzi al proliferare dei procedimenti instaurati nei suoi confronti da
cittadini italiani che, durante la seconda guerra mondiale, come il signor Ferrini, avevano subito la
deportazione e la riduzione in schiavitù, chiese ed ottenne dalla CIG (sentenza 3 febbraio 2012) il
riconoscimento dell'immunità nei confronti dello Stato italiano. La Cassazione dichiarò il difetto
di giurisdizione nei confronti della Germania e il legislatore italiano, con la legge n. 5 del 2013,
dispose espressamente l'esclusione «dell'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla
giurisdizione civile» in ottemperanza a quanto statuito dalla CIG (art. 3).
La questione pareva chiusa definitivamente fino a quando la Corte costituzionale ha accolto i
dubbi di costituzionalità prospettati dal Tribunale di Firenze sull'art. 3 della l. 5/2013. In
particolare, ha stabilito che, «sebbene l'interpretazione da parte della CIG» della norma
internazionale consuetudinaria sull'immunità degli Stati «non consent(a) un sindacato da parte di
amministrazioni e/o giudici nazionali»88, resta fermo il fatto che «il meccanismo di adeguamento
automatico previsto dall'art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei
principi fondamentali del nostro ordinamento» 89 , soprattutto se ad essere in gioco è
l'insopprimibile garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti (art. 24 Cost.), che rientra tra «i
principi qualificanti e irrinunciabili dell'assetto costituzionale dello Stato, e, quindi, (tra) i principi
che sovraintendono alla tutela dei diritti fondamentali della persona»90.
La sentenza mette bene in evidenza come quella sui controlimiti sia una competenza attuale e
non “ideale” della Corte, che la trasferisce in maniera decisa dall'“empireo” all'esperienza reale.
Tuttavia, pare opportuno riflettere su un punto: l'applicazione della dottrina dei controlimiti si è
avuta in relazione ad una norma internazionale e non dell'Unione. Il dato non è privo di
significato e rivela quella che è l'intenzione del giudice costituzionale italiano: essere parte attiva di
un dialogo collaborativo con le istituzioni europee. Ecco il motivo per il quale la Corte, al
momento, non ha tradotto in pratica le sue competenze nei confronti del diritto dell'Unione; si
tratta di una «tra quelle modalità “sfumate” di esercizio dei propri poteri, analogamente, ad es., a
quanto avviene nelle sentenze monito» che «rivolge al legislatore»91, attraverso cui ribadisce il
88 Cfr. la sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014 al p.to 3.1 del Considerato in diritto. 89 Cfr. la sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014 al p.to 2.1 del Considerato in diritto. 90 Cfr. la sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014 al p.to 3.1 del Considerato in diritto. 91 M. CARTABIA, Nuovi sviluppi nelle “competenze comunitarie”cit., p. 1023.
22 | federalismi.it |n. 24/2014
ruolo cooperativo ma sostanziale che le spetta nel dialogo tra ordinamenti92.
3.2 La complessa articolazione delle fonti: Corte costituzionale e CEDU
Analizzare il ruolo della Corte costituzionale italiana nel delineare il profilo dei diritti
fondamentali tra omogeneità europea e identità nazionali significa avere contezza della pluralità
delle fonti esistenti in materia, nell’ambito delle quali si colloca quell’attività circolare della Corte
di giustizia che, dopo aver estrapolato dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri i principi
idonei alla loro tutela, li ha rielaborati, armonizzandoli, e, infine, li ha restituiti agli operatori
interni al fine di favorirne l’applicazione rispetto alle norme di attuazione del diritto dell’Unione93.
In questo nuovo contesto, in cui la Corte assume la veste di “giudice tessitore”94 di una nuova
normativa aperta alla dimensione europea, non può essere trascurato il ruolo assunto dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora
in poi CEDU), ruolo peraltro determinante anche nell’ambito di quell’elaborazione circolare dei
diritti fondamentali posta in essere dalla Corte di giustizia.
La problematica dinanzi alla quale si è trovata la Corte costituzionale è stata quella di definire il
rango assunto dalla CEDU nel sistema delle fonti del diritto italiano, problematica derivante dalla
sostanziale diversità di quest’ultima rispetto al diritto dell’Unione: la CEDU «non crea un
ordinamento giuridico sopranazionale e di conseguenza è da considerarsi un diritto internazionale
pattizio capace di vincolare lo Stato» ma non di produrre «effetti diretti nell’ordinamento interno,
tali da legittimare i giudici nazionali a disapplicare le norme interne in contrasto»95.
Quale posizione, allora, assume la CEDU nell’ordinamento italiano e come va considerata nel
parametro del giudizio di costituzionalità? Non si tratta di una fonte di rango costituzionale, dal
momento che quelle internazionali pattizie sono «norme subordinate gerarchicamente alle norme
costituzionali»96, ma di una fonte interposta, che integra il parametro posto dall’art. 117, comma
1, Cost., rendendolo concretamente operativo nel riempire di significato il contenitore «dei
92 In questo senso si parla di una “logica compromissoria” sottesa alla teoria dei controlimiti, cfr. per tutti A. CELOTTO - T. GROPPI, Diritto UE e diritto nazionale cit., p. 1346. 93 A questo proposito si veda G. DELLA CANANEA – C. FRANCHINI, I principi dell’amministrazione europea, Torino, 2010, p. 33 in cui si parla, in tal senso, di un’“integrazione mediante il diritto”; cfr. anche G. MORBIDELLI, Corte costituzionale e Corti europee: la tutela dei diritti (dal punto di vista della Corte di Lussemburgo), in Dir. proc. amm., 2, 2006, pp. 285 ss. 94 Cfr. E. SCODITTI, Giudici europei: dialogo ascendente e discendente. La prospettiva del giudice comune nazionale, in europeanrights.eu, 18/05/2009, p. 6. 95 D. TEGA, Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del diritto, in forumcostituzionale.it, p.1. 96 A. RUGGERI, La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadrameto sistematico, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, p.216.
23 | federalismi.it |n. 24/2014
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».
Questo modello, delineato dalla Corte costituzionale nelle sentt. nn. 348 e 349 del 2007, serve a
perseguire due obiettivi di difficile conciliazione: da un lato, quello di riconoscere alla CEDU una
superiorità rispetto alle leggi ordinarie, e, dall’altro, quello di sottolineare il ruolo attivo del giudice
costituzionale italiano nel «discorso sui diritti nella grande arena europea» 97. Secondo questo
paradigma, infatti, il giudizio della Corte in cui venga in rilievo una norma della CEDU, in una
prima fase, viene ad incentrarsi proprio su di essa, controllandone la «compatibilità con tutto il
testo costituzionale» poi, solo una volta oltrepassato questo primo ostacolo, è possibile
«procedere a verificare la legittimità della norma censurata rispetto alla stessa norma interposta»98.
Nella sostanza, quindi, individuando nell’art. 117, comma 1, Cost., il fondamento della sua
interferenza nell’ordinamento interno, la Corte attrae la CEDU al suo sindacato, rimarcando,
almeno sotto un profilo teorico, che ogni interferenza normativa nell’ordinamento interno deve
passare per la sua mediazione99.
3.3 La costruzione teorica alla prova dell'esperienza: quale il ruolo della Corte nell'ambito
della tutela multilivello dei diritti fondamentali
Alla luce delle considerazioni svolte è possibile guardare il modello teorico delineato nelle sentt.
348 e 349 del 2007 come finalizzato ad un «potenziamento del ruolo del giudice costituzionale»100
realizzato mediante la collocazione della CEDU al rango di norma sub-costituzionale nella
gerarchia delle fonti.
In sostanza, come ribadito anche nella giurisprudenza successiva101, secondo questo modello, nel
momento in cui dovesse profilarsi un contrasto tra una norma interna e una norma CEDU e se il
contrasto non potesse essere risolto in via interpretativa, attraverso un'interpretazione della
norma nazionale conforme a quella CEDU, il giudice comune, non potendo disapplicare la
norma interna incompatibile con la norma convenzionale, dovrebbe denunciare detta
97 C. PANZERA, Il bello dell’essere diversi. Corte costituzionale e Corti europee ad una svolta, in forumcostituzionale.it, p. 15; cfr. in tal senso anche C. PINELLI, Sul trattamento giuridico della Cedu e delle leggi con essa configgenti, in associazionedeicostituzionalisti.it. 98 D. TEGA, Le sentenze della Corte costituzionale cit., p. 3. 99 In questo senso si veda per tutti S. STAIANO, The crisis of State sovereignty and social rights, in The Age of Human Rights Journal, 2 (June2014), p. 44. 100 Cfr. D. TEGA, Le sentenze della Corte costituzionale cit., p. 3 in cui si parla, in riferimento al tentativo della Corte di sottolineare il suo ruolo di una "riesumazione di una sorta di teoria dei controlimiti"; si veda in tal senso anche T.F. GIUPPONI, Corte costituzionale, obblighi internazionali e "controlimiti allargati": che tutto cambi perché tutto rimanga uguale?, in forumcostituzionale.it. 101 Si vedano, in particolare, le sentt. nn. 93 dell’8 marzo 2010 e 239 del 16 luglio 2009.
24 | federalismi.it |n. 24/2014
incompatibilità sollevando questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117,
comma 1, Cost.
Questo «quadro tranquillizzante»102 in cui la norma CEDU è sempre soggetta al controllo della
Corte, però, ha dovuto fare i conti con l'esperienza, e, avendo riguardo all'esperienza, è possibile
constatare come, attraverso lo strumento dell'interpretazione conforme, il paradigma risulti
disatteso e le prerogative della Corte, nella sostanza, erose103.
Infatti, sebbene l'ambito applicativo della CEDU per il giudice comune rimanga confinato al
limite dell'interpretazione adeguatrice, «anche in tali confini i risultati possono essere notevoli»104.
Basti pensare alla sent. 113 del 2011, in cui la Corte costituzionale ha di fatto accolto l'escamotage
trovato dalla Corte d'Appello di Bologna per risolvere la complessa vicenda Dorigo dichiarando
l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la possibilità di
revisionare il processo nel caso di contrasto tra la sentenza di condanna e quella definitiva di
accertamento, da parte della Corte di Strasburgo, di una violazione di un diritto fondamentale
sancito dalla CEDU105.
Emblematica è poi la sentenza n. 18821 del 2013 resa dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione
in riferimento ad una spinosa questione giuridica; si trattava di decidere in ordine alla possibilità,
per il giudice dell'esecuzione, di sostituire con la reclusione a trent'anni, la pena dell'ergastolo
inflitta all'esito del giudizio abbreviato. Più specificamente, quindi, era in discussione
l'opportunità di modificare il giudicato in attuazione dei principi dettati dalla Corte EDU nella
sentenza Scoppola c. Italia del 17/09/2009 e di applicare, nella successione di leggi intervenute in
materia, quella più favorevole106.
Le Sezioni Unite Penali, quindi, procedono ad un delicato bilanciamento di interessi107 ponendo
alla base della motivazione la «portata sostanziale» dell'art. 442, comma 2, c.p.p., che, avendo
«subito, nel tempo, varie modifiche per interventi della Corte costituzionale e del legislatore»
proprio con riferimento ai reati punibili con la pena dell'ergastolo, «deve soggiacere al principio di
legalità convenzionale di cui all'art. 7 § 1, CEDU ... vale a dire irretroattività della previsione più
102 Così D. TEGA, Le sentenze della Corte costituzionale cit., p. 3. 103 Cfr. M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione "conforme a", in federalismi.it, 8/08/2007, p. 16. 104 E. SCODITTI, Giudici europei: dialogo ascendente e discendente cit., p. 23. 105 Cfr. il dispositivo della sentenza n. 113 del 4 aprile 2011. 106V. Cass., SS. UU. Penali, 24 ottobre 2013, n. 18821, al p.to 1 del Considerato in diritto. 107 Nella specie, si trattava di bilanciare il valore dell'intangibilità del giudicato con il principio di retroattività della legge penale più favorevole all'imputato.
25 | federalismi.it |n. 24/2014
severa, ... ma, anche, e implicitamente, retroattività o ultrattività della previsione meno severa»108.
Questi esempi sono emblematici perché portano a riflettere sul ruolo effettivo che la Corte
costituzionale ricopre, allo stato attuale, nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali intesi nella
loro nuova accezione, che possiamo definire circolare.
Se da un lato, infatti, la fotografia prospettata dall'esperienza mette in luce una situazione di
evidente attivismo dei giudici comuni, la cui voce in Europa può considerarsi forte109, dall'altro,
ritrae una Corte costituzionale che se ne sta in disparte, la cui presenza nell'integrazione tra
ordinamenti è limitata rispetto al passato110.
Questa condizione di isolamento allontana l’esperienza dalle premesse postulate dalla Corte, che
ha sempre sottolineato di rifiutare «ogni possibile emarginazione di fatto dallo scambio»111 col
diritto europeo. Un'inversione di tendenza, però, sarebbe forse possibile mediante un diverso
utilizzo dello strumento del rinvio pregiudiziale.
Questo «dialogo da giudice a giudice»112, adoperato dalla Corte solo di recente e soltanto in due
casi (ord. 103/2008 e ord. 207/2013), «potrebbe essere utilizzato come canale di “esportazione”
di principi costituzionali a livello europeo, piuttosto che come via di “importazione” soltanto»113.
Essendo infatti «la logica che muove i soggetti del procedimento» di tipo «essenzialmente
cooperativo»114 si potrebbe creare un «flusso bidirezionale»115 assicurando la presenza propositiva
in sede europea delle tradizioni costituzionali nazionali116. In questo modo, la Corte costituzionale
avrebbe la possibilità di ricoprire in concreto quel ruolo determinante nel dialogo tra i giudici
quanto alla definizione della portata e della tutela dei diritti fondamentali.
4. L’analisi della prassi delle istituzioni UE, con particolare riferimento alla Corte di
Giustizia e all'art. 7 TUE come garante politico dei valori comuni nel dialogo tra
istituzioni UE e Stati membri
In apertura del presente lavoro si è fatto riferimento all’art. 7 TUE come “garante politico” dei
valori comuni e diritti fondamentali sui quali l’Unione si fonda. Il meccanismo, introdotto
108 Cfr. ancora Cass., SS. UU. Penali, 24 ottobre 2013, n. 18821, al p.to 4.4 del Considerato in diritto. 109 Cfr. E. SCODITTI, Giudici europei: dialogo ascendente e discendente, cit., che a p. 7 parla dell'"interpretazione adeguatrice" come della "chiave di attuazione del diritto sovranazionale" non dotato di efficacia diretta. 110 Supra, § 3.1. 111 C. PANZERA, Il bello dell'essere diversi cit., p. 15. 112 Così E. SCODITTI, Giudici europei: dialogo ascendente e discendente cit., p. 10. 113 M. CARTABIA, La Corte costituzionale e la Corte di giustizia: atto primo, in Giur. cost., 2008, p. 1317. 114 E. SCODITTI, Giudici europei: dialogo ascendente e discendente cit., p. 10. 115 L'espressione è di M. CARTABIA, La Corte costituzionale e la Corte di giustizia cit., p. 1317. 116 Cfr. ancora M. CARTABIA, La Corte costituzionale e la Corte di giustizia cit., p. 1317.
26 | federalismi.it |n. 24/2014
nell’ordinamento comunitario con il Trattato di Amsterdam, riformato dopo Nizza ed infine
trasfuso nel Trattato di Lisbona117, prevede la possibilità per il Consiglio, constatata su iniziativa
del Parlamento, della Commissione o di un terzo degli Stati membri la violazione dei principi
tutelati, dopo una fase interlocutoria con il Paese responsabile, di sospendere alcuni dei diritti
spettanti a quest’ultimo dall’applicazione dei Trattati.
Già nella Comunicazione 606 118 del 2003, rivolta a Consiglio e Parlamento, la Commissione
valorizzava la natura dei principi tutelati dall’art. 7 TUE ed identificati nel paragrafo 1 dell’art. 6
TUE (oggi art. 2), sottolineando la natura politica119 di tale strumento di tutela a fronte non solo
di violazioni gravi e persistenti dei valori comuni concretamente verificatesi, ma anche dello
stesso rischio.
La cruciale importanza dello strumento veniva ad essere sottolineata in un momento storico in
cui i valori della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto erano stati messi duramente
alla prova nella ben nota vicenda austriaca 120 . A tale situazione di minaccia le istituzioni
dell’Unione rispondono riformando la procedura di garanzia con la previsione di un doppio
meccanismo: uno di pre-allarme ed uno sanzionatorio meramente eventuale.
Tuttavia, al di là del dato letterale delle modifiche apportate dell’art. 7, vi sono due significati
ulteriori e determinanti da attribuire alla natura di tale strumento, ben chiariti dalla Commissione
nella già citata Comunicazione del 2003. In primo luogo all’art. 7 è attribuito un campo di
applicazione «orizzontale e generale», che permette all’Unione di intervenire non solo nella sfera
del diritto comunitario ma anche in ambiti di autonoma competenza degli Stati membri. Pur
sottolineando l’elemento politico, inoltre, il dato fiduciario121 è altrettanto evidenziato, restando
ferma la volontà di considerare le sanzioni ex art. 7 come extrema ratio122.
117Per un’attenta ricostruzione del dibattito e dell’evoluzione legislativa della norma di cui all’art. 7 si veda W. SADURSKI, Adding a bite to a bark? A story of article 7, the EU enlargement, and Jorg Haider, Legal studies research paper n. 10/01, 2010, pp 3-10. 118 COM(2003) 606, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo in merito all’articolo 7 del trattato sull’Unione Europea. Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l’Unione; si veda, in particolare, le conclusioni finali (par. 12). 119 Cfr. COM(2003) 606, op. cit., p. 6. 120 Il ben noto «caso Haider», deve il suo nome al leader del partito liberale austriaco (FPÖ), il cui successo sulla scena politica nazionale, accompagnato da prese di posizione xenofobe ed anti-europeiste, ha messo in allarme l’Unione Europea nel biennio 1999-2000, tensione sfociata nella «reazione comune» del 31 gennaio 2000 da parte di un gruppo di 14 Paesi membri guidati dalla Presidenza portoghese. 121 Cfr. C. SANNA, Commento all’art. 7 TUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell'Unione Europea, Milano, 2014, pp. 70-78. L’autore ricollega la necessità di un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri anche alla collaborazione in seno all’Unione per le procedure di consegna ed il mandato di arresto europeo. 122 La stessa Commissione, nelle conclusioni della Comunicazione COM(2003) 606 si dice «persuasa che in
27 | federalismi.it |n. 24/2014
Ecco confermata, dunque, la forte valenza monitoria123 e politica attribuita all’art 7 TUE nella
tutela dei valori fondamentali dell’Unione, impostazione che si è tuttavia presto scontrata con le
realtà politiche interne di alcuni Stati membri124. Circa un decennio dopo, infatti, la questione
ungherese 125 ha di nuovo richiamato l’attenzione sul ruolo dell’art. 7 e dei meccanismi di
prevenzione, con particolare riferimento alla tutela dello Stato di diritto, facendo emergere un
nuovo assetto dei valori comuni in questo senso. Sia il Parlamento che la Commissione, infatti,
hanno chiarito di recente126 che lo Stato di diritto rappresenta un vero e proprio pre-requisito per
la protezione dei diritti fondamentali. Quanto detto deriva proprio dalle tradizioni costituzionali
comuni di tutti gli Stati membri dell'UE e, in quanto tale, è uno dei valori principali su cui si
fonda l'Unione, come richiamato dall'articolo 2 TUE: «pertanto, lo Stato di diritto è un principio
costituzionale con componenti sia formali sia sostanziali»127.
Nel prevedere un meccanismo di tutela precedente e integrativo128 rispetto alla garanzia politica
dell’art. 7 TUE, il legislatore europeo dimostra chiaramente il procedimento adottato nel fare
proprio un principio estrapolato dalle tradizioni costituzionali comuni e come questo debba
essere attuato e tutelato in primis all’interno degli Stati membri. Viene da domandarsi, a questo
punto, come i valori comuni sui quali l’Unione si fonda, sanciti dall’art. 2 e 6 e sanzionati dall’art.
7 TUE, si pongano nel rapporto con le identità nazionali129 degli Stati membri ed il relativo
questa Unione di valori l’attuazione di sanzioni, in conformità dell’articolo 7 TUE e dell’articolo 309 TCE non si renderà necessaria» (cfr. p. 12). Il procedimento ex art. 7 viene infatti definito come opzione “nucleare”. 123 W. SADURSKI, Adding a bite to a bark? A story of article 7, the EU enlargement, and Jorg Haider, Legal studies research paper n. 10/01, 2010, pp. 11-25. L’autore ricostruisce con chiarezza il legame del caso Haider con gli imminenti allargamenti ad est dell’Unione Europea e la tutela della sua identità contro l’emersione di movimenti ultra-nazionalisti in alcuni Paesi membri 124 S. CARRERA – A. FAURES ATGER, L’affaire des Roms: a challenge to the EU’s area of freedom, security and justice, Centre for European PS, 2010, pp. 1-21. B. BUGARIC, Protecting democracy and the rule of law in the European Union: the Hungarian challenge, 2013, pp. 1-25. C. STRATULAT – P. IVAN, Romania’s democracy in reverse gear – en garde, EU!, European Policy Center Commentary, 2012, p. 2. 125 M.P. LADICICCO, Il rispetto del principio democratico da parte degli Stati europei: quale ruolo per l’Unione Europea?, in associazionedeicostituzionalisti.it, n. 3/2012. 126 COM(2014) 158, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Un nuovo quadro dell’UE per rafforzare lo Stato di diritto. Alcuni elementi della comunicazione erano stati sottolineati nel Working document on fundamental rights in the European Union in 2012 del Comitato Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni del Parlamento Europeo, p. 5. 127 Così COM(2014) 158, cit., p. 4 128 Tale strumento rappresenterebbe, secondo la Commissione, una fase preliminare di valutazione e dialogo con lo Stato interessato rispetto sia al procedimento ex art. 7 che alla procedura di infrazione prevista dall’art. 258 TFUE («soltanto se le problematiche in questione costituiscono allo stesso tempo una violazione di una specifica disposizione del diritto dell'Unione», v. COM(2014) 158, cit. supra, p. 5). 129 C. PINELLI, Protecting the fundamentals: article 7 of the Treaty on the European Union and beyond, in Foundation for European Progressive Studies, 2012, pp. 7-8.
28 | federalismi.it |n. 24/2014
sindacato delle Corti costituzionali interne, con particolare riferimento ai controlimiti nazionali.
Ad opinione di chi scrive l’impostazione così delineata sarebbe in grado di ridimensionare la
necessità di intervento del giudice interno, operando già una presunzione di condivisione dei
principi di democrazia, protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di
diritto tra tutti gli attori sullo scenario europeo. Nonostante le premesse, però, solo l’analisi della
più recente e rilevante giurisprudenza della Corte di Giustizia può essere in grado di fornire
risposte concrete in merito al rapporto tra omogeneità costituzionale europea ed identità
nazionali dal punto di vista eurounitario.
4.2 Giurisprudenza in tema di omogeneità delle tradizioni comuni e dei livelli di tutela
Le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, ai fini sia della ricostruzione
giurisprudenziale dei diritti fondamentali (come principi generali) sia della interpretazione della
Carta, hanno sempre avuto una rilevanza variabile e specifica nelle decisioni della Corte di
Lussemburgo. Le motivazioni sono da ricercare, per alcuni autori, nelle difficoltà
metodologiche130 (e non solo)131 connesse all’analisi comparata dei vari ordinamenti, che in alcune
autorevoli pronunce ha visto la Corte accogliere l’indagine svolta in tal senso dall’Avvocato
Generale 132 . Altri autori sottolineano, piuttosto, «come la Corte, nella dialettica tra principi
fondamentali del diritto comunitario (ivi compresi i diritti espressione di tradizioni costituzionali
comuni) e disposizioni costituzionali degli Stati, svolge un bilanciamento secondo i criteri della
proporzionalità e dell’interesse della Comunità»133.
Nonostante le varie distinzioni che possono essere prospettate, in ogni caso, un dato sembra
emergere come unitario dalla giurisprudenza della Corte, vale a dire l’intenzione dei giudici del
Lussemburgo di “garantire” l’omogeneità costituzionale europea a partire dal principio del
primato134 del diritto dell’Unione. Tra i più recenti casi che dimostrano tale impostazione della
130 L. COZZOLINO, Le tradizioni costituzionali comuni nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in rivistaaic.it, relazione al Convegno su “La corte costituzionale e le Corti d’Europa”, Catanzaro, 31 maggio-1 giugno 2002. 131 Cfr. B. GUASTAFERRO, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale. Tensioni costitutive e giunture ordinamentali, Milano, 2013, pp. 241-242. L’autrice sottolinea, in questo senso, anche una differenza rispetto alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati in materia di diritti fondamentali “che riuscivano ad assumere una configurazione sovranazionale grazie al richiamo ai principi generali del diritto comunitario”. 132 V. L. COZZOLINO, op. cit., pp. 12-14. L’autore mette in rilievo alcuni esempi di tale «dialettica… tra l’Avvocato generale e la Corte». 133 G. MORBIDELLI, Corte costituzionale e Corti Europee: la tutela dei diritti (dal punto di vista della Corte di Lussemburgo), in Dir. proc. amm., fasc. 2, 2006, p. 286 E ss. 134 L. RIZZA, Il caso Melloni: la Corte di Giustizia risponde con il primato dell’Unione alle pretestuose preoccupazioni dei
29 | federalismi.it |n. 24/2014
Corte di Giustizia, la sentenza Winner Wetten135 afferma chiaramente come sia «inammissibile che
norme di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, possano menomare l’unità e
l’efficacia del diritto dell’Unione» 136 , concludendo nel caso di specie che, per effetto di tale
principio, una normativa nazionale che comporti restrizioni incompatibili con la libertà di
stabilimento e prestazione di servizi, non può continuare ad applicarsi nemmeno per un periodo
provvisorio.
Nondimeno, nel 2013, la Grande Sezione, in materia di mandato d’arresto europeo e di
omogeneità dei livelli di tutela (il noto caso Melloni137), ricollegandosi altresì all’art. 53 della Carta
di Nizza138, sostiene che tale norma non autorizza in maniera generalizzata uno Stato membro ad
applicare lo standard di protezione dei diritti fondamentali garantito dalla sua Costituzione, in
quanto tale interpretazione sarebbe lesiva del principio del primato del diritto dell’Unione139.
Di fronte a pressioni da parte dei giudici nazionali per il rispetto dei propri parametri interni di
costituzionalità, dunque, la Corte di Giustizia pare rispondere non tanto con la valorizzazione
delle tradizioni costituzionali nazionali, bensì ribadendo che l’unità e l’efficacia del diritto
dell’Unione e l’omogeneità dei livelli di tutela dei diritti fondamentali non possono essere
eccessivamente condizionate dalle specificità pertinenti agli ordinamenti dei singoli Stati. Questa
lettura, pertanto, va posta criticamente a confronto con il principio di omogeneità così come
codificato negli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 TUE140, considerando come il suo fondamentale valore per il
processo di integrazione europea, ribadito per la sfera pubblica con il riferimento allo Stato di
giudici nazionali. Riconoscimento delle decisioni giudiziarie rese a seguito di procedimenti in absentia, in Quaderni Europei, www.cde.unict.it, online working paper n. 53/2013. 135 V. Corte di Giustizia, sentenza 8 settembre 2010, causa C-409/06, Winner Wetten GmbH contro Burgermeisterin der Stadt Bergheim. Per analogia, v. anche sentenza 19 novembre 2009, causa C314/08, Filipiak, punto 84. 136 Cfr. par. 61 della citata sentenza Winner Wetten. 137 Corte di Giustizia, sentenza 26 febbraio 2013, causa C-399/11, Stefano Melloni contro Ministerio Fiscal. Analogamente si veda la sentenza 29 gennaio 2013, causa C-396/11, Ciprian Vasile Radu. 138 N.L., UE - Le sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-396/11, Radu e C-399/11, Melloni. Ancora sulla rilevanza dei diritti fondamentali - quali garantiti dalla Carta UE e dalle costituzioni nazionali - nell’ambito del sistema del mandato d’arresto europeo, in osservatoriosullefonti.it, Archivio 2013. 139 V. par. 59 della sentenza Melloni (v. supra). La Corte ha ricordato che «secondo una giurisprudenza consolidata, infatti, in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, che è una caratteristica essenziale dell’ordinamento giuridico dell’Unione, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può sminuire l’efficacia del diritto dell’Unione nel territorio di tale Stato». Si noti, in tal senso, il chiaro richiamo alla sentenza Winner Wetten, causa C-409/06. Degne di interesse, nel contesto di tale caso, sono anche le conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot non solo in merito all’interpretazione del combinato disposto degli artt. 51, 52 e 53 della Carta di Nizza, ma anche sul rapporto dei medesimi con il principio del rispetto delle identità nazionali degli Stati membri sancito dall’art. 4.2 TUE. 140 R. MICCÙ, Proteggere la democrazia. Rinnovare il “contratto sociale” europeo, in federalismi.it, 3/2014, pp. 9-11.
30 | federalismi.it |n. 24/2014
diritto, necessita di una coerente definizione anche nella relazione con il principio del rispetto
delle identità nazionali degli Stati membri.
4.3 La Corte di Giustizia e le identità costituzionali degli Stati membri
Nel caso Sayn-Wittgenstein141, deciso dalla Corte di Giustizia con sentenza del 22 dicembre 2010,
per la prima volta i giudici del Lussemburgo si pronunciano facendo riferimento all’art. 4.2 TUE
nella versione novellata dal Trattato di Lisbona. La domanda del giudice remittente austriaco
verteva sulla possibilità per cui ragioni di ordine costituzionale (una legge costituzionale
sull’eguaglianza formale) potessero autorizzare uno Stato membro a non riconoscere parte del
nome ottenuto da un suo cittadino per effetto di adozione in un altro Paese UE. Nel contesto di
tale decisione gli elementi dell’ordine pubblico (peraltro già analizzato nella nota sentenza
Omega142) e della tutela dell’identità costituzionale dello Stato membro vengono considerati, al
contrario di altri giudici costituzionali143, come limite di carattere interno, e quindi relativo, al
processo di integrazione europea mediante il diritto, potendo validamente essere preso in
considerazione nel bilanciamento con gli opposti interessi tutelati, quale quello alla libera
circolazione, il cui pregiudizio è stato in questo caso ritenuto giustificato144.
Tale decisione si rivela degna di rilievo poiché aiuta a comprendere l’interpretazione data dalla
Corte di Giustizia all’art. 4.2 TUE145, soprattutto nel senso di intensificare la connessione tra il
concetto di identità nazionale e il diritto costituzionale degli Stati membri, indicando inoltre che
la risoluzione di potenziali tensioni tra questo e il diritto dell'Unione si trova in un bilanciamento
generale di opposti interessi meritevoli di tutela 146 . Il riferimento generale al rispetto delle
tradizioni costituzionali comuni, nonché il suo confronto con le libertà garantite dai Trattati, può
potenzialmente rappresentare una tappa importante nel processo di integrazione che non
141 Corte di Giustizia, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-208/09, Ilonka Sayn-Wittgenstein contro Landeshauptmann von Wien. In maniera analoga si esprime la sentenza 14 ottobre 2008, causa C-353/06, Grunkin e Paul. 142 Cfr. Corte di Giustizia, sentenza 14 ottobre 2004, causa C-36/02, Omega Spielhallen und Automatenaufstellungs GmbH contro Oberburgermeisterin de Bundesstadt Bonn, par. 30. 143 E. DI SALVATORE, Il caso Sayn-Wittgenstein: ordine pubblico e identità costituzionale dello Stato membro, in Quaderni Costituzionali, n. 2/2011, pp. 435-436. Il confronto operato dall’autore è con il Bundesverfassungsgericht tedesco, per il quale l’identità costituzionale pare restare un limite esterno ed assoluto al processo di integrazione. 144G. BIANCO, Non è un'Unione per principi. Il caso Sayn-Wittgenstein, in diritticomparati.it, 28 febbraio 2011. 145 V. M. CARTABIA, Commento all’art. 4, par. 2 TUE in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell'Unione Europea, Milano, 2014, pp. 24, 27. 146 A. VON BOGDANDY, Overcoming absolute primacy: respect for National identity under the Lisbon Treaty, in Common Market Law Review, 2011, pp. 1422-1423. Per una differente visione si veda B. GUASTAFERRO, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale. Tensioni costitutive e giunture ordinamentali, Milano, 2013, p. 241-242.
31 | federalismi.it |n. 24/2014
riconosce agli Stati la possibilità di individuarne unilateralmente gli ostacoli.
4.4 Le Carte dei diritti dell’Unione e la loro influenza sulla giurisprudenza della Corte di
Lussemburgo
Al termine dell’analisi dei concorrenti principi di omogeneità costituzionale e rispetto delle
identità nazionali degli Stati membri nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, occorre
quantomeno brevemente considerare l’influenza che le Carte dei diritti dell’Unione hanno avuto
sulla tutela dei diritti. Il nesso si giustifica proprio alla luce del fatto che la Corte ha estrapolato i
principi idonei alla tutela dei diritti fondamentali147, con il Trattato di Lisbona sintetizzati negli
artt. 2 e 6 TUE, anche dalla CEDU e soprattutto dalla Carta di Nizza.
Nonostante originariamente nei Trattati istitutivi non fosse presente un catalogo dei diritti
fondamentali, sin dalla fine degli anni Sessanta le decisioni dei giudici del Lussemburgo sono
andate nella direzione dello sviluppo, in via pretoria, di una tutela comunitaria di tali diritti148.
Nonostante le iniziali critiche dovute all’adozione di una prospettiva asseritamente economica (si
pensi al caso Grogan149), la Corte di Giustizia, in particolare dopo l’adozione della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea nel 2000, ha saputo valorizzare il suo ruolo di tutela
riconoscendo dapprima l’esistenza di diritti “assoluti” e permetterne, operandolo essa stessa, il
bilanciamento150 con libertà fondamentali garantite dai Trattati, ma anche con alcuni principi
stabiliti dalle Costituzioni nazionali. In un caso come quello della citata sentenza Melloni, tale
valutazione ha addirittura condotto al giustificato sacrificio degli standard di tutela di diritto
interno. Questi risultati potrebbero suggerire un rinnovato spazio di operatività dei controlimiti
nazionali, qualora le Corti rifiutassero di aprirsi all’auspicato judicial dialogue151 con la Corte di
Giustizia, e quest’ultima dal canto suo non dimostri maggiore attenzione nell’analisi e
valorizzazione delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, anche attraverso il
ricorso all’importante criterio interpretativo indicato dall’art. 52, par. 4, della stessa Carta dei
147 Cfr. supra par. 3.2 e 3.3. 148 G. PISTORIO, L’influenza della Carta di Nizza nelle sentenze della Corte di giustizia in materia di eguaglianza e dignità della persona, in www.europeanrights.eu, 5 maggio 2007, p. 6. 149 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 4 ottobre 1991, causa C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ldt e Stephen Grogan. 150 Si veda, in tal senso, la sentenza CGCE, 12 giugno 2003, causa C-112/00, Eugen Schmidberger Internationale Transport Planzüge contro la Repubblica, e la sentenza 14 ottobre 2004, causa C-36/02, Omega. 151 M. CARTABIA, «Taking Dialogue Seriously» The renewed Need for a Judicial Dialogue at the Time of Constitutional Activism in the European Union, Jean Monnet Working Paper 12/07, pp. 17,43.
32 | federalismi.it |n. 24/2014
diritti fondamentali152.
Con riferimento alla CEDU, infine, non soffermandosi ulteriormente sull’imprescindibile valore
che la Convenzione ha avuto per la tutela dei diritti umani in Europa, vale la pena sottolineare le
conseguenze dell’adesione operanda dall’Unione grazie alla previsione dell’art. 6.2 e 6.3 TUE con
riferimento alla delineata impostazione della Corte di Giustizia nel contesto della tutela
multilivello dei diritti. Se i diritti garantiti dalla CEDU fanno parte del patrimonio giuridico
dell’Unione in quanto principi generali, infatti, la Corte ha di recente statuito, nella contestata
sentenza Kamberaj153, che il rinvio dell’art. 6.3 TUE non impone al giudice nazionale, in caso di
conflitto tra una norma di diritto nazionale e la Convenzione, di applicare direttamente le
disposizioni di quest’ultima. Come poter leggere questo elemento? La Corte di Giustizia ha
voluto chiarire che la CEDU non è diritto dell’Unione e quindi non può vantare le qualità del
primato e dell’effetto diretto che caratterizzano il diritto europeo154, tantomeno ponendo in capo
alla Corte stessa la responsabilità di definire gli effetti della Convenzione negli ordinamenti
interni. A voler sottolineare, con questo riferimento, l’assoluta rilevanza dell’interpretazione dei
principi generali da parte della Corte di Giustizia155, anche e soprattutto nel raffronto con i
principi derivanti dagli ordinamenti interni, si richiama ancora una volta, a beneficio non solo del
rispetto delle identità nazionali così come incarnate dall’art. 4.2 TUE, ma anche di una corretta e
solida integrazione mediante il diritto degli ordinamenti che compongono l’Unione europea, la
necessità di una mutua apertura e dialogo da parte di tutti gli attori istituzionali coinvolti.
5. Conclusioni
A conclusione dell'excursus giurisprudenziale, possiamo dunque tornare ad interrogarci
sull'effettiva esistenza di una koinè europea. Se da un punto di vista strettamente normativo, il
Trattato di Lisbona, confermando e ampliando tanto il principio di omogeneità costituzionale
quanto la tutela delle identità nazionali, parrebbe offrire la base giuridica necessaria per
l’affermazione di uno ius commune europeo, l'analisi dell'esperienza ne mette in luce le carenze
152 “Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni”; art. 52, par. 4, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 2010/C 83/02, in http://eur-lex.europa.eu/. Nel Titolo VII della Carta (articoli 51-54), infatti, ne sono indicati i criteri di intepretazione ed applicazione. 153 Corte di Giustizia (grande sezion), sentenza 24 aprile 2012, causa C-571/10, Servent Kamberaj contro Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Bolzano. 154 A. E. BASILICO, Disapplicazione di leggi interne contrastanti con la CEDU? Il punto di vista della Corte di Giustizia, in rivistaaic.it, n. 3/2012, p. 10. 155 Tra i tanti contributi, si veda G. BIANCO – G. MARTINICO, The Poisoned Chalice: an Italian view on the Kamberaj case, Working Paper IDEIR n. 18/2013, pp. 9-14.
33 | federalismi.it |n. 24/2014
applicative.
Quanto al concetto di omogeneità, dall'analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge
tutta la difficoltà di operare un approfondimento dei valori costituzionali interni ai singoli Stati
membri, che non permette un utilizzo pieno degli stessi. Occorre sempre tenere a mente, poi, che
le peculiarità proprie di ciascun ordinamento si riflettono inevitabilmente sul significato che i
diritti fondamentali vengono ad assumere nello stesso. In altre parole, seppure ci fossero in due o
più ordinamenti enunciati identici rispetto al medesimo diritto, il significato da attribuirsi sarebbe
comunque il risultato di una serie di fattori, tra cui non vanno sottovalutate le dinamiche storiche
e culturali, che sono d’ostacolo ad una piena fungibilità della tutela.
Anche l’opportunità fornita dalla previsione espressa della tutela delle identità nazionali non è stata
del tutto colta: i giudici costituzionali hanno usufruito con parsimonia dell'importante strumento
che l'art. 267 TFUE concede loro. Il rinvio pregiudiziale, infatti, è, ad oggi, l'unica via attraverso
la quale le Corti interne possono "esportare" oltre i confini nazionali il bagaglio di valori
costituzionali che consentirebbe la concreta conoscenza delle "tradizioni costituzionali comuni"
da parte della Corte di Giustizia.
Ecco perché l'indivisibilità delle tutele deve passare per un'omogeneizzazione dei diritti,
intendendo per omogeneità la ricerca di un tratto comune che passi per la valorizzazione delle
peculiarità degli ordinamenti statali. Tali peculiarità, ad avviso di chi scrive, possono essere
esaltate solo mediante una proficua interazione fra le Corti.
Questa collaborazione giurisprudenziale potrebbe essere intesa quale momentanea supplenza e
giusto preludio per l'auspicata affermazione di uno statuto comune dei diritti fondamentali a
livello europeo.
L'importanza dell'attento bilanciamento tra i termini dicotomici omogeneità costituzionale e
identità nazionali è rinsaldata dalla presenza di una minaccia anti-europeista nel contesto delle
recenti elezioni europee cui potrebbero ricollegarsi conseguenti rischi nella tutela dei diritti
fondamentali e dei valori comuni sanciti negli artt. 2 e 6 TUE. A tali sollecitazioni ha
recentemente risposto anche la stessa Commissione, valorizzando il rispetto dei principi dello
Stato di diritto quali intrinsecamente connessi al rispetto della democrazia e dei diritti
fondamentali, richiamando altresì il necessario impegno di tutte le istituzioni dell’Unione a tal
proposito.
E’ evidente, infatti, la necessità di una convergenza sia degli attori istituzionali che delle Corti
europee e nazionali verso un’integrazione mediante il diritto che possa contribuire validamente
alla crescita dell’Unione e dei suoi Stati membri, tenendo sempre presente che «L’Unione Europea è
34 | federalismi.it |n. 24/2014
in primo luogo un’unione di diritto e di valori. La conquista di questi valori è il risultato della nostra storia. Essi
costituiscono il nucleo essenziale dell’identità dell’Unione e permettono a ciascun cittadino di riconoscersi in questa
appartenenza»156.
156 COM(2003) 606, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo in merito all’articolo 7 del trattato sull’Unione Europea. Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l’Unione.