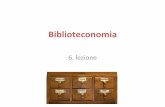2 FG9A Nationale Patente Brevets nationaux Brevetti nazionali
22 Fortunato Aiuti di Stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari e interventi nazionali...
Transcript of 22 Fortunato Aiuti di Stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari e interventi nazionali...
Aiuti di StAto e mercAto creditizio frA orientAmenti comunitAri
e interventi nAzionAli
di Sabino Fortunato
1. lo scoppio della bolla speculativa del mercato immobiliare collegata ai mutui subprime, originatasi negli Stati uniti già nella seconda metà del 2006 e perve-nuta ai suoi massimi livelli sul finire del 2008, ha innescato – com’è noto – una crisi finanziaria e una crisi dell’economia reale a livello globale, tali da evocare i fantasmi della Grande depressione degli anni trenta del secolo scorso.
ma se la crisi finanziaria è stata subito avvertita come «sistemica», la crisi dell’economia reale ha avuto valutazioni differenziate. Gli interventi dei pub-blici poteri hanno avuto a oggetto immediatamente e in maniera mimetica il settore finanziario, mentre hanno inciso sulla economia reale solo in una seconda fase e in modo differenziato.
È quanto emerge dalle stesse fonti comunitarie sugli «aiuti di Stato», in particolare dalle comunicazioni della commissione europea del 13 ottobre 20081, del 5 dicembre 20082, del 25 febbraio 20093 e del 17 dicembre 2008� (parzialmente modificata e integrata da una successiva comunicazione del 25
1 comunicazione ce n. 2008/c 270/02, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, 25 ottobre 2008, c 270/8: «l’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale».
2 comunicazione ce n. 2009/c 10/03, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 15 gen-naio 2009, c 10/2: «la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attua-le crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza».
3 comunicazione ce n. 2009/c 72/01 del 25 febbraio 2009, in Gazzetta Ufficiale del-l’Unione europea, 26 marzo 2009, c 72/1, «concernente il trattamento degli attivi svalutati nel settore bancario della comunità».
� comunicazione ce n. 2009/c 16/01, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 22 gen-naio 2009, c 16/1: «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed eco-nomica».
22_Fortunato.indd 337 17-05-2010 13:51:48
diritto, etica e mercato dopo la crisi338
febbraio 20095), intese a giustificare quegli aiuti nel contesto dell’attuale crisi, le prime tre con riferimento al sostegno diretto delle istituzioni finanziarie e la quarta con riferimento al finanziamento dell’economia reale. Gli interventi sono concepiti, peraltro, quali deroghe temporanee e limitate ai principi genera-li del diritto comunitario, che valorizzano prioritariamente come strumenti di sviluppo economico e sociale il «mercato» e la «concorrenza» e guardano con sfavore agli aiuti statali alle imprese.
nelle indicate comunicazioni il «carattere sistemico» della crisi è il presup-posto essenziale per dare fondamento agli aiuti di Stato in maniera così incon-suetamente diffusa e intensa in base alla clausola dell’art. 87, par. 3, lett. b) del trattato ce.
la carta comunitaria, infatti, dichiara in via di principio «incompatibi-li» con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati o comunque median-te risorse statali, che incidano sugli scambi intracomunitari, favorendo talune imprese o talune produzioni e che falsino o minaccino di falsare la concorren-za (art. 87, par. 1)6.
e tuttavia al divieto generale seguono deroghe (art. 87, parr. 2 e 3) e pro-cedure autorizzatorie e sanzionatorie (artt. 88-89). in particolare, alle deroghe di diritto7 si accompagnano deroghe ampiamente discrezionali a opera della commissione8, per effetto di vere e proprie clausole generali che vengono di
5 comunicazione ce del 25 febbraio 2009 che «modifica il quadro di riferimento tem-poraneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica». Questa comunicazione non risulta pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ma esiste un testo consolidato delle due comunicazioni in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 7 aprile 2009, c 83/1.
6 Si tratta dei quattro tradizionali elementi costitutivi della fattispecie di aiuto di Stato generalmente vietato, già posti in luce dalla nota sentenza nel caso Altmark della corte Ge del 2� luglio 2003, c-280/00, punto 75 («in primo luogo deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri. in terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficia-rio. in quarto luogo deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza»).
7 il paragrafo 2 del citato art. 87 dichiara automaticamente compatibili («sono compatibi-li») con il mercato comune: «gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a con-dizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti» (lett. a); «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri even-ti eccezionali» (lett. b); «gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della repubbli-ca federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione» (lett. c).
8 il paragrafo 3 del citato art. 87 dispone che «possono considerarsi compatibili» con il mercato comune altre cinque categorie di aiuti, e in particolare: quelli destinati «a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione» (lett. a); quelli destinati «a promuovere la realizzazione di
22_Fortunato.indd 338 17-05-2010 13:51:49
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 339
volta in volta riempite di contenuto dalle decisioni della commissione mede-sima, tanto che questa ha finito per elaborare, nel corso degli anni, linee guida che si risolvono – sul piano giuridico – in una preliminare autolimitazione della propria discrezionalità rispetto alle singole fattispecie concrete9.
le comunicazioni sopra indicate si collocano in questo ambito normativo e fondano una interpretazione degli aiuti, attivati nell’attuale contesto di crisi, come compatibili con il mercato comune in forza del citato art. 87, par. 3, lett. b), in quanto «destinati… a porre rimedio a un grave turbamento dell’econo-mia di uno Stato membro».
il «grave turbamento dell’economia» dell’intero Paese membro (e in verità di tutti i Paesi della comunità) viene ravvisato proprio nel carattere «sistemi-co» della crisi, nella sua idoneità a estendersi in maniera pervasiva e contagiosa a tutti i settori dell’economia.
il settore finanziario, e in ispecie quello degli intermediari finanziari, è dalla commissione considerato strategico, poiché è volto ad alimentare i flussi delle risorse che affluiscono a tutti i settori dell’economia. la crisi finanziaria mon-diale, se per un verso presenta «problemi specifici» legati al mercato crediti-
un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turba-mento dell’economia di uno Stato membro» (lett. b); quelli destinati «ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» (lett. c); quelli destinati «a promuovere la cul-tura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella comunità in misura contraria all’interesse comune» (lett. d); «le altre cate-gorie di aiuti, determinate con decisione del consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione» (lett. e).
9 nella stessa direzione della cananea, Giacinto (1993), «il ruolo della commissione nel-l’attuazione del diritto comunitario: il controllo sugli aiuti statali alle imprese», in Rivista ita-liana di diritto pubblico comunitario, pp. 399 e ss. (spec. p. �28) che parla di vere e proprie «direttive amministrative»; chiti, mario P. (200�), Diritto amministrativo europeo, milano, Giuffrè, p. 198, secondo il quale le comunicazioni sono equiparabili alle «circolari ammini-strative» che tuttavia «possono essere disattese solo in virtù di specifica e accurata motivazio-ne che dia conto delle diverse ragioni di pubblico interesse fatte proprie dalle istituzioni»; e nella giurisprudenza comunitaria corte Ge 2� febbraio 1987, causa c-310/85, punto 20 e ss.; corte Ge 26 settembre 2002, causa c-351/98 ove si precisa che «la commissione è vincola-ta dalle discipline o dalle comunicazioni da essa emanate in materia di controllo degli aiuti di Stato, nei limiti in cui queste ultime non derogano a norme del trattato e vengono accetta-te dagli Stati membri» (punto 53). Per una valutazione complessiva del sistema europeo degli aiuti di Stato si veda Sinnaeve, Adinda (2007), «How the eu manages subsidy competition», in markusen, Ann (ed.), Reining in the Competition for Capital, Kalamazoo, mi, W.e. upjohn institute for employment research, pp. 87 e ss.; Blauberger, michael (2008), From Negative to Positive Integration? European State �id Control �hrough Soft and �ard �a�European State �id Control �hrough Soft and �ard �a�, mPifG discus-sion Paper 08/� [www.mpifg.de].
22_Fortunato.indd 339 17-05-2010 13:51:51
diritto, etica e mercato dopo la crisi3�0
zio dei mutui ipotecari e alle perdite dovute a strategie eccessivamente rischio-se adottate dalle banche, per altro verso solleva «problemi sistemici» collegati all’inaridimento del prestito interbancario, alla crisi di liquidità, al rischio di propagazione all’economia reale e insomma alla «erosione generale della fidu-cia» nel sistema bancario e finanziario nel suo complesso, problemi che esigo-no allora interventi pubblici per ripristinare stabilità e corretto funzionamento di quel settore quale nodo essenziale delle economie nazionali e dell’economia mondiale10.
Si deve comunque sottolineare che, se la comunicazione del 13 ottobre 2008 sembra mostrare scarsa consapevolezza della portata sistemica della crisi anche per molti settori dell’economia reale11, la successiva comunicazione del 17 dicembre 2008 segna una svolta nella convinzione che «al di là del soste-gno di emergenza al sistema finanziario, l’attuale crisi mondiale richieda una risposta politica eccezionale» e che essa «comporterà un aumento della disoc-cupazione, un calo della domanda e un deterioramento delle finanze pubbli-che» (par. �.1).
l’art. 87, par. 3, lett. b) diventa così la base giuridica comune agli aiuti pub-blici della crisi, tanto nel settore finanziario quanto nel settore dell’econo-mia reale. e si tratta di una decisa novità, poiché i primi interventi risalenti al 2007 e sino ai primi di ottobre del 200812 sono stati autorizzati in base all’art.
10 Si veda il paragrafo 1 della comunicazione ce del 13 ottobre 2008 (supra, nota 1). non si intende in questa sede compiere una analisi e una valutazione critica delle cause della crisi, benché si sia pienamente consapevoli che quell’analisi costituisce il presupposto per una adeguata e corretta impostazione dei «rimedi». Sul punto si rinvia a draghi, mario (2009), «Audizione», 17 marzo, vi commissione finanze camera dei deputati nel corso della Inda-gine conoscitiva sulle tematiche relative al sistema bancario e finanziario; visco, ignazio (2009), �a crisi finanziaria e le previsioni degli economisti, lezione inaugurale del master in economia pubblica, roma, � marzo, il quale osserva che «se la politica economica ha gravi responsabilità, anche analisi e modelli previsivi hanno mostrato limiti importanti su cui è necessario interro-garsi»; Blundell-Wignall, Adrian, Atkinson, Paul, Hoon lee, Se (2008), «the current finan-cial crisis: causes and Policy issues», in Financial Market �rends, oecd. Si vedano anche gli Atti della vi commissione finanze e tesoro del Senato della repubblica, con le Audizioni di consob, ABi e corte dei conti, relativi alla «indagine conoscitiva sull’utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni».
11 nel paragrafo 11 della comunicazione la commissione ritiene, infatti, che «in linea di principio non si possa prevedere il ricorso all’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), in situazioni di crisi di altri singoli settori, se non sussiste un rischio analogo che tali situazioni abbiano un effetto sull’economia di uno Stato membro nel suo insieme».
12 Si tratta dei casi relativi alla crisi della northern rock decisi il 5 dicembre 2007 e il 2 aprile 2008; della WestlB decisi il 30 aprile e l’8 agosto 2008; della SachsenlB deciso il � giu-gno 2008; della roskilde i deciso il 31 luglio 2008; della Bradford&Bingley deciso il 1 ottobre 2008; della Hypo real estate Holding deciso il 2 ottobre 2008; e dell’iKB deciso il 21 ottobre
22_Fortunato.indd 340 17-05-2010 13:51:53
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 3�1
87, par. 3, lett. c)13 e con riferimento alle «linee guida per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà»1�, seguendo un approccio singolare e restrittivo15 del tutto inidoneo ad affrontare le particolarità e le sfide connes-se allo stato di crisi generalizzato.
il richiamo alla nuova e non sperimentata16 base giuridica ha una triplice funzione.
in primo luogo, esso supplisce alla debolezza istituzionale dell’unione europea nell’affrontare con provvedimenti unitari, definiti a livello comunita-rio, la crisi globale che ha colpito l’economia di tutti i Paesi membri oltre che degli altri Paesi avanzati ed emergenti del mondo17. Attraverso la filosofia degli aiuti di Stato gli interventi sono ricondotti alla competenza e alla specificità dei singoli membri dell’unione, ma nel contempo vengono coordinati in un qua-dro di regole e principi comuni che valga a mantenere il vincolo sovranaziona-le della politica comunitaria quantomeno a livello di orientamenti condivisi18.
2008. Si ricorderà che in maniera pionieristica le prime esperienze di aiuti nel settore banca-rio risalgono alle decisioni relative al credit lyonnais e al Banco di napoli nella seconda metà degli Anni novanta del secolo scorso.
13 la disposizione consente «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misu-ra contraria al comune interesse». Si veda sul richiamo alla disciplina degli aiuti per le impre-se in difficoltà la stessa comunicazione ce del 13 ottobre 2008, paragrafo 6 (supra, nota 1). Per una sintesi degli interventi autorizzati dalla commissione in quelle che vengono dalla stes-sa definite le prime due fasi della crisi si veda State �id Scoreboard – Spring 2009 Update, Spe-cial edition on State �id interventions in the current financial and economic crisis, com(2009) 16�, 08.0�.2009, 5-9.
1� Si veda comunicazione ce su «orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salva-taggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà», in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 1 ottobre 200�, c 2��/2.
15 Si vedano al riguardo i rilievi di Werner, Philipp e maier, martina (2009), «Procedure in crisis? overview and Assessment of the commission’s State Aid Procedure during the current crisis», in European State �id �a� Quarterly, pp. 177 e ss.
16 l’art. 87, par. 3, lett. b) del trattato ce ha trovato applicazione in passato una sola volta negli anni ottanta con riferimento alla Grecia: si veda decisione del 7 ottobre 1987, in Gaz-zetta Ufficiale dell’Unione Europea, 22 marzo 1988, l 76/18 e il XVII Rapporto sulla politica di concorrenza(1987), 1988, parr. 186-187.
17 nonostante molteplici sollecitazioni, il consiglio europeo del 7 ottobre 2008 non ha accolto la proposta franco-italiana di istituire un fondo europeo per la gestione comune della crisi; né si è ancora pervenuti ad accentrare nelle mani di un’autorità comunitaria le competen-ze in materia di vigilanza finanziaria.
18 Analoga valutazione in tonetti, Alessandro (2009), «la disciplina comunitaria e glo-bale degli aiuti a favore del sistema bancario», in Giornale di diritto amministrativo, pp. 659 e ss. (spec. pp. 668-669), il quale contesta l’opinione che la commissione abbia agito in manie-ra timida e opportunistica nei confronti degli Stati membri, avendo anzi utilizzato la disciplina
22_Fortunato.indd 341 17-05-2010 13:51:55
diritto, etica e mercato dopo la crisi3�2
in secondo luogo, quel richiamo incardina nella commissione la compe-tenza applicativa del sistema derogatorio, per un verso ribadendo il coordina-mento delle iniziative sulla base dei valori fondanti del «mercato comune» e della «concorrenza» e per altro verso accelerando l’adozione delle misure neces-sarie ad affrontare la crisi da parte dei singoli Stati membri. vi sarebbe stata, infatti, la possibilità di invocare, su richiesta di ogni singolo Stato membro e a fronte di «circostanze eccezionali» che lo giustifichino, una decisione unanime del consiglio (piuttosto che della commissione) per derogare in toto all’art. 87 e ai regolamenti previsti dall’art. 8919; ma non è chi non veda la complessità e intempestività di una tale procedura e soprattutto il rischio di una completa disarticolazione delle regole sostanziali del quadro comunitario.
in terzo luogo, l’art. 87, par. 3, lett. b) contiene implicitamente il limite della «straordinarietà» della misura, destinata a venir meno una volta che il «grave turbamento dell’economia» sia stato superato. Sotto questo profilo le comunicazioni ribadiscono a più riprese il carattere eccezionale e temporaneo delle misure derogatorie per la crisi. in particolare la comunicazione del 22 gennaio 2009 individua un «quadro di riferimento temporaneo» per gli aiuti straordinari ammissibili in questa fase, collegando in astratto quella tempora-neità alla durata della crisi ma in concreto prefissando un termine ultimo al 31 dicembre 2010 e un termine di verifica intermedia al 31.12.2009, entro cui commissione e Stati membri dovranno valutare l’eventuale evoluzione positiva della situazione e l’opportunità di por fine alle misure eccezionali20.
degli aiuti di Stato alla stregua dello «strumento più incisivo per assicurare il coordinamento delle azioni pubbliche nazionali». donde l’invito di alcuni commissari a considerare la questio-ne degli aiuti di Stato non come il problema della crisi, ma come soluzione alla crisi («the state aid rules are part of the solution and they are not part of the problem»: così il commissario neelie Kroes). la stessa componente della commissione ha sottolineato, nell’intervento tenu-la stessa componente della commissione ha sottolineato, nell’intervento tenu-to l’8 dicembre 2008 («the role of state aid in tackling the financial & economic crisis»), che «State aid rules… give national governments the freedom to take aim at the root causes of the crisis, but stop them from shooting themselves in the foot, or their neighbours in the back». inin senso opposto e piuttosto critico sulle debolezze mostrate dalle istituzioni comunitarie a fron-te dei rinascenti protezionismi nazionali lautenberg, Alexis P. (2009), «State Aid, nationali-sm and financial Protection in response to the Global crisis: the cohesion of the eu at the Stake», 16 giugnon [���.Federalismi.it].
19 la procedura è consentita dall’art. 88, par. 2, trattato ce. Per analoghi rilievi luja, raymond (2009), «State Aid and the financial crisis: overview of the crisis framework», in European State �id �a� Quarterly, n. 2, pp. 1�5-160.
20 ma anche la comunicazione del 13 ottobre 2008 evidenzia che «qualora vi sia un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro del genere sopra descritto, è possibile ricorre-re all’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), non per una durata indeterminata, ma soltanto fino a quando la situazione di crisi ne giustifichi l’applicazione» (par. 12).
22_Fortunato.indd 342 17-05-2010 13:51:56
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 3�3
la preoccupazione della commissione europea è legata, dunque, alla esi-genza di mantenere il quadro complessivo degli aiuti di Stato nel periodo di crisi nell’ambito dei principi fondamentali dell’acquis comunitario, a questo fine salvaguardando le «regole sostanziali» di tutela del libero scambio e della concorrenza21 e incidendo piuttosto sulle «regole procedurali» mediante una speciale procedura di crisi che velocizzi l’esame e l’autorizzazione degli aiuti con-sentiti22.
21 la preoccupazione che le «misure statali della crisi» possano trasformarsi in un perico-lo distorsivo della concorrenza e in politiche neo-dirigiste di protezionismo nazionale emerge nelle molteplici sedi internazionali in cui la questione è stata affrontata (vedi in particolare le dichiarazioni finali del G-7 del 10 ottobre 2008, del G-8 del successivo 15 ottobre e del G-20 del 15 novembre), e non solo a livello delle istituzioni comunitarie. Sul punto si veda tonet-ti, Alessandro, «la disciplina comunitaria e globale degli aiuti a favore del sistema bancario», cit., p. 661.
22 Ha così sostenuto il commissario Kroes, in un discorso del 17 febbraio 2009: «We need to be flexible on procedures – yes - but not on principle. […] flexibility does not mean throwing out the rules». e si veda ancora Werner, Philipp e maier, martina, «Procedure in crisis? overview and Assessment of the commission’s State Aid Procedure during the cur-rent crisis», cit., p. 177, i quali tuttavia ritengono che la «procedura di crisi» solleva nume-rose potenziali problematiche in termini di valutazione, certezza giuridica, partecipazione e tutela dei terzi e ritorno agli standard pre-crisi, tali da incidere sul quadro delle stesse rego-le sostanziali. Quanto alla velocizzazione del processo decisionale da parte della commissio-ne, gli autori sottolineano che la commissione ha mantenuto di fatto una media di un mese per ogni decisione a fronte di un periodo di diciotto mesi e oltre secondo la procedura norma-le (pp. 180-181). Sui caratteri della procedura valutativa di crisi si veda anche tonetti, Ales-sandro «la disciplina comunitaria e globale degli aiuti a favore del sistema bancario», cit., p. 665 e s.; nonché State �id Scoreboard (supra, nota. 13), p. 23 e s. la verifica preventiva prevede che gli Stati membri informino tempestivamente la commissione della «intenzione» di adot-tare misure e quindi notifichino subito i relativi progetti e nel modo più completo possibile, comunque prima di darvi attuazione. A notifica «completa», la commissione si impegna ad assumere velocemente la decisione, se del caso anche entro ventiquattrore e durante il fine set-timana. i presupposti del rapido funzionamento della procedura di crisi sono «close coopera-tion and full information» da parte degli Stati membri, nel cui ambito si inseriscono altresì le valutazioni preventive richieste alle Autorità nazionali competenti in materia di stabilità finan-ziaria. nel contempo, la commissione ha istituito un Economic Crisis �eam, per i contatti con gli Stati membri, e ha delegato temporaneamente poteri a un ristretto numero di commissari (neelie Kroes, José manuel Barroso, Joaquin Almunia e charlie mccreevy) per autorizzare le cosiddette «emergency rescue measures»».l’esperienza della procedura di crisi è alla base della accelerazione di un più generale tentativo di semplificazione procedurale da parte delle istitu-zioni comunitarie nell’esame degli aiuti di Stato (State �id �ction Plan). il 29 aprile 2009 sono stati adottati dalla commissione un «Best Practices code» (si veda notice from the commis-sion – Best Practices Code on the conduct of State aid control proceedings, adopted on 29.0�.09 [http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/reform.html] e una «Simplified Procedu-re» (si veda notice from the commission on a simplified procedure for treatment of certain types
22_Fortunato.indd 343 17-05-2010 13:51:58
diritto, etica e mercato dopo la crisi3��
2. È in questo contesto che trovano giustificazione i «criteri» dettati dalla commissione per la valutazione di ammissibilità degli specifici interventi che saranno (e sono stati) predisposti dai singoli Stati membri.
Se si guarda in particolare al settore finanziario (ma gli orientamenti si ripe-tono anche per il finanziamento dell’economia reale), i criteri di ammissibili-tà – che hanno a oggetto tanto «regimi generali» (a disposizione di varie o di tutte le istituzioni finanziarie in uno Stato membro) quanto «interventi singo-lari» (ad hoc per singole imprese) – vengono così declinati:
a) l’aiuto dev’essere strettamente mirato all’obiettivo, e cioè a porre rimedio al «grave turbamento» dell’economia e non perseguire altre finalità;
b) deve altresì essere proporzionato allo scopo, ovvero limitato al minimo indispensabile senza andare al di là del fabbisogno necessario;
c) deve avere carattere non discriminatorio e oggettivo; d) deve essere corredato di misure di salvaguardia, tese a evitare eventuali
abusi e indebite distorsioni della concorrenza;e) deve avere carattere temporaneo e perciò sottoposto a verifiche periodiche
e accompagnato da adeguati incentivi all’uscita;f) deve infine essere seguito, a crisi ultimata, da misure di adeguamento del-
l’ intero settore e/o da piani di ristrutturazione o liquidazione dei singoli beneficiari.
Gli indicati criteri sono peraltro commisurati a un profilo soggettivo e a un profilo oggettivo, e cioè alla situazione patrimoniale/economica del beneficia-rio e alla tipologia della misura di intervento programmato.
I. in merito al profilo soggettivo acquista rilievo la distinzione fra imprese fon-damentalmente sane, «messe in difficoltà esclusivamente dalle condizioni gene-rali di mercato», e imprese che presentano già – allo scoppio della crisi – diffi-coltà endogene, derivanti «dal loro particolare modello aziendale o da pratiche commerciali particolari».
la differente situazione soggettiva può in concreto giustificare un adegua-mento del criterio sub c. relativo al trattamento oggettivo e non discriminatorio, perché per le imprese del secondo tipo, interessate da perdite derivanti «da inef-ficienze, da una cattiva gestione delle attività/passività o da strategie rischiose»,
of State aid, adopted on 29.0�.09 [http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/reform.html]) che dovrebbero trovare applicazione dal 1° settembre 2009. Si veda al riguardo unge-rer, Herbert (2009), «State Aids 2008/2009: 12 months of crisis management and reforms», pp. 13 e ss. [http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2009_05_en.pdf]).
22_Fortunato.indd 344 17-05-2010 13:52:00
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 3�5
gli interventi potrebbero e dovrebbero ricadere nel «normale quadro degli aiuti al salvataggio» e richiedere da un canto un’ampia ristrutturazione «per ripristi-nare la redditività a lungo termine», se non addirittura la liquidazione, e d’al-tro canto misure compensative volte a limitare le distorsioni della concorrenza. di contro, le imprese illiquide ma fondamentalmente sane ricadono certamen-te nell’ambito di applicazione delle misure di crisi, avranno bisogno di una ristrutturazione meno sostanziale e le distorsioni della concorrenza che ne deri-vano saranno di norma più limitate (in tal modo la distinzione soggettiva inci-de anche sull’applicazione dei criteri sub d. e f.).
Peraltro deve riconoscersi che la determinazione della qualificazione del soggetto come fondamentalmente sano o già in difficoltà per problemi endo-geni allo scoppio della crisi pone una spinosa e non agevole questione interpre-tativa. A quale momento occorrerà guardare? Si tratterà evidentemente di una data convenzionale, con tutti i limiti che ciò comporta. la distinzione indub-biamente è funzionale a evitare fenomeni di free riders, di utilizzazioni impro-prie delle misure di crisi da parte di soggetti le cui perdite non sono correlate alla corrente crisi finanziaria globale, ma a strategie aggressive con assunzione di rischi eccessivi, a cattiva gestione e difetto di supervisione o presenza addi-rittura di operazioni fraudolente. ma dal punto di vista tecnico, molte banche non hanno avuto piena consapevolezza dei rischi assunti, per l’acquisizione di titoli più volte oggetto di cartolarizzazione, ora deprezzati23. come classificare tali imprese ai fini che ci occupano?
la differente situazione soggettiva sul piano economico/patrimoniale può incidere anche nella definizione del criterio di proporzionalità evidenziato sub b., poiché il principio di limitazione al minimo dell’intervento necessario si sposa con la non gratuità dell’intervento e la necessità che sussista un contribu-to significativo da parte del beneficiario e/o del settore sovvenzionato. in par-ticolare potrà essere prevista una «remunerazione adeguata» tendenzialmen-te vicina al prezzo di mercato in presenza, per esempio, di un intervento di garanzia dello Stato e – in caso di escussione – anche la copertura (in via di regresso) di una parte considerevole delle passività in essere. ma ove il benefi-ciario non sia immediatamente in grado di corrispondere la remunerazione e/o la parziale copertura della passività garantita, potrebbe introdursi una clausola di recupero (cla�back) o di cosiddetto «ritorno a giorni migliori», per cui ci si impegna al pagamento non appena si sarà in grado di farlo.
23 Sulla distinzione fra banche fondamentalmente sane e già in difficoltà e i profili proble-matici che essa solleva si veda luja, raymond, «State Aid and the financial crisis: overview of the crisis framework», cit., p. 1�6 e s.
22_Fortunato.indd 345 17-05-2010 13:52:01
diritto, etica e mercato dopo la crisi3�6
Parimenti il principio di non discriminazione in caso di intervento di «ricapi-talizzazione» induce a considerare positivamente «la valutazione della necessità del sostegno» compiuta da parte delle autorità nazionali di vigilanza finanzia-ria, il che presuppone l’esame dei requisiti di solvibilità di ciascun potenzia-le beneficiario. Sulla portata del principio di non discriminazione con riguardo agli interventi di «ricapitalizzazione» delle banche la commissione è ritornata in maniera molto più dettagliata con la successiva comunicazione del 15 gen-naio 20092�, dedicata precipuamente a tali interventi, evidenziando che l’ac-quisizione di azioni (ordinarie e/o privilegiate) da parte dello Stato può per-seguire un triplice obiettivo, comunque di carattere sistemico: ripristinare la stabilità finanziaria, garantire l’erogazione di finanziamenti all’economia reale, affrontare il rischio sistemico collegato alla eventuale insolvenza di banche in difficoltà per il loro particolare modello operativo o per la loro strategia di investimento. Allo stesso tempo si sottolinea che l’esigenza di raggiungere un corretto equilibrio fra stabilità finanziaria e obiettivi di concorrenza leale (fra Stati membri, fra banche e per il ritorno al normale funzionamento del merca-to del capitale di rischio) esige ancor più la necessità di distinguere fra banche fondamentalmente sane e con buone prestazioni e banche in difficoltà con pre-stazioni inferiori. in generale la differenziazione nei regimi e interventi singoli di ricapitalizzazione va commisurata ai «profili di rischio» delle banche benefi-ciarie, nel senso che le banche con profili di rischio più elevato dovranno sop-portare un «prezzo» più elevato per l’intervento25.
meno sicura è invece una ulteriore distinzione soggettiva che pure sembra essersi inizialmente affacciata negli orientamenti della commissione e ripresa altresì nella recente comunicazione del 25 febbraio 2009 sugli attivi deprezza-ti26, e cioè quella fra «banche sistemiche» (o «rilevanti») e «banche non sistemi-
2� Si veda supra, nota. 2.25 l’intervento a favore di banche fondamentalmente sane deve mirare agli obiettivi di sti-
molare la stabilità finanziaria e di sostenere il finanziamento dell’economia reale, subordinata-mente alle condizioni specificate dai paragrafi 22-�2 della comunicazione sulla ricapitalizza-zione. l’intervento a favore di altre banche con obiettivo di salvataggio è soggetto a condizioni più severe, sia sotto il profilo della remunerazione sia sotto il profilo di prevederne la liquida-zione o comunque un piano di ristrutturazione ampia e profonda con cambiamenti nel mana-gement e nella corporate governance e misure compensative, piani da sottoporre entro sei mesi dalla ricapitalizzazione e secondo i principi espressi negli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (vedi i paragrafi �3-�5 della citata comunicazione).
26 la distinzione fra banche di importanza sistemica e non è ripresa nella comunicazione citata (supra, nota. 3) come indicazione di opportunità per focalizzare, in situazione di penuria di risorse nel bilancio pubblico, le misure di rilievo degli attivi deprezzati su un «numero limi-tato di banche d’importanza sistemica». Attiene dunque all’ordine di priorità degli interventi, piuttosto che al principio di non discriminazione.
22_Fortunato.indd 346 17-05-2010 13:52:03
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 3�7
che» (o «non rilevanti»). Si è osservato che questa distinzione è comprensibile sul piano politico, ma molto meno sul piano tecnico-giuridico ai fini dell’am-missibilità agli aiuti di Stato fondati sul «grave turbamento dell’economia». Se si assume che il fallimento di una grande banca può esso stesso determinare il «grave turbamento» dell’intera economia del Paese interessato, la distinzio-ne sembra avere senso. ma quale banca, anche di piccole dimensioni, in pre-senza di una crisi globale in atto non è sufficientemente rilevante da richiama-re interventi pubblici per porre rimedio al grave turbamento dell’economia? Gli Stati membri hanno di fatto mostrato la tendenza a presumere che tutte le banche hanno carattere sistemico, di fatto annacquando la distinzione27.
3. II. Passando all’esame del profilo oggettivo, l’attenzione della commissio-ne nella comunicazione generale del 13 ottobre 2008 ricade su tre tipologie di diretto intervento a sostegno delle banche («istituzioni finanziarie»):
A) la concessione di garanzie statali a copertura di passività bancarie;B) gli interventi di ricapitalizzazione28;c) la liquidazione controllata di determinate banche.
A queste tipologie deve aggiungersi una quarta, dettagliata nella comunica-zione del 25 febbraio 200929 e avente a oggetto:
d) l’acquisizione, sotto molteplici forme, di attivi deprezzati delle banche (si tratta perlopiù dei cosiddetti «titoli tossici», ma non solo).
la garanzia pubblica sui depositi ma anche sui prestiti interbancari ha costi-tuito una delle forme di primo intervento per ripristinare la fiducia nel siste-ma finanziario e riattivare flussi di liquidità. essa non comporta un immediato esborso a carico dei bilanci statali, ma espone comunque al rischio di incre-mento del debito pubblico. Ancor più il rischio si attualizza con gli interven-ti di sottoscrizione del capitale e con l’acquisizione di attivi deprezzati, operazio-ni tutte che potrebbero affiancare altresì le misure di liquidazione controllata delle banche. tali misure potrebbero risultare discriminatorie e favorire com-portamenti opportunistici dei beneficiari in vista dell’aiuto di Stato o politi-
27 Si veda anche su questi aspetti luja, raymond, «State Aid and the financial crisis: overview of the crisis framework», cit., p. 1�7 e s.
28 Per tali operazioni occorre aver riguardo altresì alla comunicazione di precisazioni del 15 gennaio 2009 di cui alla nota 2.
29 Si veda supra, nota 3.
22_Fortunato.indd 347 17-05-2010 13:52:05
diritto, etica e mercato dopo la crisi3�8
che aggressive ed espansionistiche con l’utilizzo degli aiuti di Stato, il tutto con effetti gravemente distorsivi della concorrenza. di qui la necessità di un qua-dro comunitario comune e coordinato che orienti gli Stati membri a regolare gli interventi nella direzione strettamente necessaria a perseguire gli obiettivi di stabilità finanziaria e di riattivazione dei finanziamenti all’economia reale.
i criteri di ammissibilità degli aiuti trovano adeguamento e specificazione in relazione alle particolarità delle singole tipologie sopra indicate.
4. A) il principio di non discriminazione (criterio sub c.) assume un ruolo signi-ficativo con riguardo ai regimi generali o agli interventi singolari di «garanzia» sulle passività delle banche nella determinazione dell’estensione sia dei soggetti beneficiari sia delle passività suscettibili di aiuto.
occorre evitare interventi che possano distorcere la concorrenza tanto sui mercati limitrofi quanto nel mercato interno nel suo complesso, garantendo che l’aiuto possa beneficiare tutti i soggetti costituiti secondo il diritto dello Stato membro interessato comprese le controllate (anche da società madri con sede in altri Stati) e aventi attività significative in detto Stato, e ciò al fine di impedire il verificarsi di negative spill-overs, come la fuga dei depositi nei Paesi che per primi adottino la misura di garanzia (si pensi a quanto accaduto per le banche inglesi a fronte degli interventi a favore delle banche irlandesi).
d’altro canto occorre evitare di favorire comportamenti opportunistici dei beneficiari (moral hazard), ciò che si traduce nella selezione delle passivi-tà suscettibili di garanzia pubblica. di qui la legittimità di garanzie sui deposi-ti e titoli di debito dei clienti al dettaglio (per alimentarne la fiducia ed evitare le fughe dei depositanti), di determinati tipi di deposito all’ingrosso e anche di strumenti di debito a breve e a medio termine (purché non altrimenti garantiti, per alimentare il prestito interbancario e la liquidità) e comunque con limita-zioni alla garanzia disponibile «eventualmente in rapporto all’entità del bilan-cio del beneficiario».
ma di qui anche il divieto di coperture di debiti subordinati o indiscrimi-natamente di tutte le passività, coperture che potrebbero tradursi nella salva-guardia di azionisti e altri portatori di capitale di rischio, sui quali è invece opportuno e corretto che ricadano le perdite.
il principio di proporzionalità (criterio sub b.), per cui l’aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile, comporta che il beneficiario o quantome-no il settore beneficiato sopportino un costo dell’intervento. Si è già ricordato, al paragrafo 2., che la garanzia non può essere gratuita e deve basarsi su una «remunerazione adeguata» prossima a un possibile «prezzo di mercato», secon-do parametri che tengano conto del grado di rischio assunto dal garante e del profilo di credito del garantito; in caso di escussione, una parte considerevo-
22_Fortunato.indd 348 17-05-2010 13:52:06
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 3�9
le della passività deve far carico al privato beneficiario o al settore, immediata-mente o comunque anche in un secondo momento mediante l’inserimento di clausole di recupero o di «ritorno a giorni migliori».
la temporaneità della garanzia (criterio sub e.) si esprime nella circostanza che la durata del regime di garanzia può estendersi anche sino a due anni, pur-ché sia assicurata una verifica semestrale sulla perdurante giustificazione dello stesso, regolarmente comunicata alla commissione. Anche dopo i due anni, se permangono le condizioni di crisi, la durata del regime può essere ulteriormen-te estesa con l’approvazione della commissione.
Quanto alle misure di salvaguardia (criterio sub d.), dirette a evitare abusi e distorsioni della concorrenza, il beneficiario deve impegnarsi a non intraprende-re politiche industriali di espansione aggressiva ai danni dei concorrenti che non fruiscono del medesimo aiuto e lo Stato deve adottare misure sanzionatorie dei comportamenti lesivi, compresa la sospensione della garanzia concessa. in via esemplificativa, dovrebbero imporsi restrizioni a forme di pubblicità che sotto-lineino che la banca gode della garanzia statale o all’utilizzo della garanzia per la fissazione dei prezzi o per espandere le attività; o ancora si potrebbero porre limiti alle dimensioni del bilancio della banca beneficiaria con riguardo a para-metri quali il Pil o la crescita del mercato monetario; né potrebbero consentirsi riacquisti di azioni proprie o emissione di nuove stock options per la dirigenza.
il regime temporaneo di garanzia dovrebbe poi essere seguito da misure di adeguamento (criterio sub f ) per il settore nel suo complesso e/o dalla ristrut-turazione o liquidazione dei singoli beneficiari. in altre parole, appena la situa-zione dei mercati finanziari lo permetta e comunque entro sei mesi nel caso di pagamenti da effettuarsi in favore del beneficiario, dovrebbe essere notificato alla commissione un piano di ristrutturazione o di liquidazione della banca, affinché sia ripristinato il normale funzionamento del mercato.
5. B) Gli aiuti sotto forma di «sottoscrizione del capitale» delle banche tendo-no per un verso a rafforzare il patrimonio di base e di vigilanza e a incentivare ulteriori investimenti di rischio anche da parte dei privati, perseguendo la sta-bilità finanziaria del sistema e il ripristino della fiducia; per altro verso mirano a incrementare le disponibilità per il finanziamento all’economia reale (grazie al miglioramento dei ratios di patrimonializzazione e solvibilità). le comuni-cazioni della commissione non escludono forme addirittura di nazionalizza-zione di alcuni intermediari. ma è evidente che sia nella forma della partecipa-zione minoritaria e soprattutto maggioritaria sia, e ancor più, nella forma della nazionalizzazione si pongono rilevanti questioni sul piano della concorrenza fra Paesi membri e fra banche beneficiarie nonché sul piano della governance dell’impresa bancaria e dei suoi rapporti con i condizionamenti politici.
22_Fortunato.indd 349 17-05-2010 13:52:08
diritto, etica e mercato dopo la crisi350
i criteri da rispettare per la legittimità di questi aiuti sono fondamental-mente gli stessi fissati nel quadro generale, tenendo conto peraltro della ten-denziale irreversibilità dell’intervento.
Sulla portata del principio di non discriminazione con riguardo alla «ricapi-talizzazione» delle banche si è in parte già detto, a proposito del profilo sogget-tivo e della distinzione fra banche fondamentalmente sane e banche con diffi-coltà endogene.
Quanto al principio di proporzionalità, la direttiva della commissione preve-de che «i beneficiari dovrebbero contribuire il più possibile con i propri mezzi, compresa la partecipazione privata», che la ricapitalizzazione deve mirare al «mantenimento dei requisiti minimi di solvibilità rafforzati e/o (con) la limita-zione delle dimensioni totali del bilancio dell’istituzione finanziaria» interessa-ta e che il prezzo di emissione degli strumenti (anche sotto forma di �arrant, capitale subordinato e così via) deve essere fissato sulla base di una valutazione orientata al mercato30 e preferibilmente mediante emissione di azioni privile-giate o comunque con l’introduzione di clausole di «recupero» o cosiddette di «ritorno a giorni migliori».
in realtà la questione del «prezzo» delle misure statali di ricapitalizzazio-ne ha carattere polifunzionale, nel senso che si interseca con molteplici criteri di ammissibilità dell’aiuto. Questi aspetti trovano un più ampio sviluppo nella comunicazione del 5 dicembre 2008 dedicata precipuamente alla «ricapitaliz-zazione»31. il principio di non discriminazione induce a differenziare il prezzo con riguardo ai «profili di rischio» di ciascun beneficiario, tenendo conto degli indicatori che discendono dai requisiti normativi di solvibilità e di adeguatezza patrimoniale prospettica, dagli spread dei Credit Default S�ap (cdS) e i rating anteriori alla crisi32.
la determinazione del prezzo si combina altresì con il principio di tempo-raneità dell’intervento, reso di più difficoltosa applicazione dalla tendenziale irreversibilità della misura. Si precisa che «le condizioni di fissazione dei prez-zi dovrebbero dare alla banca un incentivo per rimborsare lo Stato non appena
30 tuttavia si ammette che «gli attuali livelli di mercato» potrebbero non riflettere necessa-riamente «quelle che potrebbero essere considerate le normali condizioni di mercato» (par. 2�).
31 Si veda supra, nota 2.32 Si veda comunicazione citata, parr. 13 e 1�. la comunicazione contiene indicazioni
dettagliate sulla metodologia di calcolo, accogliendo le raccomandazioni della Banca centrale europea del 20 novembre 2008 (parr. 16-18, nonché 26-30) e sviluppando nell’Allegato osser-vazioni sulla determinazione del prezzo del capitale proprio e sugli indicatori per la valutazione dei profili di rischio. Si prevede anche che ove i conferimenti di capitale statali siano effettuati a condizioni paritarie rispetto a quelli di privati con partecipazioni significative (30 per cento o più), la remunerazione sarà ritenuta automaticamente congrua (par. 21).
22_Fortunato.indd 350 17-05-2010 13:52:09
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 351
terminata la crisi»33 e che l’incentivo all’uscita del capitale statale mediante una maggiorazione (add-on) del prezzo di ingresso fissato è auspicabile, eventual-mente accompagnato da clausole di aumento nel tempo (o di step-up). ovvia-mente non si tratta dell’unico meccanismo di uscita, poiché si ipotizzano anche opzioni call o clausole di rimborso o che incoraggino la raccolta di capitale pri-vato prevedendo, per esempio in sede di pagamento dei dividendi, una remu-nerazione obbligatoria dello Stato (che aumenti nel tempo). ma anche una politica restrittiva di dividendi potrebbe fungere da incentivo all’uscita3�.
Analogamente ai regimi di garanzia, anche i regimi di ricapitalizzazione hanno un limite di durata biennale con verifica semestrale, da attuarsi median-te una relazione alla commissione sull’attuazione delle misure adottate, con la possibilità di revisione delle misure di salvaguardia e di riclassificazione di una impresa inizialmente considerata fondamentalmente sana fra quelle in difficol-tà, abbisognevoli di un piano di ristrutturazione35. Misure di salvaguardia (a tutela di imprese concorrenti) e misure di adeguamento, anche mediante piani di ristrutturazione, seguono linee simili a quelle già esaminate per gli interven-ti di garanzia parimenti per la distinzione fra imprese fondamentalmente sane e imprese con difficoltà endogene36.
va anche sottolineato che le nazionalizzazioni (government takeovers) delle banche non sono trattate autonomamente e ricadono, in quanto aiuti di Stato, sotto i regimi generali degli interventi per le istituzioni finanziarie sin qui ana-lizzati (regimi di ricapitalizzazione o, se del caso, di garanzia statale). il proble-ma fondamentale in caso di nazionalizzazione è collegato alla «remunerazione» dei vecchi azionisti, che deve riflettere non più del valore attuale delle azioni detenute.
ovviamente il divieto di aiuto ex art. 87, par. 1, trattato ce si applica alle imprese e non agli azionisti persone fisiche, non qualificabili come imprese. nella specie potrebbe trattarsi di azionisti fondi di investimento, imprenditori o gruppi bancari che ricevono una remunerazione più elevata rispetto al valo-re di mercato37.
33 Si vedano il par. 19, ma anche i parr. 20, 25 e 26, comunicazione citata, con l’ulterio-re precisazione (in nota 2) che «tutti gli incentivi di uscita o incentivi a rimborsare lo Stato… si intendono volti alla sostituzione del capitale statale mediante il capitale privato nella misura necessaria e adeguata nel contesto di un ritorno a normali condizioni di mercato».
3� Si vedano i parr. 31-3� comunicazione citata.35 Si vedano i parr. �0-�2 comunicazione citata.36 Si vedano i parr. �3-�5 comunicazione citata e i parr. 35 e �2 della comunicazione del
13 ottobre 2008 (supra, nota 1).37 Sul punto luja, raymond, «State Aid and the financial crisis: overview of the crisis
framework», cit., p. 152 e s.
22_Fortunato.indd 351 17-05-2010 13:52:11
diritto, etica e mercato dopo la crisi352
6. c) fondi pubblici, sotto forma di contributi o anche solo di garanzia, potrebbero accompagnare altresì «liquidazioni controllate» in casi individua-li o come seconda fase di un salvataggio, laddove si renda evidente che la banca non può essere ristrutturata con successo.
Anche qui il principio di non discriminazione impone che la scelta del tipo di passività da rimborsare con fondi pubblici segua i criteri già esaminati per i regimi di garanzia, con esclusione di azionisti ed eventualmente di determina-ti tipi di creditori (portatori di strumenti rappresentativi di capitale di rischio) sempre al fine di non favorire situazioni di moral hazard e rispettare altresì il principio di proporzionalità dell’intervento.
Quanto alla temporaneità, è difficile prefissare la durata della liquidazio-ne che deve svolgersi comunque in maniera ordinata e che potrebbe compor-tare addirittura la prosecuzione dell’attività sino alla revoca dell’autorizzazione, purché non si dia luogo a «nuove attività», quale misura di salvaguardia a tute-la dei concorrenti, del resto implicita al processo liquidatorio. e, sempre nel-l’ottica della salvaguardia della concorrenza, l’eventuale cessione della banca o di sue parti o attività a terzi deve realizzarsi attraverso una procedura aperta e a condizioni di mercato, anche al fine di massimizzare il prezzo. ove aiuti siano previsti a vantaggio dei terzi acquirenti, occorrerà un esame individuale secon-do le regole per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà38.
d) la quarta tipologia di intervento pubblico può consistere nella «acquisi-zione di attivi bancari deprezzati» (impaired assets), tipologia solo accennata nella comunicazione generale del 13 ottobre 200839 ma ampiamente sviluppa-ta nella comunicazione del 25 febbraio 2009�0.
fra le cause principali della crisi finanziaria vi è stata e vi è – com’è noto – l’incertezza sulla valutazione e sulla localizzazione dei cosiddetti «titoli tos-sici», incertezza che si è ben presto estesa anche ad attivi non originariamente tossici ma che – per effetto della spirale al ribasso innescatasi su tutti i mercati – hanno finito per subire perdite per così dire di trascinamento, anche al di là dei loro valori «reali»�1.
38 Si vedano i parr. �3-50 comunicazione del 13 ottobre 2008 (supra, nota 1).39 Si veda il par. �0, ove si precisa che l’acquisto o lo scambio di attivi da parte dello Stato
«dovrà avvenire con una svalutazione che rifletta i rischi sottostanti, senza indebite discrimina-zioni per quanto riguarda i venditori».
�0 Si veda supra, nota 3.�1 Per l’elencazione dei possibili attivi bancari e dei meccanismi di formazione delle relati-
ve perdite si veda comunicazione citata (supra, nota. 3), par. 15, nota 1. ovviamente, stabili-re quale sia il valore «reale» o «effettivo» o «fondamentale» di un cespite non è affatto agevole soprattutto in tempi di crisi generalizzata.
22_Fortunato.indd 352 17-05-2010 13:52:13
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 353
rientra innanzitutto nella responsabilità delle stesse banche valutare i rischi collegati agli attivi acquisiti e assicurarsi di poterli sopportare, assorbendone le eventuali perdite. e le banche hanno adottato misure significative, procedendo a importanti riduzioni di valore degli attivi detenuti, a riclassificarli (passan-do per esempio, per effetto di modifiche allo iAS 39, strumenti finanziari dalla categoria dei titoli di negoziazione a quella dei titoli disponibili per la vendita o detenuti sino alla scadenza) in modo da non dover evidenziare immediata-mente perdite per effetto di valutazioni al fair value comunque inattendibili in mercati illiquidi, a dotare il patrimonio netto di capitale supplementare costi-tuendo riserve ulteriori.
ma tutte queste misure si sono rivelate spesso insufficienti, compresa la rica-pitalizzazione mediante investimento pubblico, proprio a causa della segnala-ta «incertezza» valutativa degli attivi deprezzati e della loro effettiva allocazio-ne e consistenza. nella comunicazione si segnalano cifre che danno il senso della enorme gravità del problema. le svalutazioni di attivi bancari effettua-te da metà 2007 al febbraio 2009 ammontano a 1063 mld di dollari (737,6 per banche uSA e 293,7 per banche europee, comprese quelle svizzere). ma importanti istituzioni ed economisti hanno compiuto stime ben più elevate: il fmi parla di svalutazioni che dovrebbero attestarsi a circa il doppio di quel-le ufficialmente contabilizzate, e cioè a 2200 mld di dollari; nouriel roubini indica svalutazioni che si attesterebbero addirittura a oltre il triplo, a circa cioè 3600 mld di dollari�2.
l’incertezza valutativa e allocativa, che mina sia la stabilità finanziaria del-l’intero sistema sia la ripresa del finanziamento all’economia reale�3, costitui-sce dunque una questione autonoma, non risolvibile mediante aiuti di ricapi-talizzazione (che rischierebbero di ripetersi all’infinito, pregiudicando tanto la ristrutturazione del settore bancario nel suo complesso, quanto l’equilibrio già precario dei conti pubblici��). essa va direttamente eliminata attraverso inter-venti di «salvataggio» degli attivi deprezzati, ciò che può avvenire attraverso varie forme come l’acquisto, la concessione di garanzia sul relativo valore, lo scambio di attivi (titoli tossici contro titoli del debito pubblico).
nella misura in cui queste operazioni avvengono a un prezzo superiore al prezzo di mercato o – trattandosi di garanzia – a condizioni che non sarebbe-ro accettate sul mercato da un operatore privato indipendente, esse hanno per
�2 Si veda comunicazione citata par. 6, nota 2.�3 considerati obiettivi immediati della misura di salvataggio degli attivi deprezzati: così la
comunicazione citata parr. 5-7.�� considerati obiettivi di lungo termine, da conciliare con gli obiettivi immediati: si veda
comunicazione citata parr. 8-12.
22_Fortunato.indd 353 17-05-2010 13:52:14
diritto, etica e mercato dopo la crisi35�
effetto o di liberare la banca beneficiaria dalla necessità di registrare una per-dita o una riserva per copertura di perdite prevedibili o indennizzarla a poste-riori di dette perdite ovvero di liberare il patrimonio di vigilanza per ulteriori utilizzi e danno luogo, pertanto, ad «aiuti di Stato» da assoggettare ai prin-cipi generali di necessità, proporzionalità e minimizzazione delle distorsioni della concorrenza, insomma ai criteri già formulati nella comunicazione gene-rale del 13 ottobre e nella comunicazione sulla ricapitalizzazione del 5 dicem-bre 2008, con le specificità definite nella apposita comunicazione del 25 feb-braio 2009�5.
Ancora una volta la preoccupazione della commissione è quella di stabilire principi comuni e condizioni coordinate entro cui l’azione degli Stati membri non finisca per pregiudicare in maniera duratura il ripristino di una situazio-ne normale di mercato, favorendo di contro protezionismo finanziario e fram-mentazione del mercato interno. e ciò emerge nella definizione delle finali-tà degli interventi di salvataggio degli attivi deprezzati, i quali, se hanno come obiettivi immediati stabilità finanziaria e riattivazione dei flussi di finanzia-mento all’economia reale, devono comunque conciliarsi con obiettivi di più lunga durata, quali il ritorno alla normalità concorrenziale dell’intero settore bancario e la sostenibilità dei bilanci pubblici�6.
il salvataggio degli attivi deprezzati è misura paragonabile a quella di rica-pitalizzazione, ma allo stesso tempo più pericolosa. come la prima esso realiz-za un meccanismo di assorbimento delle perdite e di miglioramento dei fondi propri regolamentari; ma a differenza della ricapitalizzazione, il salvataggio degli attivi deprezzati aumenta il rischio per lo Stato che si puntualizza sui soli attivi deprezzati e non si distribuisce su tutti gli attivi e fondi della banca, eventualmente più redditizi�7.
una precondizione di ammissibilità di ogni regime di salvataggio degli atti-vi deprezzati, che influisce su tutti i criteri più volte indicati, è il rispetto del principio di trasparenza da parte dell’istante beneficiario. Questi ha l’onere di fornire una informazione completa, anteriore all’attivazione dell’ intervento pubblico, sulle svalutazioni di ciascun attivo interessato alla misura, sì da poter determinare l’ammontare dell’aiuto e delle perdite subìte dalla banca alla ces-sione degli attivi�8.
�5 comunicazione di cui supra, nota 3, parr. 16-18.�6 la commissione precisa che l’assenza di un coordinamento preventivo degli interven-
ti statali impone obbligazioni supplementari a posteriori nei controlli degli aiuti di Stato. Si vedano i parr. 13-1� comunicazione citata.
�7 Si veda par. 21, nota 1, comunicazione citata.�8 Per la descrizione dettagliata delle informazioni dovute si veda parte ii Allegato iii
della comunicazione citata.
22_Fortunato.indd 354 17-05-2010 13:52:16
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 355
l’onere di piena trasparenza, peraltro, sussiste non nei confronti del pub-blico, ma nei confronti della commissione europea, degli esperti indipenden-ti e delle autorità nazionali. il valore degli attivi oggetto della misura pubbli-ca, infatti, dev’essere certificato da esperti indipendenti, riconosciuto e validato dalla competente autorità nazionale di vigilanza. A questa informazione deve contestualmente accompagnarsi (ma potrebbe anche seguire dopo l’ammissio-ne al beneficio, in considerazione dei tempi più ampi necessari all’indagine) un esame completo delle attività (anche quelle non oggetto di intervento pubbli-co) e del bilancio della banca beneficiaria, teso a verificare la profittabilità del-l’intervento (examen de la viabilité) per la banca stessa. l’ esito dell’esame va comunicato alla commissione per la valutazione di eventuali necessarie misu-re di adeguamento�9.
il principio di non discriminazione comporta anche qui una differenziazio-ne applicativa della misura in base al profilo di rischio e alla profittabilità per ciascun beneficiario. Si ricorderà anche che tende qui ad affacciarsi la distin-zione non solo fra banche fondamentalmente sane e banche in difficoltà, ma anche fra banche sistemiche e banche non sistemiche, distinzione di dubbia utilità ma che può spingere lo Stato verso un ordine di priorità degli inter-venti. Quanto alla prima distinzione, l’esame adeguato degli attivi potrebbe portare alla rilevazione di perdite che implicano una situazione di insolven-za tecnica della banca, con la conseguenza che si dovrebbe procedere a qualche forma di gestione amministrativa o liquidatoria forzata della banca e salvo che per ragioni di stabilità finanziaria del sistema non si ritenga che sia opportuno rilevare gli attivi e proseguire l’attività per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o procedere a una liquidazione ordinata.
il principio di non discriminazione (o di oggettività) gioca il suo ruolo altresì nella individuazione degli attivi ammissibili all’aiuto. ovviamente i cosiddetti titoli tossici (tioli collegati ai mutui subprime americani, a fondi spe-culativi e a prodotti derivati) sono naturalmente «eleggibili», ma può essere necessario allargare il paniere anche ad altri titoli deprezzati a seguito della spi-rale ribassista e di cui la commissione fornisce un elenco per esigenze di coor-dinamento a livello comunitario50, giungendo persino a ritenere ammissibili anche titoli non corrispondenti ai criteri indicati e senza specifica giustificazio-ne, purché contenuti al massimo fra il 10 per cento e il 20 per cento del valore totale degli attivi bancari oggetto di intervento pubblico51.
�9 Si vedano i parr. 19-20 comunicazione citata.50 Si vedano i parr. 32 e 33 nonché Allegato iii comunicazione citata.51 così il par. 35 della comunicazione citata; ma si vedano anche i parr. �9-50.
22_Fortunato.indd 355 17-05-2010 13:52:17
diritto, etica e mercato dopo la crisi356
A ogni buon conto, anche in forza del principio di proporzionalità, il peso delle perdite deve ricadere prioritariamente sugli azionisti52 e, ove l’onere non sia misurabile ex ante, la banca dovrebbe impegnarsi alla copertura della per-dita o dei rischi anche in una fase successiva, mediante la stipula di clausole appropriate53. ma l’adeguata ripartizione dei costi fra azionisti creditori e Stato presuppone una «corretta valutazione» degli attivi precedentemente all’inter-vento pubblico, al fine di quantificare il «prezzo» di cessione degli attivi ogget-to di salvataggio e la corretta «remunerazione» dell’intervento, quale che sia la forma che questo possa assumere.
Quanto agli indicati profili, va precisato che: la metodologia generale di «valutazione» dev’essere stabilita a livello comunitario, per evitare distorsioni di concorrenza e arbitraggi fra imprese di differenti Stati; le difficoltà valutative potranno suggerire anche le forme di intervento, e così in luogo della cessione degli attivi deprezzati, quella degli attivi valutabili a una good bank dello Stato o addirittura la nazionalizzazione della banca interessata; il valore di riferimen-to degli attivi deprezzati dovrebbe essere costituito dal valore corrente di mer-cato, salvo che la situazione di crisi ne abbia determinato la poca significativi-tà o addirittura l’assenza; il «valore (o prezzo) di cessione» sarà inevitabilmente superiore al valore corrente di mercato, donde l’aiuto di Stato, ma dovrebbe comunque riflettere il sottostante «valore economico reale», sulla base dei flus-si di cassa e secondo un orizzonte temporale di medio/lungo termine; ove sia necessario allontanarsi dal valore economico reale, dovranno seguire una pro-fonda ristrutturazione del beneficiario e clausole di recupero; il prezzo dovrà inglobare una adeguata remunerazione dello Stato; la commissione si avvarrà di comitati di esperti nel processo valutativo5�.
la forma di intervento più appropriata rientra nella competenza dei singoli Stati membri, ma quale che sia tale forma (cessione diretta degli attivi deprez-zati a una bad bank dello Stato nel rispetto di una rigorosa separazione patri-moniale, funzionale e organizzativa, con riduzione al minimo di possibili con-flitti di interesse; regime di assicurazione o di garanzia statale; regime misto) la ripartizione dei costi dell’intervento deve sortire i medesimi risultati (princi-pio di equivalenza)55.
52 Quanto agli obbligazionisti può essere considerato adeguato un certo grado di protezio-ne, al fine di preservare stabilità finanziaria e fiducia nel sistema.
53 Si veda par. 2� comunicazione citata.5� Si vedano i parr. 37-�3 e Allegato iv comunicazione citata.55 Si vedano i par. ��-�6 e Allegato ii comunicazione citata. l’Allegato ii contiene una
interessante sintesi delle esperienze già in passato maturate nei regimi di gestione degli atti-vi deprezzati o anomali, secondo il sistema della bad bank o il sistema di assicurazione, negli uSA, in Svezia, francia, italia, Germania, Svizzera e repubblica ceca.
22_Fortunato.indd 356 17-05-2010 13:52:19
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 357
come ogni misura di crisi, anche il salvataggio degli attivi deprezza-ti è caratterizzato dalla temporaneità, non solo perché, secondo quando pre-visto dalla comunicazione generale per le banche, la durata del regime di tale intervento è fissato a due anni massimo, con il solito meccanismo di revisione semestrale, ma anche perché la commissione precisa che il regime specifico di questo aiuto deve prevedere un termine di sei mesi dal momento in cui è reso applicabile nello Stato membro entro cui le banche potranno avanzare doman-da di ammissione e individuare gli attivi eleggibili (con possibilità di ricondu-zione successiva per gli attivi la cui scadenza va oltre i sei mesi). e ciò al fine di evitare comportamenti opportunistici delle banche, che non evidenzino imme-diatamente ogni informazione necessaria con la speranza di avanzare la istan-za in un momento successivo quando la situazione peggiori ulteriormente56. la partecipazione a tale aiuto potrebbe addirittura essere resa obbligatoria dallo Stato membro, proprio al fine di risolvere alla radice la crisi di fiducia indot-ta dalla permanente situazione di incertezza più volte segnalata; e comunque, anche se facoltativa, dovrebbe essere accompagnata da adeguati incentivi57.
Anche per gli aiuti collegati al salvataggio degli attivi deprezzati, dovran-no attivarsi misure di salvaguardia (utilizzo degli aiuti per riattivare il finanzia-mento all’economia reale e non per finanziare politiche aggressive di crescita a danno dei concorrenti; politiche restrittive nella distribuzione dei dividen-di e nella retribuzione dei manager58) e misure di adeguamento della banca interessata e/o dell’intero settore, al fine di acquisire una redditività durevole che consenta di proseguire l’attività senza ulteriori aiuti di Stato (un piano di ristrutturazione la cui ampiezza è collegata a molteplici fattori rilevabili altre-sì dalla relazione sull’esame di profittabilità che la banca deve presentare in sede di domanda di ammissione; una ristrutturazione profonda è normalmen-te richiesta in presenza di attivi deprezzati che conducano a un patrimonio netto negativo o a una situazione di insolvenza tecnica oppure in presenza di aiuti ricorrenti o aiuti già utilizzati per coprire perdite o evitarle o in misura nel complesso superiore al 2 per cento del totale degli attivi della banca ponde-
56 Si veda par. 26 comunicazione citata. una partecipazione al regime di aiuto oltre il semestre potrebbe ammettersi solo nella eventualità di circostanze eccezionali e imprevedibili, non dipendenti da responsabilità della banca istante, e a condizioni più restrittive quanto – per esempio – al costo e alle misure di compensazione da sopportare (par. 29).
57 Si vedano i parr. 27-28 comunicazione citata.58 Si vedano i parr. 30-31 comunicazione citata; ma anche i parr. 57-59 ove si precisa-
no anche, quali misure compensative a tutela dei concorrenti: la riduzione dimensionale della banca o di sue filiali redditizie o la loro cessione; la sottoscrizione di impegni comportamentali in merito alla limitazione delle attività.
22_Fortunato.indd 357 17-05-2010 13:52:20
diritto, etica e mercato dopo la crisi358
rati in funzione del relativo rischio e in presenza di violazioni degli obblighi di informativa preliminare)59.
7. Qualche cenno è opportuno compiere anche sul «quadro temporaneo» degli aiuti di Stato programmabili per favorire il rifinanziamento dell’economia reale, posto che i relativi interventi incidono altresì sul mercato del credito. la crisi degli intermediari finanziari ha, infatti, rapidamente contagiato i settori dell’economia reale per la restrizione del credito (credit crunch) che ne è conse-guita, anche nei confronti di imprese fondamentalmente sane. la necessità di rompere il circolo vizioso ha imposto interventi pubblici nei singoli Stati mem-bri al di là delle iniziative di politica generale e delle misure ordinarie di aiuto. di qui l’esigenza della commissione europea di dettare un quadro di riferi-mento per coordinare le iniziative dei singoli Stati e nel contempo ricondur-le al rispetto dei principi fondamentali del trattato comunitario, evitando la frammentazione del mercato interno e il protezionismo.
la comunicazione del 17 dicembre 200860, che fa seguito al «Piano euro-peo per il rilancio economico»61, ricorda innanzitutto la possibilità di adozio-ne delle misure di politica generale che non ricadono nella nozione di aiuto di Stato (come le proroghe per il pagamento di oneri previdenziali e assistenziali e anche di imposte; o le misure per i dipendenti; o i sostegni diretti a favore dei consumatori: rottamazione ecc.); nonché la possibilità di utilizzo di aiuti nel quadro degli strumenti ordinari esistenti e secondo la cosiddetta strategia di lisbona (sostegni pubblici a iniziative di sviluppo sostenibile a medio e lungo termine nei campi della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione, investimen-ti soprattutto per le Pmi e per le imprese in fase di avvio, formazione, svilup-po regionale e protezione dell’ambiente; cui si aggiungono il cosiddetto rego-lamento de minimis e il regolamento generale di esenzione per categoria)62.
ma accanto a queste misure e in forza dell’art. 87, par. 3, lett. b) trattato ce, la commissione consente misure supplementari e temporanee, applicabi-li solo sotto forma di «regime», e non in forma individuale, in via di principio alle imprese sane – non in difficoltà – al 1° luglio 2008 e con durata limitata al 31 dicembre 2010 (principio di temporaneità) nel perseguimento di due obietti-vi fondamentali: sbloccare la concessione di prestiti alle imprese, consentendo
59 Si vedano i parr. 51-56 comunicazione citata.60 Si veda supra, nota �, nonché la successiva comunicazione del 25 febbraio 2009, citata
alla nota 5, contenente alcune modifiche alla precedente.61 Si veda il documento della comunicazione della commissione al consiglio europeo
com (2008) 800 del 26 novembre 2008.62 Si vedano le Sezioni 2 e 3 della comunicazione citata supra, nota �.
22_Fortunato.indd 358 17-05-2010 13:52:21
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 359
a queste di continuare ad avere accesso ai finanziamenti; stimolare le imprese a proseguire in una politica di investimenti per una crescita durevole e sostenibi-le dell’economia, soprattutto con riguardo al settore energetico e dei «prodotti verdi»63. Gli aiuti specifici a ciò finalizzati si riassumono nei seguenti6�:
• concessione di sussidi (in denaro o altro), al di là dei limiti già previsti dal regolamento de minimis, per un importo complessivo in un trien-nio di € 500.000 al lordo di imposte e ogni altro onere, ivi compresi altri aiuti fruiti dal 1° gennaio 2008 ed esclusi i settori della pesca e del-l’agricoltura;
• concessione di garanzia statale ai prestiti (sino all’importo del 90 per cento) sia per investimenti che per capitale di esercizio con riduzione del premio da pagare65;
• concessione di prestiti di qualsiasi durata e di ogni tipo a tassi agevola-ti, purché si tratti di contratti conclusi entro il 31 dicembre 2010 e per il pagamento di interessi anteriori al 31 dicembre 2012;
• concessione di prestiti agevolati per la produzione di cosiddetti «prodot-ti verdi», che comporti l’applicazione anticipata delle norme comunita-rie a tutela dell’ambiente o che vada al di là delle limitazioni imposte da tali norme;
• deroga temporanea alle linee guida sugli investimenti in capitale di rischio delle Pmi, la cui soglia massima è innalzata per un periodo di dodici mesi da 1,5 mln di euro a 2,5 mln di euro e il cui livello di par-tecipazione degli investitori privati e ridotto dal 50 per cento al 30 per cento;
• semplificazione dei criteri previsti dalla comunicazione sull’assicurazio-ne dei crediti all’esportazione66, al fine di consentire temporaneamen-te la copertura assicurativa dello Stato dei rischi non cedibili in quanto normalmente assicurabili sul mercato.
8. Se il quadro di riferimento comunitario evidenzia lo sforzo della commis-sione europea di predisporre linee di indirizzo per le misure di crisi che con-sentano, a crisi superata, il ripristino delle dinamiche di mercato e di concor-renza secondo i principi tradizionali dell’unione, qual è stata la risposta degli
63 Si veda la Sezione �.1, comunicazione citata.6� Per i dettagli si veda la comunicazione citata, Sezioni �.2-�.7 e 5.1.65 le modifiche apportate alla comunicazione citata da quella successiva del 25 febbraio
2009 riguardano soprattutto il metodo di calcolo del premio sulla garanzia.66 la si veda in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 17 settembre 1997, c 281/�.
22_Fortunato.indd 359 17-05-2010 13:52:23
diritto, etica e mercato dopo la crisi360
Stati membri e in particolare quali gli interventi messi in atto dallo Stato ita-liano?
va sottolineato che gli interventi degli Stati europei hanno seguito inizial-mente linee di indirizzo divergenti dal piano predisposto e messo in atto dagli Stati uniti, Paese da cui ha avuto origine la crisi. Gli uSA, infatti, hanno pun-tato subito, dopo i primi interventi individuali di salvataggio e prestazioni di garanzia, a un piano di salvataggio dei titoli tossici, suscitando grandi pole-miche e contrasti per una misura che poteva e può tradursi nell’assoluzione degli intermediari finanziari con costi esclusivamente a carico dei contribuenti. A fine 2008 il congresso americano ha approvato l’Emergency Economic Sta-bilization �ct, che autorizza il Segretario del tesoro ad adottare il �roubled �sset Relief Program (tArP) e cioè ad acquistare o impegnarsi ad acquista-re titoli problematici (sia quelli collegati ai mutui immobiliari sia quelli che il segretario del tesoro nella sua discrezionalità dovesse ritenere necessari), emes-si prima del 1� marzo 2008, utilizzando un fondo di ben 700 miliardi di dol-lari67. il provvedimento, concepito inizialmente come strumento a disposizione dell’esecutivo per interventi sostanzialmente insindacabili, ha subìto in sede di approvazione congressuale una serie di temperamenti e correttivi che mirano a incentivare anche i privati al piano di salvataggio, a ricondurre gli acquisti a meccanismi di mercato e a sottoporre l’operato del Segretario di Stato a nume-rosi controlli oltre che al sindacato giurisdizionale68.
Quanto agli Stati dell’unione europea, da ottobre 2008 a fine marzo 2009 la commissione ha autorizzato, sulla base delle nuove linee guida per il settore creditizio in forza dell’art. 87, par. 3, lett. b) trattato ce, 23 regimi generali di aiuto e 10 interventi ad hoc in favore di singole istituzioni finanziarie. in parti-colare, i regimi generali hanno riguardato 12 misure di garanzie, 5 di ricapita-lizzazione, 1 misura istitutiva di un fondo per il salvataggio di attivi e 5 regimi misti, per un ammontare complessivo – inclusi gli interventi ad hoc – di circa 3.000 miliardi di euro (di cui comunque 2.300 relativi a regimi di garanzia, e quindi rappresentativi del rischio massimo assunto dagli Stati ma non anco-ra di effettivi esborsi) pari al 2� per cento del Pil europeo69. in merito, poi, al «Quadro di riferimento temporaneo» per gli aiuti di Stato diretti a riattivare i
67 Per l’analisi dell’intervento vedi napolitano, Giulio (2008), «il nuovo Stato salvatore: strumenti di intervento e assetti istituzionali», in Giornale di diritto amministrativo, pp. 1083 e ss.
68 Ibidem, p. 1089 e s., in cui si individuano cinque livelli di controlli legali e politici.69 Per ulteriori dettagli si rinvia al rapporto della commissione State �id Scoreboard (supra,
nota 13), pp. 1� e ss. si veda anche la relazione del funzionario della direzione Generale sulla concorrenza della commissione ungerer, Herbert, «State Aids 2008/2009: 12 months of cri-Herbert, «State Aids 2008/2009: 12 months of cri-sis management and reforms», cit., pp. 3 e ss., pp. 3 e ss.
22_Fortunato.indd 360 17-05-2010 13:52:25
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 361
flussi finanziari verso i settori dell’economia reale, i regimi autorizzati sono 2�, di cui 8 relativi ai sussidi sino a € 500 mila, � per prestiti a interessi agevolati, 3 per investimenti in capitale di rischio, 3 per la produzione di prodotti verdi e 6 per misure di garanzia70.
deve peraltro osservarsi che recentemente si è aperta una nuova fase, che vede accentuarsi gli interventi diretti al salvataggio di attivi anomali (anche mediante costituzione di appositi veicoli, le cosiddette bad bank), riavvicinan-do così le politiche di soccorso degli Stati europei a quelle degli Stati uniti71.
9. Anche il Governo italiano si è mosso, ovviamente, con alcune misure ricon-ducibili al quadro comunitario degli aiuti di Stato, nell’intento soprattutto di contrastare la sfiducia del pubblico nel sistema bancario e finanziario e solo parzialmente a sostegno dell’economia reale.
Secondo la classificazione suggerita da Giulio napolitano (ripercorrendo l’approccio pragmatico di mario nigro sui «moduli organizzativi di pubbli-cizzazione» del credito risalente a un’opera di quarant’anni fa72), si potrebbero inquadrare quelle misure in quattro categorie:
70 Si veda State �id Scoreboard (supra, nota 13), pp. 21 e ss., ove anche riferimenti specifici agli aiuti per i settori automobilistico e del trasporto aereo.
71 Si veda ungerer, Herbert, «State Aids 2008/2009: 12 months of crisis management and reforms», cit., p. 3 e s.: «the union is now entering a new phase of restructuring and cri-sis management in the banking sector, as the flurry of State aid decisions recently taken has shown. the cleaning up of the balance sheets and required restructuring will be the domi-nant topic over the next weeks and months». Anche mario draghi, nel suo Intervento del 17 marzo 2009 alla camera dei deputati, vi commissione, nel corso della Indagine conoscitiva sulle tematiche relative al sistema bancario e finanziario, ha osservato: «Gli interventi hanno evi-tato un collasso del sistema, ma non hanno ancora portato chiarezza sui bilanci di quelle ban-che che più hanno investito in titoli “tossici”: permane l’incertezza sull’entità e la distribuzione delle perdite nei bilanci di quelle che erano le più grandi banche mondiali. inoltre è prevedibile che la recessione deteriorerà gli attivi bancari».
72 nigro, mario (1969), Profili pubblicistici del credito, milano, Giuffrè. l’approccio prag-matico di mario nigro si contrapponeva ai tentativi di razionalizzazione sistematica proposti in particolare da massimo Severo Giannini secondo le formule del credito come «servizio pub-blico» (Giannini, massimo Severo (1939), «osservazioni sulla disciplina della funzione credi-tizia», in Scritti giuridici in onore di S. Romano, Padova, cedam, oggi in Id. (2002), Scritti, ii, milano, Giuffrè, pp. 1 e ss.) e, più tardi, come «ordinamento sezionale» (Giannini, massimo Severo (19�9), «istituti di credito e servizi d’interesse pubblico», in moneta e credito, pp. 111 e ss. (oggi in Id. (2003), Scritti, iii, milano, Giuffrè, pp. 57 e ss.; Giannini, massimo Severo (1991), «Gli ordinamenti sezionali rivisitati», in Amorosino, Sandro (a cura di), �a ristruttu-razione delle banche pubbliche, milano, Giuffrè, oggi in Id. (2006), Scritti, iX, milano, Giuf-frè, pp. 127 e ss.).
22_Fortunato.indd 361 17-05-2010 13:52:27
diritto, etica e mercato dopo la crisi362
(A) le misure riconducibili al modulo di pubblicizzazione finanziaria, mediante il quale lo Stato mira a garantire l’esposizione debitoria delle banche per incrementarne la liquidità;
(B) quelle relative al modulo di pubblicizzazione proprietaria, con cui lo Stato sostiene il processo di ricapitalizzazione e, più in generale, di ripatrimonializzazione del sistema bancario, considerando la portata strategica del settore;
(c) quelle relative al modulo di pubblicizzazione funzionale, diretto a riat-tivare i flussi finanziari verso l’economia reale e indirettamente a inci-dere sulla «governance» delle istituzioni finanziarie;
(d) le misure relative al modulo di pubblicizzazione regolamentare, inteso a ridisegnare le regole del sistema finanziario per garantirne la stabilità e prevenire crisi future, soprattutto mediante il rafforzamento dei siste-mi di vigilanza anche a livello globale73.
mentre le ultime misure hanno dichiaratamente carattere strutturale, ma sono al contempo le più difficili da definire e soprattutto da implementare, le prime tre misure hanno carattere dichiaratamente congiunturale (temporaneo ed eccezionale), poiché strumentali al superamento della grave crisi sistemica attraversata dall’economia nazionale e in verità dall’intera economia mondiale.
resta ovviamente la preoccupazione di un forte condizionamento dei mec-canismi di mercato, difficile da riassorbire in tempi ragionevolmente brevi alla cessazione dello stato di crisi.
(A) Alle misure di pubblicizzazione finanziaria sono ascrivibili le garanzie sta-tali sui depositi bancari al dettaglio, nonché le garanzie statali sulle passività le operazioni temporanee di scambio di titoli, per agevolare l’accesso delle ban-che italiane a una adeguata provvista di liquidità.
la garanzia sui depositi bancari al dettaglio, che il ministero dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato a fornire per 36 mesi (dall’entrata in vigo-re del d.l. 9 ottobre 2008, n. 155 – convertito nella legge n. 190/2008 – che l’ha introdotta), si affianca ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti con i contributi degli stessi intermediari su basi privatistiche (si vedano gli artt. 96 e 96-bis tuf) e ha carattere integrativo e aggiuntivo della garanzia interban-caria, nel senso che dovrà prima attivarsi la garanzia privata e quindi suben-trerà quella statale, ove il fondo risulti insufficiente (art. �, comma 1, d.l. n.
73 napolitano, Giulio (2009), «l’intervento dello Stato nel sistema bancario e i nuovi profi-li pubblicistici del credito», in Giornale di diritto amministrativo, n. �, pp. �79 e ss.
22_Fortunato.indd 362 17-05-2010 13:52:28
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 363
155/2008)7�. Si tratta, comunque, di una misura destinata ad agire più sul piano psicologico, della ripresa di fiducia dei risparmiatori nel sistema ban-cario, e per questa via a difenderne la liquidità evitando la corsa al ritiro dei depositi.
la concessione di garanzia del ministero dell’economia e delle finanze sulle passività delle banche italiane, purché risultanti da operazioni di finanziamento poste in essere successivamente al 13 ottobre 2008 e aventi durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni, persegue più direttamente la finalità di sostenere la liquidità delle banche cercando di riattivare il mercato dei prestiti interbancari; nel contempo se ne ribadisce la temporaneità, poiché il regime è attivabile sino al 31 dicembre 2009 (art. 1-bis, comma 1, d.l. citato, come modificato in sede di conversione75).
nella stessa linea si muovono le operazioni di scambio temporaneo di titoli di Stato con strumenti finanziari detenuti da banche italiane o passività delle banche italiane controparti (art. 1-bis, comma 2, d.l. citato), operazioni che consentono alle banche che ne fossero temporaneamente sfornite di disporre di strumenti finanziari inclusi nelle categorie ammesse o accettate come garanzia nelle ope-razioni di prestito presso l’eurosistema ovvero sul mercato interbancario.
la garanzia statale, inoltre, può estendersi anche a favore di altri soggetti che mettano a disposizione di banche italiane titoli stanziabili per operazioni di rifi-nanziamento presso l’eurosistema (art. 1-bis, comma 3, d.l. citato), al fine di agevolare il trasferimento di detti titoli fra diversi comparti dell’attività finan-ziaria, a vantaggio del settore bancario.
Queste tre ultime tipologie di intervento sono complementari alle misu-re di ricapitalizzazione (di cui si dirà fra poco) (art. 1-bis, comma 6) e devo-
7� la garanzia del fondo interbancario ha origini comunitarie. la regolamentazione comu-nitaria prevedeva una soglia minima di € 20.000 a depositante, che è stata elevata a € 100.000 a seguito della crisi (passando per una fase intermedia in cui il tetto è stato elevato a € 50.000). l’italia prevede una soglia superiore, che giunge agli € 103.291,38 per depositante. la versione originaria del d.l. n. 155/2008 limitava la garanzia ai soli depositanti di banche italiane (aventi cioè sede legale in italia). in sede di conversione la limitazione è stata eliminata, evidentemente nel rispetto del principio comunitario di non discriminazione e al fine di ricomprendervi anche i depositanti di filiali e succursali italiane di banche estere: si veda il Dossier n. 80 di novem-bre 2008 del Servizio Studi del Senato sul disegno di legge A.S. n. 1230 per la conversione in legge del d.l. n. 155/2008 (pp. 39 e ss.), ove anche una ricostruzione dei sistemi di garanzia dei depositi vigenti in italia e una sintesi di quelli dei principali paesi esteri, nonché i recenti svi-luppi in sede comunitaria.
75 la norma in oggetto (art. 1-bis) è stata inserita nel testo del d.l. n. 155/2008 durante la conversione nella legge n. 190/2008, ma proviene dal d.l. del 13 ottobre 2008, n. 157 che è stato contestualmente abrogato ma in concreto trasfuso nel detto provvedimento, facendo salvi gli atti già posti in essere.
22_Fortunato.indd 363 17-05-2010 13:52:29
diritto, etica e mercato dopo la crisi36�
no comunque realizzarsi in maniera onerosa per i beneficiari nel rispetto di «condizioni di mercato», previa valutazione tecnica della Banca d’italia, inte-sa sostanzialmente a verificare che l’operazione si risolva in un approvvigio-namento di liquidità in un contesto di adeguatezza patrimoniale della banca beneficiaria e di capacità di questa di far fronte alle obbligazioni assunte (art. 1-bis, comma 5). inoltre i crediti del ministero dell’economia e delle finanze derivanti da tali operazioni sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili e immobili, che prevale su ogni altro privilegio (art. 1-bis, comma �).
il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 27 novembre 2008, che detta i criteri, le modalità e le condizioni delle dette operazioni76, completa il quadro di conformità delle misure ai principi sanciti in sede comu-nitaria, stabilendo (art. 1):
• nel rispetto del principio di proporzionalità che «l’entità delle operazioni poste in essere è limitata a quanto strettamente necessario per porre rime-dio alla attuale grave turbativa dell’economia», prevedendo un monito-raggio semestrale i cui esiti vanno comunicati alla commissione euro-pea, né l’ammontare massimo delle operazioni per «singola banca» può eccedere il patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;
• nel rispetto del principio di salvaguardia della concorrenza che le ban-che beneficiarie «devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per il tra-mite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivol-te al pubblico», pena l’esclusione dall’ammissione a successive operazio-ni di sostegno, e che «l’espansione delle attività di bilancio delle banche beneficiarie» a livello di «crescita aggregata» non debba superare deter-minati limiti.
76 lo si veda in Gazzetta Ufficiale, 9 dicembre 2008, n. 287. il d.m. tiene conto in modo più consapevole dei principi sanciti dalla comunicazione ce del 13 ottobre 2008, e in parti-colare dei principi di proporzionalità, non discriminazione, temporaneità, nonché delle misure di salvaguardia e di adeguamento dirette a limitare abusi a danno di imprese concorrenti e ad avviare processi di ristrutturazione duratura. vengono altresì seguite le raccomandazioni della Banca centrale europea del 20 ottobre 2008 sui termini economici della garanzia rilasciata dallo Stato. le caratteristiche delle passività (strumenti finanziari di debito) delle banche ita-liane ammissibili alla garanzia statale e il relativo procedimento sono fissati agli artt. 2 e 7 del d.m.; gli artt. 3 e 8 specificano le caratteristiche delle operazioni di scambio di titoli e il relati-vo procedimento di ammissione; mentre gli artt. � e 7 trovano applicazione alle garanzie dello Stato a favore di terzi che forniscano titoli utilizzabili a fini di rifinanziamento con l’eurosiste-ma. le caratteristiche della garanzia statale e le condizioni economiche sono sancite dagli artt. 5 e 6; e l’obbligo di presentare un «piano di ristrutturazione» da parte della banca che attiva la garanzia statale è disciplinato dall’art. 9.
22_Fortunato.indd 364 17-05-2010 13:52:31
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 365
(B) il modulo della pubblicizzazione proprietaria si è espresso con la previ-sione che legittima il ministero dell’economia e delle finanze a sottoscrive-re (o a garantire la sottoscrizione di) aumenti di capitale di banche italiane e di società capogruppo di gruppi bancari italiani per le quali la Banca d’italia abbia accertato una situazione di inadeguatezza patrimoniale. la partecipazio-ne dello Stato assume la forma di azioni senza diritto di voto privilegiate nella distribuzione dei dividendi (sino alla data di eventuale cessione a terzi), con il duplice intento da un canto di non spingere la pubblicizzazione sino al punto di incidere sull’autonomia gestionale dell’impresa bancaria e d’altro canto di offrire allo Stato un’adeguata remunerazione per ripagare i contribuenti del sacrificio sofferto77.
l’intervento pubblico deve essere, comunque, accompagnato da un piano di risanamento («programma di stabilizzazione e rafforzamento») della durata minima di trentasei mesi, valutato anch’esso dalla Banca d’italia e suscettibi-le di modifiche in corso d’opera, ma pur sempre – per le variazioni sostanziali – previa autorizzazione del ministero e sentito il parere dell’Autorità di vigilan-za (art. 1 d.l. n. 155/2008). la Banca d’italia valuta inoltre che le politiche dei dividendi, approvate dall’assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento, siano coerenti con il programma stesso.
come richiesto dagli orientamenti comunitari, la valutazione delle condi-zioni per l’intervento del ministero è dunque effettuata dalla Banca d’italia, quale organo tecnico che accerta l’inadeguatezza patrimoniale della banca rica-pitalizzanda e verifica l’adeguatezza del programma di stabilizzazione e di raf-forzamento e le politiche distributive dei dividendi. non si tratta di un inter-vento ablativo, poiché presuppone l’istanza della banca interessata.
diversamente è a dirsi per le banche nei cui riguardi fossero adottate le «procedure di cui al titolo iv del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385» (testo unico bancario), poiché la competenza a deliberare aumenti di capitale cui partecipi il tesoro è qui spostata a favore dei commissari straordinari (pre-via autorizzazione della Banca d’italia) e sottratta agli organi decisionali della banca (in particolare all’assemblea) (art. 2 d.l. n. 155/2009)78.
77 in sede di conversione è stato precisato che le azioni sottoscritte dallo Stato non vengono computate nel limite complessivo della metà del capitale sociale, proprio a tutte le azioni senza diritto di voto o con voto limitato a particolari argomenti o con voto subordinato al verificar-si di particolari condizioni non meramente potestative (art. 2351 c.c., comma 2), e che sono riscattabili dall’emittente, purché la Banca d’italia attesti che l’operazione non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilità della banca né del gruppo bancario di appartenenza.
78 la norma, anzi, allarga le ipotesi che possono legittimare l’Autorità ad adottare tutti i provvedimenti previsti dal titolo iv del testo unico Bancario (tuB), e dunque sia quel-
22_Fortunato.indd 365 17-05-2010 13:52:32
diritto, etica e mercato dopo la crisi366
ove si tratti di banche cooperative, le azioni acquisite dal ministero pos-sono superare i limiti partecipativi previsti in via ordinaria79. È infine escluso l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto in caso di superamento della soglia partecipativa del 30 per cento, anche per acquisiti «di concerto» (in deroga agli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, tuf)80.
(c) il modulo di pubblicizzazione funzionale trova espressione nei cosiddet-ti «tremonti bond», obbligazioni emesse da banche italiane e da società capo-gruppo di gruppi bancari italiani e sottoscritte dal tesoro, con la finalità di rafforzare il patrimonio di vigilanza della banca beneficiaria, che deve essere «fondamentalmente sana», e per questa via riattivare i flussi finanziari necessa-ri ad alimentare l’erogazione del credito verso l’economia reale (art. 12 d.l. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2). «non si tratta in questo caso di operazioni di salvataggio, ma di una misura per raf-
lo di amministrazione straordinaria sia quello di gestione provvisoria che di liquidazione coat-ta. viene in particolare aggiunta l’ipotesi di ricorso alle procedure in oggetto in una situazione di grave crisi, anche di liquidità, della banca o della società capogruppo di un gruppo banca-rio, avente rilevanza sistemica, e che quindi possa recare pregiudizio alla stabilità complessiva del sistema finanziario. «la fattispecie – osserva la relazione che accompagna il disegno della legge di conversione – ha dunque una connotazione di maggiore flessibilità rispetto a quelle già esistenti, riferendosi a una situazione di «grave crisi» e prescindendo dalla necessità di perdite, essendo sufficiente una crisi di liquidità; l’ampliamento è giustificato dal requisito aggiuntivo del possibile impatto sistemico della crisi».
79 il testo originario del d.l. n. 157/2008 prevedeva anche che fossero derogate le disposi-zioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto e la relazione accompagnatoria specifi-cava che la deroga riguardava «in particolare la regola per cui ogni socio ha un solo voto a pre-scindere dal numero di azioni possedute», al fine di «garantire l’esercizio di poteri commisurati alla partecipazione acquisita». l’abrogazione di tale parte mi sembra discendere dalla contrad-dizione con quanto previsto per tutte le altre banche.Quanto ai limiti partecipativi nelle ban-che cooperative, si ricorderà che in via ordinaria, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, tuB, la partecipazione al capitale sociale delle banche popolari, da parte di ciascun socio, non può superare lo 0,5 per cento del capitale stesso, mentre, ai sensi dell’articolo 3�, comma �, del medesimo tuB, nessun socio di una banca di credito cooperativo può possedere azioni il cui valore nominale superi i 50.000 euro. il comma 5 dell’art. 1 d.l. n. 155/2009 stabilisce inoltre che la qualità di socio di una banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni da parte dal ministero, in tal modo derogando alle previsioni in materia di cui all’articolo 30, commi 5 e 6, tuB, i quali prevedono che l’ammissione a socio sia subordinata al gradimento da parte del consiglio di amministrazione della banca.
80 Peraltro il d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), contenente le «misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», ha modificato gli artt. 10�, 10�-bis e 10�-ter del tuf al fine di rafforzare le difese delle società italiane quotate in caso di lancio di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio (si veda art. 13).
22_Fortunato.indd 366 17-05-2010 13:52:34
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 367
forzare il sistema e per evitare che, in un contesto macroeconomico fortemen-te deteriorato, si avvii una spirale perversa tra emergere di sofferenze e restri-zione del credito»81.
e proprio per questo si tratta di un intervento temporaneo, attuabile sino al 31 dicembre del 2009 nel rispetto degli orientamenti comunitari, e dunque a condizione che:
• sussista una specifica richiesta dell’emittente, che può essere solo una banca italiana o una società capogruppo di gruppi bancari italiani, le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati;
• l’operazione risulti «economica nel suo complesso» per il ministero e «tenga conto» delle condizioni di mercato, anche se la remunerazione degli strumenti finanziari così emessi può essere collegata (in tutto o in parte) agli utili distribuibili ex art. 2�33 c.c. (donde il vincolo conforme per l’assemblea che decide sulla destinazione degli utili);
• l’operazione persegua le finalità di «assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all’economia e un adeguato livello di patrimonializzazio-ne del sistema bancario»;
• gli strumenti finanziari da emettere siano privi dei diritti di voto e comunque del diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o un sinda-co ex art. 2351 c.c. (ultimo commma);
• il carattere temporaneo dell’intervento può essere rafforzato dalla pre-visione (statutaria) a favore dell’emittente della facoltà di rimborso o riscatto, purché la Banca d’italia attesti che l’operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca né del gruppo ban-cario di appartenenza;
• gli strumenti finanziari siano comunque computabili nel patrimonio di vigilanza (core �ier 1) e abbiano allora lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie; al fine di rafforzare questo profilo di patrimonia-lizzazione, se ne può prevedere la convertibilità in azioni ordinarie, su richiesta dell’emittente (l’esercizio della facoltà di conversione è ovvia-mente sospensivamente condizionato alla delibera di aumento del capi-tale);
• la sottoscrizione da parte del ministero è subordinata alla «valutazione da parte della Banca d’italia delle condizioni economiche dell’opera-zione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza»;
81 così mario draghi nel suo Intervento del 17 marzo 2009 alla camera dei deputati (supra, nota 71).
22_Fortunato.indd 367 17-05-2010 13:52:35
diritto, etica e mercato dopo la crisi368
• venga sottoscritto un «protocollo d’intenti» fra la banca interessata e il ministero che impegni la prima al rispetto del livello e delle condizio-ni di credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, di adeguati livelli di liquidità a favore dei creditori delle pubbliche ammi-nistrazioni per fornitura di servizi e di beni, di politiche di dividendi coerenti con l’esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializza-zione;
• sul piano della governance della banca beneficiaria, l’emittente adotti un «codice etico» che fra l’altro contenga previsioni in materia di remune-razione dei vertici aziendali (limiti alle stock options e quant’altro).
i criteri, le modalità e condizioni di sottoscrizione degli strumenti finanziari sono ulteriormente definiti in un d.m. del 25 febbraio 2009 (in Gazzetta Uffi-ciale, 7 marzo 2009, n. 55), il quale fa più puntuale applicazione delle linee guida comunitarie e dei criteri di determinazione del costo dell’operazione per il beneficiario raccomandati dalla Banca centrale europea. in particola-re è disposto che «le banche che ricorrono agli interventi previsti dal (presente) decreto devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del soste-gno ricevuto senza intraprendere politiche di espansione aggressive incompati-bili con gli obiettivi di cui all’art. 12, comma 1, del d.l. n. 185, e conseguirne indebiti vantaggi» (art. 1, comma 3) e che «la Banca d’italia monitora l’espan-sione delle attività di bilancio delle banche interessate» (art. �, comma 1)82.
la legge prevede, altresì, a tutela della finalità di riattivazione delle linee di credito verso l’economia reale, un monitoraggio sulle operazioni e sui loro effetti sull’economia. A tal fine istituisce speciali osservatori presso le prefettu-re, con la partecipazione dei soggetti interessati. la Banca d’italia, a sua volta, fornisce al ministero dell’economia dati e analisi sull’andamento del credito e sui suoi costi, su base regionale, a ulteriore integrazione e completamento delle ampie informazioni disaggregate a livello territoriale già diffuse nelle proprie pubblicazioni.
«È essenziale – ha osservato il governatore della Banca d’italia83 – che l’ana-lisi delle condizioni del credito a livello locale non sconfini in un ruolo di pres-sione sulle banche che spinga ad allentare il rispetto di criteri di sana e pruden-
82 il d.m. prevede anche che il «protocollo di intenti», a sottoscriversi fra banca interessa-ta e ministero, venga definito sulla base di un accordo quadro tra il ministero e l’Associazione Bancaria italiana e abbia a oggetto la disponibilità complessiva di credito da concedere a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese, definita tenendo conto delle esigenze di svilup-po dell’economia, della domanda di credito attesa e della necessità di assicurare una prudente allocazione del credito. l’accordo quadro è stato regolarmente stipulato.
83 Si veda sempre supra, nota 71.
22_Fortunato.indd 368 17-05-2010 13:52:36
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 369
te gestione nella selezione della clientela. ritengo che debbano essere evitate interferenze politico-amministrative nelle valutazioni del merito di credito di singoli casi. il credito è e deve restare attività imprenditoriale, basata su un prudente apprezzamento professionale della validità dei progetti aziendali. le banche imprudenti prima o poi finiscono in dissesto e smettono anche di far credito. ma la prova sollecitata dalla crisi è severa e richiede di sapere esse-re bravi banchieri anche quando l’economia va male. di fronte all’inevitabile peggioramento della qualità del credito dovuta alla recessione occorrono scelte lungimiranti: non basta tenere i conti in ordine. un fermo sostegno ai clienti con buon merito di credito evita che una stretta creditizia eccessiva aggravi la recessione e quindi peggiori la posizione degli stessi clienti delle banche».
(d) da ultimo occorre sottolineare la grande difficoltà di por mano agli inter-venti di pubblicizzazione regolamentare, in altre parole a ridisegnare le norme che devono governare nell’immediato dopo-crisi su basi rinnovate i mercati finanziari e più in generale l’economia globale, dando vita a quella che è stata definita la «Bretton Woods» del XXi secolo e così a un sistema di Global �egal Standard per un futuro sostenibile che eviti il ripetersi di crisi così estese e disastrose. ovviamente, nulla impedisce che i singoli Stati o più estese aree regionali (come l’unione europea) affrontino il tema con riferimento al pro-prio ambito di competenza territoriale, ciò che è in parte accaduto e sta acca-dendo8�. ma è evidente che, proprio le caratteristiche globali della crisi, rendo-no del tutto insufficienti sforzi individuali ed esigono regole parimenti globali.
Sennonché proprio su tale aspetto, al di là dei buoni propositi e delle mani-festazioni di intenti o di generici documenti, le divergenze sembrano farsi più profonde.
A cominciare dalla denominazione stessa del progetto, che la cancellie-ra tedesca, Angela merkel, ha voluto indicare più genericamente come Glo-bal Charter e il ministro italiano, Giulio tremonti, ha designato più puntual-mente come �egal Standard e che, da ultimo, nei documenti ufficiali del G-8, tenutosi a l’Aquila dall’8 al 10 luglio 2009, è divenuto meno impegnativamen-te il «dodecalogo» del cosiddetto «lecce framework», dal documento elabora-to dai ministri delle finanze degli otto Paesi riuniti a lecce per i lavori preli-minari allo stesso G-8.
8� Si veda per gli Stati uniti il documento del congressional oversight Panel, Special Report on Regulatory Reform, January, 2009; per la Gran Bretagna financial Services Autho-rity, �he �urner Revie�: � regulatory response to the global banking crisis; e per l’ue the High-level Group on financial Supervision in the eu, Report, Brussels, 25 febbraio 2009 (cosiddet-to rapporto de �arosière).
22_Fortunato.indd 369 17-05-2010 13:52:37
diritto, etica e mercato dopo la crisi370
Anche sul grado di vincolatività di questi nuovi «standard» permangono contrasti fra chi ritiene sufficiente un approccio da soft la� e chi invoca di contro veri e propri trattati internazionali vincolanti; e così ancora persisto-no divergenze sui contenuti e soprattutto sulla filosofia di fondo che dovreb-be contrassegnare questo nuovo attivismo delle pubbliche autorità in merito alla eteroregolazione e alla vigilanza della comunità degli affari, quando anco-ra echeggiano gli inni da poco innalzati alle liberalizzazioni e alla deregola-mentazione dei mercati e degli intermediari finanziari.
il percorso non si presenta, dunque, né agevole né breve, come hanno con-fermato gli esiti del G-8 de l’Aquila, il quale da un canto ha riconosciuto che «reforms of financial regulations will be implemented swiftly, ensuring a level playing field» e che «the crisis has revealed the importance of propriety, inte-grity and transparency regarding the conduct of international business and finance, so as to strengthen business ethics», ma d’altro canto ha rinviato alle iniziative già intraprese dall’ocSe e da altre organizzazioni internazionali il compito di sviluppare principi e standard comuni delineati nel «lecce fra-mework» e per i quali sussiste l’impegno a riprenderli nel G-20 di Pittsburgh programmato per il prossimo autunno85.
85 la dichiarazione dei ministri delle finanze del G-8, riuniti a lecce il 13 giugno 2009, così si esprime sul punto: «the crisis has revealed the importance of strengthening our com-mitment to standards of propriety, integrity and transparency. to address these issues in a comprehensive fashion, we agreed on the need to develop the lecce framework – a set of com-mon principles and standards regarding the conduct of international business and finance – which builds on existing initiatives and lays the foundation for a stable growth path over the long term (see the attached annex for details). We are committed to working with our inter-national partners to make progress with this initiative, with a view to reaching out to broader fora, including the G-20 and beyond. We discussed regulatory reform in our countries and at the international level. We are swiftly implementing the decisions taken at the london Sum-mit and call on others to join our efforts to ensure global financial stability and an internatio-nal level playing field. We urge the relevant international institutions to closely monitor the implementation of these decisions. We also call on the fSB to develop a toolbox of measures to promote adherence to prudential standards and cooperation with jurisdictions».Si riporta qui di seguito il cosiddetto «lecce framework»: �he �ecce Frame�ork: Common Principles and Standards for Propriety, Integrity and �ransparen-cyWe are in the middle of the worst crisis since the Great depression. the breadth and intensi-ty of the prolonged downturn have revealed the importance of strengthening our commitment to standards of propriety, integrity and transparency. excessive risk taking and the violation of these basic principles contributed to undermine international economic and financial stabili-ty. this occorre both in areas that relied on self regulation and market discipline and in fields with formal rules and oversight, revealing flaws in the functioning of markets. for the market economy to generate sustained prosperity, fundamental norms of propriety, integrity and tran-sparency in economic interactions must be respected. the magnitude and reach of the crisis
22_Fortunato.indd 370 17-05-2010 13:52:38
aiuti di stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari 371
l’ocSe, in effetti, unitamente ad altre quattro organizzazioni internazio-nali – l’international labour organization (ilo), l’international monetary fund (imf), la World Bank (WB) e la World trade organization (Wto) – si è assunto il compito di effettuare dapprima un «inventario» degli strumen-ti già esistenti a livello di cooperazione internazionale sul piano economico e sociale86 e quindi di elaborare i principi comuni da sottoporre all’approvazione dei maggiori Paesi del mondo, su cui peraltro ha aperto un pubblico confron-to in rete87.
has demonstrated the need for urgent action in this regard. reform efforts must address these flaws in international economic and financial systems with resolve. this will require promo-ting appropriate levels of transparency, strengthening regulatory and supervisory systems, bet-ter protecting investors, and strengthening business ethics. today, we, the G-8 finance mini-sters, discussed the need for a set of common principles and standards for propriety, integrity and transparency regarding the conduct of international business and finance. We have agreed on the objectives of a strategy, «the lecce framework», to create a comprehensive framework, building on existing initiatives, to identify and fill regulatory gaps and foster the broad inter-national consensus needed for rapid implementation. the lecce framework recognizes that there is a wide range of instruments, both existing and under development, which have a com-mon thread related to propriety, integrity and transparency and classifies them into five cate-gories: corporate governance, market integrity, financial regulation and supervision, tax coo-peration, and transparency of macroeconomic policy and data. Specific issues covered include, inter alia, executive compensation, regulation of systemically important institutions, credit rating agencies, accounting standards, the cross-border exchange of information, bribery, tax havens, non-cooperative jurisdictions, money laundering and the financing of terrorism, and the quality and dissemination of economic and financial data. international institutions and for a have already developed a significant body of work addressing a number of important issues in these areas, but, in many cases, the initiatives suffer from insufficient country par-ticipation and/or commitment. today, we agreed to create a coherent framework which buil-ds on work done by the imf, World Bank, oecd, fSB, fAtf, and other international orga-nizations, to strengthen the global market system. to ensure effectiveness, we will make every effort to pursue maximum country participation and swift and resolute implementation. We are committed to working with our international partners to make progress with the lecce framework, with a view to reaching out to broader fora, including the G-20 and beyond.
i documenti si possono rintracciare sul sito ufficiale del G-8 2009 de l’Aquila [www.g8ita-lia2009.it/G8/Home/G8-G8_layout_locale-1199882089535_Home.htm].
86 � «Global Charter»/»�egal Standard». �n Inventory of Possible Policy Instruments, oecd [www.oecd.org/globalstandard/blog], 19 marzo 2009.
87 Per alcuni interessanti interventi, si veda il sito oecd [www.oecd.org/globalstandard/blog]. l’iniziativa è passata, comunque, per varie tappe sin dagli inizi del 2009, su cui vedi il «timeline of Global Standard» sempre nel sito dell’oecd.
22_Fortunato.indd 371 17-05-2010 13:52:39








































![Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/genere-tra-epistemologia-e-trasformazione-sociale-gender-epistemological-category.jpg)