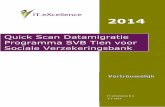Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for...
Transcript of Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for...
281
13.1 Sesso e genere
L’analisi del sistema sesso/genere, e l’acceso confronto tra le teorie es-senzialiste e culturaliste che si sono occupate della questione, hanno accompagnato le domande di mutamento sociale caratterizzanti il mo-vimento delle donne e sviluppate più di recente in quelli degli/delle omosessuali.
Il tema è oggi ancor più attuale in quanto gli assetti di convivenza sociale implicano sempre più la decostruzione delle categorie di ma-schile e femminile, e la ridefinizione di legami sociali capaci di prescin-dere dall’ingombranza del “fallologocentrismo” e dell’“eterosessualità obbligata”.
13.1.1. maschile e femminile
Uno studio del genere attraverso la psicologia conduce in primo luogo alla questione di cosa debba essere inteso per femminile e maschile: aspetti culturali, biologici, inconsci, o l’interagire dei tre aspetti?
Andrebbe discussa poi la differenza tra “Maschile” e “Femminile”, in quanto categorie, immagini, modelli, rappresentazioni della specie umana, e i singoli soggetti di sesso maschile e femminile.
Possono esserci uomini cosiddetti “femminili” e donne “maschili”, tuttavia non esiste una relazione tra i due livelli del discorso, pena la creazione di frequenti mistificazioni (Arcidiacono, 1991). Nell’affron-tare temi del genere, è necessario evitare la tautologica sovrapposizione tra Femminile e Materno, oltre a quella di Maschile e Femminile con Uomo e Donna. Siamo uomini e donne di sesso maschile e femminile
13
Il genere tra epistemologia e trasformazione sociale
di Caterina Arcidiacono e Agostino Carbone
elementi di psicologia sociale
282
e, in quanto singoli soggetti, ognuno ha la propria storia, definizione e individualità.
Nel dibattito culturale e politico la confusione tra i diversi livelli del discorso è tuttavia frequente.
Le teorie della psicologia sociale hanno criticato le impostazioni della psicologia classica che spiegavano le differenze di genere in ter-mini biologici o individualistici, trascurando i fattori sociali. Più di re-cente persino una psicologia sociale evoluzionista, in una prospettiva tesa a valorizzare le interazioni tra natura e cultura, vede le asimmetrie di genere come buoni adattamenti che l’impatto con l’ambiente e la riproduzione ha richiesto alla specie umana (Attili, 2007).
Sin dai primi anni del Novecento, molti autori hanno indagato spe-rimentalmente le differenze di genere. Secondo il noto meta-studio di Maccoby e Jacklin (1974), uomini e donne sarebbero diversi soltanto in relazione a quattro aree: la capacità verbale, le capacità visuospaziali, le capacità matematiche e l’aggressività. La letteratura evidenzia inol-tre sempre più spesso come gli studi di laboratorio soffrano di alcuni limiti sperimentali: il campione prescelto, la tendenza a riportare i dati significativi e a omettere quelli non significativi, la distorta operazio-nalizzazione dei concetti, la compiacenza nei confronti degli stereotipi correnti, la tendenza a trascurare il contesto. Al giorno d’oggi, nelle spiegazioni di senso comune, le diversità di genere sono spiegate nei termini dell’interazione tra fattori biologici e influenze ambientali e l’enfasi delle studiose femministe sul ruolo dei fattori sociali si pone in contrapposizione alle ipotesi che propongono il ruolo degli ormoni e dei fattori genetici (sociobiologia) come unici fattori esplicativi delle caratteristiche dei sessi.
Anche le teorie antropologiche mettono in rilievo l’influenza della cultura sulle differenze di genere: autori come Bronisław Malinowsky e Margaret Mead hanno mostrato come i ruoli sessuali siano profon-damente variabili da cultura a cultura. I teorici dell’apprendimento sociale evidenziano poi che i bambini acquisiscono i ruoli di genere attraverso un processo di apprendimento basato sul rinforzo positivo e negativo.
Secondo Gilligan (1982), che come Chodorow (1978) propone, in particolare, una rappresentazione positiva e autonoma della bambina, anche le differenze nel ragionamento morale tra uomo e donna sono dovute alle diverse esperienze vissute dai soggetti dei due sessi e non
13. il genere tra epistemologia e trasformazione sociale
283
a una presunta incapacità femminile di raggiungere standard morali adeguati.
Seguendo un approccio di genere che rinuncia a una visione mera-mente morfologica, l’insieme delle caratteristiche biologiche, cultura-li, sociali e psichiche porta così il singolo individuo a ritenere di appar-tenere a un genere piuttosto che all’altro; il loro interrelarsi è ciò che all’interno del gruppo degli uomini e delle donne determina le identità di genere dei soggetti che vi appartengono.
13.1.2. formazione e sviluppo dell’identità di genere
Con identità di genere si intende l’interazione dei fattori che influen-zano, in ogni fase, lo sviluppo sessuale, nel loro contesto storico, cultu-rale e biografico, un costrutto che viene analizzato dalle scienze sociali attraverso un approccio multidisciplinare che tenta di delineare un modello di differenziazione sessuale che contempli ampio spettro di variazioni. Il concetto di identità di genere viene utilizzato nell’ambi-to della ricerca psicologica che non rinuncia a collocare la soggettività umana in un contesto storico-culturale. Esso è fondante di un approc-cio all’interrelazione tra individuale e sociale che tenga conto delle in-fluenze del contesto sociale nella strutturazione e nello sviluppo della personalità umana. Allo stesso tempo con esso si tiene conto degli ef-fetti dei modelli di sviluppo individuale sull’organizzazione sociale e, più specificatamente, sui modelli di sviluppo della persona e della fa-miglia, dell’interrelazione tra i sessi, dell’assunzione di ruoli e funzioni sociali da parte degli uomini e delle donne, dell’attribuzione di senso e valore al sesso maschile e femminile (Zanuso, 1982).
La ricerca psicologica più recente ha indagato lo sviluppo dei primi anni di vita e le modalità con cui cominciano a caratterizzarsi le dimen-sioni sessuali.
Secondo Stoller (1968) la differenza tra maschi e femmine si svilup-pa e si completa tra i 18 mesi e i 3 anni. La differenza di genere a 3 anni è un dato acquisito. Per l’acquisizione dell’identità di genere l’elemento determinante non è l’aspetto biologico ma l’attribuzione di sesso che viene fatta al bambino o alla bambina.
L’acquisizione dell’identità di genere, la consapevolezza di appar-tenere a un sesso e non all’altro si inizia ad acquisire già intorno ai 18 mesi di vita e ad essa concorrono caratteristiche biologiche, culturali, sociali e psicologiche.
elementi di psicologia sociale
284
Nell’essere maschio o femmina c’è una differenza biologica ma an-che una legata a percezioni personali (“cosa io sento”), a “cosa le perso-ne intorno a me ritengono che io sia”.
Un maschio scozzese che gira con la gonnellina si sente profonda-mente maschio, in quanto la gonna in Scozia non è un attributo fem-minile ma un costume tradizionale. Il genere è perciò una categoria della cultura: l’essere maschi e femmine ha una determinante valenza culturale.
Le caratteristiche di genere si riferiscono quindi alla componente biologica (come sono fatto), sociale (come gli altri mi vedono), sog-gettiva (come io mi vedo), educativa (come sono stato cresciuto), cul-turale (quale dimensione il maschile-femminile ha nel contesto di vita in cui vivo).
Nell’antica Grecia era ritenuto un pregio avere un pene piccolo, perché più duttile e malleabile e in grado di garantire un maggiore piacere, secondo Aristotele persino più fecondo; in epoca romana è invece il pene di grosse dimensioni a essere apprezzato. Si tratta di un esempio del diverso riconoscimento sociale attribuito in epoche diver-se a una componente del corpo umano.
Le ricerche di Duveen e Loyd (1990) sull’attribuzione e sull’identi-ficazione di genere sono tuttora attuali ed emblematiche. Osservando le reazioni di alcune mamme nei confronti di neonati di sei mesi a cui erano stati cambiati gli abiti – ai maschi erano stati messi quelli tradi-zionalmente “da femmina” e alle femmine i vestiti “da maschio” – gli studiosi hanno notato che quando i “maschi” vocalizzavano le mamme avevano espressioni di approvazione (“Bene, sei forte! Come sei vigo-roso!”); se invece erano le “bambine” a richiamare la loro attenzione, si rapportavano a esse con messaggi tranquillizzanti: “Piano, stai calma, non ti preoccupare, stai tranquilla”.
Quei neonati costituivano, quindi, uno specchio neutro su cui agi-vano le fantasie o le attribuzioni dell’adulto.
Altre ricerche degli stessi autori con bambini di 4, 5 anni sono in-centrate sull’osservazione di cosa succede quando con l’altalena vo-gliono giocare due femmine oppure un maschio e una femmina: in questo secondo caso, la femmina scende spontaneamente da sola op-pure ubbidisce all’invito del maschio di scendere (Duveen, 1991).
A quest’età, ovviamente, non c’è ancora consapevolezza dell’inte-riorizzazione di categorie di genere, ma l’asimmetria di potere nella
13. il genere tra epistemologia e trasformazione sociale
285
modalità di gestire i rapporti sociali è già presente: i bambini maschi provengono da un contesto sociale all’interno del quale hanno impa-rato che le donne devono farsi indietro. L’acquisizione delle categorie maschili e femminili appare quindi precoce: è sociale, collettiva, con-nessa al contesto e alle regole del mondo adulto in cui si vive.
Come vengono trasmesse queste regole? Esse non passano con l’e-ducazione, né con messaggi di tipo etico, ma attraverso il modo con cui il bambino e la bambina decodificano quello che succede.
Arcidiacono (1998) riporta l’esempio di Nicola, un bambino di 4 anni, che aveva sviluppato la seguente teoria ingenua relativa al genere: tutte le donne hanno i denti d’oro, mentre gli uomini no. La babysitter aveva infatti alcuni denti d’oro, come la mamma e la zia: nel suo mondo sociale le donne avevano i denti d’oro e gli uomini non li avevano. Que-sto bambino aveva fatto una sua buffa lettura del mondo in cui viveva.
Il bambino o la bambina decodificano i messaggi così come vengo-no loro trasmessi e li utilizzano per farsi una loro idea del mondo.
Maschile e femminile sono categorie astratte: non c’è alcuna don-na che sia femminile, non c’è alcun uomo che sia maschile. Maschile e femminile sono pertanto dimensioni categoriali generalizzanti che variano, del resto, a seconda dei contesti, delle regole e delle interazio-ni sociali.
Non esiste un’unica modalità maschile o femminile di esprimersi: esistono tante modalità femminili e maschili. Esiste, invece, l’unitarie-tà e l’unicità della singola persona.
Ci sono quindi modelli diversi di maschile e femminile, così come diversi modelli di verità, di bene, di giustizia; la realtà è fatta del nostro agire, e ognuno cerca di essere più o meno giusto, più o meno buono, di esprimersi rispetto alla propria etica personale, al proprio mondo di valori e, certo, anche rispetto al maschile o al femminile.
Dalle ricerche di Brown e Gilligan (1992) è emerso che le ragazzine fino a 8-10 anni mantengono una certa forza, sicurezza, autonomia, autodecisionalità, autoreferenzialità; con l’inizio della preadolescenza quelle stesse bambine sembrano invece perdere la loro carica di asserti-vità e di affermazione.
Questo ci fa capire come nel percorso di vita, quando si avvicina il momento dell’assunzione di un’identità femminile adulta, quella che poteva essere una capacità di autoaffermazione si viene a diluire nella modalità di espressione socialmente riconosciuta. Si dice che la
elementi di psicologia sociale
286
scuola offra stimoli e opportunità uguali, in realtà essa mostra una di-versa modalità di relazionarsi con i soggetti a seconda che siano ma-schi o femmine. Sembra, ad esempio, che a livello di scuola elementare le bambine occupino meno spazio dei maschi, abbiano cioè bisogno di uno spazio minore per esprimersi, e che gli adulti tollerino molto meglio la vivacità maschile piuttosto che quella delle bambine. Altre ricerche hanno dimostrato che nei gruppi classe le bambine tendono a compiacere di più le insegnanti, sono attratte dall’essere socialmente desiderabili e quindi cercano l’approvazione e il consenso degli adulti (Duveen, Lloyd, 1990).
13.1.3. le rappresentazioni sociali del genere
Il confine tra individuale e sociale, tra ciò che è geneticamente determi-nato e ciò che è culturalmente dato, è labile e controverso. Si costruisce e ricostruisce continuamente in un processo di costante ridefinizione attraverso il corso delle generazioni. Inoltre, lo studio delle variazioni all’interno delle categorie sociali, più che quello delle differenze tra categorie o gruppi sociali, ha contribuito a ridimensionare competenze riconosciute a un sesso e non all’altro.
Il concetto di rappresentazione sociale (cap. 8) e della sua interio-rizzazione è quello che nella ricerca più recente offre migliori possibi-lità di comprendere come categorie e attribuzioni maschili e femminili si formino già nella prima infanzia. Le rappresentazioni sociali degli adulti che accudiscono il bambino orientano i pensieri, i sentimenti e le attività nei confronti di quest’ultimo e quindi quelle del bambino stesso. Con il tempo, poi, il bambino – diventando egli stesso attore sociale – interiorizzerà le rappresentazioni sociali di genere della col-lettività a cui appartiene ed esprimerà la propria identità di genere in rapporto ai modi di pensare socialmente diffusi.
Tuttavia il discorso è abbastanza complesso perché rappresentazio-ni sociali, stereotipi e pregiudizi (cap. 12) possono a loro volta diven-tare parte integrante dell’identità del singolo individuo per effetto dei processi di interiorizzazione delle rappresentazioni sociali.
Aspettative verso il ruolo maschile e quello femminile, stereotipi e pregiudizi, interiorizzazione dei ruoli e dei modelli di relazione sessua-le e affettiva veicolati dal contesto familiare e dall’ambiente sociale di appartenenza sono gli elementi che determinano il senso che ognuno attribuisce al proprio essere maschio o femmina e, quindi, il modo di
13. il genere tra epistemologia e trasformazione sociale
287
concepire la relazione tra i sessi. Bianca Gelli (2009), nella Psicologia della differenza di genere, porta ad attraversare con agilità e riflessività le molte concettualizzazioni e ricerche che definiscono la soggettività femminile tra vecchi pregiudizi e sfide della parità.
In breve, qui possiamo dire che la convenzione comune negli anni settanta utilizzava la parola “sesso” in riferimento alla divisione bina-ria tra maschio e femmina secondo un criterio biologico e utilizzava il termine “genere” per descrivere le differenze derivanti dalla costru-zione sociale.
In anni più recenti, Lloyd e Duveen (1992) hanno proposto di con-tinuare a differenziare l’essere membri di un gruppo sessuale e le iden-tità sociali di genere.
Ciò permette di sfuggire dall’assunzione che tutti i membri di un gruppo ses-suale adottano i ruoli di genere nella stessa maniera. In altre parole, nel distin-guere sesso e genere siamo in grado di considerare le variazioni dei compor-tamenti definiti secondo il genere all’interno dei gruppi sessuali (ivi, p. 16).
Abbiamo ritenuto (Duveen, Lloyd, 1990) che anche all’interno del domi-nio del genere, dove le rappresentazioni sociali impongono agli individui un obbligo imperativo di adottare un’identità di genere sociale, differenti identità di genere sono possibili all’interno dello stesso gruppo sessuale (ivi, p. 179).
In tal senso, per far fronte a tale problema la ricerca sociale, in una pro-spettiva costruzionista, ha sviluppato il concetto di identità situate al fine di rendere conto di come sia il senso di sé che le scelte personali di un soggetto possano variare in relazione alla rappresentazione di sé e della realtà in cui vive, contestando l’assunto che esista un’unica iden-tità di genere.
Gli studi sulla formazione delle differenze sessuali tra maschi e fem-mine, e quelli sul ruolo materno e le implicazioni connesse allo svolgi-mento di funzioni allevanti sullo sviluppo di uomini e donne, hanno portato significativi contributi all’analisi degli stereotipi e dei pregiu-dizi sessuali, fornendo elementi di comprensione allo sviluppo e alla formazione dell’identità di genere per maschi e femmine.
La categorizzazione sociale è alla base della formazione del giudizio con cui l’individuo organizza i dati di realtà semplificandoli (cap. 5). Tale processo cognitivo, anche in questo caso, costruisce il pensiero e
elementi di psicologia sociale
288
porta alla formazione degli stereotipi e dei pregiudizi di genere offren-do un valido strumento di conoscenza delle attribuzioni di abilità e competenze secondo il genere di appartenenza. Tuttavia gli stereotipi di genere hanno una dimensione sia descrittiva che prescrittiva. Essi contribuiscono alla costruzione di aspettative differenti per il compor-tamento maschile e femminile non tanto in quanto definiscono come le persone siano, ma come ci si attende che siano. Lo stereotipo assume così una valenza normativa che a sua volta influenza la desiderabilità sociale dei comportamenti in relazione al genere/sesso di appartenen-za. Vi è ormai ampia consapevolezza che specifiche qualità vengono attribuite ai soggetti (all’uomo e alla donna) in virtù del sistema di pensiero e delle norme di riferimento di chi giudica. Pertanto maschile e femminile, come già detto, possono essere considerate delle norme etiche, valori di riferimento del soggetto pensante e non caratteristiche intrinseche dell’oggetto osservato.
Negli ultimi anni lo studio delle variazioni all’interno delle ca-tegorie sociali ha contribuito, inoltre, a ridimensionare competenze riconosciute a un sesso e non all’altro. Ciò ha tolto significato all’ac-ceso dibattito, tanto caro ai discorsi del luogo comune, su ciò che sanno fare o sono i maschi e ciò in cui eccellono o di cui difettano le femmine.
Il concetto di rappresentazione sociale e della sua interiorizzazione è quello che nella ricerca più recente offre migliori possibilità di com-prendere come categorie e attribuzioni maschili e femminili si formino già nella prima infanzia. Le rappresentazioni mentali degli adulti che accudiscono il bambino/a ne orientano i pensieri, i sentimenti e le atti-vità. Con il tempo, poi, il bambino/a diventerà egli stesso attore socia-le, interiorizzerà le rappresentazioni sociali di genere della collettività a cui appartiene e si esprimerà in rapporto ai modi di pensare, sentire e agire della stessa (Lloyd, 1997).
I tempi sono ormai maturi per una discussione non ingenua sul maschile e sul femminile, che sappia distinguere tra le esperienze reali degli uomini e delle donne, ciò che è ritenuto Maschile e Femmini-le a livello sociale e culturale. Si tratta di differenziare il mondo reale dal simbolico e dall’immaginario, esplorando e distinguendo, tra loro, l’immaginario delle donne da quello degli uomini. Poiché il femmini-le è qualcosa di diverso dalla donna, ci si deve domandare in cosa sia
13. il genere tra epistemologia e trasformazione sociale
289
diverso il femminile di cui noi donne parliamo dal femminile definito dai maschi lungo tutta la storia.
Sempre in psicologia sociale non può infine essere tralasciata un’ul-teriore prospettiva che attribuisce al ruolo di genere (gender role) una funzione precipua nella definizione delle differenze tra maschi e fem-minile in quanto racchiude tutte le caratteristiche, compiti, mansioni e attributi definiti all’interno di un contesto dato come maschili e\o femminili. Per Eagly (1987) i ruoli di genere – come gli specifici ruoli sociali di figlia, amica, capo – influenzano il comportamento delle sin-gole donne. Essi sono fermamente radicati nella divisione sociale del lavoro e nei ruoli sociali assolti da maschi e femmine. Per la teoria dei ruoli, mascolinità e femminilità sono da vedersi come copioni recitati nella vita quotidiana di cui bisogna apprendere battute, entrate, uscite e utilizzo della scena. In questa prospettiva la psicologia sociale si dedi-ca allo studio di stereotipi, pregiudizi e rappresentazioni connessi alle differenze tra ciò che è ritenuto maschile e femminile.
Secondo la prospettiva decisamente costruzionista di Burr (1998), infine, il modo in cui comprendiamo il mondo è una costruzione so-ciale prodotta dalle interazioni interpersonali e da quelle linguistiche. In Italia, Procentese (2005) ha proposto in tal senso un’analisi del ruo-lo paterno alle prese con compiti allevanti.
13.2 Il genere nel pensiero postmoderno
La rassegna dei modelli esplicativi del genere proposti dalla psicologia sociale non è esaustiva: per comprenderne fino in fondo la funzione sociale bisogna interrogarsi su come il genere sia vissuto, organizzato e regolamentato dagli assetti sociali e dalle forme giuridiche, nonché dal genere stesso. Tale processo è ancor più necessario in quanto con l’avvento dell’epoca della cosiddetta postmodernità hanno acquisito visibilità nuove forme di unione, parentela, convivenza, generativi-tà che scardinano la normatività dei modelli di rapporto fino a oggi socialmente intellegibili, quindi legittimati. Per comprendere fino in fondo problematiche e assunti frutti del sistema messo in atto dalla creazione del genere come dispositivo sociale è necessario approfondir-ne gli effetti performativi, reificati, che inevitabilmente conformano e
elementi di psicologia sociale
290
organizzano i rapporti entro i contesti seguendo una logica dicotomica uomo/donna, eterosessualità/omosessualità, attivo/passivo.
13.2.1. decostruendo il genere
Già per Foucault (1973) il potere regolatore crea e modella, ed essere assoggettati a una regola significa essere prodotti in quanto soggetto, proprio attraverso il processo di regolamentazione. In materia di ge-nere Judith Butler, filosofa femminista e queer (riquadro 13.1) della Berkeley University, a partire dalla pubblicazione di Gender Trouble (1990) ha sviluppato un’indagine genealogica che denuncia i processi che fondano il processo di categorizzazione del genere, dichiarando fallace definire quest’ultimo come interpretazione culturale delle dif-ferenze bio-anatomiche. Il genere non sta dunque alla natura come il sesso alla cultura.
La sua critica è focalizzata su due istituzioni definitorie: il fallo-gocentrismo e l’eterosessualità obbligatoria. Allo scopo di criticare l’eterosessualità pervasiva anche nella letteratura femminista, Butler (1990) allarga il campo delle possibilità per il genere decostruendo “verità” che delegittimano pratiche sessuali non normative. L’autrice riconosce l’esistenza e l’emergenza nell’ordine discorsivo di pratiche sessuali non normalizzate mettendo in dubbio la stabilità del genere, come categoria di analisi.
Per Butler, infatti, il genere non è qualcosa che le persone hanno, né un attributo dell’essere. Affermando che non esiste un’identità di ge-nere che prescinda da un determinato soggetto, la studiosa statuniten-se mette fine all’idea di genere come qualcosa di reale; la sua ricerca ne rivela, allo stesso tempo, il carattere prettamente costruito nei rapporti
riquadro 13.1Un chiarimento terminologico
Il termine queer è usato da chi rifiuta con forza le tradizionali identità di ge-nere, le categorie dell’orientamento sessuale come gay, lesbica, bisessuale ed eterosessuale, da chi si rappresenta e percepisce come oppresso dall’eteronor-matività (cfr. anche Richardson, Mclaughlin, Casey, 2006). Nel 1990 Teresa de Laurentis proponeva con queer un termine che dovesse servire a dirimere l’automatismo evocato dalla formula “studi gay e lesbici”, che il più delle volte porta all’elisione delle differenze dei soggetti e alla naturalizzazione di una comune identità.
13. il genere tra epistemologia e trasformazione sociale
291
con la sfera sociale, e quello performativo, ossia la sua dimensione defi-nitoria dei rapporti della quotidianità. Butler mette in discussione una metafisica della sostanza, il pensiero che dà per scontata l’esistenza di un soggetto portatore di attributi. L’attenzione è così posta sul modo attraverso il quale il genere viene prodotto, ovvero è tesa a delineare gli effetti del processo di reificazione che ha portato a considerare qualco-sa di astratto come concreto.
Il genere è, infatti, una relazione e non un attributo individuale, e nemmeno una marca di differenza biologica, linguistica e/o culturale. È una pratica regolatrice che governa la costruzione dei processi iden-titari. In quest’ottica anche il sesso è una categoria del processo di pro-duzione del genere stesso. Il genere quindi non deve essere concepito come l’iscrizione culturale di significato su un sesso dato in preceden-za, ma deve designare l’apparato della produzione mediante il quale vengono creati i sessi, il sistema attraverso cui hanno luogo la produ-zione e la normalizzazione del maschile e del femminile.
Un discorso restrittivo del genere, che persiste nel binarismo uomo/donna, maschile/femminile, eterosessualità/omosessualità, e inteso come unico modo di intendere l’ambito del genere, mette in atto un’o-perazione di potere regolatrice che naturalizza le pratiche egemoni, impedendo l’ipotesi del loro smantellamento.
13.2.2 nuove identità e forme di convivenza: questioni lgbtq
In che modo i generi, di cui sopra, sono vissuti entro la scena della quo-tidianità?
Il rapporto tra movimento delle donne e di liberazione omosessuale è quanto mai cruciale: l’omosessuale maschio è visto come alleato del femminismo nel sovvertire il fallocentrismo maschilista poiché nella propria condizione di omosessuale egli scoprirebbe la contraddizione con la norma patriarcale ed eterosessuale (Mieli, 1977).
L’uscita dall’invisibilità obbligatoria in cui era relegato il desiderio omosessuale è stato un processo in cui, tra vergogna personale e socia-le, prendeva timidamente spazio la possibilità di confutare un destino molto spesso ineluttabile. Partiva così la sfida alla segregazione (riqua-dro 13.2).
Considerando la sessualità come categoria cruciale di analisi nelle scienze sociali, quali l’antropologia, la sociologia, la psicologia, la sto-
elementi di psicologia sociale
292
ria, la letteratura e gli studi culturali, questi studi hanno permesso di documentare quanto le pratiche sessuali siano pratiche sociali frutto di un processo storico-discorsivo di cui oggi è necessario occuparsi. Così come Women’ Studies non riguardano esclusivamente le donne, i Queer Studies non si occupano di persone gay, bisessuali o transes-suali, ma del rapporto tra quest’ultimi e i significati culturali che ne organizzano la convivenza entro la socialità. In particolare la lgbtq Psychology (l’acronimo sta per Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer) esamina i differenti aspetti di vita entro i contesti di appar-tenenza, quali gli effetti della discriminazione, l’omogenitorialità, il coming-out, lo sviluppo e la riassegnazione dell’identità di genere.
Sussiste nel nostro paese una presenza fantasmatica, sia per quan-to riguarda la diffusione degli studi gay e lesbici sia la legittimazione dell’omosessualità, che fatica a diventare oggetto del discorso politico se non per quanto concerne la legittimità della concessione di istitu-zioni normative quali il same-sex marriage o l’adozione a carico di cop-pie gay.
riquadro 13.2Alcuni richiami storici sul processo di delegittimazione sociale dell’omosessualità
Nel 1968, in Italia, il letterato Aldo Braibanti veniva condannato a nove anni di reclusione (ridotti in appello a quattro) in quanto affetto da “omosessuali-tà intellettuale”, colpevole di aver plagiato Giovanni Sanfratello, un giovane che aveva scelto di andare a vivere con lui.
Il 28 giugno 1969, allo Stonewall Inn, bar di New York, un gruppo di giovani omosessuali, soliti frequentare quel luogo di ritrovo veniva assalito e malmenato dalla polizia locale. L’anno seguente un gruppo di manifestan-ti sfilava per le strade della Grande Mela per denunciare le violenze dello scorso giugno. Nasceva così il primo Pride, la prima parata dell’orgoglio omosessuale.
Il processo di depatologizzazione dell’omosessualità ha avuto inizio nel 1973, quando l’American Psychiatric Association ha espunto l’omosessualità dal novero dei disturbi mentali, eliminata poi nel 1990 anche dal manuale di riferimento dell’oms (International Classification of Diseases, icd).
Tra gli anni settanta e ottanta, a ridosso dell’attivismo associazionista e del processo di legittimazione sociale dell’omosessualità, prendono forma all’in-terno delle discipline umanistico-letterarie gli studi gay e lesbici, lgbtq, allo scopo di istituire un processo rivendicativo e recuperativo capace di teorizza-re sulla condizione gay, lesbica e in seguito trans.
13. il genere tra epistemologia e trasformazione sociale
293
Un aneddoto: nel 1995, durante la conferenza delle Nazione Unite sulla condizione della donna svolta a Pechino, il Vaticano ha sostenuto che il termine “genere” dovrebbe essere bandito dal programma delle ong poiché non si tratta d’altro che di sinonimo di “omosessualità” (Butler, 2004).
13.3 Il cammino delle pari opportunità
Nei paesi di cultura occidentale si è assistito negli ultimi anni a pro-fonde trasformazioni sociali e culturali; si sono affermate legislazioni orientate verso la parità dell’uomo e della donna nella coppia, si rico-noscono i diritti sociali delle donne, si assiste a un massiccio ingresso femminile nel mercato del lavoro.
I codici di comunicazione uomo-donna sembrano tuttavia essere rimasti inalterati. È come se vi fosse uno scarto tra il mondo delle re-lazioni socio-culturali e quello degli affetti e delle identità personali.
13.3.1. la segregazione femminile
La relazione uomo-donna, al di fuori di un ambito pubblico, conserva, in forma più accentuata, regole e modelli di un’organizzazione sociale più arcaica. Nella vita privata alle donne è consentita l’attività lavorati-va, purché il valore a essa attribuito resti subordinato a quello attribui-to al consorte e alla vita familiare.
Attualmente gli ostacoli alla partecipazione femminile, al di fuori del focolare domestico, più che di natura legale e giuridica, o ammini-strativa, sono di natura culturale e relativi alla mancanza di parità di trattamento, alla persistenza di inique opportunità.
Come mai, nonostante i progressi dell’assetto legislativo, continua-no a esistere barriere invisibili all’accesso delle donne al mondo del la-voro e alle cariche pubbliche?
Per le donne è difficile accedere a posti gerarchicamente elevati, in particolare nei territori da sempre ritenuti di dominio maschile, quali l’università, la magistratura, le amministrazioni dello Stato e la politi-ca. Più in generale, le donne riescono ad avanzare solo fino a un cer-to punto nella loro carriera politica e professionale, trovando ostacoli nel proseguire oltre. Se in teoria le donne possono contare sulle stesse
elementi di psicologia sociale
294
opportunità offerte agli uomini, nei fatti esse si ritrovano bloccate da sistemi di esclusione ben radicati nella cultura di molte società.
La presenza numerica delle donne nella forza lavoro è più bassa ri-spetto a quella degli uomini, nonostante il fatto che esse costituiscano più della metà della popolazione; in Italia esse percepiscono, inoltre, un reddito mediamente inferiore rispetto ai maschi, senza contare l’ineguale distribuzione del genere nei diversi settori occupazionali. Difatti, nonostante le donne possano legalmente accedere a qualsia-si lavoro, esse non si distribuiscono in modo uniforme nei settori di attività, ma si concentrano principalmente in poche occupazioni che spesso richiamano i ruoli tradizionali del lavoro domestico e di cura e sono spesso meno remunerative (estetiste, insegnanti, parrucchiere, assistenti sociali ecc.).
Vi è una segregazione verticale che riguarda la scarsa collocazione delle donne ai vertici delle organizzazioni nelle posizioni di maggior prestigio, potere decisionale e retribuzione. Tale segregazione sotto-linea l’esistenza di una forte sproporzione tra le donne presenti nei settori lavorativi e il numero che assume posizioni di potere in quei determinati settori.
Tuttavia non è ancora chiaro se gli ostacoli che le donne si trovano ad affrontare siano maggiori nel percorso di ascesa verso posizioni di maggior potere o siano presenti a qualunque livello lavorativo. La lo-cuzione glass ceiling è una metafora per indicare le barriere invisibili (dette appunto di “vetro”) che ostacolano il raggiungimento delle po-sizioni di vertice da parte delle donne. Si riesce a vedere la meta, ma si sbatte contro un soffitto nascosto e impenetrabile.
Quando parliamo invece di segregazione orizzontale ci riferiamo alla presenza quasi esclusiva delle donne in determinate aree, lasciate libere dagli uomini perché ritenute superate da altre più prestigiose e attuali. Al glass ceiling si va così ad aggiungere quello che viene definito sticky floor (“pavimento di pece”), espressione che traduce efficacemen-te le difficoltà che le donne incontrano allorché cercano di spostarsi in spazi di quasi esclusiva pertinenza maschile. Questa doppia forma segregativa è ben evidenziabile, in particolare in riferimento all’Italia, oltre che in ambito politico anche in settori quali il mondo universi-tario, la magistratura, le libere professioni, il mondo imprenditoriale.
È evidente come il numero di donne che rivestono cariche politiche prestigiose sia assai più ridotto rispetto al numero di uomini che rico-
13. il genere tra epistemologia e trasformazione sociale
295
prono tali incarichi. C’è da interrogarsi sul perché di tale gap politico. Numerose al riguardo le interpretazioni fornite da esperti di diverse discipline.
I sostenitori dell’approccio culturale ipotizzano che l’assenza seco-lare di donne dai posti di potere abbia contribuito a far considerare la politica un territorio maschile e a identificare la leadership politica con caratteristiche tipicamente maschili. Si sono così rafforzati stereotipi di genere che vedono gli uomini portati più naturalmente a occupare posizioni di responsabilità politica. Le donne vengono ritenute meno adatte a ricoprire ruoli cui si associano qualità come la competitività, l’aggressività, la capacità di comandare e prendere decisioni impopola-ri. Le donne stesse non ambirebbero a posizioni di leadership in quan-to meno orientate al potere dei maschi.
Secondo l’approccio situazionale, invece, le donne non riescono ad arrivare ai vertici della politica perché hanno difficoltà a conciliare gli impegni familiari con i tempi della politica.
Il modello del gatekeeping si basa al contrario su una visione diffe-rente, sostenendo che sono i colleghi maschi a impedire di fatto alle donne di accedere alle massime cariche nei partiti e nelle istituzioni. Infatti le decisioni sono prese da élite maschili che impedirebbero l’in-gresso delle donne nelle stanze del potere.
Secondo Donata Francescato et al. (2008) non ci sono differenze significative tra uomini e donne in termini di padronanza dei temi socio-politici. Dal loro studio emerge tuttavia che le donne politiche italiane sembrano avere un livello totale di empowerment minore di quello dei loro colleghi, soprattutto nelle componenti relative al senso di autoefficacia personale e alla propensione alla leadership. Le donne politiche hanno tuttavia un punteggio di empowerment significativa-mente più elevato della media femminile e il più alto in assoluto rispet-to anche a donne che lavorano in settori tradizionalmente maschili, come le sindacaliste e le poliziotte.
Ma perché donne che hanno raggiunto traguardi ambiti, elette a cariche politiche locali e nazionali, si sentono meno autoefficaci dei loro colleghi? Le sostenitrici dell’approccio situazionale hanno ipo-tizzato che, mentre gli uomini hanno il sostegno delle mogli nello svolgere il loro lavoro, le donne, dovendo anche assolvere a un ruolo cruciale nelle loro famiglie, avrebbero un sovraccarico di responsa-bilità e, non potendo far bene tutto, si sentirebbero meno efficaci.
elementi di psicologia sociale
296
Tuttavia le donne intervistate hanno affermato, più spesso dei loro colleghi maschi, di aver ricevuto sostegno nella propria carriera po-litica non solo dalla famiglia d’origine ma anche dal partner e dai figli. Inoltre, una percentuale significativamente maggiore di uomini dichiara di aver subito effetti negativi nella vita privata a causa degli impegni politici.
I risultati della ricerca non confermano le ipotesi di coloro che se-guono l’approccio situazionale e danno invece maggior sostegno ai fautori dell’approccio teorico del gatekeeping o della discriminazione sessuale.
13.3.2. riforme legislative e azioni positive
In Italia le donne hanno ottenuto il diritto al voto in tempi relativa-mente recenti, precisamente nel 1946, e fino al 1963 non era permesso loro l’accesso a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, com-presa la magistratura. Bisognerà anche attendere fino al 1981 (legge 5 agosto 1981, n. 442) perché sia eliminato dal codice civile il “delitto d’onore”, che concedeva una forte riduzione della pena a chi avesse uc-ciso la moglie, la figlia o la sorella al fine di difendere “l’onor suo o della sua famiglia”.
Tra le tappe legislative che hanno segnato in Italia la condizione femminile si segnala nel 1970 l’istituzione del divorzio e nel 1975 la riforma del diritto di famiglia con una nuova normativa che pone fine al potere assoluto del padre nei confronti dei figli e pone termine all’e-sercizio di tutela nei confronti della moglie.
Nel 1977 prende corpo la parità di trattamento tra uomini e donne rispetto al lavoro e quindi il superamento di qualsiasi discriminazione basata sul sesso (legge 9 dicembre 1977, n. 903). Nel 1978 si sancisce l’autodeterminazione della donna sul proprio corpo e viene appro-vata la legge che prevede l’interruzione volontaria della gravidanza (legge 22 maggio 1978, n. 194), ma bisogna aspettare ancora vent’anni (legge 15 febbraio 1996, n. 66) perché la violenza sessuale sia inserita tra i reati contro la persona e non più tra quelli contro la morale e il buon costume. A partire dagli anni ottanta vengono istituite com-missioni e consulte con funzioni consultive e di orientamento nel governo, nelle Regioni e nei Comuni per rendere effettive le parità e le pari opportunità per le donne. Per un esame più circostanziato del rapporto tra legislazione e condizione femminile si veda la ricca rasse-
13. il genere tra epistemologia e trasformazione sociale
297
gna della letteratura in una prospettiva psicosociale a cura di Minou Mebane (2008).
Va qui adesso evidenziato che la strategia più significativa per in-centivare la partecipazione delle donne in politica è rappresentata dalle cosiddette azioni positive. Tali azioni si suddividono in tre ca-tegorie: a) identificazione di una quota di seggi riservati alle donne stabilita in base alla legge elettorale; b) determinazione di quote per le donne, stabilita dalla legge, che tutti i partiti politici devono rispetta-re nella preparazione delle liste elettorali; c) determinazione di quote di genere decise su base volontaria e autodeterminata dai singoli par-titi politici.
È poi il caso di sottolineare che nel 1993, in occasione della riforma dei sistemi elettorali comunali e provinciali, nell’urgenza di istituire misure di effettiva promozione delle pari opportunità, furono intro-dotti alcuni obblighi per i partiti politici, tra cui quello di prevedere una riserva di quote per l’uno e per l’altro sesso nelle liste dei candi-dati. Si disponeva, in particolare, il divieto di sovrarappresentare nelle singole liste – oltre i 2/3 – uno dei due sessi, a pena della dichiarazione di inammissibilità della lista stessa. Lo strumento della “riserva di quo-te” (cosiddette “rosa”, in quanto volte a favorire la partecipazione delle donne) fu una delle modalità in cui si esplicarono le azioni positive. Si è tuttavia trattato di un percorso non molto lineare. La Corte Costi-tuzionale, con la sentenza n. 422/1995, ha infatti dichiarato l’illegitti-mità di tali azioni sostenendo che ogni differenziazione in ragione del genere è da ritenersi discriminatoria e in contraddizione con l’art. 51 della Costituzione. Nel 2009 la Regione Campania ha tuttavia varato una legge regionale che prevede per l’elettore la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza: in quest’ultimo caso una preferenza deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza (legge 27 marzo 2009, n. 4, art. 4, comma 3).
Questa innovativa strategia legislativa propone una soluzione ori-ginale per agevolare l’ingresso in politica delle donne: sotto il profilo giuridico non lede il principio della parità di opportunità tra uomini e donne, bensì tende a ridefinire un nuovo equilibrio senza imporlo e soprattutto sancisce la preferenza di genere.
Di recente la politica delle azioni positive ha trovato ampia espres-sione in tutta la legislazione e le misure che favoriscono il work/family
elementi di psicologia sociale
298
balancing, ovvero gli interventi che promuovono una migliore conci-liazione tra famiglia e lavoro, tra le esigenze delle madri e quelle dei padri al di là dei ruoli (Fine-Davis et al., 2007).
13.3.3. dalle pari opportunità alla promozione delle opportune differenze
La battaglia per la promozione di pari opportunità nelle relazioni e nella società civile non è conclusa. È necessario infatti sviluppare azio-ni finalizzate a:a) favorire un’etica dell’autodeterminazione e del rispetto di sé e dell’altro;b) individuare le differenze del processo di crescita tra maschi e fem-mine e, pertanto, le diverse modalità di rapportarsi alla sessualità e alle relazioni tra i sessi;c) valorizzare sia la capacità di entrare in relazione con l’altro sia di differenziarsene restando fedeli a sé stessi, ai propri desideri e progetti;d) promuovere nei media e in ambiti culturali lo spazio per la riflessio-ne e la discussione sugli stereotipi di genere, o almeno avviare strategie per non contribuire alla loro perpetuazione;e) rinforzare il lavoro di rete attraverso la creazione di comitati di vi-gilanza istituzionali e dei consumatori, codici di comportamento del-la pubblicità e dell’uso delle nuove tecnologie gender friendly (Vitali, 2009).
La cronaca degli ultimi anni testimonia come l’asimmetria delle relazioni di genere sia ancora una realtà che incide sulla qualità dei rapporti tra uomo e donna. Il perpetuarsi di situazioni di predominio nella vita di coppia e allo stesso tempo l’instaurarsi di un’etica relazio-nale più paritaria promossa dalle legislazioni creano un contesto di in-certezza e vulnerabilità da cui originano incomprensioni ed episodi di violenza che incidono sulla vita delle donne, delle coppie e dei bambini (Arcidiacono, Di Napoli, 2012).
Se è vero che i processi di trasformazione degli assetti di genere non possono essere attuati nell’arco di una sola generazione, una società de-cisa a superare gli attuali modelli di interrelazione tra i sessi e a incidere sullo sviluppo di ognuno di essi deve porsi l’obiettivo di individuare i nodi di trasmissione dei modelli, le modalità di interiorizzazione degli stessi e istituzionalizzare programmi di sensibilizzazione ed educazio-ne compensatoria.
13. il genere tra epistemologia e trasformazione sociale
299
Da un lato, il femminismo liberale punta a sviluppare nelle don-ne una maggiore consapevolezza delle pratiche di educazione dei figli, nonché del ruolo degli strumenti educativi, con l’obiettivo di modifi-care gli atteggiamenti sociali nei confronti dei ruoli di genere; dall’al-tro il femminismo radicale individua il fondamento delle differenze di genere nelle relazioni tra i sessi e identifica nella concezione sessuale vigente i fattori centrali del predominio maschile sulle donne nella sfe-ra sia pubblica che privata.
13.4 L’approccio di genere nel processo di ricerca
e nella progettazione di interventi
L’approccio di genere nella ricerca considera credenze, atteggiamenti e comportamenti umani in una prospettiva contestuale-ecologica che tie-ne conto dell’influenza dell’azione delle dimensioni di genere, etnicità/razza e classe. Anche se non si dispone di un’esauriente rassegna della letteratura in tal senso (Bond, Mulvey, 2000), le biografie di autorevoli autrici che hanno contribuito allo sviluppo di metodologie qualitative mostrano come l’esperienza del femminismo abbia accompagnato lo svi-luppo della ricerca qualitativa tesa a dar voce (give voice) alle esperienze di vita di gruppi e soggetti marginali. Più in generale, le critiche mosse dalla psicologia femminista verso i metodi quantitativi sviluppano un pensie-ro complesso che si focalizza su tre dimensioni precipue: la rimozione del contesto, la negazione della soggettività, la negazione della relazione tra ricercatori e partecipanti (Mazzara, Montali, 2010). Tale contrappo-sizione ha poi trovato nei principi della psicologia di comunità un sup-porto alla critica del modello individualistico, che vittimizza gli oppressi senza dare valore ai fattori sociali intrinseci ai contesti di vita (tab. 13.1).
Da una recente ricerca (Wasco, Bond, 2009) in cui sono state pre-se in esame le riviste di psicologia di comunità pubblicate dal 1973 al 2007, i cui titoli contenevano la parola “genere” o “differenza sessuale”, emerge che sono tre le modalità in cui il genere viene trattato all’in-terno della ricerca scientifica: variabile categoriale (80%), variabile di processo (7,8%), variabile contestuale (12%).
Bond e Mulvey (2000) hanno poi evidenziato lo specifico contri-buto offerto dall’approccio femminista allo sviluppo di metodologie
elementi di psicologia sociale
300
qualitative che danno voce alle parole degli attori sociali, promuovono un approccio narrativo che si completa con l’utilizzo di pratiche di ri-flessività circa il processo di ricerca. Cinque gli elementi fondamentali da utilizzare nella pratica di ricerca (McHugh, Cosgrove, 2004):– dar voce alle esperienze quotidiane delle donne;– allontanarsi da una modalità di pensiero fondata su dicotomie;– introdurre un processo riflessivo;– adottare un approccio partecipativo;– adottare strumenti di ricerca volti all’emancipazione e alla promo-zione dell’empowerment.
È attraverso questi elementi che si attiva un processo che partendo dalle donne, e per mezzo della loro partecipazione, arriva alle donne stesse, arricchendo l’intera comunità di un bagaglio di emancipazione e facendo della ricerca una pratica di azione e trasformazione sia socia-le che culturale.
tabella 13.1 Critiche mosse dalla psicologia di comunità e dal movimento delle donne (Mul-vey, 1988)
Critiche della psicologia di comunità alla psicologia clinica
Critiche delle donne mosse alla società
Il rapporto medico-paziente replica rapporti di dipendenza dei gruppi emarginati
La relazione tra i ruoli uomo/donna replica una relazione di dipendenza delle donne dal potere maschile
La psicologia clinica colpevolizza i pa-zienti
La società vittimizza e colpevolizza le donne
I criteri di definizione della malattia mentale sono creati da culture locali
La diagnosi psichiatrica ha l’uomo come parametro di sanità e quella della donna è intesa come “scarto” dal mo-dello maschile proposto
I problemi personali sono scissi da quelli sociali
Il concetto di “natura femminile” vei-cola un sessismo latente
La psicologia clinica incoraggia un adattamento alle norme stereotipali
La società incoraggia un adattamento ai ruoli tradizionali di genere
Le soluzioni individuali non funziona-no a causa delle disuguaglianze sociali: minoranze sociali e poveri sono com-parati a bianchi di classe media
Le soluzioni individuali non funziona-no a causa delle disuguaglianze: le don-ne sono comparate agli uomini
13. il genere tra epistemologia e trasformazione sociale
301
Domande di verifica
1. Cosa s’intende per maschile e femminile, sesso e genere?2. Cosa s’intende per stigma di genere?3. Cosa s’intende per rappresentazione di genere?4. Come costruire pari opportunità?5. Cosa s’intende per lgbtq?
Letture consigliate
arcidiacono c., di napoli i. (a cura di) (2012), Sono caduta dalle scale... I luoghi e gli attori della violenza di genere, FrancoAngeli, Milano.
“La camera blu. Rivista di studi di genere”, www.camerablu.unina.itgelli b. (2009), Psicologia della differenza di genere. Soggettività femminili
tra vecchi pregiudizi e nuova cultura, FrancoAngeli, Milano.mebane e. m. (2008), Psicologia delle pari opportunità. Per la promozione del
benessere individuale e sociale delle donne, Unicopli, Milano. procentese f. (2005), Padri in divenire. Nuove sfide per i legami familiari,
FrancoAngeli, Milano.vitelli r., valerio p. (2012), Sesso e genere. Uno sguardo tra storia e nuove
prospettive, Liguori, Napoli.
![Page 1: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Genere tra epistemologia e trasformazione sociale [Gender: epistemological category and promises for social change]. In S. Smiraglia (eds.) Elementi di Psicologia Sociale. Orientamenti,](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022410/63213dfc8a1d893baa0cf9ba/html5/thumbnails/21.jpg)