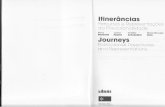Lingua e identita' sociale 2014
Transcript of Lingua e identita' sociale 2014
1 Lingua e identità sociale
L’analisi della relazione tra lingua e identità sociale è un campo accademico molto vasto e prolifico che, per ovvie ragioni di spazio, non può essere trattato per intero in questo capitolo. È utile però ricordare come l’identità possa scaturire attraverso i diversi processi di uso sociale della lingua1, sia ad esempio nell’interazione tra variabili sociali (genere, educazione, località, religione, ecc.) e stilistiche (scelte lessicali, fonetiche, ecc.), sia nella definizione di identità linguistica come associazione tra determinate espressioni di cultura e denominazioni specifiche di un idioma (Italiano, Swahili, Quechua, ecc.). La lingua è sicuramente uno degli strumenti fondamentali di trasmissione della cultura. Per questo, la lingua è da sempre vista come un elemento caratterizzante dell’identità individuale poiché (insieme all’etnia, religione, ecc.) identifica un parlante come appartenente a un determinato gruppo e, al tempo stesso, contribuisce all’identità collettiva del gruppo come elemento di differenziazione dagli altri gruppi. Per molto tempo questo stretto rapporto tra lingua e identità è stato visto in termini essenzialisti, statici e deterministici. Le lingue cioè sono spesso state rappresentate come espressioni “naturali” del carattere collettivo di un ethnos in grado di determinare o condizionare il modo di pensare dell’individuo. È questa l’interpretazione più “forte” dell’ipotesi whorfiana2 secondo cui attraverso la lingua non trasmettiamo solo il codice ma anche la visione stessa del mondo e della realtà codificate nelle strutture linguistiche. Questa nozione di lingua come qualcosa d’intrinseco all’individuo è però sempre meno favorita dalla linguistica e dall’area interdisciplinare di studi culturali che tendono a leggere l’ipotesi whorfiana in chiave più “debole” come relativismo culturale o, in forme più critiche, a confutarla completamente concependo la lingua principalmente come processo di costruzione
1 Secondo una definizione generica, la lingua rappresenta un sistema codificato di suoni e simboli che cipermette di comunicare il pensiero e interagire socialmente. Inoltre secondo la classica distinzione saussuriana (De Saussure, 1992) la lingua può essere vista distintamente come sistema sintattico di significanti-significati che esiste in forma astratta (langue) o come l’utilizzo pratico di tali strutture (parole).2
Secondo l’ipotesi di Sapir-Whorf, le strutture di una lingua influenzano e determinano il modo di pensare degli individui (Gumperz, 1996).
Franco Zappettini 2016 ©Varani, N., De Boni, F. Geografia Interculturale McGraw Hill
Lingua e identità sociale 2
sociale soggetto a dinamiche storiche, politiche, economiche e quindi fluido e in continuo cambiamento. Conviene così precisare che non è sempre possibile identificare una lingua come entità a sé stante se non con la cautela del relativismo storico e sociale. L’approccio strettamente linguistico che tende a classificare i sistemi linguistici secondo certi gradi di similitudine o differenziazione va dunque sempre integrato con diversi approcci geografici, sociali e storici essenziali a spiegare i mutamenti linguistici e della loro funzione all’interno della società.
Questo capitolo tratterà della relazione tra lingua ed identità sociale e, nella sua analisi, considererà sia gli aspetti propriamente linguistici sia quelli socio e geo-politici per una migliore comprensione del complesso fenomeno chiamato lingua. Pertanto, inizialmente, ci si soffermerà sulla distribuzione geografica delle lingue in rapporto alle variabili etniche e spaziali di pertinenza degli studi della geografia umana e sociale. Successivamente si considereranno le variabili sociali (genere, educazione, località, religione, ecc.) e stilistiche (varianti lessicali, sintattiche, fonetiche e, nel caso di bilinguismo/multilinguismo, l’uso separato o mescolato dei diversi codici linguistici come “marcatori d’identità”), proprie del campo d’indagine della sociolinguistica. Infine, ci si dedicherà alla politica della lingua e si tratterà di come la definizione di una lingua sia costruita principalmente su basi ideologiche con conseguenze sull’identità sociale (ad es. quali parlanti costituiscono una ‘minoranza’; quale variante è standardizzata).
1. La classificazione delle lingue e la loro distribuzione geografica e sociale
Una definizione precisa di quante lingue esistono nel mondo e della loro distribuzione geografica dipende ovviamente da come si definisce una lingua. Se, come anticipato nella prefazione di questo capitolo, per lingua intendiamo un sistema semiotico (suoni e segni associati a certi significati più o meno convenzionalizzati) utilizzato per esprimersi e interagire all’interno della società, è possibile una classificazione delle caratteristiche fonetiche, morfologiche e sintattiche dei diversi sistemi e una comparazione del loro grado di affinità o differenziazione. Questo è il campo di ricerca della linguistica comparativa che ha analizzato migliaia di sistemi linguistici evidenziando come, ad esempio, la lingua Rotokas parlata in Papua Nuova Guinea prevede solo 11 fonemi (a, e, g, i, k, o, p, r, s, t, u, v, e) mentre i gruppi Xóõ! stanziati in Namibia e Botswana hanno un repertorio fonetico costituito da 112 fonemi (tra cui il famoso suono click). La linguistica comparativa ha altresì evidenziato come esista anche una notevole varietà tra lingue dal punto di vista morfologico e sintattico. Ad esempio mentre l’italiano e molte lingue romanze derivate dal latino costruiscono la frase con l’ordine Soggetto-Verbo-Oggetto (SVO), l’arabo normalmente preferisce l’ordine VSO, mentre in turco, hindi, e giapponese l’ordine standard è SOV. Altri criteri di classificazione delle lingue comprendono le modalità di flessione di sostantivi e verbi (ad esempio se e come una lingua forma i plurali o usa affissi temporali per il futuro o il passato). Inoltre, secondo la misura in cui radice ed affissi
Lingua e identità sociale 3
si legano, le lingue possono essere classificate come isolanti (ad es. il vietnamita, il cinese e il tailandese), flessive (ad es. l’italiano e in genere le lingue romanze) ed agglutinanti (ad es. il turco, lo swahili, l’estone). Se ad esempio consideriamo la morfologia di una frase quale “a casa di mio padre” questa sarà espressa nelle diverse lingue con diversi gradi di agglutinazione come negli esempi seguenti:
trong ngôi nhà của cha tôi (vietnamita) în casa tatălui meu (rumeno) Babamin evinde (turco) Inoltre la classificazione delle lingue fa riferimento a ricostruzioni storiche ed
archeologiche che consentono di ipotizzare la derivazione di gruppi o ceppi di lingue da una lingua genitrice o proto-lingua comune. Il latino, ad esempio, ha dato origine alle lingue romanze: l’italiano, lo spagnolo, il francese, il portoghese, il rumeno, il catalano, il sardo ed il provenzale. Anche il proto-germanico si è evoluto in forme distinte, creando, da un lato, il gruppo di lingue germanico occidentali che comprendono il tedesco moderno, l’olandese e l’inglese e, dall’altro, differenziandosi nel gruppo scandinavo o germanico settentrionale di cui fanno parte il danese, lo svedese e l’islandese (esiste anche un terzo gruppo di lingue estinte detto germanico orientale o gotico). A loro volta il latino ed il proto-germanico (così come i gruppi di protolingue slave, celtiche, italiche, elleniche, indo-iraniane e baltiche) fanno parte di un ceppo comune chiamato indo-europeo che sarebbe stato parlato circa 6000 anni fa da popolazioni originarie delle steppe della Russia meridionale (spesso identificate con la cultura transpontica del Kurgan). La linguistica comparativa ha ricostruito circa 1500 vocaboli del proto-indoeuropeo dimostrando come tali vocaboli si siano trasformati in forme distinte attraverso cambiamenti fonetici regolari nel corso dei secoli. Ad esempio l’italiano cuore e il danese hjerte derivano rispettivamente dal latino cordis e dal proto germanico hertò, a loro volta entrambi derivati da una radice comune indo europea ricostruita come k ̑ered (cfr. il greco moderno kardià, il russo serdtse e l’hindi hriday). Attraverso questa ricostruzione filologica spesso la classificazione delle lingue usa la metafora delle famiglie linguistiche per rappresentare diversi rami genealogici, cioè gruppi linguistici derivati da una lingua “genitrice” (vedi Figura 1).
Lingua e identità sociale 4
Figura 1. Distribuzione odierna delle lingue derivate dall’Indo-Europeo per famiglia: 1. Ellenico 2. Lingue indo-iraniane 3. Lingue romanze 4. Lingue celtiche 5. Lingue germaniche 6. Armeno 7. Lingue baltiche 8. Lingue slave 9. Albanese
Fonte: vedi nota bibliografica 1
Fellman et al (2011) raggruppano le lingue del mondo nelle seguenti principali famiglie linguistiche:
− Lingue indo-europee − Lingue uro-altaiche − Lingue sino-tibetane − Giapponese-coreano − Lingue dravidiche − Lingue afro-asiatiche − Lingue niger-kordofaniane (Niger-Congo) − Lingue sudanesi
Lingua e identità sociale 5
− Lingue nilo-sahariane − Lingue del gruppo khoisanide − Lingue paleo-asiatiche − Lingue austroasiatiche − Lingue malayo-polinesiane − Lingue australiane − Lingue amerinde − Lingue eschimesi-aleutine − Lingue papuasiche − Lingue caucasiche
Inoltre questi gruppi a loro volta si possono suddividere in altri 100-300
sottofamiglie. Per quanto riguarda il numero d’idiomi specifici le stime più recenti indicano che attualmente esisterebbero oltre 7000 lingue parlate nel mondo (www.ethnologue.com). Tale numero non include le lingue morte (che sono decisamente molte più di quelle attualmente parlate) ed è soggetto a contrarsi ulteriormente. Le lingue con il maggior numero di parlanti sono elencate nella tabella 1. (N.B. questi dati statistici tendono a variare secondo i criteri usati per la definizione di parlanti L1 o L2 (cfr. box 1 sotto)).
Tabella 1. Lingue parlate da almeno 45 milioni di persone come prima lingua (L1) (Fonte www.ethnologue.com integrato con altri dati statistici provenienti da vari siti Internet).
Denominazione Lingua Famiglia Parlanti (milioni)
1 Cinese mandarino Sino-Tibetano 1151 2 Inglese Indo-Europeo 1000 3 Spagnolo Indo-Europeo 500 4 Hindi Indo-Europeo 490 5 Russo Indo-Europeo 277 6 Arabo Afro-Asiatico 255 7 Portoghese Indo-Europeo 240 8 Bengalese Indo-Europeo 215 9 Francese Indo-Europeo 200
10 Malese, Indonesiano Malese-Polinesiano 175 11 Tedesco Indo-Europeo 166 12 Giapponese Altaico 132 13 Farsi (Persiano) Indo-Europeo 110 14 Urdu Indo-Europeo 104 15 Punjabi Indo-Europeo 103 16 Wu (o Shanghainese) Sino-Tibetano 90 17 Vietnamita Austroasiatico 86 18 Giavanese Malese-Polinesiano 85 19 Tamil Dravidiano 78 20 Coreano Altaico 78
Lingua e identità sociale 6
21 Turco Altaico 75 22 Telugu Dravidiano 74 23 Marathi Indo-Europeo 72 24 Italiano Indo-Europeo 62 25 Tailandese Sino-Tibetano 60 26 Burmese Sino-Tibetano 56 27 Cantonese Sino-Tibetano 55 28 Kannada Dravidiano 47 29 Gujarati Indo-Europeo 46 30 Polacco Indo-Europeo 46
Box 1 – Definizione di L1, L2 e LS
Con Lingua 1 (L1) s’intende normalmente la lingua che un individuo impara per prima (talvolta è anche detta lingua materna). È’ dunque l’idioma della prima socializzazione e degli affetti; questo può essere un dialetto e non necessariamente rappresenta la lingua ufficiale del Paese di appartenenza del parlante. Con Lingua (L2) si intende una lingua appresa successivamente all’L1 normalmente attraverso la scolarizzazione: questa può essere la lingua nazionale o una delle lingue ufficiali del Paese in cui avviene la scolarizzazione, o una lingua franca di larga diffusione. Inoltre un individuo può apprendere una o più lingue come lingua straniera (LS) ad esempio nella scolarizzazione superiore o per altri motivi. Sebbene il processo di acquisizione di una lingua sia influenzato dalla precocità di apprendimento, i livelli di competenza linguistica raggiungibili possono dipendere da diverse variabili (motivazione, prestigio, affinità tra L1 e L2, ecc.).
Inoltre se si considerano le lingue parlate da almeno un milione di persone nel mondo come L1 o L2 (attualmente 389) si possono fare alcune riflessioni. Queste lingue costituiscono il 6% del numero totale di lingue esistenti mentre i parlanti di queste lingue rappresentano il 94% della popolazione mondiale. Per contro, il restante 94% del numero di lingue esistenti è parlato da un numero di persone che costituisce il 6% della popolazione mondiale. Questo sostanzialmente ci dice che la diversità linguistica a livello mondiale sta subendo una rapida contrazione con, da un lato, poche lingue (le cosiddette lingue di grande comunicazione) che risultano estremamente vitali (rischio di estinzione=0), e dall’altro lato, un gran numero di lingue che sono pressoché estinte o che si stanno estinguendo (rischio di estinzione=9) (cfr. https://www.ethnologue.com/statistics/status). La previsione è che nel 2100 sopravvivranno non più di 600 delle lingue attualmente utilizzate nel mondo. È importante notare che, secondo la sistematizzazione linguistica per famiglie, la distribuzione geografica non sempre segue la logica della ramificazione filologica. Ad esempio, nonostante la maggioranza delle lingue parlate nel continente europeo sia di origine indoeuropea, esistono tuttavia lingue come l’ungherese, l’estone, il finnico ed il basco (Euskara) che non appartengono alla famiglia indoeuropea (le
Lingua e identità sociale 7
prime tre sono di ceppo ugro-altaico mentre il basco è di origine sconosciuta). Queste differenze sono ancora più accentuate negli altri continenti, dove esiste un’elevata frammentazione linguistica dovuta a processi migratori che intrecciano le relazioni linguistiche con le dinamiche storiche e sociali del territorio. Una mappa della distribuzione delle lingue nel mondo limitata alla famiglia di appartenenza pertanto ci offre una rappresentazione parziale che spesso non può dire molto sulla dimensione sociale del linguaggio come il prestigio sociale percepito di una lingua o sul fatto che un individuo possa essere bilingue o multilingue. A questo proposito è bene fare una distinzione tra il bilinguismo ed il multilinguismo come distinti fenomeni personali e sociali. Nella dimensione personale il bi-multilinguismo si riferisce all’abilità individuale di parlare più di una lingua, mentre nella sua dimensione sociale indica la coesistenza di più lingue all'interno di una società (senza che necessariamente tutti i componenti della società abbiano abilità bi-multilinguistiche). A livello sociale, il bi-multilinguismo è sicuramente la norma nella maggior parte dei Paesi del mondo, anche se si tende a rappresentare le società nazionali come linguisticamente omogenee. A livello individuale le stime sono più difficili perché dipende se si considerano forme dialettali (cfr. par. 3 di questo capitolo) e i diversi livelli di competenza L1-L2-LS del parlante. Tuttavia si ritiene che più della metà e forse tre quarti della popolazione mondiale utilizzi due o più lingue (o dialetti) nella vita quotidiana (Grosjean, 2010; Crystal, 2011).
2. Lingue in contatto e mutamenti linguistici
Frequentemente, nel corso della storia, ci sono state forme di contatto tra i parlanti di lingue diverse ad esempio attraverso scambi commerciali, culturali o religiosi, attraverso guerre e conquiste, relazioni coloniali e naturalmente a seguito di processi migratori. Quando due lingue entrano in contatto, si possono pertanto produrre diversi gradi di “frattura” e trasformazione delle lingue in oggetto che dipendono da una serie di variabili quali, ad esempio, il grado di somiglianza tra le lingue, la durata del contatto tra i gruppi e il tipo di relazione sociale, economica e politica che esiste tra i gruppi. Ad esempio il risultato degli incontri culturali legati alla colonizzazione è spesso stato la supremazia della lingua egemone e l’estinzione di quella socialmente ed economicamente più debole com’è accaduto per la maggior parte dei dialetti nativi amerindi e di quelli aborigeni dell'Australia che si persero in seguito alla colonizzazione britannica. Qui, a sua volta, la lingua “dominante” ha iniziato a svilupparsi autonomamente, dando origine, col tempo, a una varietà distinta: pensiamo all’inglese americano o a quello australiano, al portoghese brasiliano, o allo spagnolo sudamericano. Va anche ricordato che esistono casi d’isolamento linguistico come ad esempio il tedesco parlato dalla comunità Amish della Pennsylvania che ha mantenuto pressoché intatte le caratteristiche dei dialetti dei coloni provenienti dalle regioni del Reno, dell’Alsazia e dalla Svizzera grazie alla particolare struttura sociale endogena della comunità in oggetto.
Lingua e identità sociale 8
Talvolta i cambiamenti sono principalmente lessicali e riguardano l’adozione o prestito di vocabolario. Nel caso della Media Lengua dell'Ecuador, l’influenza dello spagnolo si è manifestata in maniera decisiva con l’incorporazione di un vocabolario neolatino (circa il 90%) nelle strutture grammaticali proprie del Quechua (un gruppo di lingue native delle Ande). In altri casi il prestito si è limitato a calchi linguistici, cioè neologismi modellati sulla lingua di provenienza (ad es. grattacielo coniato sul modello inglese skyscraper). I prestiti linguistici scaturiscono dall’esigenza di colmare lacune lessicali legate ai nuovi artefatti culturali o alle nuove scoperte. Ad esempio, seppur con diverse varianti fonetiche ed ortografiche, gran parte delle lingue europee ha adottato i termini patata e tabacco dalle lingue caraibiche con cui gli esploratori spagnoli entrarono in contatto e attraverso le quali conobbero quei nuovi prodotti. Per lo stesso motivo gli scambi culturali del Rinascimento hanno introdotto termini italiani come stucco, ballerina, opera e, più recentemente, molti termini culinari in un gran numero di lingue europee e non.
In molti casi il mutamento è avvenuto a livello fonetico e/o ortografico: come visto brevemente nella sezione precedente le lingue indoeuropee si sono create attraverso cambi regolari dei fonemi originali del proto-indoeuropeo che alcuni studi attribuiscono ad interferenze fonetiche di popolazioni locali (cfr. le trasformazioni di pitar (sanskrito), pater (latino e greco), padre (italiano), Vater (tedesco) e father (inglese)). In altri casi i mutamenti possono essere più strutturali e manifestarsi in trasformazioni morfologiche e sintattiche come ad esempio la perdita dei casi, la grammaticalizzazione di certi vocaboli e così via. Bisogna tener conto inoltre che molto spesso i cambiamenti a livello lessicale, fonetico e sintattico avvengono in maniera dinamica e interdipendente tra di loro attraverso la fusione di un nuovo sovrastrato con un substrato già esistente che porta ad un accumulo graduale delle influenze e dei mutamenti nel corso dei secoli. Per esempio, la lingua maltese è una stratificazione di strutture linguistiche del gruppo semitico (filologicamente affine all’arabo) con strati lessicali derivati dal siciliano, dallo spagnolo, dal francese e dall’inglese. Un altro esempio di stratificazione è l’inglese moderno che nasce su un substrato germanico con successive stratificazioni di cui la più importante è quella legata all’invasione normanna (cfr. Approfondimento 1).
Approfondimento 1I mutamenti linguistici nella storia della lingua inglese
La storia della lingua inglese nasce con le migrazioni degli Angli, dei Sassoni e degli Juti, tribù di origine germanica che giunsero nell’attuale Gran Bretagna intorno al quinto secolo D.C. quando ormai era avvenuto il ritiro dei Romani dalla provincia Britannia. Le tribù anglosassoni si stanziarono principalmente nel sud-est e nel centro dell’Inghilterra mentre le popolazioni di origine celtica (già presenti sul territorio da parecchi secoli) rimasero dove l’avevano confinate i Romani, cioè nel nord e nell’ovest (per questo la Scozia ed il Galles sono tuttora le aree di prevalente parlata tradizionale celtica). I dialetti celtici hanno contribuito pochissimo all’inglese moderno se non per alcuni toponimi. I dialetti parlati dalle popolazioni anglosassoni, invece, cominciarono a fondersi creando diverse varietà regionali di quello che ora viene considerato l’Old English. Questa
Lingua e identità sociale 9
forma di lingua anglosassone si consolidò con l’unificazione dei vari regni regionali nel regno d’Inghilterra sotto Alfredo il Grande. Di questo periodo esistono varie testimonianze scritte tra cui il famoso Beowulf (VIII secolo opera di anonimo). L’inglese del Beowulf è ancora una lingua sostanzialmente germanica e praticamente incomprensibile ai parlanti dell’inglese moderno. L’invasione di popolazioni di origine scandinava intorno all’ottavo secolo D.C. portò nuovi cambiamenti linguistici. Anche se per un certo periodo gli insediamenti vichinghi rimasero concentrati nella parte nord-ovest della penisola britannica (ad est dello storico confine chiamato Danelaw), ci furono molti contatti tra le popolazioni anglosassoni e vichinghe. Il fatto che la lingua parlata da vichinghi ed anglosassoni (entrambe derivata dal proto germanico) fossero reciprocamente comprensibile facilitò in una certa misura un processo di fusione ed assimilazione delle due lingue. Questo tipo di trasformazioni sono particolarmente evidenti nel dittongo sk. Parole che in proto germanico utilizzano sk furono palatalizzate nell’Old English diventando sh (cfr. fisk → fish; skal → shall). Tuttavia parole che non furono originariamente importate dalle tribù anglosassoni rientrarono nell’Old English attraverso la forma scandinava che mantiene il suono duro ad esempio sky, skin. Esistono anche casi di vocaboli come shirt e skirt che hanno la stessa etimologia, ma si sono differenziate semanticamente e che oggi coesistono nell’inglese moderno. Un altro importante cambiamento avvenne con l’arrivo dei Normanni nel 1066. Sebbene di origine scandinava i Normanni che arrivarono in Gran Bretagna provenivano dalla vicina Francia settentrionale dove si erano integrati con la nobiltà franco-carolingia. La lingua che portarono era pertanto una lingua d’oïl con vocaboli e strutture di derivazione latina. Per un certo periodo la lingua dei Normanni rimase parlata solo dalla classe dirigente ed aristocratica mentre le classi sociali più basse continuarono a parlare l’Old English. Questa differenziazione sociolinguistica si ritrova ad esempio ancora oggi con vocaboli di origine anglosassone usati per indicare l’animale (pig, sheep/lamb, ox/cow) e vocaboli di origine normanna con cui si indica la carne (pork, mutton, beef). Progressivamente, però, l’Anglo-Normanno, soppiantò le due lingue dando origine al cosiddetto Middle English intorno al XIV secolo. Questa forma di inglese è ancora in gran parte fondata sulle strutture germaniche ma ha già perso la flessione dei casi e, nel lessico, usa circa il 50% di vocaboli di etimologia latina. Inoltre tra il 1400 ed il 1600 si assiste al cosiddetto grande spostamento vocalico (great vowel shift) con cui cambia il modo in cui si pronunciavano le vocali. Ad esempio meat - che inizialmente era pronunciata mɛːt (una pronuncia simile all’ortografia) - viene sempre più pronunciata mi:t (vicino alla pronuncia attuale). Questo non viene registrato nella grafia ed è per questo che oggi lo spelling inglese può essere problematico per i non madrelingua. Al tempo in cui scriveva Shakespeare il cambiamento vocalico era pressoché completato ed è per questo che la lingua di Shakespeare è già sostanzialmente comprensibile ad un parlante dell’inglese moderno. Dal XVII secolo in poi l’inglese moderno (Modern English) si espande al di fuori delle isole britanniche grazie all’impulso coloniale. In quest’ultimo periodo i mutamenti sono pochi e riguardano principalmente l’introduzione di nuovi vocaboli presi a prestito dalle lingue etniche delle colonie ad esempio bungalow, curry, mango, teak, jungle derivati da lingue del subcontinente indiano. Negli ultimi 150 anni l’espansione mondiale della lingua inglese è continuata seguendo l’espansione economica degli Stati Uniti che l’ha reso, di fatto, la lingua franca globale. Oggi il numero di coloro che parlano l’inglese come lingua straniera (1 miliardo) supera di gran lunga quello degli individui per i quali è la lingua madre. In Internet l’inglese rimane la lingua dominante anche se altre lingue stanno crescendo ad un tasso superiore. Quale sarà il futuro della lingua
Lingua e identità sociale 10
inglese? Alcuni studiosi ritengono che succederà all’inglese quello che è successo al latino con le lingue romanze cioè una sempre maggiore frammentazione e differenziazione tra le varianti ‘non standard’ di diversi world Englishes, i cosiddetti Chinglish, Franglais, Hinglish, Konglish, Singlish, Spanglish, ecc. (vedi figura 2).
Figura 2. Un cartello in Spanglish che
pubblicizza una casa in affitto in un quartiere a maggioranza ispanica nella città di Desoto in Texas. Si nota l’uso del lessico inglese to rent (dare in affitto) con una costruzione sintattica spagnola (l’impersonale se e l’accordo verbale della terza persona singolare).
Fonte: vedi nota bibliografica 2
In alcuni casi i mutamenti morfologici e sintattici possono portare alla creazione di
nuovi idiomi, come nel caso dei pidgin3 e delle lingue creole. Il pidgin (un nome che sembra derivare dalla pronuncia cinese della parola inglese business) è una forma di lingua franca (box 2), cioè una lingua semplificata che usa elementi delle lingue madri dei parlanti. Esistono molti esempi di pidgin: negli scambi tra russi e norvegesi nel XIX secolo, si utilizzava il russonorsk, una miscela di vocaboli di entrambe le lingue, mentre nel Pacifico nord-occidentale, tra il Canada e l’odierno Oregon era diffuso il Chinook basato sulla lingua dei popoli nativi dell’area che vennero in contatto con coloni inglesi e francesi. Nelle miniere di minerali e diamanti del Sudafrica, Namibia e della Repubblica Democratica del Congo si è sviluppato un pidgin chiamato fanagalo che usa elementi delle lingue zulu, dell’afrikaans, ed dell’inglese. Mentre il pidgin rappresenta una L2 (cioè non è lingua madre di nessun parlante) ed ha normalmente una grammatica molto semplice, le strutture grammaticali del pidgin possono essere codificate e standardizzate e diventare la L1 delle generazioni successive dando così origine ad una lingua creola4. Sebbene molti di questi idiomi siano caduti in disuso, si stima che attualmente esistano circa 350 pidgin e lingue creole parlate da 100 milioni di persone. Alcune di queste lingue
3 Il pidgin è una lingua di comunicazione usata tra parlanti di due lingue diverse. Il pidgin si caratterizza per forme lessicali e grammaticali semplificate. 4 La parola creolo deriva dal francese créole e dallo spagnolo criollo ed entrò in uso in queste lingue per significare “nato e cresciuto in una certa località” (cfr. lo spagnolo criar (allevare) a sua volta derivato dal latino “creare”).
Lingua e identità sociale 11
creole sono addirittura diventate lingue ufficiali di alcuni Stati, ad esempio il papiamento (una miscela di portoghese e spagnolo) ad Aruba, Bonaire e Curaçao; il bislama a Vanuatu; ed il Tok Pisin (corruzione fonetica di Talk Pidgin) in Papua Nuova Guinea. Ancora più rilevante è l’importanza acquisita dal creolo haitiano e dallo Swahili. Il creolo haitiano si originò attraverso il commercio degli schiavi che i francesi operavano tra l’Africa occidentale e le isole caribiche. È pertanto una lingua di base francese con influenze spagnole, portoghesi e di varie lingue indigene africane. Con il tempo è diventato la lingua ufficiale di Haiti (insieme al francese) dove è parlato da oltre dieci milioni di persone (circa il 95% della popolazione haitiana). Ciò fa della nazione haitiana la più grande comunità di parlanti creoli del mondo. Inoltre, a seguito della diaspora haitiana, si sono create importanti comunità haitiane nelle principali città del Nord America dove l’haitiano è spesso usato come lingua supplementare nei servizi pubblici: ad esempio la metropolitana di Boston effettua annunci sia in inglese che in creolo haitiano mentre a Miami gli autobus hanno spesso scritte trilingue (cfr. Fig. 3).
Lo Swahili è un pidgin creato a partire da una serie di dialetti bantu con prestiti lessicali dall’arabo. Nato in corrispondenza delle zone costiere dell’Africa orientale, si è poi diffuso verso l’interno seguendo inizialmente le carovane arabe che trasportavano schiavi e avorio e, successivamente, lungo le rotte commerciali usate durante la dominazione coloniale inglese e tedesca. Oggi lo Swahili è parlato da circa quindici milioni di persone ed è diventato una delle lingue ufficiali di Kenya, Tanzania, Uganda, Repubblica Democratica del Congo, Isole Comore, Zanzibar, e dell’Unione Africana, oltre che, di fatto, funzionare come lingua franca tra questi Paesi (cfr. Fig. 4).
Figura 3. Iscrizione trilingue su un autobus
di linea a Miami, Florida, USA. La scritta riflette le tre principali comunità linguistiche che convivono nella città: anglofona, ispanica ed haitiana. Fonte: vedi nota bibliografica 3.
Lingua e identità sociale 12
Figura 4. Area di diffusione
dello Swahili. Fonte: vedi nota bibliografica 4.
Box 2 - Le lingue franche La lingua franca è lo strumento usato per la comunicazione da due o più gruppi di parlanti che entrano in contatto, spesso per commercio, e che non conoscono la lingua dell’altro. La necessità di comunicare induce i parlanti dei gruppi a ricorrere ad un linguaggio semplificato che usa vocaboli delle due lingue. In senso stretto il termine lingua franca si riferisce alla lingua usata a partire dall’anno 1000 dai commercianti nel bacino del Mediterraneo che usavano una misto di vocaboli italiani, francesi spagnoli, e arabi. In un senso più ampio, il termine lingua franca è passato a significare qualunque lingua veicolare che consenta la comunicazione tra parlanti di lingue diverse. In senso lato si può pertanto parlare di lingua franca anche quando due gruppi di parlanti ricorrono ad una terza lingua conosciuta da entrambi (come è avvenuto, in diverse epoche storiche con il latino, il greco, l’arabo, il francese e l’inglese).
2.1 Le dinamiche sociali dei cambiamenti linguistici Quanto finora discusso ci porta alla considerazione che storicamente i
cambiamenti linguistici sono processi estremamente dinamici e fluidi e che, in diversa misura, molte lingue si sono create attraverso processi di “creolizzazione” in cui le trasformazioni linguistiche sono frutto e simbolo di cambiamenti culturali, sociali e storici. Come studiato dalla sociolinguistica del contatto, le ragioni e le dinamiche per cui, ad esempio, certe varianti fonetiche o lessicali entrano in uso e si attestano come forme standard di uno o più gruppi possono essere molteplici. Spesso il prestigio sociale percepito di una certa forma lessicale o fonetica e la sua diffusione di massa
Lingua e identità sociale 13
attraverso l’istruzione ed i mass media fa sì che i parlanti producano la stessa variazione, ad esempio la Received Pronunciation (RP) del sud-est inglese. Questo processo tuttavia non avviene solo per convergenza ma può anche avvenire per divergenza, cioè attraverso il distanziamento del parlante da forme percepite come negative o meno prestigiose (ad esempio la RP può essere associata alle classi abbienti ed istruite ed usata in contrasto con le varianti lessicali e fonetiche dell’inglese cockney o del nord). Inoltre i processi di convergenza e divergenza delle varianti linguistiche sono soggetti a specifiche contingenze storiche e geografiche: basti pensare alle forme di accento non-rotico (l’omissione della pronuncia della consonante r) che tende ad essere associato con forme di prestigio sociale solo nella Gran Bretagna degli ultimi 50 anni mentre in epoca georgiana o vittoriana aveva associazioni opposte. Inoltre lo stesso accento non-rotico nella New York degli anni 60 aveva valenza sociale negativa mentre l’opposto accento rotico contraddistingueva le classi sociali superiori (Labov, 2006).
La stessa differenziazione sociale si riscontra nelle società bilingue o multilingue dove i diversi codici si differenziano funzionalmente - ad esempio nella distinzione d’uso tra ambiti formali ed informali - e i contesti sociali determinano l’uso del codice più appropriato. Questa situazione è chiamata diglossia, triglossia o poliglossia (se rispettivamente riguarda due, tre o più lingue). In situazioni diglossiche una lingua è considerata la varietà più prestigiosa ed è usata in contesti formali come nell’istruzione e nei rapporti con le istituzioni civili e religiose, mentre l’altra varietà è principalmente utilizzata in contesti informali come nelle relazioni in famiglia o tra amici. Ad esempio ad Haiti il francese ha funzione formale mentre il creolo haitiano ha funzioni informali; nel mondo arabo la lingua del Corano (arabo classico o letterario) riveste principalmente funzioni formali o religiose mentre nelle relazioni quotidiane si tende ad usare l’arabo colloquiale nelle sue varianti regionali. Spesso però in contesti sociali multilingue, i diversi codici possono essere preferiti perché riflettono percezioni di identità etnica e culturale e quindi assumono valenze specifiche in termini di rapporti di forza politica ed economica come nel caso del francese e l'inglese in Canada ed in particolare nel Québec. Il Québec è una provincia che ha sempre mantenuto importanti legami con la Francia esprimendo la propria identità anche attraverso l’uso della lingua francese. Nel Québec il francese è parlato da circa il 90% della popolazione e da circa i due terzi degli abitanti di Montréal - la citta principale – dove di fatto rappresenta la lingua franca di comunicazione della città. La minoranza anglofona (circa il 12%) tuttavia ha sempre esercitato una forte dominanza economica. Nel 1977, a seguito di una grossa campagna antianglofona, venne passata la Legge 101 che riconobbe il francese come unica lingua ufficiale e rese obbligatoria l’istruzione in francese anche per gli immigrati, oltre ad imporre tutta la segnaletica dei negozi e la pubblicità solo in francese (una normativa tuttavia resa meno restrittiva dalla successiva Legge 178 che in parte modificò e ridusse tali requisiti). Un altro caso di tensione legata a identità linguistiche di due gruppi è rappresentato dal Belgio. Lo stato belga nacque dall’accorpamento delle comunità vallone (di lingua francese) e fiamminga (di lingua olandese) oltre ad una minoranza tedesca. Inizialmente il francese fu adottato come unica lingua ufficiale e dell’istruzione e per molto tempo godette del rango di prestigio mentre il fiammingo
Lingua e identità sociale 14
venne relegato ad un uso vernacolare. Successivamente, a seguito dei cambiamenti economici e sociali legati alla chiusura delle miniere nella parte vallone e alla crescita dell’economia fiamminga, iniziò un’azione politica che portò al riconoscimento del fiammingo come lingua ufficiale insieme al francese e al tedesco. Nonostante oggi il territorio belga sia ufficialmente trilingue, questa definizione è da intendersi piuttosto come coesistenza di due comunità parlanti lingue diverse all’interno di un’unità geografica demarcata da un netto “confine linguistico” che riflette notevoli tensioni sociali tra le comunità vallone e fiamminga. Per contro, sebbene Bruxelles rappresenti un’enclave francofona in territorio fiammingo, la maggioranza dei suoi abitanti è bi-trilingue a livello personale in quanto conosce sia francese che fiammingo (e molto spesso anche il tedesco e l’inglese).
3. Lingua o dialetto? La politica dell’identità linguistica
Come abbiamo visto nelle sezioni precedenti, la definizione di lingua basata su criteri lessicali, fonetici e sintattici consente una classificazione dei diversi sistemi di codice secondo il loro grado di affinità. Codici filologicamente parenti vengono così considerati parte dello stesso gruppo linguistico mentre le diverse varianti di un codice che sono “reciprocamente comprensibili” (cfr. box 3) vengono considerate dialetti. La “comprensibilità reciproca” tuttavia è un concetto generico che va interpretato in termini di gradualità non solo spaziale o geografica (la continuità dialettale) ma anche sociale. Oltre alle varianti regionali di un codice, infatti, esistono anche codici linguistici che usano vocaboli e locuzioni che sono proprie di certi ambiti professionali o che sono preferite da gruppi accomunati, per esempio, da età, religione o orientamento ideologico (i socioletti). Inoltre, ognuno di noi tende ad usare la lingua in maniera individuale attraverso l’uso idiosincratico del lessico, della pronuncia, del registro, ecc. Per questi motivi, per certi linguisti un dialetto può essere anche rappresentato dalle microvarianti degli idioletti personali. Sono stati sollevati anche problemi rispetto all’idea di comprensibilità perché la comprensibilità ha una componente individuale e motivazionale e può anche essere “assimetrica” anziché reciproca, cioè funzionare in una sola direzione. In questo caso la spiegazione più plausibile di come, ad esempio, un parlante della varietà americana d’inglese abbia più difficoltà a capire un parlante della varietà scozzese d’inglese che non viceversa risiede nel fatto che ci sono molte più opportunità di essere esposti alla variante americana (attraverso televisione, film, musica, ecc.) piuttosto che nelle caratteristiche intrinseche delle due varianti. Occorre quindi tener presente che, oltre a criteri linguistici, esistono anche diverse variabili sociali che determinano vari gradi di comprensibilità e che il criterio di comprensibilità reciproca va pertanto interpretato in forma relativa e non assoluta, cioè come una scala di diversi gradi.
Lingua e identità sociale 15
Lo stato-nazione è i l p r i n c ip i o s e c o n d o cu i i l t e r r i t o r i o d i cu i lo S ta to è s o v ra n o co i n c i d e co n la n a z io n e . I l te r m i n e “ n a z io n e” è c o n t ro v e rs o m a é d a m o l ti i n te rp r e ta to co m e g r u p p o c u ltu r a lm en t e o m o g e n e o . C i s o n o p o ch i e s e m p i a l m o n d o d i s ta ti -n a z io n e n e l s i g n if ic a to s t r e tt o d e l te r m i n e ( a d e s em p io i l G ia p p o n e e l ’ Is la n d a ) m en t re la m a g g i o r p a r t e d e g l i s ta ti -n a z io n e m o d er n i s o n o c o s t ru z io n i p o li ti c h e (a d e s e m p i o i l B e lg i o d o v e a l l ’ in t e r n o d e l lo S ta to e s i s to n o g r u p p i d i s t in t i c u ltu r a lm en t e : i v a l lo n i e d i fi a m m in g h i) . L a li n g u a i n s i em e a ll ’e tn i a e a l la r e li g io n e è s e m p r e s ta ta ch i a m a ta i n c a u s a n e lla c o s t ru z io n e d e llo s ta to s i a c o m e e le m e n to e tn i co - c u ltu r a le ( v e d i i l R o m a n ti c is m o te d es c o ) c h e c o m e q u es ti o n e c i v ic a ( v e d i lo s ta t o fr a n c es e d i L u ig i X IV ) .
Box 3 - La comprensibilità reciproca di due codici linguistici
In linguistica una delle discriminanti più usate per stabilire la distinzione tra lingua e dialetto è il principio di “comprensibilità reciproca”. Due codici sono considerati reciprocamente comprensibili se i parlanti di un codice riescono a capire con relativa facilità i parlanti dell’altro codice (e viceversa) senza dover imparare il codice altrui. Una continuità dialettale di comprensibilità reciproca è una catena di dialetti geograficamente adiacenti ai cui estremi i codici non sono più reciprocamente comprensibili. Ad esempio il Rhineland rappresenta una continuità dialettale delle lingue germaniche che segue il corso del Reno dall’Olanda alla Svizzera meridionale. Talvolta esistono però “interruzioni” della continuità dialettale in prossimità delle zone di confine che possono essere spiegate con l’attrazione di un dialetto verso la sfera di standardizzazione della lingua nazionale dello stato di appartenenza (vedi sotto).
Inoltre la relatività della distinzione tra lingua e dialetto deve fare riferimento a specifiche condizioni sociali, storiche, politiche, economiche che fanno sì che una forma dialettale venga standardizzata come lingua e percepita come più prestigiosa degli altri dialetti. In questo senso è quindi importante notare come la lingua non sia un’entità fissa e come ciò che costituisce la forma standard di una lingua non sia un fatto naturale ed oggettivo ma una costruzione sociale. La distinzione tra lingua e dialetto quindi può spesso essere il prodotto ideologico dello stato-nazione piuttosto che scaturire da criteri puramente linguistici. Storicamente, la formazione e la standardizzazione di una lingua nazionale è spesso stata dettata dalla necessità dello stato-nazione di diffondere sul territorio un sistema di comunicazione che facilitasse l’amministrazione, l’istruzione e la vita pubblica. Al tempo stesso, una lingua unificata ha contribuito al senso di appartenenza dei cittadini alla nazione e alla riproduzione dell’identità nazionale. Pertanto, quelle che oggi definiamo lingue nazionali sono spesso i dialetti delle città o regioni dove era nato e si era sviluppato il potere economico e politico dello stato. Ad esempio, il francese è, di fatto, il dialetto parigino che tra il XII e il XV secolo venne esportato ed imposto al resto del territorio nazionale. Lo stesso accadde con il dialetto della regione castigliana che, in seguito alla reconquista del 1492, assurse allo status di lingua nazionale spagnola. Da questo punto di vista, molti linguisti concordano con l’aforisma (spesso attribuito a Max Weinreich) che “una lingua è un dialetto con un esercito ed una marina militare”.
Lingua e identità sociale 16
I n g eo g ra f ia li n g u i s t ic a u n ’isoglossa è u n a l in e a c h e d e li m ita u n ’a r ea ca r a tt e r iz z a ta d a u n d e te rm in a to fe n o m e n o li n g u is ti c o (a d e s . l ’u s o p a r t ic o la r e d i u n a cc e n to o u n a f o r m a le s s i c a le ) .
Spesso è stato il desiderio di differenziare un codice linguistico nazionale da quello di un altro stato che ha portato alla creazione e standardizzazione di un dialetto come lingua. Ad esempio, per molti secoli la lingua usata in Norvegia è stato il Bokmål, sostanzialmente una variante del danese parlato durante i circa 400 anni di dominazione danese. Il movimento indipendentista che portò alla costituzione della Norvegia moderna cercò anche una variante più “pura” e rurale della lingua nazionale secondo l’ideologia romantica ottocentesca. Venne cosi introdotto il Nynorsk un dialetto delle regioni più occidentali, ma sempre strettamente imparentato con le altre lingue scandinave. Oggi esistono due forme ufficiali di norvegese (oltre al Sami riconosciuto come lingua etnica): il Bokmål e il Nynorsk. Questo tipo di confronto ideologico è continuato anche nel XX secolo. Nella federazione jugoslava il serbo-croato rappresentava una delle lingue ufficiali dell’ex-Jugoslavia ed era basato su una forma standardizzata di dialetti serbi e croati (di matrice slava e reciprocamente comprensibili) che era avvenuta nel XIX secolo. Gli stati indipendenti che emersero della dissoluzione della federazione jugoslava ufficializzarono il serbo-croato come lingua propria rinominandolo ad hoc (croato in Croazia e serbo in Serbia) e dando a queste lingue una caratterizzazione più “nazionale” attraverso la differenziazione di alcuni vocaboli ed il diverso sistema di scrittura cirillico e romano. Inoltre il serbo-croato è diventato la lingua ufficiale della Bosnia e del Montenegro, dove è stato rispettivamente chiamato bosniaco e montenegrino. Nel complesso, croato, serbo, bosniaco e montenegrino costituiscono quattro codici di comunicazione che dal punto di vista linguistico sono varianti della stessa lingua ma che ufficialmente hanno lo status di lingue separate.
Contrariamente a quanto detto finora, esistono numerosi esempi di come la definizione di una lingua nazionale abbia portato a considerare dialetti quei codici che, dal punto di vista linguistico, sono invece propriamente lingue distinte. Ad esempio, nell’accezione comune, ci si riferisce spesso ai vari idiomi parlati in Cina come dialetti del “cinese”. In realtà, il cantonese, l’hakka e molti altri idiomi del centro e del sud della Cina non hanno nulla in comune con il mandarino (il dialetto di Pechino che in forma standardizzata è diventato la lingua dello stato cinese) se non alcuni ideogrammi quali ‘casa’ o ‘riso’ che appartengono alla lingua scritta basilare che ogni cinese impara a scuola. Anche nel caso dell’italiano spesso il termine dialetto è usato in maniera impropria (quantomeno in base al criterio di comprensibilità reciproca) perché i dialetti “italiani” non rappresentano varianti regionali della lingua italiana standard, né si sono storicamente sviluppati da essa. Come sappiamo, la lingua italiana fortemente voluta dal movimento intellettuale del XVIII secolo, sostanzialmente attinse alla forma letteraria del toscano duecentesco e trecentesco a sua volta derivato dal latino volgare. Ma nel frattempo, parallelamente al toscano, nel corso dei secoli si erano sviluppati anche altri idiomi regionali derivati dal latino volgare ed influenzati da precedenti substrati. In questo senso, i dialetti regionali italiani sono i “fratelli” piuttosto che i “figli” del Toscano. Inoltre i dialetti a nord dell’isoglossa che coincide
Lingua e identità sociale 17
con lo spartiacque dell’Appennino Tosco-Emiliano (la cosiddetta linea La Spezia-Rimini) e, in misura più sfumata, quelli a sud della Roma-Ancona non sono reciprocamente comprensibili con il toscano, dando così un certo fondamento linguistico alla classificazione dei dialetti gallo-italici, reto-romanzi e italico meridionali come lingue distinte (cfr. Fig. 5), in quanto il grado di differenziazione linguistica che esiste ad esempio tra il toscano ed il friulano è della stessa portata di quello che esiste tra l’italiano ed il francese. Inoltre, a causa della storica frammentazione politica italiana in città-stato e all’introduzione relativamente recente dell’italiano come lingua standardizzata (si calcola che, all’atto dell’unificazione del 1861, solo il 2,5% della popolazione parlasse un italiano standard), la lingua nazionale non ha mai avuto una forte funzione identitaria ad esempio alla stregua del francese. Nonostante quindi la diffusione di massa dell’italiano negli anni ‘50-60 ad esempio con la televisione, si ritiene che, fino intorno alla metà degli anni ‘70, circa un terzo della società italiana era diglossica, cioè usava l’italiano in contesti formali mentre nelle relazioni familiari, e non solo, prediligeva l’uso di un idioma locale. Dopo un periodo in cui l’uso del dialetto venne stigmatizzato o limitato ad un ruolo di gergo, negli ultimi anni abbiamo assistito ad una rivitalizzazione dei dialetti sia in ambito culturale che in ambito politico dove spesso la lingua è strumentalmente legata a rivendicazioni indipendentiste (vedi ad esempio la Lega Nord in Italia, ma anche i movimenti indipendentisti catalani, baschi, scozzesi, ecc.). Naturalmente si può sostenere che esiste un’estrema variazione tra il grado di affinità linguistica di questi idiomi e quelli da cui cercano di differenziarsi (ad esempio il basco è filologicamente molto più lontano dal castigliano di quanto non lo sia il catalano). Anche qui, però, oltre a criteri linguistici entrano in gioco variabili socio-politiche come la “coscienza linguistica” dei parlanti, cioè la misura in cui un gruppo etnolinguistico riconosce sé stesso e la propria parlata come sufficientemente diversa da un'altra per essere definita
una lingua separata.
Figura 5. Distribuzione dei principali gruppi dialettali in Italia. Fonte: vedi nota bibliografica 5.
Lingua e identità sociale 18
Box 4 - La rivitalizzazione linguistica
In certe circostanze la rivitalizzazione di una lingua, cioè il ripristino di un idioma attraverso la volontà politica di un governo o un’autorità, può preservare e riaffermare un’identità etnica e culturale, com’è avvenuto nel caso dell’ebraico. Durante la diaspora del popolo ebreo l’antica lingua ebraica (di ceppo semitico) continuò ad essere usata solo nei testi religiosi e come lingua franca solo in forma scritta mentre la maggior parte degli ebrei assimilò le lingue locali delle aree dove si insediarono (cfr. per esempio lo yiddish, un dialetto germanico parlato dagli ebrei emigrati nell’Europa dell’Est). Con il movimento sionista e la fondazione dello stato di Israele nel 1948, l’antica lingua ebraica venne ripristinata come lingua quotidiana attraverso l’ammodernamento del vocabolario dell’ebraico classico e diventò lingua ufficiale insieme all’arabo e all’inglese. La rivitalizzazione dell’ebraico rappresenta un caso piuttosto raro di lingua “dormiente” che è stata riportata in auge con successo attraverso l’azione politica.
Il gaelico irlandese in Irlanda, il bretone e l’occitano in Francia, il gallese, lo scozzese e il cornico in Gran Bretagna, rappresentano altri esempi di tentativi di rivitalizzazione che hanno avuto minore successo. I processi di rivitalizzazione vanno visti nel contesto di una nuova “politica della diversità” che si è ad esempio concretizzata in iniziative coordinate dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea quali la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, un trattato internazionale con cui gli stati europei si impegnano a tutelare e promuovere lingue “regionali” e “minoritarie”. Sebbene a tutt’oggi l’Italia (insieme ad altri stati) non ha abbia ancora ratificato la Carta, lo stato italiano riconosce e tutela con apposite leggi nazionali (come la 482/99) e regionali 12 gruppi linguistici minoritari: friulano, ladino, tedesco, sloveno, occitano, francese, francoprovenzale, albanese, greco, sardo, catalano e croato, rappresentati da circa 2.500.000 parlanti distribuiti in 1.171 comuni di 14 regioni. Inoltre, l’italiano (la lingua ufficiale dell’Italia) è parificato al francese in Val d’Aosta e al tedesco in Trentino-Alto-Adige (cfr. Fig. 6).
Figura 6. Minoranze Linguistiche in Italia Fonte: vedi nota bibliografica 6.
Lingua e identità sociale 19
Infine, negli stati a struttura federale la definizione di lingua nazionale è più
complicata ed è spesso sostituita dall’adozione di una o più lingue ufficiali nella ricerca di un equilibrio tra le gerarchie linguistiche, culturali e politiche. Ad esempio, con la nuova costituzione del 1996, il Sud Africa ha segnalato una svolta rispetto alla politica nazionalista ed oppressiva dell’apartheid (che assegnava all’afrikaans la posizione di lingua dominante) optando per 11 lingue ufficiali che rappresentano il 98% degli idiomi parlati dalla popolazione sudafricana. L’inglese invece rappresenta la lingua ufficiale della Nigeria e, di fatto, la lingua franca (seppur nella variante pidgin) tra le oltre 200 lingue parlate sul territorio nigeriano. Nella stessa maniera, lo stato indiano non ha una lingua “nazionale” ma due lingue ufficiali (hindi e inglese) usate dall’amministrazione centrale e oltre 20 lingue riconosciute a livello federale. La Svizzera, per contro, riconosce quattro lingue come lingue sia nazionali sia ufficiali: il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. Queste lingue sono parificate nei rapporti con la pubblica amministrazione ma solo a livello federale, mentre a livello locale e nell’istruzione ogni cantone gestisce liberamente le proprie politiche linguistiche.
Conclusione
Questo capitolo ha presentato la complessa relazione tra lingua ed identità sociale e ha evidenziato come i fattori geografici, linguistici, storici e sociali contribuiscano alla formazione e alla definizione di una lingua. Ha sottolineato come la classificazione delle lingue, ad esempio, possa basarsi su ricostruzioni filologiche che ipotizzano l’evoluzione di proto-gruppi di lingue in diverse varietà. Ha inoltre mostrato come lo studio della loro distribuzione geografica ci aiuti a capire il fenomeno migratorio linguistico e le trasformazioni linguistiche avvenute a seguito di conquiste o contatti commerciali e politici. Il presente capitolo aveva anche lo scopo indicare l’importanza di scienze ausiliarie come la sociolinguistica variazionista e la sociologia del linguaggio per la comprensione dei fenomeni linguistici. Infatti, entrambe ci aiutano a spiegare le dinamiche ed i perché di questi mutamenti nella loro duplice ed interdipendente dimensione linguistica e sociale. Nel complesso, si è visto come le lingue non siano entità fisse nel tempo e nello spazio, ma piuttosto siano in continuo divenire come le onde che “erodono” certe parlate creandone al contempo altre nuove. Questa dinamica trasformativa è alimentata anche, da un lato, dalla ricerca di definire i codici linguistici in forme “standard” e, dall’altro, dalle valenze sociali che i diversi parlanti attribuiscono alla convergenza/divergenza rispetto a tali forme, che, come abbiamo visto, contribuiscono alla costituzione delle identità dei parlanti. Infine si è voluto porre l’accento sugli aspetti propriamente ideologici e di potere. Infatti, se da un lato la lingua può rappresentare l’espressione e lo strumento fondamentale di trasmissione di una cultura, dall’altro lato tale associazione può diventare uno strumento ideologico nelle relazioni di potere. Attraverso l’annosa
Lingua e identità sociale 20
questione della classificazione di lingue e dialetti si è voluto criticamente riflettere sui diversi aspetti che contribuiscono alla costruzione sociale di un idioma.
Riferimenti bibliografici CRYSTAL D. (2011) From the world to the word – and back again (CILT Primary Languages
Show plenary talk. DE SAUSSURE F. (1992 ed. originale 1916) Corso di linguistica generale, Laterza, Roma-
Bari. FELLMANN J.D., BJELLAND M.D., GETIS A., GETIS J. (2011) Geografia umana, Seconda
edizione, McGraw-Hill, Milano. GROSJEAN F. (2010) Bilingual: life and reality, Harvard University Press. GUMPERZ J. (1996) Rethinking Linguistic Relativity, Cambridge University Press. LABOV W. (2006, ed. originale 1966) The Social Stratification of English in New York City,
Cambridge University Press.
Note bibliografiche Nota bibliografica 1: Indo-European branches map.png Autore: Hayden120. Creato il 16/1/2012 e successive modifiche. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44354198 Immagine usata sotto licenza Creative Commons CC BY-SA 3.0 Nota bibliografica 2: Spanish for rent sign in Desoto Texas.jpg Autore: Pete Unseth. Creato il 25/11/2013 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spanish_for_rent_sign_in_Desoto_Texas.JPG Immagine usata sotto licenza Creative Commons CC BY-SA 3.0 Nota bibliografica 3: Foto di proprietà dell’autore, Miami 30/12/2015. Nota bibliografica 4 : Maeneo penye wasemaji wa Kiswahili.png Autore: Kwamikagami. Creato il 31/8/2014 https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=43708890 Immagine usata sotto licenza Creative Commons CC BY-SA 3.0
Nota bibliografica 5: Map of italian languages/dialects. _-_Forms_of_Dialect.jpg Nessun autore leggibile automaticamente. Wento presunto. Creato 15/4/ 2007. Modificato da Franco Zappettini https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italy_-_Forms_of_Dialect.jpg Immagine usata sotto licenza Creative Commons CC BY-SA 3.0 Nota bibliografica 6: Regions, provinces and municipalities in Italy.svg
Lingua e identità sociale 21
Autore: Alessio Cimarelli. Creato il 22/7/2013. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27386068 Materiale usato sotto licenza Creative Commons CC BY 3.0, NOTE BIOGRAFICHE FRANCO ZAPPETTINI (PhD Applied Lingusitics, Università di Londra) è Honorary Research Associate alla Royal Holloway (Universita di Londra) dove si occupa di analisi del discorso in ambito organizzativo e politico. È inoltre Professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (DiSFor) dell’Università degli Studi di Genova dove cura i laboratori di Lingua Inglese e della Didattica dell’Italiano per Stranieri. Ha pubblicato su riviste internazionali di Linguistica Applicata ed Analisi Critica del Discorso. © 2016 FRANCO ZAPPETTINI
























![[dan] SOCIALE STATISTIKKER [ger] SOZIALSTATISTIK ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63317434ac2998afa709bb57/dan-sociale-statistikker-ger-sozialstatistik-.jpg)