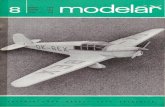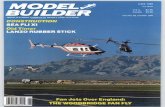rc. Loredana DI PINTO, Cura studiorum. Storie e Testi 23, M. D’Auria Editore, Napoli 2013, in SDHI...
Transcript of rc. Loredana DI PINTO, Cura studiorum. Storie e Testi 23, M. D’Auria Editore, Napoli 2013, in SDHI...
LXXX 2014
PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIUSQUE IURISFACULTAS IURIS C IV IL I S
STUDIA ET DOCUMENTA
HISTORIAE ET IURIS
DIRECTOR
✠ HENRICUS DAL COVOLO
REDACTOR
FRANCISCUS AMARELL I
A SECRETIS
SEBAST IANUS PACIOLLA
LATERAN UNIVERS ITY PRESS
STUDIA ET DOCUMENTA HISTORIAE ET IURIS
FUNDAVERUNT AC DIREXERUNT
AEMILIUS ALBERTARIO ARCADIUS LARRAONA SALVATOR RICCOBONOGABRIUS LOMBARDI IOANNES ALOISIUS FALCHI
DIRECTOR
✠ HENRICUS DAL COVOLO
Rettore della Pont. Univ. Lateranense
REDACTOR
FRANCISCUS AMARELLI
A SECRETIS
SEBASTIANUS PACIOLLA
CONSILIUM REDACTIONIS
F. GALGANO L. DE GIOVANNI G. LUCHETTI R. BASILED.A. CENTOLA E. GERMINO G.M. OLIVIERO NIGLIO G. PAPA
COMITATUS SCIENTIFICUS
F.P. CASAVOLA(Presidente em. della Corte Costituzionale e Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica)
L. ATZERI (Max-Planck-Institut Frankfurt a. M.) – C. BALDUS (Heidelberg) –M. BALESTRI FUMAGALLI (Milano Statale) – G. BASSANELLI (Bologna) – M. G. BIAN-CHINI (Genova) – C. BUZZACCHI (Milano Bicocca) – J. CAIMI (Genova) –G. CAMODECA (Napoli L’Orientale) – M. CAMPOLUNGHI (Perugia) – J. M. CARRIÉ(Paris EHESS) – P.L. CARUCCI (Napoli Federico II) – C. CORBO (Napoli Federico II) – J. P.C O R I A T ( P a r i s I I ) – G . D E C R I S T O F A R O ( N a p o l i F e d e r i c o I I ) –G. DE SIMONE (Roma Laterano) – A. Fdez DE BUJAN (Madrid UA) – F. Fdez DE BUJAN(Madrid UNED) – G. FALCONE (Palermo) – I. FARGNOLI (Milano Statale) – L. FASCIONE(Roma Tre) – L. FRANCHINI (Roma Europea) – E. FRANCIOSI (Bologna) – S. A. FUSCO(Macerata) – P. GARBARINO (Piemonte Orientale) – L. GAROFALO (Padova) – C. GIACHI(Firenze) – S. GIGLIO (Perugia) – F. GNOLI (Milano Statale) – A. GUZMAN BRITO (Valparai-so Catolica) – E. HÖBENREICH (Graz) – R. LAMBERTINI (Modena) – C. LANZA (SecondaUniv. di Napoli) – O. LICANDRO (Catanzaro) – A. LOVATO (Bari) – F. LUCREZI (Salerno) –L. MAGANZANI (Piacenza Cattolica) – G. MANCINI (Teramo) – V. MAROTTA (Pavia) –M. MIGLIETTA (Trento) – M. L. NAVARRA (Perugia) – G. NEGRI (Milano Cattolica) –A. PALMA (Napoli Federico II) – F. PERGAMI (Milano Bocconi) – S. PULIATTI (Parma) –G. PURPURA (Palermo) – R. QUADRATO (Bari) – F. REDUZZI (Napoli Federico II) –E. STOLFI (Siena) – A. TORRENT (Madrid URJC) – G. VALDITARA (Torino) – C. VENTU-RINI (Pisa) – U. VINCENTI (Padova) – J. G. WOLF (Freiburg i.B.) – P. ZANNINI (Torino).
Redactionem ephemeridis Studia et Documenta Historiae et Iuris quaecumque attinent, mittendasunt ad officium ephemeridis Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano
Omnes libri qui accipientur in ephemeride nunciabuntur: quorum vero duplex exemplar par-venerit, exarabitur, quo fieri poterit, peculiaris recensio.
Quando non riconducibile ad autori invitati dalla Rivista a collaborare con un loro contribu-to, la pubblicazione degli scritti che vengono proposti è subordinata alla valutazione positivaespressa (rispettando l’anonimato di autore e valutatori) da due studiosi scelti dalla Redazione, inprimo luogo, tra i componenti del Comitato Scientifico; oppure, sentiti i loro vertici, tra i colleghidella Società Italiana di Storia del Diritto.
La decisione sulla meritevolezza della pubblicazione è comunque assunta dalla Redazionedella Rivista, presso cui viene conservata tutta la documentazione relativa alla procedura di revisio-ne svolta.
Ciò in adesione al comune indirizzo adottato, in tema di regole che governano le pubblicazioniscientifiche, dalle riviste romanistiche italiane (oltre SDHI., AG., BIDR., Iura, Index ed altre) in sèguitoalle indicazioni del Gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Boulvert e a conseguentidelibere del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Gli autori, i cui scritti vengano accettati per la pubblicazione, sono pregati di inviare anche unabstract in lingua inglese e almeno due parole-chiave in inglese e nella lingua del contributo utiliz-zando il seguente indirizzo di posta elettronica: francoamarelli6tin.it
TIPOGRAFIA S. PIO X - MMXIV
La rivista ha periodicità annuale.L’abbonamento decorre dal 1o gennaio di ogni anno. I fascicoli
non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 10 giornidal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spe-discono contro rimessa dell’importo
Gli abbonamenti possono essere pagati:
– in ITALIAtramite bonifico bancario o C/C postale a favore della PontificiaUniversità Lateranense/Editoria:Cin N; Abi 07601; Cab 03200; C/C 000076563030
– all’ESTEROtramite bonifico bancario a favore della Pontificia Università Latera-nense/Editoria:Banco posta – Poste Italiane S.p.a.IT 23 N 07601 03200 000076563030BIC BPPIITRRXXX per valuta in EuroBIC POSOIT22XXX per tutte le altre valute
specificando sempre la causale del versamento.
Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamentidi indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fasci-colo vanno indirizzati a:
Lateran University Press – Ufficio Marketing e AbbonamentiPiazza S. Giovanni in Laterano, 4 – 00120 CITTÀ DEL VATICANO
TEL. 06/698 95 688 – FAX 06/698 95 501 -E-MAIL : [email protected]
RIVISTA PUBBLICATA NELLA CITTÀ DEL VATICANO
IURA PROPRIETATIS VINDICABUNTURPONTIFICIAE UNIVERSITATI LATERANENSI
✠ HENRICUS DAL COVOLO, Sponsor
I N D E X
– Per il centesimo compleanno di Antonio Guarino (Francesco Paolo Casavola) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
– Gabrio Lombardi nel centenario della nascita (Francesco Paolo Casa-vola – Francesco Amarelli . . . . . . . . . . . . . XI
– Un vecchio Maestro e un vecchio libro d’Università (Fulvio Tessitore) XXV
STUDIA
JOSEPH GEORG WOLF, Arescusa . . . . . . . . . . . . . 3GIUSEPPE VALDITARA, Leges e iurisprudentia fra democrazia e ari-
stocrazia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17ARMANDO TORRENT, La lex locationis de las tres societates publi-
canorum concurrentes sub hasta en el 215 a. C. . . . . . . . 71ANNAMARIA MANZO, Note sulla giurisprudenza arcaica . . . . . 101CARMEN PENNACCHIO, Farmaco, un Giano bifronte. Dei veleni e medi-
camenti, ovvero breve storia di un ossimoro . . . . . . . . . 117ANTONINO SESSA, Cittadinanza espansiva ed espansione della cittadi-
nanza. Politiche di integrazione e motivazione culturale al reato: tra laRoma antica e il mondo attuale . . . . . . . . . . . . . 171
JUAN ANTONIO BUENO DELGADO, El exilio en Roma. Tipos y conse-cuencias jurídicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
SARA GALEOTTI, Rupit, rupitias, noxia, damnum: il danneggia-mento nella normativa preaquiliana . . . . . . . . . . . . 229
MARIA TERESA CAPOZZA, Ancora su sacerdotium e imperium: latutela del sacerdotium e utilitas della res publica nelle Novelle diGiustiniano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH, L’integrazione degli Hispani nella comu-nità romana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
DOCUMENTA
PAOLO LEPORE, In tema di pollicitatio ad una res publica: alcunispunti ricostruttivi desumibili da AE. 1894, 148 . . . . . . . 307
VI Index
NOTAE
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI, Di un libro sull’usus servitutis . 331GENNARO CARILLO, Semnotes. La ‘legge’ tra venerabilità e caducità
(in margine a un libro di Emanuele Stolfi) . . . . . . . . . 339SETTIMIO DI SALVO, Ius gentium e lex mercatoria . . . . . 351FRANCESCA GALGANO, Mundi totius elementa ... et eorum di-
spositio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359GIANNI SANTUCCI, Legum inopia e diritto privato. Riflessioni intorno
ad un recente contributo . . . . . . . . . . . . . . . . 373FEDERICO PERGAMI, Il ruolo e la funzione del giudice nel processo roma-
no di età classica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395MARÍA EUGENIA ORTUNO PÉREZ, A new perspective on the limitation
of legacies (lex Falcidia de legatis) . . . . . . . . . . . 411INES DE FALCO, I giuristi e il testamentum militis. L’orientamento di
Iavolenus Priscus . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
EVENTA
– Un pomeriggio al Collège de France (John Scheid, Jean-Michel David, Aldo Schiavone), . . . . . . . . . . . . . . 449
– Nómoi e dualità tragiche. Un seminario su Antigone (Emanuele Stolfi) 467
VARIA
ALFREDO MORDECHAI RABELLO, Il comodato e l’affitto di case in diritto ebraico: traduzione e commento al capitolo VIII della MishnàBavà Metzi’à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
RECENSIONES LIBRORUM
CHIARA CORBO, Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio (Enrico Dal Covolo) . . . . . . . . . . . . . . . . 523
ORAZIO LICANDRO, L’Occidente senza imperatori. Vicende politiche ecostituzionali nell’ultimo secolo dell’impero romano d’Occidente (Fran-cesco Amarelli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
GIUSEPPINA ARICÒ ANSELMO, Antiche regole procedurali e nuove pro-spettive per la storia dei comitia (Bernardo Santalucia) . . . . 528
VIIIndex
LOREDANA DI PINTO, Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legi-slazione imperiale (Valerio Marotta) . . . . . . . . . . 540
ROSSELLA LAURENDI, Profili costituzionali e orientamenti politici delprincipato di Claudio (Valerio Marotta) . . . . . . . . . 547
SARA LONGO, Senatusconsultum Macedonianum. Interpretazione e appli-cazione da Vespasiano a Giustiniano (Giuseppe Falcone) . . . 559
UMBERTO LAFFI, In greco per i Greci. Ricerche sul lessico greco del pro-cesso civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarieromane (Emanuele Stolfi). . . . . . . . . . . . . . . 572
FRANCESCA REDUZZI MEROLA, Atti del XXXIII Convegno interna-zionale GIREA, Dipendenza ed emarginazione tra mondo antico e mo-derno (Stefania Castaldo) . . . . . . . . . . . . . . 582
CHRONICA
– Repubblicanesimo e impero da Polibio ai ‘Padri Fondatori’ (Aldo Schia-vone, Umberto Vincenti, Valerio Marotta, Pietro Costa) . 591
– Civitas, Iura, Arma (Anna Maria Mandas) . . . . . . . . . 639– Casistica e sistema nel pensiero giuridico europeo (Sara Galeotti) . . 645– Terra, Acqua, Diritto (Lauretta Maganzani) . . . . . . . . 653– Antonio Fernández De Buján. Académico y Doctor Honoris Causa (Fran-
cesco Amarelli, Federico Fernández de Buján) . . . . . 655– Nono Premio romanistico Internazionale Gérard Boulvert . . . . . 659– Roma e le altre culture nel Tardoantico (Marco Caputo, Carla Sfa-
meni, Antonio Ibba, Francesco Lucrezi, Antonio Marchetta,Fabio Troncarelli) . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
EPISTULAE AD REDACTIONEM MISSAE
ANTONIO GUARINO, Labeo, o dell’equipaggio suicida . . . . . . 751
LIBRI IN EPHEMERIDE ACCEPTI
[a cura di Donato Antonio Centola, Giovanni Papa, GiuseppinaM. Oliviero Niglio, Raffaele Basile e Lorena Atzeri] . . . 753
540 Recensiones librorum
.
un’ipotesi contro l’altra. Il libro della Aricò Anselmo costituisce – ci tengo a riaf-fermarlo – una tappa fondamentale negli studi sulle assemblee popolari romane, eresterà per lungo tempo un imprescindibile punto di riferimento per gli studiosi.Da esso potranno apprendere moltissimo non solo gli storici del diritto pubblicoromano, ma anche gli archeologi, i cultori di topografia arcaica e gli studiosi delleistituzioni del mondo antico in generale.
BERNARDO SANTALUCIA
Univ. Firenze [email protected]@unifi.it
LOREDANA DI PINTO, Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale,Storie e Testi 23, M. D’Auria Editore, Napoli 2013, pp. 244.
Il successo secolare dell’impero romano si deve ascrivere a un sistema divalori che apparve alle élites, e non solo a esse, meritevole di essere tutelato controi nemici esterni e interni. Il minimo comun denominatore di queste aristocrazie fula condivisione di una cultura letteraria, fondamentalmente unitaria, trasmessa digenerazione in generazione da scuole istituite e finanziate, allo stesso tempo, dalpotere imperiale, dalle singole comunità cittadine o dalla munificenza dei privati.
Il volume di Loredana Di Pinto ripercorre questa vicenda, privilegiandol’esame degli scritti dei giuristi e delle constitutiones principum, senza però trascuraredel tutto fonti d’altra natura, dalle testimonianze letterarie alle epigrafi. Il libro,suddiviso in due parti, nella prima, che si svolge in quattro capitoli, approfondiscelo studio della politica culturale imperiale tra Nerva e gli Antonini.
Al principato di Nerva (Cap. I. L’epoca di Nerva. Tre testi a confronto) devonoascriversi due testimonianze (Tit. Ulp. 24.28, da coordinare con Marcian. 13 inst.D. 30.117 e con Plin. ep. 4.13) di grande rilievo. L’A. ritiene estremamente proba-bile che la facoltà introdotta dal successore di Domiziano «di istituire legati civita-tibus» proponga «un nesso con una delle cause di istituzione di tale tipo di legatitrasmesseci» rispettivamente da Marciano e da Paolo in D. 30.117 e in D. 30.122(3 regul.) (p. 38): vale a dire gli alimenta. Mentre, allo stesso tempo, esclude che,durante il principato di Nerva, il termine alimenta ricomprendesse in sé, accanto,al significato di sostentamento alimentare in senso proprio, «anche quello desti-nato all’istruzione dei fanciulli».
Quest’analisi, sulla scorta della letteratura esistente, perviene a conclusionilargamente condivisibili. Eppure, per comprendere a pieno il contenuto delladecisione riferita in Tit. Ulp. 24.28, l’A., a mio parere, avrebbe dovuto approfon-dirne la portata normativa. Il diritto di ricevere in legato fu attribuito alle sole civi-tates romane (municipia e coloniae) o anche a quelle peregrinae? Sul punto lastoriografia romanistica è sempre apparsa profondamente divisa. A mio parere, sesi giudica plausibile un’estensione del beneficio alle comunità peregrine,dovremmo allora guardare alla diffusione, sempre più intensa dopo la metà del Isecolo d.C., della civitas Romana nelle provinciae grecofone. Ogni cittadino romanoera tenuto a redigere il proprio testamentum attenendosi alle regole del ius civile. Manel caso in cui fosse stato, allo stesso tempo, anche polítes di una città greca, comeavrebbe potuto far fronte, al pari d’ogni altro aristocratico, ai suoi doveri neiconfronti della comunità dei propri concittadini? Proprio per questo ritengo estre-
541Recensiones librorum
.
1 Se così fosse, sarebbe allora verosimile che, a questo scopo, sia stata concessa un’actioficticia.
2 Vd., in particolare, Phil. V.S. 2.1 (549) da coordinare con Fronton. ad Marcum Caesarem3.3.2 (Van den Hout2).
3 Sulla disputa tra Sabiniani e Proculiani cfr. Gai. 1.196; Tit. Ulp. 11.28; P.S. 3.4.1-2; I.1.22.pr.; C.I. 5.60.3 (a. 529).
mamente probabile l’ipotesi che, quantomeno dal principato di Adriano, anche lecivitates non romane fossero ritenute idonee a ricevere per legato1. L’A., volendoverificare quest’ipotesi, avrebbe potuto giovarsi, assieme alle vitae Sophistarum diFilostrato2, anche della cospicua documentazione riguardante l’istituzione difondazioni concernente la parte greco-loquente dell’Impero. Ma, obiettivamente,tale indagine avrebbe imposto per forza di cose la preliminare stesura di un altrovolume.
L’esame scrupoloso di Plin. ep. 4.13 [una lettera indirizzata a Cornelio Tacito(pp. 39-44)] consente, attraverso la ricostruzione di una concreta vicenda, dicomprendere quali difficoltà si dovessero affrontare e superare per istituire unascuola. Plinio, informato del fatto che i giovani di Como (la città da cui provenivala sua famiglia) per assenza di praeceptores dovevano recarsi a studiare a Milano,decise di provvedere, elargendo una somma corrispondente a un terzo del-l’impegno complessivo previsto. Avrebbe coperto volentieri l’intero importo senon si fosse convinto del fatto che tale decisione avrebbe dato luogo a favoritismifrequenti, invero, lì dove gli insegnanti erano assunti dalle città a spese pubbliche.Plinio decise diversamente, demandando ai genitori il compito di scegliere i prae-ceptores (omnia enim libera parentibus servo), purché questi ultimi contribuissero almenoper i due terzi: difatti anche quanti si sarebbero disinteressati del denaro altrui,avrebbero, al contrario, avuto certamente cura del proprio, vigilando che fosseattribuito solo a chi apparisse degno di insegnare. I genitori, pur accollandosigran parte della spesa, avrebbero certamente risparmiato quel che, altrimenti,avrebbero dovuto comunque impegnare per il viaggio e la lunga residenza deiloro figli in altre città.
Nel cap. II (Il munus educationis dell’età di Traiano, pp. 45-52) l’A. si chiede sele frumentationes istituite da Traiano (Plin. Paneg 26-3-4) avessero un fine soltantoassistenziale o anche «educativo in senso ampio», propendendo, in base alconfronto con Dio (Xiph.) 68.5.4, per la seconda ipotesi.
Il cap. III (Studiorum causa. Un caso di esenzione dai munera negli anni di Adriano,pp. 53-70) si sofferma, in un primo momento, su due provvedimenti ascrivibili adAdriano. In una constitutio (riferita in C.I. 10.40[39].2 Imp. Alexander A. Crispino) sistabilisce che gli studenti fuori sede non avrebbero potuto costituire il propriodomicilium nella città ove dimoravano se non fossero trascorsi almeno dieci anni ecolà avessero fissato il luogo principale della propria esistenza. Tale decisione siproponeva il fine evidente di esonerare gli studenti dai carichi fiscali nella civitasdella quale avrebbero potuto essere considerati incolae. Una volta, però, trascorsidieci anni, e solo nel caso in cui vi avessero stabilito il proprio domicilium, essisarebbero stati sottoposti ai munera consueti.
Estremamente interessante appare il contenuto del provvedimento adrianeotramandato da Ulp. 2 fideicomm. D. 34.1.14.1. Secondo l’imperatore il limitemassimo d’età entro il quale era possibile devolvere il sussidio istituito daglialimenta doveva essere esteso fino al compimento del diciottesimo anno per i pueri edel quattordicesimo per le puellae. Sebbene il termine fissato da Adriano si disco-stasse da quello generalmente riconosciuto dai giuristi3, per Ulpiano, pietatis causa,
542 Recensiones librorum
.
4 Cfr. Phil. V.S. 1.25 (534).5 2 excusation. D. 27.1.6.2.
non avrebbe dovuto considerarsi difforme (non est incivile) dal ius civile o forse, (se siascrive a civile o incivile un altro senso) dalle consuetudini della civitas. Si è ricon-nessa questa testimonianza con un passo della H.A. Vita Hadr. 7.8. L’espressioneincrementum liberalitatis, che vi si legge, allude verosimilmente al provvedimentoimperiale cui fa riferimento il passo ulpianeo, ma sfugge senza dubbio alla nostraconoscenza se esso fosse stato dettato dall’insorgere di troppi frequenti contro-versie inerenti alla durata del diritto agli alimenta pubblici, o se fosse derivato daun semplice gesto di liberalità del principe.
A proposito di Tit. Ulp. 24.28 e di Paul. l.s. de sen. cons. D. 36.1.27, l’A. nonapprofondisce adeguatamente due ardue questioni. In primo luogo ancora unavolta non si chiarisce come debba intendersi l’espressione <civitates>, quae subimperio populi Romani sunt. Inoltre, una volta identificato con il Sc.tum Apronianumquello di cui si fa menzione in Tit. Ulp. 24.28, sarebbe stata forse opportuna unadigressione sul tema della distinta tutela processuale dei lasciti (legati, da un canto,fedecommessi dall’altro) in favore delle civitates.
Che Adriano abbia confermato e rafforzato il diritto all’immunità dall’ob-bligo di recipere hospitem a filosofi, grammatici, retori e medici è attestato da duepassi del Digesto: Charis. l.s. de mun. civ. D. 50.4.18.30 e Modest. 2 excusat.D. 27.1.6.8). Sarebbe stato opportuno, a tal riguardo, determinare la reale portatadi questo privilegio, utilizzando, per esempio, la vasta aneddotica riferita da Filo-strato nelle sue Vitae Sophistarum e, in particolare, il famoso episodio che ebbecome protagonisti, nella città di Smirne, il futuro imperatore Antonino Pio, allora(nel 134/135) proconsole d’Asia, e il retore Antonio Polemone4.
Il cap. IV (I provvedimenti a favore dei maestri tra Antonino Pio e Marco Aurelio,pp. 71-89) prende in esame, nel § 1o, l’epistula di Antonino Pio al koinón dell’Asiariferita in Modest. 2 excusat. D. 27.1.6. Il successore di Adriano ridusse il numerodelle persone esenti, affidando alla boule di ciascuna pólis il compito di definire unalista, entro un numero predefinito, di quanti potessero godere dell’atéleia. Le cittàdell’Asia, soggette a regolamento provinciale, furono suddivise in tre classi: grandi,medie e piccole, identificate rispettivamente con le metropóleis ton ethnon, le sedi diassise giudiziarie (i conventus) e, infine, tutte le altre, rimanenti città5.
L’A., pur proponendo una dettagliata descrizione dei contenuti normativi diquest’epistula, non chiarisce se sia stato lo stesso imperatore a identificare, nei tregradini di questa scala gerarchica, le prime con le metropóleis, le seconde con le sedidi conventus e le ultime con le altre città o se, invece, questo regolamento sia statodefinito nei dettagli soltanto dall’interpretazione giurisprudenziale. A mio parerela distinzione tra metropóleis ton ethnon, agoraì dikon e tutte le restanti città, esclusedalle prime due categorie, se non dalla stessa lettera di Antonino Pio, fu peròstabilita, quasi certamente, da un più antico provvedimento normativo. Sarebbeinverosimile attribuire il criterio fondamentale, per applicare in modo corretto ledisposizioni dell’epistola imperiale, al lavoro interpretativo della giurisprudenza oall’arbitrio di ciascuna pólis, nessuna, è ragionevole pensarlo, disposta a ricono-scersi inferiore alle altre.
In verità il tono della frase, che comincia con eıßkoùv, può dar l’impressioneche si tratti di un commento del giurista, ma i criteri da lui enunciati si confor-
543Recensiones librorum
.
6 Su questi temi, da ultimo, V. MAROTTA, Le strutture dell’amministrazione provinciale nel quartolibro dei Discorsi Sacri, in P. DESIDERI, F. FONTANELLA (a c.), Elio Aristide e la legittimazione grecadell’impero di Roma, Bologna 2013, 156 ss., 181 s., con altri ragguagli.
7 Cfr. Phil. V.S. 1.8 (490).
mano in maniera tanto precisa alla realtà amministrativa dell’Asia da rendereestremamente inverosimile l’ipotesi che si tratti di una sua personale escogita-zione. Concludere, insomma, che la lettera di Antonino Pio al koinón di quellaprovincia non vi facesse neppure un implicito riferimento, non tiene debito contodelle concrete modalità di sviluppo dell’attività normativa imperiale. Si conside-rino, inoltre, alcune osservazioni del giurista tramandateci proprio in D. 27.1.6.2(quasi al principio del §) ... kaıù aıΩre¥seiv tinev prosxeı¥menai t√ no¥mw∞ , o™perdhloytai ej eßpistolhv �Antwnı¥noy toy Eyßseboyv ... (trad. lat. Mommsen «... etcondiciones quaedam adiectae in lege: quod intellegitur ex epistola Antonini Pii ...»): dal loroesame traspare che almeno alcune delle condizioni poste per concedere l’immu-nità erano state fissate, secondo l’epistola antoniniana, da norme via via aggiun-tesi al nómos, ossia (è una mia congettura) alla lex provinciae. In altre parole è lostesso giurista ad segnalare che, anche quando non citerà verbatim il contenuto delprovvedimento di Antonino Pio, ciò non di meno ne riproporrà i contenuti, daintegrare, peraltro, con discipline giuridiche già definite da norme anteriori, riferi-bili probabilmente, per quanto attiene al rango delle poleis asiane, anche a materiedifferenti da quelle oggetto dell’epistola tramandata in D. 27.1.6.2.
Lo stesso Antonino Pio, non sappiamo se nel medesimo provvedimento o inaltro successivo (ma il dato, in ogni caso, emerge da D. 27.1.6.10), temperò questamisura, permettendo alle póleis di concedere immunità, perfino in soprannumero,a quanti si distinguessero nella propria professione. I docenti più insigni avreb-bero potuto comunque invocare e ottenere l’atéleia. A sostegno di tale interpreta-zione si può invocare, a mio parere, il racconto di Elio Aristide (Hieroi Logoi IV, §§92 e ss), che propone, in effetti, un significativo riscontro: la boule di Smirne nonebbe alcuna difficoltà a concedere l’immunità, inserendo il retore, proprio perchéparticolarmente insigne, in soprannumero nella lista dei privilegiati6.
Come è noto (cfr. D. 27.1.6.7), inoltre, Antonino Pio non stabilì il numeroesatto di filosofi che, in ogni città, avrebbero potuto godere del diritto all’esen-zione dai munera: difatti, a suo avviso, erano davvero rari coloro i quali professa-vano la filosofia. E poi i veri filosofi, se facoltosi, avrebbero provvedutospontaneamente a offrire i propri beni per sovvenire alle necessità della loropatria7.
Marco Aurelio, per quanto emerge dal complesso delle testimonianze che loriguardano, perfezionò compiutamente l’opera dei suoi predecessori. Anch’egli,tuttavia, al di là di disposizioni sporadiche e occasionali a favore dei maestri dellediscipline più prestigiose (dalla grammatica alla retorica), non si curò mai dicreare, per impulso del potere centrale, autentiche e pervasive istituzioni scola-stiche. La formazione culturale dei giovani, com’è d’altra parte logico che fosse,fu demandata, il più delle volte, alle iniziative spontanee di ciascuna comunitàcittadina. Ma tutto questo non può destare alcuna sorpresa, ove si presti atten-zione alla peculiare natura dell’impero romano. I compiti che il potere imperialeassegnava a se stesso appaiono al nostro sguardo, e per davvero lo erano in effetti,estremamente limitati. Determinate attività, sebbene all’imperatore e agli altriagenti del governo romano competesse una funzione di tutela e di direzione, spet-tavano esclusivamente alle singole città, le quali (voglio sottolinearlo ancora unavolta), in specie nel caso delle póleis greche, concepivano se stesse come soggetti di
544 Recensiones librorum
.
ius gentium piuttosto che come parti di uno ‘stato territoriale’. Il più delle volte ilpotere imperiale interveniva solo se le decisioni di una città interferissero con ilbuon andamento del governo provinciale.
Rispetto alla prima, nella II parte, suddivisa a sua volta in due lunghi capitoli,il filo del discorso procede in modo meno rapsodico. L’A. infatti, nel cap. I (Gliassetti normativi degli anni di Alessandro Severo, pp. 93-159), propone un’interessanterassegna di testi, tratti principalmente dagli scritti dei giuristi severiani, riguar-danti le differenti forme di tutela degli studenti che si allontanavano, per motivi distudio, dalla casa paterna. Giurisprudenza e cancelleria imperiale hanno inaugu-rato, tra l’età antonina e la fine della dinastia severiana, una serie di indirizziinterpretativi volti a tutelare gli studi e i giovani che vi erano impegnati. Quantoai munera, la segreteria a libellis di Alessandro Severo (cfr. C.I. 10.4.40[39].2) ribadì,sulla scorta d’una precedente decisione d’Adriano, che gli studenti, costretti avivere lontano dalla propria patria (origo) studiorum causa, fossero esentati, peralmeno dieci anni, dagli oneri che solitamente gravavano sugli incolae. PerUlpiano (56 ad ed. D. 47.10.5.5), che consolida, è probabile, un più antico indi-rizzo interpretativo, la lex Cornelia de iniuriis poteva applicarsi – per reprimerel’irruzione violenta presso la propria abitazione – anche a favore di chi vivesse aRoma (o altrove, possiamo presumere) per motivi di studio senza avervi preso ilproprio domicilium. Si può riconnettere a tale riconoscimento anche l’estensionedella legittimazione attiva all’esercizio dell’actio iniuriarum al filius familias alias agensstudiorum causa /cfr anche Ulp. 23 ad ed. D. 5.1.18.1).
Il pretore (Ulp. 12 ad ed. D. 4.6.28 pr.) ha considerato valido motivo diconcessione dell’in integrum restitutio l’assenza studiorum causa (puta studiorum causa, forteprocuratore suo defuncto: ne decipiatur per iustissimam absentiae causam). Non si computaalla ratio portionis, quae ex defucti bonis ad eundem filium pertinuit, quanto sia statosomministrato dal padre al figlio studiorum causa. In tal caso ogni somma si consi-dera elargita con sentimento di pietà e non col proposito di concedere un credito(non credendi animo) (cfr. Ulp. 6 opin. D. 10.2.50).
In C.Gr. 3.10 (cfr. C.I. 4.28.5), che riferisce un rescritto di Severo Alessandro aSeptimia Musa, si propone una rilevante deroga al regime tipico del Sc.tum Mace-donianum: non si applica il suo dispositivo allorché il denaro a mutuo sia statoconcesso a un filius familias allontanatosi dalla casa paterna studiorum causa.
In un altro rescritto di Severo Alessandro – C.I. 10.40[39].2 (in particolare § 1)– una volta ribadito che agli studenti deve concedersi uno statuto più favorevole,si precisa che, qualora si provi che il domicilium nella splendidissima civitas Laodice-norum non sia stato preso per motivi di studio, la dichiarazione mendace nonavrebbe giovato, né avrebbe comportato l’esonero dall’adempimento dei muneraricadenti in capo agli incolae. Identificare, in assenza di altri elementi di prova,Laodicea con Berytus è però quantomeno azzardato. Laodicea, distrutta nel corsonella guerra tra Diodoto Trifone e Antioco VII (140 a.C.), fu poi ricostruita colnome di Laodicea nella Fenicia. Ma, nelle fonti giuridiche e, in particolare, inUlp. 1 de cens. D. 50.15.1.1, Berytus è ricordata come Berytensis colonia Augustana,quae – sottolinea Ulpiano – ius Italicum habet, mentre, nella documentazione epigra-fica, il suo nome, fin dal I secolo, è quello di Colonia Iulia Augusta Felix Berytus.
Inoltre la città di Laodicea ricordata in questo rescritto potrebbe, peresempio, anche essere, Laodicea in Celesiria (cfr. Est et Laodicena colonia in SyriaCoele, cui divus Severus ius Italicum ob belli civilis merita concessit: Ulp. 1 de cens.D. 50.15.1.3), oppure un’altra delle tante póleis che avevano ricevuto, in età elleni-stica, questo nome.
A partire da questa incerta identificazione, corretta o meno che sia ora non
545Recensiones librorum
.
8 In Origenem 5.56-69. Cfr. specialmente 5.58 «... uno dei miei insegnanti, ... incaricato di
importa, l’A. propone un excursus senz’altro interessante che, pur incentrandosisulla figura di Ulpiano e sulla nozione di vera philosophia (1 inst. D. 1.1.1.1), sisofferma anche sul più generale problema dell’insegnamento del diritto in etàseveriana e nei successivi decenni del secolo III. È però estremamente improba-bile che si possa, con qualche verosimiglianza, individuare in Ulpiano l’estensoredi questo rescritto o il suo ispiratore. In effetti, che si tratti di una subscriptio o diun’epistula, Ulpiano, in quanto praefectus annonae e, poi, praefectus praetorio, nonavrebbe avuto (non dico titolo) ma certamente tempo per ingerirsi in questioni diroutine riguardanti, a seconda che si tratti di una subscriptio o di un’epistula, la segre-teria a libellis ovvero quella ab epistulis.
Nel cap. II (La legislazione tardoantica, pp. 161-217) si rileva come i provvedi-menti imperiali, in materia di excusatio munerum per cause di studio, riguardinodecisioni singole e isolate assunte, a parte qualche eccezione, per «far fronte aspecifiche impellenti necessità del tempo»: ad esempio la carenza d’architetti, inspecial modo per le opere di urbanizzazione di Costantinopoli (cfr. CTh. 13.4.1Imp. Constantinus A. ad Felicem, 27 agosto del 334, che concerne, invero, le provinciaeafricane, CTh. 13.4.2 Imp. Constantinus A. ad Maximum P[raefectum] P[raetori]o a. 337,CTh. 13.4.3 Impp. Constantius et Constans AA. ad Leontium P[raefectum] P[raetori]o del 6luglio del 344) o il riordino delle sue scuole al tempo del secondo Teodosio (CTh.14.9.3 Imp. Theod[osius] A. et Valentinianus Caes. del 27 febbraio del 425).
La tutela degli studi è l’oggetto di C.I. 1.51.1 Impp. Diocletianus et MaximianusAA. Paulino (14 luglio del 286) e di C.I. 10. 53[52].2 Imp. Gordianus A. Heracliano(ascrivibile, probabilmente, a Gordiano III). Politico-religiosi sono gli intenti cheemergono, invece, da C.Th. 13.3.5 Imp. Iulianus A. del 17 giugno del 362 e daC.Th. 13.3.6 Impp. Val(entini)anus et Valens A.A. ad Mamertinum P(raefectum) P(raetori)odell’11 gennaio del 364. Un dispositivo tipicamente disciplinare è quello fissato nel370, per regolare il soggiorno a Roma di studenti provenienti dall’Oriente edall’Occidente, da CTh. 14.9.1 Imppp. Val(entini)anus, Valens et Gr(ati)anus A.A.A. adOlybrium P(raefectum) U(rbi). Chi si recava nell’Urbe discendi cupiditate, doveva esibireal magister census il permesso rilasciatogli dal governatore della propria provincia, undocumento che doveva necessariamente indicare il suo luogo di provenienza, idati concernenti la propria famiglia e, infine, qualità e doti culturali del nuovostudente.
Senza dubbio più interessante appare il contenuto normativo diC.I. 10.50[49].1 Impp. Diocletianus et Maximianus A. A. Severino et ceteris scholasticisArabiis e di C.I. 10.50[49].2 Impp. Diocletianus et Maximianus A. A. Theodoro. Nelprimo rescritto si dispone che gli studenti aventi dimora a Berito e impegnati neglistudi liberali e, soprattutto, in quello del diritto (maxime circa professionem iuris) nonne dovevano essere distolti, attraverso l’imposizione di munera, fino al compimentodel venticinquesimo anno di età. Questo riferimento alla scuola di Berito nonstupisce affato. Essa, nel corso del III secolo, aveva conquistato tanto prestigio daaffiancarsi a quella di Roma quasi su di un piano di parità. Vi fece esplicitamenzione l’autore dell’Encomio di Origene (forse Gregorio il Taumaturgo), il quale,attorno al 235, mentre aveva già in animo di approfondire a Roma, dopo averneappreso i primi rudimenti con il suo maestro di grammatica latina, lo studio deldiritto, dovette raggiungere a Cesarea Marittima il cognato, adsessor del governa-tore. Egli decise allora di proseguire i suoi studi nell’importante scuola di Berytus,non molto distante dalla destinazione della sorella e di suo marito8. Nel secolo IV
546 Recensiones librorum
.
insegnarmi il latino (non perché arrivassi a una piena padronanza di questa lingua, ma solo
perché non ne fossi del tutto sprovveduto ... e per caso costui a sua volta non era del tutto igno-
rante delle leggi): ispirandogli (scil. la provvidenza) questa idea, per mezzo suo mi invitò a
studiare il diritto romano ...60 ... Presomi come allievo, cominciò a insegnarmi con grande
impegno: buttò lì poi una cosa, che si dimostrò più vera di ogni altra: che lo studio dei nómoisarebbe stato per me il miglior viatico (...), sia che volessi diventare un retore di quelli che
contendono nei tribunali, sia che scegliessi un altro mestiere ... 62 Così mentre iniziavo a
studiare, volente o nolente questi nómoi, era come se mi fossero stati imposti dei vincoli e la città
di Berito quale motivo e occasione del viaggio sin qui: si trattava della città, non molto distante,
più romana che ci fosse e la si reputava una palestra del diritto ... 64 Peraltro, non era così inevi-
tabile la mia venuta qui, ..., dato che per i nostri studi giuridici sarebbe stato possibile anche
recarci nella città di Roma»: trad. italiana di M. RIZZI in GREGORIO TAUMATURGO (?), Encomiodi Origene, Milano 2002, 130-132: cfr. H. CROUZEL S.J. in GRÉGOIRE LE THAUMATURGE,
Remerciement à Origène suivi de la Lettre d’Origène a Grégoire, S.Chr. 148, Paris 1969, 118-121.
Libanio non nascondeva il proprio disprezzo nei confronti dello studio del diritto(máthesis ton nómon), che giudicava conveniente soltanto per le persone lente dicomprendonio (or. IV, 346 ss. Förster, §§ 21-23). Il retore, nelle sue epistole e indifferenti luoghi delle sue orazioni, recriminava sul fatto che i giovani venisseroinviati a studiare dai loro padri la lingua latina e il diritto a Berito o a Roma. Sicondanna lo studio del diritto soprattutto perché esso rischia di distogliere igiovani dalla tradizionale paideía greca. Cionondimeno anche Libanio, comeosserva correttamente l’A., era perfettamente consapevole della dura realtà deisuoi tempi e del rilievo pratico conquistato dagli studi giuridici. Proprio perquesto tentò di rendere Antiochia, la sua città, ‘competitiva’, anche su questopiano, con la non lontanissima Berito, cercando di far istituire una cattedra didiritto e introducendo nella scuola anche l’insegnamento del latino (pp. 187 ss.).
Non si può purtroppo dar conto dei tanti contenuti di quest’interessantevolume. Ma si devono quantomeno segnalare gli excursus sul Panegirico(Pan. Lat. 5) di Eumenio al Cesare Costanzo Cloro sulla rinascita delle scuole diAutun (a. 298) e gli intelligenti rilievi su Cassiod. Variae 1.39 e 4.6. Quanto alprimo, forse sarebbe stato opportuno sottolineare con maggior enfasi (è ciò cheemerge soprattutto da Pan. Lat. 5.6, 5.13 e 5.14) le strette relazioni che scuola eamministrazione pubblica intrattenevano reciprocamente Non soltanto la scuolaè la fucina dei futuri funzionari (5.5.4: cfr. p. 194), ma il nuovo direttore delcentro di Autun, vale a dire lo stesso Eumenio, assume il suo nuovo incarico dopoaver prestato servizio, per molti anni, nelle segreterie del Palazzo imperiale (PanLat. 5.6.2 ... et hoc ipsi palatio parentis sui munus invexerit ut mediocrem quidem pro ingeniomeo naturaque vocem, caelestia tamen verba et divina sensa principum prolocutarum, ab arcanissacrorum penetralium ad privata Musarum adyta transtulerit).
Non ho voluto tacere il mio dissenso su alcuni punti, più o meno marginali, e,in particolare, sull’interpretazione di C.I. 10.40[39].2, ma sarebbe senza dubbioingeneroso contestare l’utilità di quest’elegante opera prima di Loredana DiPinto, curata con scrupolo in ogni dettaglio.
VALERIO MAROTTA
Univ. di Pavia [email protected]
547Recensiones librorum
.
1 Ma a volte decisamente importanti, come è, per esempio, il caso di D. MANTOVANI, Leclausole «senza precedenti» della lex de imperio Vespasiani, in Tradizione romanistica e Costituzione, tomo II,
dir. L. LABRUNA, Napoli 2006, 1035 ss.2 Novi generis imperia constituere iura magistratuum commutare, Reggio Calabria 2008 e F. COSTA-
BILE, Caius Iulius Caesar: dal dictator al princeps, dal Divi Filius al Cristo. Augusto e le maschere del potere,Roma 2013. Ma si possono ricordare i manuali dello stesso F. COSTABILE, Storia del diritto pubblicoromano, Reggio Calabria 2012 e di A. PETRUCCI, Corso di diritto pubblico romano, Torino 2012.
3 Profili costituzionali del ruolo dei militari nella scelta del princeps. Dalla morte di Augusto all’avvento diVespasiano, Napoli 1989.
4 Ma vd. l’accurata recensione di F. LUCREZI in Teoria e Storia del Diritto Privato 6 (2013).
ROSSELLA LAURENDI, Profili costituzionali e orientamenti politici del principato diClaudio, Opuscula Regina Historica II, Iiritieditore, Reggio Calabria
2012, pp. 159, distributore esclusivo «L’Erma» di Bretschneider,
Roma.
1. – I grandi temi del diritto pubblico romano non sono stati al centro, inquesti ultimi decenni, degli interessi degli studiosi italiani. Mentre il numero degliarticoli dedicati alle vicende istituzionali della civitas, dalla sua fondazione all’etàgiustinianea, è stato, se non cospicuo1, certamente consistente, le monografie (inspecial modo quelle dedicate all’età del principato) si contano sulle dita dellemani.
Ricorderei, andando a ritroso, i recenti volumi di Felice Costabile2 e quello,ormai lontano nel tempo, di Francesco Milazzo3. Il libro di Rossella Laurendi,che si giova di un sontuoso corredo iconografico, rappresenta, pertanto, una feliceeccezione, cui spero possa far séguito una positiva inversione di tendenza.
Mi sottrarrò all’impegno di descrivere puntualmente il contenuto dei cinquecapitoli in cui è suddivisa questa monografia4, per soffermarmi soltanto sui suoiprincipali snodi critici. La tesi di fondo dell’autrice è senza dubbio innovativa:l’esame delle fonti letterarie antiche e delle legendae monetali del principato diClaudio dimostra che l’adclamatio imperatoria della guardia pretoriana non devevalutarsi come un evento di rilievo solo politico, ma come una decisiva innova-zione costituzionale che ebbe poi profonde ripercussioni sulle forme di attribu-zione del potere imperiale, in special modo nel longus annus dei quattro imperatori.
In tal modo Rossella Laurendi incrocia uno snodo cruciale degli studi sulprincipato. Per Theodor Mommsen, il potere imperiale, basandosi sull’imperium(che egli definiva, senza esitazioni ma infondatamente, già al tempo di Augustoproconsulare) e sulla potestà tribunizia, richiedeva due specifici atti di fondazione.L’imperium del princeps trovava il suo punto d’origine nell’acclamazione da partedelle truppe o da parte del senato (ovvero o da parte dei militari o [e] da parte delsenato), e il titolo di imperator, che ne derivava e che figurava nella titolatura,rendeva idonei all’esercizio dell’imperium. Al contrario dell’acclamazione dei capimilitari vittoriosi di età repubblicana, in cui un imperium consulare o proconsularepoteva trasformarsi così in titolo d’imperator, durante il principato l’acclamazioneportava specificamente verso la detenzione di un imperium. A causa di questo attorivoluzionario, che esprimeva la sovranità diretta del populus in armi, l’imperium delprinceps non avrebbe avuto bisogno, secondo il Mommsen, di essere confermatodai comizi. Il conferimento della potestà tribunizia era successivo a questa accla-
548 Recensiones librorum
.
5 TH. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht3, II, Leipzig 1887, 840 ss.6 J. KROMAYER, Die rechtliche Begründung des Prinzipats, Diss. Strassburg-Marburg 1888, 33 ss.;
H. E. PELHAM, Essays, Oxford 19112, 60 ss.7 Non risolutive, invero, in specie quelle che si vorrebbero trarre dalla lettura dei testi dionei
citati, infra, nelle note 8 e 9.8 Dio 53.12.1.9 Dio 53.32.6.10 Suet. Tib. 21.1. «Qualche tempo dopo , essendo stata presentata dai consoli una legge in
virtù della quale avrebbe dovuto amministrare le province assieme ad Augusto (... lege per consuleslata, ut provincias cum Augusto communiter administraret ...) e fare con lui il censimento, celebrato il
lustro, partì per l’Illirico».11 Secondo la quale l’imperium del collega di Augusto (ossia Agrippa) è conferito da una legge
(methenòs [...] exousìan mèizo [eìnai] ... en nòmoi ekyròte): P. Köln VI n. 249, ll. 7-11 «... E in qualsiasi
provincia ti trascinasse la repubblica romana, fu decretato per legge che nessuno in quelle
province avesse potere maggiore del tuo ...» trad. it. dal greco di A. FRASCHETTI, Roma e il prin-cipe, Roma-Bari 1990, 287.
12 ... Quod adle<c=G>t(us) pro co(n)s(ule) et ei pro co(n)s(ule) de quo lex ad populum lata esset ut inqua(mcum)q(ue) / provinciam venisset maius ei imperium quam <ei=SIBI> qui eam provinciam proco(n)s(ule)optine/[ret e]sset dum in omni re m<ai>us imperium Ti(berio) Cae(s)ar<i> Aug(usto) quam Germ(anico) Caesariesset ...
13 I commentarii dei fratres Arvales fanno menzione di decisioni comiziali di diverso contenuto –
comitia tribuniciae potestatis, comitia consularia, comitia sacerdotiorum, comitia pontificis maximi – mai, però (e
su questo dettaglio si concentrò, per l’appunto, l’attenzione di Theodor Mommsen), di comitiaimperii (dei quali, invero, parla unicamente Tacito, Hist. 1.14).
14 Tutto questo a maggior ragione perché – come ha dimostrato J. SCHEID, L’investiture impé-riale d’après les commentaires des Arvales, in CCG 3 (1992), 221 ss. – i documenti che sembravano soste-
nere l’ipotesi mommseniana, i commentarii dei fratres Arvales, non rendono il servizio che si chiede
loro. I redattori di questi resoconti non citavano sistematicamente tutti gli atti d’investitura, ma
operavano una scelta, variabile secondo l’epoca, tra l’acclamazione da parte del Senato, il confe-
rimento comiziale della potestà tribunizia ed, eventualmente, le elezioni sacerdotali, l’attribu-
zione di certi titoli o certi avvenimenti. Quando si studiano le diverse scelte, si constata che i
mazione e, come provano i commentarii dei fratres Arvales, era deciso dal populus,conformemente alla natura civile di questo potere. La legge sulla potestà tribu-nizia avrebbe compreso così tutta una serie di altri privilegi, in breve quel che ècontenuto nella famosa lex detta de imperio Vespasiani, ovvero nella legge dalla qualei giuristi romani fanno derivare il diritto di rendere obbligatorie, al pari delle leges,le disposizioni imperiali.
La tesi del Mommsen5 è stata contestata, già nel XIX secolo, dal Kromayer edal Pelham6. Si è osservato che, per quanto il titolo d’imperator esprimesse l’ido-neità a esercitare un imperium, il potere, cui questo titolo rendeva idonei, fosseconferito dai comizi, a immagine dei grandi imperia straordinari della tarda repub-blica (quelli di Pompeo, Crasso e Cesare). Alle prove citate a sostegno di questainterpretazione7 – il regolamento del 27 a.C.8, quello del 23 a.C.9 e le disposizionidel 13 d.C. riguardanti l’imperium di Tiberio quale conlega di Augusto10 – si aggiun-gono ora la testimonianza della laudatio Agrippae11 e la lex sull’imperium di Germa-nico riferita dalle ll. 33-36 del Sc.tum de Cnaeo Pisone patre12. La potestà tribuniziasarebbe stata accordata da un’altra legge comiziale, che comprendeva soltanto ladefinizione di questa potestà e il nome del beneficiario.
La ricostruzione del Mommsen poneva in luce alcune fasi salienti del proce-dimento di investura imperiale13, ma il Kromayer aveva senza alcun dubbioragione nel sostenere che, per l’imperium al pari della tribunicia potestas, la leggecomiziale interpretasse un ruolo rilevante14. Infatti l’insieme dei dati disponibili
549Recensiones librorum
.
sacerdoti o i redattori dei commentarii selezionavano due aspetti dei poteri imperiali e due momen-
ti cruciali dell’investitura: l’acclamazione da parte del Senato e i comizi tributi. La scelta del-
l’acclamazione imperatoria, di fronte al voto comiziale sulla potestà tribunizia, mostra innanzi
tutto che, anche se il titolo d’imperator era solo un epiteto che dava diritto a certi onori e che abili-
tava il titolare a ricevere, se glielo si dava, un imperium effettivo, bisogna guardarsi dallo svalutarlo
troppo. In secondo luogo, la scelta dell’acclamazione imperatoria da parte dl senato (e non da
parte dei soldati) e del voto comiziale sulla potestà tribunizia è perfettamente logica. Essa ricorda
l’attribuzione delle due componenti essenziali del potere imperiale, e i momenti più importanti
del loro conferimento: l’acclamazione imperatoria da parte del Senato e il voto dei comizi tributi.
Questa scelta tace su altri momenti, come l’acclamazione da parte dei soldati, i decreti senatoriali
che invitavano i magistrati a convocare i comizi e il voto delle leggi che conferivano l’imperium e
gli altri privilegi.15 F. LUCREZI, ‘Leges super principem’. La ‘monarchia costituzionale’ del principato, Napoli, 1982,
119 ss., e ID., Aspetti giuridici del principato di Vespasiano, Napoli, 1995, 67 ss.16 MANTOVANI, Le clausole «senza precedenti» della lex de imperio Vespasiani cit., 1035 ss.
consente di concludere che la sola acclamazione imperatoria (militare o senatoria)conferisse al principe la titolarità dell’imperium; ma tutto lascia supporre che essanon fosse certamente idonea, senza un ulteriore intervento dei comizi, a discipli-narne l’esercizio, permettendo, ad esempio tra le altre cose, ai loro titolari diconservarlo una volta rientrati nell’urbs, ossia nell’area definita dal pomerium.
2. – In base a queste considerazioni possiamo definire uno scenario teorico diinvestitura, col quale, poi, confrontare l’accesso al potere di Claudio così comeesso è stato ricostruito da Rossella Laurendi (pp. 39 ss., 51 ss.) sulla base di un’ac-curata esegesi di Cassius Dio 60.1.3-4 e dei conii claudiani che recano le legendaeIMPER RECEPT e PRAETOR RECEPT. In un primo momento i soldati accla-mano il futuro princeps. Il senato approva questa procedura chiamando imperator,conformemente a una tradizione repubblicana ma in un senso nuovo, colui che letruppe hanno acclamato. Nel corso della stessa seduta, o in occasione di sedutesuccessive, il senato decreta la convocazione dei comizi perché si attribuiscano achi è stato appena acclamato imperator la potestà tribunizia, l’imperium (maius) e tuttii diversi privilegi dei quali godevano i predecessori. Al contempo si decreta che ilnuovo princeps sia eletto console, sia cooptato in tutti i collegi sacerdotali e siaeletto Pontifex Maximus.
Anche Rossella Laurendi (pp. 46-50) non dubita del fatto che, almeno apartire dal principato di Caligola (se non da quello di Tiberio), una o più leges diinvestitura conferissero ai principes l’insieme dei poteri imperiali, ivi compresil’imperium e la tribunicia potestas. Alla luce della letteratura più recente l’A., a propo-sito della cosiddetta lex de imperio Vespasiani, accoglie conclusioni con le quali èarduo non convenire: difatti è necessario osservare che ogni lettura stratigrafica diquesto documento legislativo è infondata. L’omissione in tre capita – il III, il IV el’VIII – della citazione di precedenti imperatori non segnala, come vorrebbe, peresempio il Lucrezi15, la presenza di norme nuove, appositamente introdotte perVespasiano e riconducibili, pertanto, alle particolari circostanze in cui avvenne lasua ascesa. Quest’assenza ha, come si è chiarito16, unicamente una spiegazionegiuridica, dipendente dal differente contenuto delle clausole e dalla loro funzionenel sistema della lex. La mancata menzione dei predecessori deriva dal fatto che sitrattava di clausole totalmente diverse, per natura, dalle clausole che, invece, lacontenevano. I capita I, II, V, VI e VII attribuivano poteri. Le tre norme restanti –
550 Recensiones librorum
.
17 L’autrice sottolinea il fatto che Dione, contrariamente a quanto erroneamente riferito da
parte della storiografia moderna, non afferma che a conferire tà loipà sarebbero stati il Senato e i
comizi, ma i consoli, i quali, però, non avrebbero avuto alcun legittimo potere in tale senso, per
cui la frase dovrebbe intendersi come una espressione ‘sintetica’, nel senso che «Dione avrebbe
scritto che i consoli “ratificarono” e “votarono” per volere in realtà dire “fecero ratificare” e
“fecero votare”, convocando allo scopo gli organi assembleari ... competenti, cioè sia il senato sia
i comitia tributa, in base al loro ius agendi cum patribus e cum plebe».18 MILAZZO, Profili costituzionali del ruolo dei militari cit., 79 ss., 89 s.
quelle definite nei capita III, IV e VIII – non ne conferivano, ma regolavano glieffetti degli atti del princeps (per il futuro, clausole III e IV, per il passato, clausolaVIII).
3. – Claudio fu acclamato imperatore dalle milizie nei castra praetoria il 24gennaio del 41, il medesimo giorno della morte di Caligola. Per l’A., nella visionegiuridico-costituzionale romana, la precisa determinazione del dies a quo del-l’imperium non aveva una funzione meramente cronologica e formalistica, ma unapeculiare funzione celebrativa. La postposizione della festività del dies imperii diClaudio al 25 si giustificò con la circostanza che si considerava infausta la data del24 a causa della nex del predecessore (Suet. Claud. 11). In altre parole questa sceltanon si può interpretare, secondo la Laurendi, come un cedimento del principealle pretese del senato, né, tantomeno, nell’atto di ratifica dell’assemblea si vollericonoscere il primo passo del procedimento di investitura, per occultare così ilrilievo dell’adclamatio dei milites.
Nella prospettiva della Laurendi (Cap. III, Imper[ium] recept[um], pp. 51-78), atal riguardo, appaiono decisive – accanto a Cass. Dio 60.1.3-4, oggetto di un’ese-gesi precisa fino allo scrupolo e, allo stesso tempo, persuasiva, dal momento chegiustamente si osserva che i consoli, come tali, non potevano conferire alcunpotere17 – le fonti numismatiche e, in particolare, tre tipi monetali, coniati per unlungo periodo di tempo (forse, in alcuni casi, anche oltre il 47), recanti le legendaea) IMPER RECEPT / castra (figura con copricapo o elmo a calotta senza apex easta); b) IMPER RECEPT / castra (figura con elmo crestato e lancia); c)PRAETOR RECEPT / principe e pretoriano [da sciogliere forse in praetor(iani)recept(i) o praetor(ianus) recept(us), o praetor(ianis) recept(is)]. In queste monete e, soprat-tutto, nella legenda IMPER RECEPT [da sciogliersi in imper(ator) recept(us) o in imper(ium) recept(um)] potremmo individuare una prova dell’efficacia costitutiva dellaproclamazione da parte delle truppe. Sulla base delle legendae monetali e dellefigure che corredano questi conii – l’imperatore, un pretoriano, la dea Roma, icastra praetoria –, la Laurendi svela anche il loro autentico messaggio politico ecostituzionale, illustrando quel che le appare un motivo ricorrente delle celebra-zioni e della ‘propaganda’ del tempo: «Claudio <è> stato ricevuto come impera-tore nel pretorio, o che nel pretorio gli <è> stato conferito l’imperium» (pp. 65 e66). La circostanza che l’imperatore sia divenuto tale per volontà dei pretoriani èun fatto che «viene riconosciuto senza infingimenti, con una iniziativa assoluta-mente nuova, unica nelle emissioni monetarie di tutto il periodo imperiale»(p. 69).
Il pan to krátos dioneo, così come ha sostenuto anche Francesco Milazzo18,corrisponde all’imperium senza qualificazione ulteriore, vale a dire all’imperium mili-tiae attribuito al principe da parte dell’esercito. Il valore costitutivo, cui, secondola convincente interpretazione di Rossella Laurendi, alludono anche le icono-grafie monetali, trova una precisa conferma nell’ homológhesan (‘fecero ratificare’),
551Recensiones librorum
.
19 (F.-JACQUES)-J. SCHEID, Roma e il suo impero. Istituzioni, economia, religione, trad. it. Roma-
Bari 1992, 35, ove altra bibl.20 MOMMSEN, Römisches Staatsrecht3, II, cit., 1132-1133.
che il più tardo Dione attribuisce ai consoli che, convocati il senato e i comizitributi, fecero poi omologare l’acclamazione e il giuramento già fatti dall’esercito.In tutto questo si coglie senz’altro un forte elemento di novità di fondamentalerilievo politico, perché non può sfuggire l’evidente umiliazione del senato privatodi ogni potere di investitura effettiva e relegato a un mero compito di ratifica expost (il significato tecnico-giuridico dell’homológhesan di Cass. Dio 60.4 non sfuggeall’autrice a p. 73 s.). In tal modo si infliggeva un colpo ai fondamenti repubbli-cani della costituzione augustea, inaugurando la serie dei dies imperii militari, segnoevidente del fatto che l’esercito era divenuto l’arbitro del potere imperiale e ilprincipale attore di quel complesso procedimento che conduceva dall’electio deiprincipes alla loro formale investitura.
In ogni caso l’autrice è consapevole (p. 74) del rilievo, assolutamente decisivosul piano formale, dell’assemblea popolare. Difatti i riti dei fratres Arvales, come haosservato John Scheid19, avevano luogo soltanto dopo il voto dei comizi. Eppurenon c’è dubbio – e si deve convenire con l’A. – che Claudio e, più tardi, Vespa-siano considerassero proprio dies imperii quello dell’acclamazione e del giuramentodelle truppe.
4. – Anche l’analisi politica delle vicende, che fecero séguito al cruento assas-sinio di Caligola, nella ricostruzione di Rossella Laurendi (pp. 27-34) apparesenz’altro convincente. La scelta dei pretoriani si comprende, secondo l’A., allaluce di Ios. A.I. 19.227, la sola fonte a recepire un perduto autore di parte claudia.Le opinioni del démos e della boulé, vale a dire del popolo e del senato, non concor-davano, perché quest’ultimo s’illudeva di restaurare, con la libertas, il propriopotere, mentre il popolo nutriva risentimento nei confronti dei patres, ricono-scendo negli imperatori un freno alla loro avidità e un rifugio per sé stesso. Unarestaurazione della repubblica senatoria avrebbe, inoltre, comportato il rischio diuna guerra civile, come quella che s’era verificata ai tempi di Pompeo. I preto-riani, dal canto loro, sapevano che la porta del senato, a differenza di quella delprinceps, per loro sarebbe rimasta sbarrata: il che equivale a dire che essi intende-vano tutelare il rapporto di clientela che li vincolava alla gens imperatoria.
Meno rilevante – qualora, invece, guardassimo alle caratteristiche salienti delprincipato in quanto regime – sembrerebbe la discussione, impostata nel cap. IV(pp. 79-82), sulla volontà popolare come fattore di legittimazione del conferi-mento del potere. In effetti l’autrice si concentra sul problema della presa delpotere da parte di Claudio e si chiede esclusivamente chi fosse, nel conferimentodell’imperium al principe, il rappresentante più adeguato della volontà popolare: ilsenato o i milites? Ma questo approccio, a ben vedere, non costituisce un difetto,dal momento che il principato, come sottolineava Theodor Mommsen, muorecon ciascun imperatore, per rinascere sempre nuovo con il suo successore20. Ilche, a mio giudizio, impone di studiare sempre, allorché le fonti lo consentano, lepeculiarità di ogni singola adclamatio imperatoria.
In ogni caso occorre tener conto anche di alcune specifiche regolarità checonnotano, alla luce delle categorie costituzionali romane, l’investitura imperiale.In questo quadro ha rilievo solo secondario se l’acclamazione attributiva del-l’imperium (a maggior ragione qualora la Laurendi condivida, come mi pare, ladottrina del Mommsen) sia ritualmente compiuta o dal senato o dai soldati. Infatti
552 Recensiones librorum
.
21 A tal riguardo un’attenta disamina delle fonti e della storiografia è in MILAZZO, Profilicostituzionali del ruolo dei militari cit., 7 ss.
22 MOMMSEN, Römisches Staatsrecht3, II cit., 877 nt. 1 ritiene che il termine imperium, in Gaio
(1.5) e in Ulpiano (D. 1.4.1pr.-1), non indicherebbe altro che la ‘posizione imperatoria’ del prin-
cipe, bastando, invece, per l’imperium l’acclamazione militare o senatoria. Sul punto vd. anche
MANTOVANI, Le clausole «senza precedenti» della lex de imperio Vespasiani cit., 1038 e nt. 12. In ogni
caso proprio questa nomenclatura, adoperata dal Mommsen, non esclude la possibilità che i
modi d’esercizio dell’imperium fossero disciplinati anch’essi dalla cosiddetta lex di investitura su
conforme decisione del senato: tra le altre cose, si sarebbe dovuto quantomeno prevedere che
esso non si estinguesse quando l’imperatore avesse attraversato il pomerium, e si sarebbe dovuto
stabilire, inoltre, che esso fosse sempre maius rispetto a quello dei governatori delle province
proconsolari. Sui meccanismi di conferimento dei poteri imperiali vanno attentamente riconside-
rati alcuni testi della Historia Augusta (Pert. 5.6; Did. Iul. 3.4, Alex. Sev. 1.3, Tac. 19.2, Prob. 12.8; ma
vd., in part., M. Ant. 6.6) e di Tacito (Tac. Ann. 13.21.3 da riconnettere ad Ann. 12.41.1), testimo-
nianze che ricordano, significativamente, l’esistenza di un proconsulare ius (ius proconsulare). Sul tema
vd. J. BÉRANGER, L’imperium proconsulaire et la puissance tribunicienne dans l’Histoire Auguste, in BHAC1977/1978, Bonn 1980, 1-15; F. LOVOTTI, Il conferimento dei poteri ad Alessandro Severo con particolareriferimento ai tempi dichiarati nell’«Historia Augusta», in G. BONAMENTE-F. PASCHOUD (a c. di), Histo-riae Augustae Colloquium Perusinum, Bari 2002, 345-354. Vd. anche J. GAUDEMET, Le concept d’impe-rium dans l’Histoire Auguste, in BHAC 1968/1969, Bonn 1970, 91-97, 92 ss. part. e J. BÉRANGER,
L’expression du pouvoir suprème dans l’Histoire Auguste, in BHAC 1971, Bonn 1974, 21 ss. Da non tra-
scurare, infine, Cass. Dio 53.32.5-6, secondo il quale tutti i poteri del principe avrebbero un
fondamento legale: sulla visione dello storico bitinico, in ultimo, con bibl., M. L. FREYBURGER-
GALLAND, Res publica restituta chez Dion Cassius, in F. HURLET-B. MINEO (a c. di), Le Principatd’Auguste. Réalités et représentations du pouvoir. Autour de la Res publica restituta, Rennes 2009, 325 ss.,
337 ss.23 B. LEVICK, Claudius, New Haven – London 1990, 41 s.
l’insieme dei poteri, che corrispondono alla posizione imperatoria (quel cheUlpiano, in D. 1.4.1, connota con le parole omne suum imperium et potestas), è confe-rito dal populus al princeps mediante un atto che i giuristi romani definiscono lex deimperio. Sono molto numerose le testimonianze che attestano la continuità neltempo delle prerogative politiche del populus. Non ha importanza che la cosiddettalex de imperio, votata dal populus, fosse sempre stata – e così certamente in età anto-nina e severiana – la presa d’atto di decisioni assunte in altra sede. Le forme del-l’investitura imperiale mostrano che il regime del principato – se valutato sulpiano delle categorie del diritto di età repubblicana – non costituiva, né formal-mente né concettualmente, un potere assoluto (vale a dire un potere che trovi inse stesso o in una legittimazione solo divina il proprio fondamento). Per quantoeccezionali fossero i poteri del princeps (acclamato Augustus e imperator dal senato odai milites21), essi erano accordati, secondo procedure e regole del tutto consonealla tradizione, dal populus su conforme decreto del senato22. Pertanto, sul pianogiuridico, la costituzione imperiale si fondava, al pari di quella d’età tardo repub-blicana, sulla nozione di sovranità popolare.
5. – Claudio fu anche il primo imperatore estraneo alla gens Iulia: eppure egliassunse (come rileva l’A.) – sebbene le consuetudini che regolavano la trasmis-sione, di generazione in generazione, dei nomina (o dei cognomina) non lo prevedes-sero – l’appellativo di Caesar. In tal modo si inaugurò una prassi che fu perpetuataanche quando la cosiddetta dinastia giulio-claudia, con la morte di Nerone, siestinse. Non di meno la prospettiva di Courtney Edward Stevens (il cui pensiero èstato formulato in una conversazione privata, mai pubblicata, ripresa da BarbaraLevick in uno scritto del 199023), secondo il quale Claudio sarebbe stato il primo
553Recensiones librorum
.
24 Vd. H.A. Sev. 10.3, 10.5, 16.4, 19.3; Caracall. 9.2; Get. 2.2, 5.3; Macrin. 3.3, 3.9, 5.1;
Diadumen. 1.8, 6.2, 7.1, 7.6; Heliog. 1.5, 33.8; Alex. 2.2, 5.3, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.4, 9.6, 10.4.25 H. A. Val. 5.4-8; Val. 6.7-9.26 Difatti per l’elezione a pontifex maximus (comitia sacerdotiorum) si dovevano convocare soltanto
diciassette delle trentacinque tribù.27 T. E. J. WIEDEMANN, Claudius, in A. K. BOWMAN-E.CHAMPLIN-A.LINTOTT, The
Cambridge Ancient History2, X. The Augustan Empire, 43 B.C. – A.D. 69, Cambridge 1996, 230 s.
imperatore romano – una prospettiva che la Laurendi sembrerebbe condividerealmeno in parte – è, a mio giudizio, fallace. È senza dubbio vero che questa deci-sione ebbe effetti decisivi, dal momento che con quest’appellativo (Caesar) sisanciva la trasmissione del potere domestico nella famiglia dei ‘Cesari’ e, di conse-guenza, la compiuta legittimità dei principes. A tal riguardo si potrebbe farmenzione di un altro esempio solitamente trascurato dagli storici: il cognomen Anto-ninus, in conseguenza dell’auto-adozione di Settimio Severo nella famiglia diMarco Aurelio, avrebbe potuto divenire un ulteriore elemento connotativo dellacarica imperiale qualora, dopo quasi novanta anni (ottantaquattro per esserprecisi) di principes Antonini, Severo Alessandro non avesse rifiutato di assumerlocome proprio e, di conseguenza, non avesse posto consapevolmente fine a taletradizione24.
Ma, nella prospettiva dello Stevens, quella dell’imperatore sembrerebbeconnotarsi come una carica unitaria e non come una somma di poteri disgiunti(imperium proconsulare, tribunicia potestas, magistrature, pontificato massimo etc.). Èun punto di vista che, sul piano giuridico-costituzionale, non posso proprio condi-videre. A tal proposito potrei ricordare che anche l’autore di un’opera tarda (fineIV / inizi V secolo), come l’Historia Augusta, appariva in grado – proprio perché inpossesso di ampie cognizioni giuridico-antiquarie – di individuare le differenticomponenti magistratuali del potere del princeps e di elaborare, a tal riguardo,interessanti rilievi. Il Biografo sapeva cogliere, nella titolatura imperiale, i diffe-renti elementi che sostanziavano il potere della suprema carica e, allo stessotempo, giungeva perfino a immaginare – come attesta un episodio famoso, forseinventato di sana pianta – che una componente essenziale della posizione impe-riale (i poteri censorii), ne fosse scorporata per poter così restaurare, ma in unanuova dimensione, l’antica magistratura della censura25. Pertanto giuridicamentenon è mai venuta meno, perfino in epoca tardoantica, la capacità di percepire lapeculiare natura dei differenti poteri conferiti agli imperatori, distinguendo conprecisione gli uni dagli altri. E quest’osservazione trova riscontro anche nelcomplesso procedimento di investitura dei principes: infatti è assolutamenteevidente che, almeno nel I secolo d.C., i comitia consularia o, a maggior ragione, icomitia per l’elezione a pontifex maximus non possono coincidere con quelli attribu-tivi della tribunicia potestas e, forse, dell’imperium26.
6. – Si possono senz’altro condividere i rilievi critici della Laurendi(pp. 36-37) alle conclusioni di Thomas E. J. Wiedemann27, secondo il quale, perdefinire in termini propriamente giuridici il problema della proclamazione mili-tare di Claudio, si dovrebbe comparare il meccanismo istituzionale, che ha presie-duto a questa specifica presa del potere, con quelli che regolano la tutela dellapossessio nel processo interdittale. L’A. giustamente osserva che l’ambito dellequestioni giuridiche inerenti al problema della successione imperiale è del tuttodiverso da quelli che attengono al ius privatum. Secondo le categorie del dirittopubblico romano il potere conquistato illegalmente era al più qualificato, e sotto il
554 Recensiones librorum
.
28 MOMMSEN, Römisches Staatsrecht3, II cit., 1132-33.29 Gai. 1 regul. D. 50.17.100 Omnia, quae iure contrahuntur, contrario iure pereunt: vd. MOMMSEN,
Römisches Staatsrecht3, II cit., 1132.
profilo della legittimità, con il termine tyrannis. Ciò non di meno credo sia oppor-tuno sottolineare con maggior enfasi che il complicato ragionamento del Wiede-mann sarebbe stato considerato, alla luce delle loro categorie giu-ridico-costituzionali, assurdo dagli stessi romani di età imperiale fino altardoantico. Un riscontro, a tal riguardo, si legge nella vita Pescennii Nigri (2.5-7, inparticolare). Didio Giuliano, secondo il Biografo, sarebbe giunto a tal punto dipazzia da far emanare nei confronti di Settimio Severo un interdetto, col quale glisi proibiva di assumere l’imperium, perché apparisse che egli (Didio Giuliano), abuon diritto, aveva ottenuto il principatus, precedendo l’avversario: (2.7) par deniqueinsania fuit, quod cum Severo ex interdicto de imperio egisse fertur, ut iure videretur principatumpraevenisse.
7. – L’ascesa al potere di Claudio segnò politicamente la fine di ogni velleitàdi restaurazione della libertas repubblicana: e ciò appare senz’altro evidente allaluce delle Antiquitates Iudaicae (19.186-189), nelle quali Flavio Giuseppe descrivel’effimero tentativo di restaurazione del regime consolare del 24 gennaio del41 d.C. Se il principato muore con ciascun imperatore, per rinascere semprenuovo con il suo successore, il regime imperiale è però, anche e soprattutto,un’autocrazia temperata dalla rivoluzione giuridicamente permanente28, vale adire da un dispositivo che domina l’intero diritto, pubblico e privato, di Roma29:ogni rapporto di diritto si dissolve, viene meno, nello stesso modo in cui esso èstato costituito. Sul piano giuridico formale il principato, al pari delle magistra-ture straordinarie, è per davvero – come sottolinea il Mommsen – costituzional-mente ammissibile senza essere costituzionalmente necessario, né ha sensodefinirlo come un ordinamento facente capo al solo imperatore, proprio perchéesso moriva con ciascun principe, per rinascere sempre nuovo. Per esprimersi intermini più chiari, si deve riconoscere che il principato, proprio per perpetuarsi inquanto regime, deve regolarmente rigenerarsi e rilegittimarsi nelle istituzionirepubblicane. A ogni adclamatio imperatoria, che ha sempre, nel senso momm-seniano dell’espressione, una valenza ‘rivoluzionaria’, devono far necessariamenteséguito i decreti del senato e la lex o le leges di investitura votate dai comitia. Ma – loribadisco – sul piano politico (e, forse, anche sul piano di quel che oggi comune-mente si definisce costituzione materiale), l’ascesa al potere di Claudio segna ladefinitiva uscita di scena di ogni velleità di restaurazione repubblicana. Questoparticolare aspetto del principato è perfettamente colto dal Biografo della HistoriaAugusta (nella sua rapsodica, ma compiuta riflessione su tre secoli di storia delleistituzioni d’età imperiale), allorché egli, nella vita Avidii (Cassii), descrive i senti-menti politici di questo sfortunato usurpatore. Discendente, per linea materna,della stirpe dei Cassii (quelli che avevano cospirato contro Cesare), Avidio Cassionutriva in sé un odio segreto per il principatus e non poteva sopportare il nome diimperatore, sostenendo che nulla è più funesto del nome di impero, dal momentoche la res publica non se ne sarebbe potuta liberare se non per mezzo di un altroimperatore: 1.4 Hic ergo Cassius ex familia, ut diximus, Cassiorum, qui in C. Iuliumconspiraverant, oderat tacite principatum nec ferre poterat imperatorium nomen dicebatque {nil}esse gravius nomine imperii, quod non posset e r. p. tolli nisi per alterum imperatorem. Mi
555Recensiones librorum
.
30 TH. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht3, I, Leipzig 1887, 57; MOMMSEN, Römisches Staat-srecht3, II cit., 94-95, 241 s., 845.
31 Sulla questione se l’imperium consulare di Augusto, tra il 27 e il 23 a.C., fosse maius rispetto a
quello dei proconsules vd. F. HURLET-A. DALLA ROSA, Un quindicennio di ricerche su Augusto. Unbilancio storiografico, in SCO 45 (2009) (ma 2011), 173 ss., con particolare riferimento al contenuto di
contributi di cui qui non si è fatta menzione (quelli di A. Giovannini e di K. M. Girardet).32 J. L. FERRARY, À propos des pouvoirs d’Auguste, (2001), ora in ID., Recherches sur les lois comitiales
st sur le droit public romain, Pavia 2012, 513 ss., 521 ss.
sembra evidente come questo passo, confermi, ove ve ne fosse bisogno, il punto divista di Theodor Mommsen, per il quale il principato era un’autocrazia tempe-rata dalla rivoluzione giuridicamente permanente.
8. – È senz’altro vero che l’imperium conferito dall’adclamatio imperatoria deimilites non può essere identificato con l’imperium proconsulare. Ma non comprendoperché la Laurendi scriva che «la formula imperium proconsulare non <è> mai usatadalle fonti in riferimento ai principes» (p. 45). Come vedremo, così non è. Ma,prima di far menzione delle fonti che adoperano questa nomenclatura, è oppor-tuno sgombrare il campo da alcuni equivoci che ancora si rinvengono nellamanualistica italiana. Secondo Theodor Mommsen, Augusto, sebbene nel 27fosse console, avrebbe governato le Spagne, le Gallie, le Germanie, la Siria e, diconseguenza, comandato le legioni, che vi erano acquartierate, in forza di unimperium proconsulare. Difatti, a suo parere, una importante riforma sillana (una lexCornelia de provinciis) avrebbe completamente dissociato la magistratura superiore (ilconsolato e, di conseguenza, anche la pretura) confinata alla provincia urbana eall’imperium domi, e le promagistrature (proconsoli e propretori), che avrebberoricevuto il monopolio dell’imperium militiae e, dunque, delle provinciae30. In realtànon vi è mai stata, né in epoca sillana né successivamente31, una legge cheavrebbe espressamente privato il consulare imperium della sua componente militare.Ad Augusto viceversa – proprio come accadde a Cesare nel 59 a.C, con la lexVatinia, e a Pompeo e a Crasso, nel 55 a.C. con la lex Trebonia – furono attribuiti,benché fosse console, poteri straordinari e una vasta provincia. Ogni tentativo diinquadrare questi precedenti (del 59 e del 55 a.C.) e il dispositivo definito nel27 a.C. nella nozione di province consolari, nel senso tradizionale del termine,appare fallace, dal momento che tali attribuzioni si sottraggono, per le forme diconferimento dei poteri e per la loro durata, alla regola fondamentale della colle-gialità. Pertanto la discussione storiografica, focalizzata a torto sulla ricerca diun’evoluzione del consulare imperium, deve essere ricentrata, come ha osservatoJean-Louis Ferrary32, sul problema delle province e sui modi della loro collazione.Non vi è dubbio, dunque, che Augusto, nel 27 a.C., sia stato chiamato a gover-nare Spagne, Gallie, Germanie, Siria, nonché Egitto (secondo specifiche moda-lità, quest’ultimo, regolate da un’apposita lex), in virtù del consulare imperium, chegià possedeva quando queste provinciae gli furono affidate; ma dal momento cheegli le ricevette per un periodo di dieci anni e che, allo stesso tempo, non si potevaprevedere la continuatio del suo consolato durante questo lungo periodo, il senato-consulto, che fu decretato, e la legge che lo ratificò, dovevano prevedere cheAugusto avrebbe potuto governare le sue provinciae ‘come console o come procon-sole’ (consul prove consul). La provincia affidata ad Augusto nel 27 non era, pertanto,una provincia consularis (è significativo, del resto, che egli non la designi mai global-mente come propria provincia al singolare), né si subordina ai criteri di attribuzionetipici delle provinciae consulares. I provvedimenti assunti nel 27 a.C. si inscrivono
556 Recensiones librorum
.
33 Dio 53.32.5 «... inoltre, gli permise di assumere l’imperium proconsulare (ten te archen ten anthy-paton)...»: vd. nt. successiva.
34 F. COSTABILE – O. LICANDRO, Tessera Paemeiobrigensis. Un nuovo editto di Augusto dalla Tran-sduriana provincia e l’imperium proconsolare del princeps Roma 2000, MEP 3 (2000), 147-235; F. COSTA-
BILE, Addendum alla tessera Paemeiobrigensis, in MEP 6 (2001), 365-431; altra bibl. in FERRARY, Àpropos des pouvoirs d’Auguste cit., 528 s. e nt. 61.
35 Dio 53.32.5 «... a vita, di modo che non dovesse deporlo ogni volta che entrava nel pome-rium per poi riassumerlo nuovamente...».
36 Sulle quali, a eccezione di Ann. 13.21.3, non preso in considerazione né da MOMMSEN,
Römisches Staatsrecht3, II, cit., 855 e nt. 1, né da A. H. M. JONES, The ‘Imperium’ of Augustus (1951), in
ID., Studies in Roman Government and Law, Oxford 1960, 13-15, 15 part., vd. BÉRANGER, L’imperiumproconsulaire et la puissance tribunicienne dans l’Histoire Auguste cit., 6 s., 9 ss. con bibl. Egli, esaminando
anche Ann. 13.21.3, sottolinea opportunamente che non si può distinguere, a differenza di quanto
pensavano O. Karlowa e P. Willems, tra ius proconsulare e imperium proconsulare.
nella tradizione dei comandi straordinari della fine della Repubblica, che pote-vano essere attribuiti a un privatus investito, in certe occasioni, di un consulare impe-rium (come nel caso delle leggi Gabinia [67 a.C.] e Manilia [66 a.C.] in favore diPompeo), o a un console in carica (così, per esempio, con la lex Vatinia [59 a.C.] infavore di Cesare e con la lex Trebonia [55 a.C.] in favore di Pompeo e di Crasso).Si può affermare, in conclusione, che i consoli non sono mai stati espressamentespogliati del loro imperium militiae, benché, a eccezione di Augusto, non abbianopiù avuto, di fatto, occasione di esercitarlo. Ma, dopo il 23 a.C., Augustocontinuò a governare l’enorme provincia affidatagli, esercitando tale potere (impe-rium) in quanto promagistrato (pro consule)33. Quando egli, nelle province, volevadenominare questo potere magistratuale nella propria titolatura, adoperava iltermine proconsul, come ora è stato confermato da un editto da lui promulgato nel15 a.C. e riferito dalla cosiddetta Tessera Paemeiobrigensis34. Il senato e, soprattutto,il popolo, con un’apposita lex, dovettero precisare, non di meno, che l’imperium delprincipe, diventato proconsolare, dopo la sua rinuncia al consolato, non sisarebbe estinto quando egli avesse passato il pomerium e, in ogni caso, sarebbe statosuperiore anche a quello dei governatori delle province proconsolari (governate,cioè, secondo le regole fissate dalla lex de provinciis del 27 a.C.)35.
E tuttavia, già nel corso del I secolo d.C., per definire sinteticamente il poteredi comando (di fatto perpetuo) conferito ai principes, si cominciò ad adoperarel’espressione imperium proconsulare. Impongono di formulare questa conclusionealcuni testi degli Annales di Tacito (e proprio in riferimento al principato diClaudio) e dell’Historia Augusta: Tac. Ann. 12.41.1 et Caesar adulationibus senatus libenscessit, ut vicesimo aetatis anno consulatum Nero iniret atque interim designatus proconsulareimperium extra urbem haberet ac princeps iuventutis appellaretur; Ann. 13.21.3 Baiarumsuarum piscinas extollebat, cum meis consiliis adoptio et proconsulare ius et designatio consulatuset cetera apiscendo imperio praepararentur; H.A. M. Ant. 6.6 post haec Faustinam duxituxorem et suscepta filia tribunicia potestate donatus est atque imperio extra urbem proconsulariaddito iure quintae relationis), che parlano di imperium (o ius) proconsulare. Sono tuttetestimonianze36 che, da un canto, consentono di presumere – se seguiamo l’ipotesiinterpretativa dello Jones (che diverge sensibilmente da quella del Mommsen) –l’esistenza di una specifica disciplina per legem dello stesso imperium attribuito all’Au-gustus dall’adclamatio imperatoria dei milites o del senato e, per altro canto, permet-tono di concludere che ad alcuni giovani «correggenti» della famiglia imperiale(in questo specifico caso a due adottati dall’Augustus in carica [rispettivamenteClaudio e Antonino Pio]), come Nerone, nel 51 d.C., e Marco Aurelio, sia stato
557Recensiones librorum
.
37 Cfr. M. PANI, L’imperium del principe, in Acta Flaviana I, Roma 2009, 193. Sulla medesima
linea del Pani si colloca anche P. BUONGIORNO, Nuove riflessioni sui poteri di L. Vitellius nell’anno 43d.C., in RIDA 55 (2008), 139 ss., 147 ss., 151 ss.. 156 e nt. 56 part., per il quale, con una critica alle
tesi dello Jones, a L. Vitellio, nel 43 d.C., e, forse, prima di lui, a L. Aelius Seianus, sarebbe stato
conferito, in una sorta di ‘collegialità impropria’, un imperium consulare domi et militiae. Dione Cassio
(58.7.4 in riferimento a Seiano), adoperando l’espressione anthypatike exousía, definirebbe proconsu-lare un imperium che ancora non era noto come tale. È possibile che sia così: ma io propenderei
per l’ipotesi che la fonte di Tacito (in Ann. 12.41.1) già utilizzasse tale nomenclatura.38 FERRARY, À propos des pouvoirs d’Auguste cit., 527, 563 ss.39 Si tenga presente, a tal riguardo, che Augusto recuperò l’uso in Roma delle insegne del-
l’imperium soltanto nel 19 a.C. mediante la promulgazione – occorre presumere – d’una specifica
legge. Come abbiamo più volte ricordato, nella tradizione repubblicana il promagistrato, facendo
ritorno dalla propria provincia, conservava il suo imperium finché non avesse oltrepassato il pome-rium. L’imperium, d’altra parte, comportava anche l’uso degli insignia (littori e fasces, in particolar
modo) e l’esercizio di una serie di poteri da esso indissociabili, come, per esempio, la coercitio e la
iurisdictio. Nel 23 a.C., allorché gli fu attribuita la tribunicia potestas, Augusto ottenne di essere
esonerato, al contempo, dalla regola che impediva, a pena di perdere l’imperium, di attraversare il
pomerium. Questo fondamentale privilegio poneva, però, problemi di cui non si era percepita a
pieno la portata. Infatti, fino al 19 a.C., Augusto dovette astenersi, all’interno del pomerium, da
ogni atto idoneo a manifestare il proprio imperium. Su questo punto la legge del 23 a.C. probabil-
mente non si pronunciava. Al contrario, nel 19 a.C., si precisò che Augusto, proprio come acca-
deva all’esterno del pomerium, poteva essere preceduto anche in città dai suoi littori (in numero di
concesso un imperium proconsulare che, però, non contemplava, forse, né l’uso degliinsignia, né l’esercizio del potere, così conferito, entro l’urbs37.
Nel I secolo d.C. e, probabilmente, già sotto il regno di Claudio, si iniziò aconnotare l’imperium dei principes – svincolato dall’osservanza della regola quoad inurbem introisset e, praticamente, divenuto perpetuo – come imperium proconsulare.Occorre, tuttavia, pur sempre distinguere lo scopo sotteso alla misura del 23 a.C.da una conseguenza che le è solo implicita e che si manifestò a pieno solo inséguito, nel corso del principato di Tiberio. Augusto non tentò, attraverso unsotterfugio, di farsi attribuire un imperium virtualmente perpetuo. E, per smentireuna simile affermazione, è sufficiente ricordare come egli abbia costantementeprovveduto, fino alla sua morte, a far decretare dal senato e a far votare daicomizi la prorogazione di un imperium e di province per i quali, ogni volta, eraprevista una durata limitata di dieci o cinque anni. Mentre, nella tradizione deldiritto pubblico d’età repubblicana, il promagistrato restava alla testa dellapropria provincia fino all’arrivo del suo successore, e conservava l’imperium fino almomento in cui oltrepassava, ritornando in città, la linea del pomerium, questotermine fu eliminato, per il princeps, dalla riforma del 23 a.C., senza, al contempo,introdurre un nuovo termine legale. La conseguenza di questa lacuna non potevamanifestarsi prima che un princeps dimenticasse di farsi rinnovare i propri poteri(cosa che accadde con Tiberio, nel 23 d.C., allo scadere del termine dei poteriche gli erano stati rinnovati, per un decennio, nel 13 d.C.). Soltanto alloradivenne evidente che il suo imperium non aveva un termine legale, a maggiorragione perché il senato, al termine del decennio, non avrebbe inviato, nelleprovince cosiddette imperiali, proconsoli che subentrassero ai legati pro praetore dinomina imperiale38.
Questo specifico potere dei principes, connotato come imperium proconsulare, eradefinito extra urbem, così come per Nerone in età claudiana, se al giovane destinatoalla successione non era concesso, a differenza dell’Augustus, di far uso delleinsegne dell’imperium all’interno del pomerium39. Naturalmente, mentre non si
558 Recensiones librorum
.
dodici): tutto questo (ossia l’uso degli insignia imperii) implicava, al contempo, il possesso della coer-citio e, virtualmente, d’una certa iurisdictio.
possono coltivare dubbi di sorta sull’impiego della formula imperium proconsolare giànel corso del I secolo d.C., è senza dubbio arduo, al contrario, comprendere comee perché il suo uso si sia imposto.
9. – Il quinto capitolo (Conquiste e integrazione dell’impero, pp. 93-116), esaminal’insieme delle testimonianze storico-letterarie, epigrafiche e numismatiche dedi-cate alle campagne militari di Claudio. All’esordio del suo regno, il principe, perlegittimare il proprio potere di fronte alla sorda ostilità del senato, diede inizio auna fortunata e veloce campagna di conquista della Britannia. Ma perfino questorapido successo gli fu ritorto contro: le vociferazioni senatorie sulla troppo facilee, dunque, ingloriosa conquista della Britannia spiegherebbero, secondo laLaurendi, certi accenti della celebrazione claudiana della conquista e, in partico-lare, l’inusitata violenza che si rappresenta, nel famoso rilievo di Afrodisia, controla nuova provincia (p. 92, fig. 35). Nel confrontarsi con il tema della visione ecume-nica della romanità nel pensiero di Claudio, l’autrice formula interessanti osserva-zioni sulla tabula Lugdunensis e sulla tabula Clesiana: l’indubbia originalità della suapolitica in tema di concessione della cittadinanza ai provinciali, è valutataconfrontandola con i precedenti di Cesare e con le attitudini più restrittive diAugusto, e, infine, con quelle di nuovo ben più generose di Adriano.
10. – Chiudono il libro un’appendice di Tavole con riproduzioni di statue,epigrafi, cammei, affreschi ed edizioni relativi al principato di Claudio (pp. 114-128); un ragguaglio bibliografico (pp. 129-146) e, infine, gli indici (delle fonti,pp. 147-149; dei termini giuridici, pp. 150-151; dei nomi geografici, topografici edi popoli, p. 154; degli autori moderni, pp. 155-158).
Insolitamente ricco ed elegante è l’apparato iconografico che correda questobel libro. Le immagini, soprattutto quelle dei conii costantemente interpretate allaluce delle iscrizioni delle loro legendae, consentono di confrontarsi con fonti cherecuperavano le peculiari visioni istituzionali di ceti estranei al ristretto ambitodelle élites dominanti (vale a dire l’ordine senatorio e l’ordine equestre). Forse èimproprio parlare, per il mondo antico, di propaganda, ma l’insistito ricorrere,nei primi anni del principato claudiano, di certe immagini e di certe legendae non ècasuale. Nel gioco politico inaugurato dall’adclamatio imperatoria di Claudioavevano conquistato forza e peso politico, a scapito delle velleità repubblicanedell’ordo senatorius, nuovi ceti, come, per esempio, le ‘borghesie’ dei municipiiitalici, ben rappresentate nelle coorti della guardia pretoriana.
Al di là di alcuni sporadici e in fondo marginali punti di dissenso, quello diRossella Laurendi è per davvero un bel libro, elegante e di piacevole lettura. Untratto lo connota in modo estremamente positivo: lo studio del diritto romano, inspecial modo di quello pubblico, rivolto a una più profonda conoscenza delle isti-tuzioni del mondo antico, e non ridotto, come anche purtroppo a volte accade, aun inutile esercizio fine a se stesso.
VALERIO MAROTTA
Univ. Pavia [email protected]