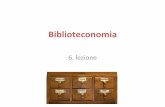2 FG9A Nationale Patente Brevets nationaux Brevetti nazionali
Questioni nazionali e questione delle nazionalità nell'Europa ottocentesca
Transcript of Questioni nazionali e questione delle nazionalità nell'Europa ottocentesca
MEMORY, IDENTITY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Iulian Boldea (Coord.)
Edizioni Nuova Cultura
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Copyright © 2012 Edizioni Nuova Cultura - Roma ISBN: 9788868120016 DOI: 10.4458/0016 Copertina: Dumitru-Mircea Buda Composizione grafica: Dumitru-Mircea Buda
È vietata la riproduzione non autorizzata, anche parziale, realizzata con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia,
anche ad uso interno o didattico.
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Table of Contents
Iulian Boldea Introduction (DOI: 10.4458/0016-01) ................................................................... 7
Al. Cistelecan Faith Testimonials (DOI: 10.4458/0016-02) .................................................... 11 Ștefan Borbely The Literary Pursuit of a Historian of Religions: The Case of Ioan Petru Culianu (DOI: 10.4458/0016-03) .................................................................................. 29 Caius Dobrescu Sphinx Riddles for Zalmoxis (DOI: 10.4458/0016-04) ................................... 43
Codrin Liviu Cuțitaru Identities and Models in Romanian Criticism (DOI: 10.4458/0016-05) ......................................................................................................... 59 Ovidiu Pecican Between Dacians and Roma People (DOI: 10.4458/0016-06) ........................ 71 Dumitru Chioaru Après le Postmodernisme: le Neant ou Bien un Nouveau Classicisme? (DOI: 10.4458/0016-07) ................................................................................... 85 Cornel Sigmirean A Romanian Student in Rome at the Second Half of the 19th Century (DOI: 10.4458/0016-08) ........................................................................................... 93 Liviu Malița 1918: One Nation and Two Memories (DOI: 10.4458/0016-09) ....................... 121 Mircea A. Diaconu The Critical Spirit in“România Literară” in 1989 (DOI: 10.4458/0016-10) ....................................................................................................... 135 Sorin Crișan The Transylvanian Printing in the 16th-17th Century (DOI: 10.4458/0016-11) ........................................................................................................ 147 Iulian Boldea E.M. Cioran. Exile and Melancholy (DOI: 10.4458/0016-12) ......................... 157 Dorin Ștefănescu Centre et Concentration. L’Actualité d’une Théorie Romantique (DOI: 10.4458/0016-13) ................................................................................... 169 Nicoleta Sălcudeanu La Dissidenza Romena durante il Regime Comunista (DOI: 10.4458/0016-14) ....................................................................................................... 179 Andrei Terian The Dark Modernism (DOI: 10.4458/0016-15) ............................................. 193 Adrian Lăcătuș The Novel and the Community (DOI: 10.4458/0016-16) ............................ 207 Cătălin Ghiță William Blake’s Aesthetic Vision: Milton (DOI: 10.4458/0016-17) ................ 215 Luminița Chiorean, Andreea-Maria Sâncelean Sexism and Language (DOI: 10.4458/0016-18) ....................................................................................................... 227
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Table of Contents 6
Giordano Altarozzi Questioni Nazionali e Questione delle Nazionalità nell’Europa Ottocentesca (DOI: 10.4458/0016-19) .................................................................................. 247 Eugeniu Nistor Communication, Action et Connaissance (DOI: 10.4458/0016-20) ............. 263 Alex. Cistelecan From Legitimation to Information, and Back Again (DOI: 10.4458/0016-21) ........................................................................................................ 269 Simina-Maria Terian The Basis for the Semantics of Repeated Discourse (DOI: 10.4458/0016-22) ........................................................................................................ 281 Doina Butiurca On a Typology of Lexical-Semantic and Syntactic Creativity in the Advertising Text (DOI: 10.4458/0016-23) ............................................................................ 293 Constantina Raveca Buleu Symbolic Forms of Power in the 19th Century Europe (DOI: 10.4458/0016-24) ........................................................................................... 301 Petruța Blaga, Smaranda Ștefanovici Conceptual Clarifications on Communication Based on Distance Education and Training of Human Resources (DOI: 10.4458/0016-25) ..... 319 Dumitru-Mircea Buda Identity and Coherence in the Structure of Postmodernism (DOI: 10.4458/0016-26) .............................................................................. 331 Daniela Petroșel Romanian Science Fiction and the Working Future (DOI: 10.4458/0016-27) ....................................................................................................... 339 Eva Monica Szekely Intercultural Practice Development in Higher Education (DOI: 10.4458/0016-28) ....................................................................................................... 349 Dana Rus Explicit Allegiance in the Formation of American Identity (DOI: 10.4458/0016-29) ....................................................................................................... 363 Fábián István Some Aspects Concerning Jewelry and Weapons as Markers of Ethnicity (DOI: 10.4458/0016-30) ....................................................................................... 373 Bianca-Oana Han Words that ‘Speak’ My World (DOI: 10.4458/0016-31) .......................... 383 Maria-Laura Rus Meaning Extension in Romanian and Italian (DOI: 10.4458/0016-32) .... 391 Lucian Săcălean Romanies, a Present Matter (DOI: 10.4458/0016-33) ................................ 399 Corina Bozedean Le Dialogue des Cultures chez Henry Bauchau, à Travers le Mythe de Babel (DOI: 10.4458/0016-34) ......................................................................................... 411 Nicoleta Medrea Looking from the Other Side: Kipling’s Travel Impressions (DOI: 10.4458/0016-35) ....................................................................................................... 421 Lako Cristian Which Way Localization: Translation or Copywriting? (DOI: 10.4458/0016-36) ....................................................................................................... 433 Cristina Nicolae Madness and the Dissolution of the Self: Mrs. Dalloway (DOI: 10.4458/0016-37) .................................................................................................................................................. 433
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Giordano Altarozzi QUESTIONI NAZIONALI E QUESTIONE DELLE
NAZIONALITÀ NELL’EUROPA OTTOCENTESCA
Abstract: During the XIXth century, the Central and Eastern Europe is crossed by the process of national identity’s affirmation. All the national movements, often in conflict with each other, have a common enemy in the three Empires ruling over the region. The national issue spreads everywhere in Central and Eastern Europe, assuming a value of contestation of the estab-lished order. But the struggle for national affirmation also produces a strug-gle between nationalities: the national idea starts to become nationalism. Key-words: Nationalities, National Idea, Nationalism, Central and Eastern Europe, Risorgimento. Nel corso dell’Ottocento l’Europa centro-orientale è percorsa da un processo di affermazione dell’identità nazionale, destinato a produrre una vera e propria rivoluzione della carta geopolitica continentale. Nonostante le tante differenze e contrapposizioni, tale processo pre-senta una caratteristica di base comune, costituita dalla lotta contro le «rigide cornici sopranazionali, a base dinastica»1 rappresentate dai tre grandi imperi che dominano l’Europa centrale e quella danubiano-balcanica i quali, dopo una lunga fase di lotte che caratterizza la pri-ma età moderna, giungono nel corso della prima metà del Settecento a un tacito compromesso in detrimento di quei popoli che cominciano
1 Angelo Tamborra, L’Europa centro-orientale nei secoli XIX-XX (1800-1920), Vallar-
di, Milano 1971, p. 3.
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Giordano Altarozzi 248
a sviluppare un sentimento nazionale e a sollevare la questione della loro rappresentanza in un corpo politico indipendente.
Questo processo presenta notevoli differenze se comparato con quello di più antica origine che si svolge in Occidente. Le differenze tra le due parti del continente vanno ricercate nello sviluppo storico di lungo periodo2. Nell’Europa occidentale, dalla fine dell’epoca me-dievale si sviluppano – seppure con alcune rilevanti eccezioni, come Italia e Germania – le prime formazioni statali moderne che costitui-scono la culla dei futuri Stati nazionali3. Nell’Europa centro-orientale, al contrario, si affermano le grandi formazioni plurinazionali, che so-stituiscono il principio nazionale con quello dinastico. Come conse-guenza, anche il risveglio nazionale dei popoli europei procede lungo percorsi differenziati; in Occidente esso è relativamente accelerato e avviene di solito in accordo con le case regnanti, interessate a sfrutta-re a proprio vantaggio qualsiasi possibile elemento capace di garanti-re l’accentramento del potere da parte della corona; la particolare conformazione geografica e demografica riduce poi i conflitti interni tra nazionalità diverse, limitati qualora esistano a ristrette zone di frontiera. In Europa centro-orientale invece la storia ha lavorato più in profondità, producendo una commistione di popoli, lingue, con-fessioni religiose che pongono – e porranno ancor più con la compar-sa del sentimento nazionale – seri problemi di convivenza, rendendo più difficile il cammino verso la formazione di Stati nazionali, da rea-lizzare il più delle volte in opposizione alle dinastie – che compren-dono il valore rivoluzionario e per esse potenzialmente mortale delle nuove idee – e agli altri popoli conviventi su uno stesso territorio4. So-lo alla fine del Settecento è possibile trovare un primo, significativo tentativo di affermazione di quelle che qualche secolo più tardi Otto
2 Sull’importanza della lunga durata nella comprensione dei fenomeni e dei pro-
cessi storici cfr. Fernand Braudel, Histoire et Sciences sociales. La longue durée, in “An-nales. Économie, Sociétés, Civilisations”, a. 1958, vol. 13, nr. 4, pp. 725-753.
3 Cfr. Giovanna Motta, La nuova organizzazione dello Stato nell’Europa dell’età moder-na, in “Anuarul Institutului Italo-Român de Studii Istorice”, a. 2004, nr. 1, pp. 23-36.
4 Sulla nascita e la diffusione del sentimento nazionale in diverse parti d’Europa si vedano: Federico Chabod, L’idea di nazione, Laterza, Roma / Bari 2008; Hagen Schulze, Aquile e leoni. Stato e nazione in Europa, Laterza, Roma / Bari 2004.
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Memory, Identity and Intercultural Communication 249
Bauer avrebbe definito “nazionalità senza storia”5; tale tentativo è fa-vorito dalla diffusione delle idee della Rivoluzione francese, che rag-giungono anche gli angoli più remoti d’Europa portate dalle truppe napoleoniche, dal successo del nascente capitalismo industriale che genera una nuova classe borghese cosciente di sé e portatrice di inte-ressi e aspirazioni nuove, che mal si conciliano con il sistema dell’Ancien Régime, dall’avvento infine della nuova cultura romantica, soprattutto di matrice tedesca, che con il pensiero di Johann Gottfried Herder propaga nella coscienza collettiva il mito nazionale e la mis-sione storica di cui ogni nazione è portatrice. Come evidenzia Robert J. W. Evans, ci si trova dunque di fronte a un paradosso: l’interna-zionalizzazione dei processi ricordati porta ovunque in Europa alla diffusione del culto della propria nazione, delle peculiarità del pro-prio popolo e implicitamente alla superiorità di quest’ultimo in rap-porto con gli altri6.
Tale risveglio nazionale forza gli schemi dinastici e sopranaziona-li, seppure in gradi e tempi diversi da caso a caso. Le prime avvisa-glie di tale processo si riscontrano laddove l’istituzione imperiale ri-sulta più debole, all’interno dell’Impero ottomano, che già da lungo tempo si trova in crisi e che secondo molti è tenuto in vita artificial-mente da Inghilterra e Francia, a cui poi si aggiungerà l’Austria, che ne percepiscono il valore stabilizzatore sia contro l’avanzata degli in-cipienti nazionalismi che dell’espansionismo russo, mirante a esten-dere il proprio controllo sulla regione balcanica, dove favorisce pro-getti pan-slavisti, e su quella mediterranea, dove invece accentua la comune appartenenza al cristianesimo orientale, come avviene con il trattato di Küçiük Kaynarka del 1774, che sancisce il diritto di inter-vento dello zar a difesa dei sudditi ortodossi del sultano. Dall’Im-pero ottomano, con l’indipendenza greca e la sempre maggiore au-tonomia dei Principati danubiani e della Serbia, i movimenti nazio-nali si estendono rapidamente all’intera regione, e soprattutto ai ter-
5 Cfr. Otto Bauer, Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Verlag der Wie-
ner Volksbuchhandlung Ignaz Brand, Wien 1907, pp. 187 segg. 6 Cfr. Robert J. W. Evans, Austria, Hungary, and the Habsburgs. Essays on Central
Europe, c. 1683-1867, Oxford University Press, Oxford / New York, 2006, pp. 102-103.
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Giordano Altarozzi 250
ritori sottoposti all’autorità asburgica, dove la sapiente politica di Giuseppe II, di Maria Teresa, di Leopoldo II non riesce a sedare le aspirazioni di tutte quelle nazionalità che li abitano. Al contrario, proprio il riformismo che caratterizza tale epoca porta alla nascita di una prima classe borghese che tenta di adeguarsi agli orientamenti della borghesia occidentale, abbracciando dunque sia rivendicazioni liberali che nazionali7.
L’aspetto sociale costituisce infatti uno dei tratti fondamentali co-muni a tutta l’Europa centro-orientale. Dalla Russia alla penisola da-nubiano-balcanica si assite alla graduale costituzione di un’élite di estrazione piccolo-nobiliare e borghese influenzata, grazie anche alla peregrinatio academica di quegli anni, dalle diverse correnti politico-culturali occidentali8. La questione nazionale finisce dunque per so-vrapporsi a quella sociale, e le rivendicazioni nazionali della nascente borghesia hanno anche una valenza di contestazione dell’ordine co-stituito, basato in gran parte sui privilegi dell’alta nobiltà tradiziona-le, che nella prima metà del XIX secolo rappresenta il più fedele, se non l’unico alleato delle dinastie, ivi compresa quella asburgica: «Questa classe media..., pur senza costituire un corpo a sé e avere chiara coscienza della propria entità come classe sociale si colloca tut-tavia come un elemento dinamico fra la nobiltà, da un lato e il ceto contadino... dall’altro. Aperto verso l’alto e verso il basso, questo ceto finirà col rappresentare l’elemento nazionale di rottura del vecchio ordine dinastico, e insieme sociale, con finalità e obiettivi che sono nazionali»9.
Di fronte alla montante marea delle rivendicazioni nazionali, i grandi imperi dinastici tentano di rispondere con i mezzi più diversi: l’accresciuto controllo da parte delle polizie politiche dei diversi Stati si alterna e a volte si affianca a politiche riformiste e talora a soluzioni costituzionali, mentre vengono avviate politiche pubbliche volte ad ampliare talune istituzioni – come esercito e scuola, per esempio – de-
7 Cfr. Angelo Tamborra, op. cit., pp. 4-5. 8 In merito si veda Cornel Sigmirean, The Students and the European Assertion of the
National Issue, in “Transylvanian Review”, a. 1994, vol. III, n. 4, pp. 127-143. 9 Angelo Tamborra, op. cit., p. 9.
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Memory, Identity and Intercultural Communication 251
stinate ad accrescere la fedeltà dei sudditi nei confronti della dina-stia10. I contrastanti interessi di politica estera degli imperi finiranno però per favorire la comparsa di sentimenti nazionali. I richiami alla comune origine slava o tedesca generano in talune popolazioni un sentimento di appartenenza a un corpo distinto, e questo a sua volta produce una reazione da parte degli altri elementi etnici posizionati ancora al margine della storia, che cercano nel passato storico gli ele-menti di un’eredità spesso inventata, ma comunque percepita come reale: «Non una certa storia fa la nazione, bensì la nazione, una volta costituita, inventa la storia che, apparentemente, ne sta alla base. Non una certa lingua, condivisa, aggrega gli uomini all’interno della na-zione, bensì la nazione, una volta costituita, elabora una lingua stan-dard che impone a tutti i suoi membri»11.
L’elemento culturale presenta dunque un primato rispetto a quello propriamente politico12. All’inizio la lotta è condotta sul terreno lin-guistico e storico, e laddove la lingua vernacolare è caduta in desue-tudine, l’obiettivo primo è quello di ristabilirne la piena validità lette-raria e poi politico-amministrativa. La lotta per la lingua rappresenta dunque l’aspetto primario dell’ascesa nazionale, e intorno a essa ap-paiono i primi contrasti con l’autorità centrale, ma anche con le altre nazionalità. È il caso del croato, sostituito a seconda delle zone dall’ungherese, dal tedesco o dall’italiano, ma anche quello del bulga-ro, del serbo, del romeno, dell’ucraino13. Il risveglio nazionale di talu-
10 Cfr. Teodora Shek Brnardić, Modalities of Enlightened Monarchical Patriotism in
the Mid-Eighteenth Century Habsburg Monarchy, in Balázs Trencsényi – Márton Zászka-liczky (eds.), Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Pa-triotic Discourses in Early Modern East Central Europe, Brill, Leiden / Boston 2010, pp. 631-661.
11 Cfr. Lucian Boia, Două secole de mitologie naţională, Humanitas, Bucureşti 2002, pp. 15-16.
12 Sulle diverse implicazioni della visione politica rispetto a quella culturale della nazione in Europa centrale e centro-orientale, cfr. Guido Zernatto, L’Autriche et l’Europe centrale, in “Politique étrangère”, a. 1940, vol. V, nr. 1, pp. 24-34.
13 Si vedano, tra i tanti casi, Antonello Biagini, Simeon Radev. Le nazioni balcaniche e la guerra italo-turca (1911-1912), in “Rassegna Storica del Risorgimento”, a. LXIII, vol. 63, fasc. 4, Ottobre-Dicembre 1976, pp. 203-214; Robert J. W. Evans, Language and State
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Giordano Altarozzi 252
ni popoli provoca infatti, quasi per emulazione, processi simili presso altri, ma spesso determina pure reazioni e opposizioni. Nel caso dell’Ungheria asburgica, per esempio, l’ascesa del sentimento nazio-nale magiaro significa in primo luogo opposizione all’elemento do-minante tedesco, ma allo stesso tempo produce rivalità difficili da controllare con le altre comunità non magiare, che già dal XVIII seco-lo hanno cominciato a loro volta a esprimere una propria coscienza nazionale.
Un problema nuovo si affaccia quindi nell’evoluzione storica e po-litica dell’Europa centro-orientale: quello della differenziazione na-zionale, che significa esigenza di definizione del limite, della frontiera tra una nazione e l’altra, frontiera che è in primo luogo culturale, ma che tende presto a trasformarsi in politico-territoriale14. E ciò solleva a sua volta questioni nuove, di lunga durata, che affliggono il continen-te europeo dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai giorni nostri. Se infatti i confini geografici, politici, economici tra determinate regioni possono essere tracciati con relativa facilità, molto più difficile risulta l’identificazione dei limiti precisi di frontiere che sono a un tempo culturali ed etniche. Tra i due concetti – confine e frontiera – esiste una differenza apparentemente sottile ma estremamente importante: il primo rappresenta uno spazio geografico ben delimitato, una linea di equilibrio tra due soggetti politici che separa ma che al tempo stes-so mette in contatto, senza produrre necessariamente conflitti insana-bili; la seconda si configura invece come una fascia dinamica che con-
Building: The Case of the Habsburg Monarchy, in “Austrian History Yearbook”, a. 2004, vol. 35, pp. 1-24; Daniel Baric, Á l’écoute des langues parlées en Croatie durant la première moitié du XIXe siècle. Entre communication et incompréhensions, la parte de l’allemande, in “Balkanologie. Revue d’études pluridisciplinaires”, a. 2004, vol. VIII, nr. 2, pp. 71-87. Una trattazione generale in Robert J. W. Evans, Austria, Hungary, and..., cit., pp. 109-112.
14 Cfr. Robert J. W. Evans, Essay and Reflection: Frontiers and National Identities in Central Europe, in “The International History Review”, a. 1992, vol. XIV, n. 3, pp. 480-502; Rolf Petri, Gerarchie culturali e confini nazionali. Sulla legittimazione delle frontiere nell’Europa dei secoli XIX e XX, in Silvia Salvatici (a cura di), Confini. Costruzioni, attra-versamenti, rappresentazioni, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, pp. 79-99.
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Memory, Identity and Intercultural Communication 253
trappone due mondi diversi15. Le frontiere tra diverse nazionalità so-no dunque mobili e, si potrebbe aggiungere, sfumate, perché le zone di contatto, dove finisce una nazione e comincia un’altra, danno luo-go a un’area in cui popolazioni diverse convivono e tendono a fon-dersi. In tal modo compaiono sulla scena politica, fin dal 1848, quei problemi di delimitazione che daranno luogo a lunghe e dolorose questioni territoriali, in molti casi ancora irrisolte: questione adriatica tra italiani e slavi, questione transilvana tra magiari e romeni, contra-sto nazionale tra serbi, croati e magiari nella Penisola balcanica, que-stioni slovacca e rutena, solo per ricordarne alcune16.
Se da tale quadro generale si passa all’analisi del caso specifico dell’Impero asburgico, si può notare una singolare particolarità, ossia la sostanziale coincidenza di attegiamento fra la politica di differen-ziazione nazionale perseguita dal centro e l’analogo sforzo di indivi-duazione portato avanti dalle singole nazionalità17. Il primo terreno su cui avviene tale incontro è quello puramente statistico, quantitati-vo; sia le nascenti nazionalità, sia l’amministrazione imperiale sento-no l’esigenza di creare un quadro d’insieme che offra le corrette pro-porzioni delle forze in campo, le prime al fine di valutare al meglio le effettive possibilità di successo in caso di lotta armata rivoluzionaria,
15 Cfr. Diego Redivo, “Il confine orientale: un’analisi storica”, in Aa. Vv., Fiume le-
gionaria. A ottant’anni dall’impresa dannunziana. Atti del Convegno. Trieste, 27 novembre 1999, Arti grafiche Riva, Trieste 2001, pp. 50-51.
16 In merito ai singoli casi e alla loro evoluzione di lungo periodo si vedano Carlo Magnino, Il complesso etnico dei Carpazi: escursioni nella Rutenia carpatica, Istituto per l’Europa orientale, Roma 1933; Ernesto Sestan, Venezia Giulia. Lineamenti di storia etni-ca e culturale, Edizioni Italiane, Roma 1947; Antonello Biagini, Storia della Turchia con-temporanea, Bompiani, Milano 2002; Idem, Storia della Romania contemporanea, Bom-piani, Milano 2004; Idem, Storia dell’Ungheria contemporanea, Bompiani, Milano 2006; Pasquale Fornaro, Risorgimento italiano e questione ungherese (1849-1867). Marcello Cer-ruti e le intese politiche italo-magiare, Rubbettino, Soveria Mannelli 1995; Stefano Bian-chini, La questione jugoslava, Giunti, Firenze 2003; Giuseppe Motta, Le minoranze nel XX secolo. Dallo Stato nazionale all’integrazione europea, FrancoAngeli, Milano 2006; Alessandro Vagnini, L’Ungheria nella guerra dell’Asse, Periferia, Cosenza 2007; Stefano Bottoni, Transilvania rossa. Il comunismo romeno e la questione nazionale, 1944-1965, Ca-rocci, Roma 2007.
17 Cfr. Angelo Tamborra, op. cit., p. 13.
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Giordano Altarozzi 254
la seconda per valutare la reale forza numerica dei nuovi soggetti che si affacciano sulla scena della storia. Da tale sforzo emergono i primi censimenti imperiali miranti a valutare le singole forze nazionali con cui ormai si devono fare i conti, a testimonianza del fatto che esse fanno ormai parte della realtà dell’Impero asburgico. Ciò non signifi-ca però che Vienna sia ormai disposta ad accettare la trasformazione interna dell’Impero e a riconoscere frontiere interne tracciate su basi nazionali18. Al contrario, i censimenti che si susseguono tra gli anni Quaranta e Ottanta del secolo hanno la finalità di tracciare un quadro chiaro delle diverse realtà dell’Impero al fine di meglio utilizzarle le une contro le altre per poter così mantenere più a lungo possibile la struttura centralista dello Stato. Si tratta della tradizionale politica del divide et impera, che la corte imperiale applicherà per tutto il XIX seco-lo appoggiandosi di volta in volta, a seconda delle contingenze, su una o più nazionalità contro le altre19.
Tale politica diventa esplicita nel corso degli eventi rivoluzionari del 1848-1849, al tempo stesso liberali e nazionali, che scuotono a fondo la struttura politica dell’Impero e, nonostante il successo finale delle forze reazionarie, cambiano definitivamente la cornice storica in cui esso opera. La Primavera dei Popoli rappresenta veramente un momento di svolta nella storia europea e mondiale, tant’è che uno storico di primo livello come Eric J. Hobsbawm non esita a definirla: «the first and last European revolution in the (almost) literal sense... the vir-tually simultaneous overthrow of old regimes over the bulk of continental Europe west of the Russian and Turkish empires, from Copenhagen to Pa-lermo, from Brasov to Barcelona»20. Tale carattere epocale è confermato da Angelo Tamborra, secondo il quale: «la scomparsa dalla scena del Metternich si unisce ad un primo, fecondo incontro di popoli, di ceti intellettuali e rivoluzionari che fanno appello all’idea di nazionalità e si riconoscono in essa. I risultati, sul momento, non saranno vistosi,
18 In merito a tale aspetto si veda Edith Saurer, Una contraddizione sistematica: i con-
fini nella monarchia asburgica fra Sette e Ottocento, in Silvia Salvatici (a cura di), op. cit., pp. 23-36.
19 Angelo Tamborra, op. cit., p. 14. 20 Eric J. Hobsbawm, The Age of Capital,1848-1875, Abacus, London 1995, p. 14.
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Memory, Identity and Intercultural Communication 255
anzi appariranno deludenti. Ma come il movimento mette in discus-sione principalmente l’État du centre... per fare appello, contro un ideale puramente dinastico, alla dottrina dei Diritti dell’Uomo e at-traverso essi a quella degli inalienabili diritti delle Nazioni, è l’Au-stria absburgica che viene investita principalmente dalla tormenta»21.
L’Impero asburgico, fedele fin dal XVII secolo al principio dinasti-co e a una ben definita stratificazione sociale, fonda il suo potere sulla contrapposizione di forze sociali portatrici di interessi conflittuali; in particolare, già dal Seicento gli Asburgo sostengono l’alta nobiltà, te-desca o germanizzata oppure magiara e portatrice di interessi opposti a quelli della grande massa di contadini, come pure a quelli della an-cor debole borghesia cittadina e della piccola nobiltà. Da questo pe-riodo, dunque, la dinastia ricorre a quel sistema di divide et impera che diverrà pratica comune nel XIX secolo anche in sede nazionale, con lo scopo di tenere unite le varie nazionalità all’interno di una cornice dinastica e sopranazionale. Così irrigidito all’interno di un simile si-stema di rapporti sociali e nazionali, l’Impero asburgico risulta tutt’altro che flessibile e capace di adattarsi alle spinte esterne e inter-ne che lo investono22. Ma proprio tali forze risultano particolarmente forti nella prima metà del secolo. Nonostante il rigido sistema di con-trollo imposto dalla Reazione23, le idee di uguaglianza e i diritti uni-versali espressi a livello individuale dalla Rivoluzione francese si af-fermano e si diffondono, essendo applicati anche a livello di naziona-
21 Angelo Tamborra, op. cit., p. 97. Più in generale sulla Primavera dei Popoli
nell’Europa centro-orientale si veda Pasquale Fornaro (a cura di), Liberalismo, costitu-zioni, nazionalità. Il 1848 in Italia e nell’area danubiana, Le Lettere, Firenze 2011.
22 Esemplificativa in tal senso è l’ostinazione con cui le autorità viennesi rifiutano di adottare il termine “Stato” per indicare i territori imperiali, preferendo le denomi-nazioni “Monarchia” o “Casa”; in tale senso si veda Robert J. W. Evans, Historians and the State in the Habsburg Lands, in Wim Blockmans – Jean-Philippe Genet (eds.), Visions sur le développement des États européennes. Théories et historiographies de l’État modern. Actes du colloque de Rome, 18-31 mars 1990, École française de Rome, Roma 1993, pp. 203-218.
23 Come modello di tale sistema di governo si rimanda qui alle “Istruzioni segrete per la polizia austriaca in Italia” pubblicate in Denis Mack Smith, Il Risorgimento italiano. Storia e testi, Laterza, Roma / Bari 2010, pp. 34-36.
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Giordano Altarozzi 256
lità, considerate come individualità storiche portatrici di diritti uni-versali, primo dei quali quello alla formazione di un’unità statale che ne contenga tutti i membri24. Tutto ciò non sfugge ovviamente all’at-tenzione degli uomini di governo austriaci, i quali cercano di fronteg-gare la tempesta imminente con gli strumenti che sono propri alla lo-ro mentalità conservatrice e reazionaria; polizia, esercito, censura, al-leanza continentale dei troni divengono gli elementi chiave di una politica volta a prevenire e dove necessario a liquidare qualsiasi ten-tativo “rivoluzionario”, sia sul piano sociale che più propriamente politico.
Lo sfondo su cui si sviluppano gli eventi del 1848-1849 è dunque caratterizzato da un continente in pieno processo di sviluppo liberale e nazionale. Segni premonitori dell’imminente scoppio rivoluzionario sono d’altronde evidenti già negli anni immediatamente precedenti la Primavera dei Popoli. Già dal 1845 i territori polacchi soggetti alla Prussia e all’Austria sono in fermento, grazie all’intensa attività co-spirativa e organizzativa svolta dai diversi gruppi dell’emigrazione, presenti soprattutto a Parigi e Londra ma con ramificazioni in tutto il continente25. Proprio qui, nella Polonia austriaca, le autorità viennesi sperimentano quella tattica del divide et impera successivamente ap-plicato, in modo generalizzato, ai propri dominii. Sfruttando la parti-colare struttura etnica e sociale della regione, infatti, gli austriaci uti-lizzano a proprio favore lo storico dissidio sociale esistente tra il ceto magnatizio polacco e le masse contadine rutene, sollevando nel 1846 queste ultime contro i nobili proprietari con il pretesto che il successo della rivoluzione e la conseguente rinascita di una Polonia indipen-dente avrebbe significato per esse un inasprimento della dipendenza feudale26. Bisogna tuttavia aspettare la sollevazione parigina perché le idee di libertà e di affermazione nazionale si propaghino in tutto il
24 Cfr. Federico Chabod, op. cit., pp. 236 segg. 25 Una sintesi dell’attività svolta dall’emigrazione polacca durante l’Ottocento in
Barbara Jelavich, The Polish Emigration, 1831-1871: The Challenge to Russia, in Aa. Vv., L’émigration politique en Europe aux XIXe et XXe siècles. Actes du colloque de Rome (3-5 mars 1988), École française de Rome, Roma 1991, pp. 235-245.
26 Cfr. Angelo Tamborra, op. cit., pp. 100-101.
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Memory, Identity and Intercultural Communication 257
continente, accendendo il fuoco della rivoluzione. Nell’Impero asbur-gico, dove per la prima volta si afferma la dottrina rivoluzionaria dei diritti dell’uomo e del cittadino, la rivoluzione ha all’inizio un carat-tere prevalentemente sociale, con le masse contadine che scendono in campo per liberarsi dalle servitù di natura medievale alle quali sono sottoposte da secoli. Ma presto esse cominciano ad avvertire una dif-ferenza anche nazionale; composte in gran parte da elementi ruteni, slovacchi, croati, serbi, romeni, esse sentono di essere diverse dal ceto magnatizio – magiaro o magiarizzato, austro-tedesco o germanizzato – anche sul piano dell’appartenenza nazionale. E benché le loro ri-vendicazioni non coincidano con le rivendicazioni radicali della bor-ghesia e dell’intellighenzia cittadina, esse finiscono per fare causa comune con queste ultime contro l’oppressione che è a un tempo so-ciale e nazionale27.
Tra tutte le nazionalità che compongono il vasto puzzle dell’Im-pero, quella che per prima e più decisamente recepisce il messaggio rivoluzionario proveniente dalla Francia – accanto ai polacchi che vi-vono da vicino gli eventi parigini – è la magiara, che già da tempo ha sviluppato una sua identità quale nazione “storica”. Senonché gli un-gheresi, con la loro grande nobiltà magnatizia, dominano da secoli masse di contadini spesso di altra origine etnica, sottoposte a un re-gime che non sarebbe improprio definire feudale. Le riforme liberali proposte fin dall’inizio del secolo da diversi esponenti della nazione magiara finiscono per favorire le rivendicazioni delle altre nazionalità della monarchia, che esponenti radicali come Lajos Kossuth non sono disposti a prendere in considerazione. Ciò favorisce l’azione reazio-naria di Vienna, che già dalla fine del Settecento non aveva esitato a contrastare ogni velleità nazionale.
Fin dall’inizio la rivoluzione ungherese assume talune caratteristi-che ben precise: essa è a un tempo: «nazionale, come avvenne pure in Italia o in Germania; nobiliare... anche perché, mancando in Ungheria una borghesia nel senso classico del termine, l’aristocrazia ungherese ne assunse la guida; liberale, in quanto promosse l’emancipazione dei servi, la libertà di espressione e di stampa, l’uguaglianza dei cittadini
27 Ibidem, p. 104.
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Giordano Altarozzi 258
dinanzi alla legge, la tolleranza religiosa (nell’ambito delle religioni ufficialmente riconosciute)»28. Con le leggi approvate nel marzo 1848, l’Ungheria si trasforma dunque in una monarchia semi-parlamentare; la Dieta feudale di Bratislava è sostituita da un parlamento elettivo (con voto ristretto) con sede a Budapest, con Vienna è mantenuto un rapporto di unione personale, lo Stato diviene una monarchia unita-ria estesa a tutte le terre della Corona di Santo Stefano, con conse-guente soppressione delle Diete autonome di Transilvania e Croazia, il latino è sostituito dal magiaro quale lingua amministrativa, neces-saria anche per l’elezione al parlamento. In tal modo si conferma dunque lo stato di sottomissione delle nazionalità non magiare. Ma attraverso tale impostazione di fondo, di conservazione sociale e di conferma dell’elemento magiaro quale unico detentore di diritti poli-tici, i rivoluzionari ungheresi, con Kossuth alla guida, si precludono ogni possibilità di successo e finiscono per favorire i piani reazionari dell’Austria29.
La rivoluzione risulta però troppo forte, e lo stesso principe di Metternich è costretto alle dimissioni. In tale contesto anche le altre nazionalità dell’Impero cominciano ad avanzare rivendicazioni na-zionali; particolarmente attivi sono gli slavi, che si riuniscono in un congresso a Praga prontamente represso dall’intervento dell’esercito austriaco, ma non da meno sono i romeni di Transilvania e Banato, che mantengono stretti contatti con i loro fratelli d’oltre Carpazi30. La dissoluzione del Congresso slavo rappresenta il primo successo della repressione austriaca, senza però che l’Impero abbia la forza
28 Gábor Andreides, Le “leggi di aprile” e la questione delle nazionalità nell’Ungheria
del 1848-1849, in Pasquale Fornaro (a cura di), Liberalismo, costituzioni, nazionalità..., cit., pp. 43-44.
29 In merito si veda Pasquale Fornaro (a cura di), Liberalismo, costituzioni, nazionali-tà..., cit., e in particolare i saggi di Gábor Andreides, op. cit., pp. 43-54; Anna Irimiás, La questione delle nazionalità nella rivoluzione ungherese del 1848-49 secondo Oszkár Jászi, pp. 55-62; Giordano Altarozzi, La questione delle nazionalità tra i romeni di Transilvania, pp. 73-92.
30 Sul congresso slavo di Praga cfr. Angelo Tamborra, op. cit., pp. 108-115; in meri-to allo sviluppo della rivoluzione tra i romeni di Transilvania si veda Giordano Alta-rozzi, op. cit.
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Memory, Identity and Intercultural Communication 259
necessaria per passare alla controffensiva; in tal senso l’imperatore, che aveva già concesso una costituzione nell’aprile del 1848, è obbli-gato in breve tempo a ritirarla e a convocare un’Assemblea costi-tuente nel luglio dello stesso anno. Questa però, nata dal compro-messo tra dinastia e forze moderate e dominata dalla diffidenza tra i diversi elementi ormai orientati su posizioni nazionali, come pure dai timori di rivolgimenti sociali radicali, risulta inefficiente. A tali problemi si aggiunge anche quello della scarsa rappresentatività, tenendo conto del fatto che l’Ungheria ha ormai raggiunto una si-tuazione di semi-indipendenza, mentre le provincie italiane sono minacciate dall’avanzata dell’esercito sardo, come nel caso della Lombardia, o si sono proclamate indipendenti e repubblicane, come a Venezia. In tale contesto l’unico atto di una certa rilevanza è l’approvazione della Legge di Emancipazione con cui viene abolito il servaggio, destinata ad avere un grande impatto sullo sviluppo successivo dell’Impero asburgico. Soppresso il sistema feudale, i grandi proprietari non si dimostrano infatti interessati a trattenere nelle loro proprietà le forze di lavoro in eccesso; ciò determina un vasto spostamento di popolazioni dalle campagne ai centri urbani, finendo per uniformarne il carattere nazionale a quello delle zone rurali circostanti. Sul piano economico-sociale, la disponibilità di nuova forza-lavoro a basso costo favorisce lo sviluppo di imprese di tipo capitalistico ma anche la conseguente comparsa di una lotta di classe che tende ad assumere un carattere nazionale tra la borghesia urbana tedesca o germanizzata – e italiana nel caso della Dalmazia – e il ceto operaio di immigrati polacchi, ruteni, croati, slovacchi, ce-chi. La diminuita pressione demografica sull’ambiente rurale favori-sce a sua volta una prima concentrazione di proprietà nelle mani di quanti rimangono. Ma da tale legge Vienna trae anche vantaggi immediati; essendo poco familiarizzate con la complessità della vita politica, le masse contadine attribuiscono la misura alla volontà dell’imperatore, di cui abbracciano l’assolutismo in antitesi alle po-sizioni radicali degli intellettuali e della classe borghese31. Ancora una volta, dunque, Vienna riesce a dividere, tramite una politica tut-
31 Cfr. Angelo Tamborra, op. cit., pp. 115-116.
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Giordano Altarozzi 260
to sommato dilatoria, le forze che potenzialmente possono essere in-teressate a sostenere la rivoluzione.
Intanto le truppe austriache, sconfitte le forze sarde nella prima battaglia di Custoza, cominciano a recuperare terreno in Italia, dove Carlo Alberto è lasciato progressivamente solo dagli altri sovrani ita-liani e obbligato in agosto a firmare l’armistizio di Salasco. Unico problema con cui le autorità viennesi devono confrontarsi è dunque quello ungherese, mentre le posizioni dei rivoluzionari magiari ten-dono a indebolirsi sempre più. Nei territori sottoposti all’autorità un-gherese la politica radicale di Kossuth provoca infatti le proteste e le prese di posizione contrarie sia dei cerchi moderati magiari, sia so-prattutto delle altre nazionalità che, esposte al centralismo di Buda-pest, tornano a guardare con fiducia a Vienna e all’imperatore.
Una volta ottenuti la supremazia all’interno dell’Assemblea costi-tuente e il sostegno delle nazionalità non magiare della Corona di Santo Stefano, gli Asburgo si sentono sufficientemente forti per re-primere la rivoluzione ungherese. A Vienna le forze rivoluzionare più estremiste tentano un’ultima sollevazione, chiedendo l’unione della parte tedesca dell’Impero a una più ampia Germania organizzata su basi nazionali, ma la risposta delle autorità è stavolta pronta e decisa, avendo in breve tempo ragione degli insorti. La sconfitta della rivolu-zione a Vienna segna praticamente la fine del movimento nazionale e rivoluzionario nei territori asburgici, in Germania, in Italia32 e infine in Ungheria, dove la rivoluzione si trasforma in guerra aperta33, de-
32 Sugli eventi connessi alla resistenza della Repubblica veneziana cfr. Francesco
Carrano, Della difesa di Venezia negli anni 1848-49, Tipografia Moretti, Genova 1850; Carlo Alberto Radaelli, Storia dello assedio di Venezia negli anni 1848 e 1849, Tipografia del Giornale di Napoli, Napoli 1865; Gennaro Maria Monti, La difesa di Venezia nel 1848-1849 e Guglielmo Pepe, Collezione meridionale editrice, Roma 1933.
33 Sulla guerra d’indipendenza magiara esiste una vasta pubblicistica; per alcune linee fondamentali relative al modo in cui essa è percepita dai contemporanei unghe-resi si rimanda al seguente testo: Mihály Horvát, History of the Hungarian War of Inde-pendece of 1848-1849, in Balázs Trencsényi – Michal Kopeček (ed. by), Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770-1945). Texts and Commentaries, vol. II, National Romanticism. The Formation of National Movements, Budapest / New York, CEU Press 2007, pp. 57-64.
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Memory, Identity and Intercultural Communication 261
stinata a essere perduta dai magiari nonostante l’eroico sostegno di polacchi e italiani34, in gran parte a causa del mancato appoggio delle altre nazionalità, spaventate dai progetti di magiarizzazione iniziati dalle autorità di Budapest fin dai primi giorni della rivoluzione e, in taluni casi, anche prima35.
L’intervento russo in Ungheria al fianco dell’Austria rinforza la so-lidarietà dei troni contro le forze rivoluzionarie, e all’ombra di tale rinnovata alleanza Francesco Giuseppe si sente abbastanza sicuro per portare a compimento la sua opera di centralizzazione, imponendo anche all’Ungheria – che fino a quel momento aveva goduto di una certa autonomia all’interno dell’Impero – un regime assolutistico si-mile a quello delle altre provincie, sotto l’egida della Costituzione di Kromeřiž concessa il 4 marzo 1849. Gli Asburgo riescono dunque a sfruttare a proprio vantaggio la questione delle nazionalità dell’Euro-pa danubiano-balcanica, senza per questo risolvere in modo definiti-vo la più generale questione nazionale, che si afferma sempre più in tutto il continente. Nel 1848-1849, con altre parole, l’Impero asburgico non trova una soluzione di lungo periodo ai problemi che lo affliggo-no. La sconfitta delle forze rivoluzionarie e l’opposizione generata tra le diverse nazionalità costitutive dell’Impero offrono all’Impero asburgico qualche decennio di tranquillità. Le questioni fondamentali non sono però risolte, ed esse torneranno a farsi sentire nella seconda metà del secolo per divenire esplosive alla fine dell’Ottocento e nei primi due decenni del Novecento, culminando con lo scoppio delle due guerre balcaniche, prologo della prima guerra mondiale.
34 Cfr. Angelo Tamborra, op. cit., pp. 120-139. Si vedano altresì: Giulio Del Bono,
Italia ed Ungheria nel 1848-1849, in “Rassegna Storica del Risorgimento”, a. XXIV, fasc. II, febbraio 1937, pp. 347-368; Pasquale Fornaro, Risorgimento italiano e questione..., cit.
35 Si vedano in merito i seguenti testi, pubblicati in Balázs Trencsényi – Michal Kopeček (ed. by), op. cit.: Johann Majláth, An Examination of the Question: Whether to Annex the Carpathian Slavs and Ruthenians to the Magyars, pp. 262-267; Lajos Kossuth, Proposal. Concerning the Future Political Establishment of Hungary, pp. 268-276; L’udovít Šuhajda, Magyarism in Hungary, pp. 348-353. Nello stesso senso si veda anche Simion Bărnuţiu, Un document pentru limba română din an 1842, in “Foaia pentru minte, inimă şi literatură”, vol. 16, n. 38 (1853), pp. 285-288 e n. 39 (1853), pp. 295-298.
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata
Giordano Altarozzi 262
Aknowledgement This paper is a result of the project `Transnational Network for Integrated Management of Postdoctoral Research in Communicating Sciences. Institutional building (postdoctoral school) and fellowships program (CommScie)" - POSDRU/ 89/1.5/S/63663, financed under the Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013
Bozza 2
formato mm 170x240 b/n
allestimento brossu
ra fresata