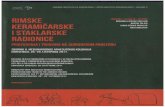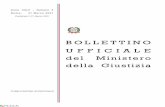CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE Ricerca storica e questioni teoriche
Transcript of CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE Ricerca storica e questioni teoriche
CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIAINTERNAZIONALERicerca storica e questioni teoriche
Pier Paolo Portinaro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINODIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI
WPAP
ERS
ORKING
5
Pier Paolo Portinaro
CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALERicerca storica e questioni teoriche
Working Papers n. 5 – Settembre 2005DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI
Torino, Italy
© DSP – (Dipartimento di Studi Politici)Università di TorinoVia Giolitti, 3310123 Torino – Italy Tel. +39 011 6704101/6704102 Fax +39 011 6704114 http://www.dsp.unito.it
Realizzazione grafica: Alfonsetti Comunicare, Torino, 011 5188405Stampa Viva, Torino – settembre 2005
WPAP
ERS
ORKING
3
DPShttp://www.dsp.unito.it/wrkpaprs.html
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICIUniversità degli Studi di TorinoVia Giolitti, 33 – 10123 Torino – Italy
Tel. +39 011 6704101 / 6704102 Fax +39 011 6704114 http://www.dsp.unito.it
Il Dipartimento di Studi Politici ha carattere interdisciplinare e nasce dalprogetto di studiare in modo integrato il mondo della politica in tutti i suoiaspetti: dalla riflessione teorica e storica sulla formazione delle idee e delledottrine politiche, all’analisi comparata dei sistemi politici e delle forme didemocrazia nelle società contemporanee, sullo sfondo dei processi di globa-lizzazione e di trasformazione delle relazioni internazionali.
Il Dipartimento si è costituito l’8 novembre del 1982, per iniziativa di ungruppo di studiosi che intendevano raccogliere e sviluppare la tradizione distudi e ricerche fondata da maestri come Norberto Bobbio, Luigi Firpo eAlessandro Passerin d’Entrèves, che dalla metà degli anni cinquanta aveva tro-vato sede nell’Istituto di Scienze Politiche “Gioele Solari”, nucleo della futuraFacoltà di Scienze Politiche e successivamente disciolto in conseguenza dellalegge istitutiva dei dipartimenti universitari. In esso sono confluiti filosofi, stori-ci, politologi e sociologi, che al di là del proprio ambito specialistico sonoaccomunati dall’interesse unitario per l’approfondimento della politica.
All’interno del Dipartimento si possono distinguere varie aree di ricerca. Laprima di esse concerne lo studio del pensiero politico in prospettiva storica, daiclassici del pensiero antico e medioevale alle ideologie e dottrine politiche con-temporanee. Una seconda area, di carattere politologico e sociologico, riguar-da lo studio delle forme di stato e di governo, il funzionamento dei regimi poli-tici, le trasformazioni della democrazia, la comunicazione politica e i media.Una terza area è dedicata allo studio delle relazioni internazionali e ai pro-blemi della pace. Una quarta area si occupa dei problemi connessi all’inte-grazione europea e allo studio del pensiero e dei movimenti federalisti. Unaquinta area si occupa dei problemi dello sviluppo e della storia dei paesi noneuropei, dall’America Latina all’Asia e all’Africa.
Il Dipartimento di Studi politici cura la pubblicazione di una collana diworking papers. Lo scopo della collana è di far conoscere tempestivamentealla comunità scientifica ipotesi di lavoro, interventi, materiali di ricerca, inattesa di pubblicazione o giunti ad una fase finale di elaborazione.
WPAP
ERS
ORKING
4
Sommario
L’ultima decade del ventesimo secolo ha conosciuto l’istituzione di unamolteplicità di nuovi tribunali internazionali, fra cui i Tribunali penali inter-nazionali per l’ex Jugoslavia e per il Ruanda. Questi sviluppi hanno datoimpulso al progetto per la creazione della Corte penale internazionale,che esercita giurisdizione su crimini di guerra, crimini contro l’umanità egenocidio. Lo Statuto della CPI prevede anche un’eventuale giurisdizionesul crimine d’aggressione (sul modello dei tribunali di Norimberga e Tokiodopo la seconda guerra mondiale), a condizione che venga prima adot-tata una precisa definizione del crimine di aggressione.
Molti attribuiscono a tali tribunali un valore più simbolico che pratico:essi danno espressione alle aspirazioni della comunità mondiale verso loStato di diritto e il cosmopolitismo, il loro ruolo è pedagogico e di indiriz-zo, ma il loro impatto sul comportamento effettivo degli Stati può esseresolo marginale. È probabile che ciò sia vero. Ma la storia insegna che,assicurando la punibilità, i tribunali dimostrano che i diritti fondamentalisono reali e che lo Stato di diritto è essenziale alla pace; e che fermare ilgenocidio, il democidio e altri crimini politici può essere per gli Statinazionali un interesse vitale, non solo un valore morale.
Un ampio consenso sembra del resto sussistere circa la necessità diportare a compimento l’attuale sistema di giustizia internazionale. Poichégli Stati non sono naturalmente inclini ad attenersi al diritto penale inter-nazionale, suggerimenti normativi includono il bisogno di migliorare l’o-peratività delle corti, indurre gli Stati a collaborare nei procedimenti e adattenersi alle sentenze dei tribunali. Ma la forza conservatrice della dot-trina della sovranità resta il maggiore impedimento alla creazione dirobuste istituzioni di giustizia internazionale.
Il saggio analizza evoluzione, legittimità e funzioni del sistema dellagiustizia penale internazionale, mettendo in luce il contrasto tra la corni-ce normativa e la dura realtà della politica e il contesto della resa dei conticon le ingiustizie storiche in un mondo in cui la giurisdizione in materia didiritto internazionale umanitario è in crescita. I risultati dell’analisi mostra-no che la credenza nel primato del diritto e l’orientamento favorevole adun’autonoma giurisdizione non sono ancora del tutto acquisiti dagli Stati.Nei loro atteggiamenti nei confronti delle corti internazionali prevalgonoconsiderazioni di natura strategica. Il carattere liberale e democraticodegli Stati non è di per sé garanzia di un atteggiamento favorevole allagiurisdizione internazionale. In ogni caso, anche gli Stati democraticisono più inclini a sostenere tribunali penali internazionali se l’opinionepubblica è colpita dai crimini in questione.
WPAP
ERS
ORKING
5
Summary
The last decade of the twentieth century witnessed the establishment ofa variety of new international tribunals, including the InternationalCriminal Tribunals for the former Yugoslavia and for Rwanda. These devel-opments gave momentum to the project for creation of the InternationalCriminal Court, which has jurisdiction over war crimes, crimes againsthumanity, and genocide. There is also a provision in the ICC-Statute foreventual jurisdiction over the crime of aggression (on the model of theNuremberg and Tokio tribunals following the Second World War); but theStatute requires that a consistent definition of the crime of aggression beadopted before the Court could exercise this form of jurisdiction.
Many see the value of such tribunals as more symbolic than practical:it represents the aspirations of the world community toward rule of lawand cosmopolitism, their role is educative and visionary, but can have onlya marginal impact on the actual behaviour of states. That may be true. Buthistory shows, that, by ensuring accountability, the tribunals demonstratethat basic human rights are real and that the rule of law is integral topeace; stopping genocide, democide and other political crimes can bethen a vital national interest, not just a moral value.
A broad consensus seems to have emerged that completion of the cur-rent international jurisdictional system is necessary. Since states are notprepared naturally to comply with international criminal law, normativesuggestions include the need to shape the courts’ abilities more convinc-ingly, to induce states to participate in court proceedings and to complywith courts’ judgements. But the conservative force of the doctrine of statesovereignty remains the biggest impediment to the creation of strong insti-tutions of international justice.
The essay explores evolution, legitimacy and functions of the interna-tional criminal justice system, highlighting the contrast between the nor-mative framework and the harsh reality of politics and the context of nego-tiating historical injustices in a world of expanding jurisdiction over inter-national humanitarian law. The analytical results show that legalist beliefsand a court-friendly attitude of states have not been achieved yet to a fullextend. States’ attitudes towards international courts are of a rather strate-gic nature. The liberal and democratic character of states does not vouchfor a friendly attitude towards international jurisdiction. Anyway, demo-cratic states are most likely to support international criminal tribunals ifpublic opinion is outraged by the crimes in question.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
7
1. NUOVE FRONTIERE 1
Dopo decenni di stagnazione, gli ultimi annidel XX secolo hanno conosciuto un ritorno diattenzione e di iniziative nell’ambito del diritto
internazionale e, più specificamente, della giurisdizione penale interna-zionale, che si è tradotto nell’istituzione ad opera del Consiglio diSicurezza delle Nazioni Unite dei Tribunali ad hoc per l’ex Jugoslavia(ICTY: 25 maggio 1993) e per il Ruanda (ICTR: 8 novembre 2004), nel-l’approvazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale(ICC: 17 luglio 1998) e nell’entrata in vigore del medesimo (1 luglio2002).
A fare da contrappunto a questi sviluppi si deve constatare, ad ontadelle attese nutrite negli anni ’90 e delle insistite retoriche dei diritti umani,l’acuirsi dei conflitti etnici, l’esplodere di nuove emergenze umanitarie, ilritorno della guerra, sia pure nella modalità low intensity, l’escalation delterrorismo internazionale, la delegittimazione dell’Onu, in definitiva uncerto rimbarbarimento del diritto internazionale2. Per cui appare lecita ladomanda, che ormai molti osservatori si pongono, se il nuovo attivismonell’ambito della giustizia penale internazionale non appartenga, più cheal novero delle policies che fanno storia, all’ambito della politica-spetta-colo, e se non configuri, nel migliore dei casi, soltanto una nuova utopiadella società civile transnazionale, appunto quella di una giustizia cosmo-politica incaricata di fare il processo alla storia.
Chi considera con un orientamento meno scettico i recenti sviluppi si
1. 1. INTRODUZIONE
1 Questa ricerca è stata svolta durante l’a.a. 2004/2005 presso il Max-Planck-Institut fürausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg i. B. grazie ad un contributodell’Alexander-von-Humboldt-Stiftung.
2 Cfr. Lutz/Giessmann 2003, Chomsky 2005. Può essere interessante, per misurare lavanità dei passi avanti compiuti, confrontare le recenti dichiarazioni dell’internazionalistaBruno Simma, «Eine Verwilderung der Sitten im Völkerrecht». Gespräch mit Bruno Simma,in Tolmein 2000, pp. 13-27, con le osservazioni di Bert Röling sullo stato “miserabile” deldiritto internazionale alla fine degli anni settanta: «it is miserable because the existing law –its machinery and consent – is not able to serve the well-being of all the members of the legalcommunity» (Röling/Cassese 1993, p. 136).
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
8
chiede invece se queste innovazioni non debbano essere interpretatecome un indizio tangibile di un progresso giuridico dell’umanità, di quelprogresso che secondo il paradigma kelseniano dovrebbe approdare pergradi alla centralizzazione del sistema giuridico internazionale3. E ineffetti, se si guarda alle modalità con cui società e istituzioni hanno fattofronte ad atrocità commesse nel corso di guerre, guerre civili o nell’eser-cizio di un potere totalitario (e che nel corso nel XX secolo hanno trovatodefinizione nelle categorie dei crimini contro la pace, crimini di guerra,crimini contro l’umanità e genocidio), si deve riconoscere che i tribunalipenali internazionali (civili, non militari) si collocano al vertice di unascala che ha visto la resa dei conti con il passato farsi sempre meno affi-data alla contingenza e sempre più consapevole, sempre meno violenta esempre più sottoposta a procedure regolate dal diritto interno e interna-zionale.
Alle atrocità del genere sopra menzionato, nella storia sono infattistate date sostanzialmente le seguenti risposte: a) vendetta, cioè ritorsioniviolente e persecutorie nel quadro di un’immediata resa dei conti (che pre-suppone una chiara vittoria di una parte sull’altra), b) rimozione, nelsenso di un oblio omertoso (e questa è la soluzione che s’impone soprat-tutto quando la bilancia dei crimini è quasi in pareggio e i vincitori nonsono troppo sicuri della loro posizione), c) amnistia, nel senso di una deci-sione politica, giuridicamente formalizzata come legge, di seppellire ilpassato ponendo fine alle reciproche accuse, pretese di riparazione,domande di giustizia (anche qui si tratta spesso dell’atto politico di un vin-citore debole e ricattato), d) giustizia nazionale, quando si fa ricorso aitribunali interni, magari su pressione esterna, per punire crimini che impu-niti potrebbero pregiudicare il ritorno alla normalità dei rapporti, e) giu-stizia internazionale (dei vincitori), nel caso invece che, dopo una guerratra Stati, la giustizia sia amministrata dai vincitori, pur nel rispetto di rego-le condivise del diritto internazionale, f), giustizia internazionale (di cortiindipendenti), quando infine a giudicare siano istituiti o chiamati tribuna-li indipendenti, espressione della comunità internazionale. Naturalmente
3 Cfr. per una ricostruzione e un bilancio critico della posizione di Kelsen e della sua scuo-la Bernstorff 2001, Zolo 2001 e Brunkhorst 2005.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
9
nella realtà il trapasso tra queste modalità di risposta è meno nitido diquanto possa apparire nella teoria4 – ed è il proposito di queste paginemostrare le ambiguità e le zone grigie in riferimento a tutte le categoriedella tipologia, rielaborandola infine all’interno di una più generale teo-ria delle transizioni politiche.
La svolta verso la giustizia penale internazionale si afferma nellesocietà democratiche quasi a sancire la loro superiorità morale nei con-fronti dei regimi autoritari e totalitari. La resa dei conti giudiziaria con ilpassato si rivela di norma, in contesti democratici, una scelta opportuna,consentendo di perseguire la stabilizzazione di un nuovo assetto di pote-re e la minimizzazione dell’incertezza (un ordinamento nuovo deve fon-darsi su certezze): i processi infatti 1) contribuiscono a far luce sul passa-to e quindi a smontare miti, pregiudiziali ideologiche e costrutti cospira-tori che favoriscono la polarizzazione politica, 2) segnano una svolta isti-tuzionale, che sottolinea l’inizio di una nuova epoca, in cui valgono nuoveregole, 3) statuiscono un esempio che dovrebbe fungere da deterrente alripetersi di crimini analoghi e quindi neutralizzano la conflittualità, 4)offrono un’alternativa alla vendetta e alla resa dei conti violenta5. Essapresenta, tuttavia, anche costi considerevoli e insidiose incognite. Nonsempre, ad esempio, i processi funzionano davvero come stabilizzatori; avolte aumentano la tensione e producono fratture politiche durature(soprattutto dove non si dia un rapporto univoco vincitori/vinti). A fronte
4 E di fatto nella letteratura sono state proposte anche tipologie più articolate, da cui inquesta sede si può prescindere (ma su cui rimando ad un lavoro di prossima pubblicazio-ne). Cfr. Quaritsch 1995, p. 139 ss, Schaal/Wöll 1997, H. König, Von der Diktatur zurDemokratie oder Was ist Vergangenheitsbewältigung, in König/Kohlstruck/Wöll (Hg.),1998, pp. 371-92, E. Garzón Valdés, Prolog: Staatsterrorismus, Gerechtigkeit und Justiz, inAhlbrecht/Ambos 1999, pp. 3-18, Biegi 2004, p. 34 ss.
5 Cfr. König, op. cit. in König/Kohlstruck/Wöll 1998, p. 382. Prendendo le mosse da unaclassificazione delle funzioni della giustizia penale internazionale proposta da AntonioCassese (giustizia per le vittime, riconciliazione, stabilimento della verità, imposizione dellostato di diritto, deterrenza), Lattimer e Sands ne individuano le seguenti otto ragioni: 1.Providing justice for victims 2. Establishing truth for reconciliation 3. Providing an alternati-ve to vengeance 4. Distinguishing individual from group responsability 5. Removing crimi-nals from power 6. Deterring future crimes 7. Supporting the rule of law 8. Filling the enfor-cement gap created by the advance of human rights and humanitarian norms(Lattimer/Sands 2003, pp. 18-22).
del basso rendimento politico, la funzione di deterrenza può poi essereinsignificante, quando il rivolgimento politico sia stato radicale (come nelcaso delle dittature europee del XX secolo) o laddove si debba contrasta-re una macrocriminalità sistemica, protetta da una diffusa cultura dell’im-punità (come nel caso di tutti i paesi a fragile tradizione democratica).
Con lo sviluppo della giustizia penale internazionale sembra delinear-si un nuovo paradigma. Diritto penale e diritto internazionale si presenta-vano fino agli inizi del XX secolo domini reciprocamente escludentisi ocomunque non comunicanti (se si prescinde dalle norme contro la pirate-ria e il traffico degli schiavi che si sviluppano già nell’età dello jus publi-cum europaeum)6. La storia novecentesca conosce invece l’istituzionaliz-zazione della giurisdizione penale internazionale, sia pure come proces-so legato a circostanze eccezionali, a conclusione di guerre e guerre civi-li. Non si tratta per altro soltanto dell’edificazione di un’infrastruttura dellagiustizia penale internazionale. L’espansione del potere e delle funzionigiudiziarie che ha caratterizzato l’evoluzione delle democrazie costituzio-nali negli ultimi decenni ha portato ad un allargamento della competenzadei tribunali interni e all’affermazione del principio di competenza uni-versale come corollario dell’universalità dei diritti dell’uomo. Se tradizio-nalmente gli Stati esercitavano la propria potestà punitiva nei confronti dipresunti autori di crimini internazionali alla luce dei principi di territoria-lità (per crimini perpetrati sul proprio territorio), nazionalità attiva (per cri-mini commessi da propri cittadini) e di nazionalità passiva (per criminiperpetrati su propri cittadini), in anni recenti è diventato sempre più fre-quente il «ricorso al principio di universalità, con il quale uno Stato affer-ma la propria giurisdizione penale a prescindere dal luogo di commissio-ne del crimine, e dalla nazionalità del presunto reo o della vittima»7.
Alla base di questa fiducia nella giustizia penale per porre rimedio allegrandi ingiustizie della storia è sicuramente il trend generale di espansio-ne del potere giudiziario che ha caratterizzato a livello globale l’evolu-
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
10
6 Per la storia del diritto penale internazionale cfr. Ahlbrecht 1999, König 2003, p. 38 ss,Köchler 2003, p. 51 ss, Satzger 2005, p. 150 ss.
7 Cassese 2004, II, p. 164. Ma sul tema cfr. Peyró Llopis 2003, Reydams 2003; inoltreBassiouni/Wise 1995, Bassiouni 1999a, Ambos 2002, Werle 2003.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
11
zione degli ultimi decenni8. L’esperienza giuridica di tutte le società demo-cratiche ormai comprova che i tribunali sono – se collocati entro un con-testo istituzionale cooperativo – gli strumenti più efficaci per la garanziadei diritti umani9. Questo assunto trova parziale conferma anche a livellointernazionale. Non tutte le istituzioni nate a tutela dei diritti, dall’UNHuman Rights Committee alle carte africane e islamiche sui diritti umani,contemplano l’istituzione di tribunali che sanciscano le violazioni, ma intaluni casi, dall’European Convention on Human Rights and FundamentalFreedoms entrata in vigore nel 1953 all’American Convention on HumanRights of the Organization of American States del 1979, è prevista la pro-tezione ad opera di specifiche istanze giudiziarie10. L’evoluzione dei siste-mi giuridici d’altro canto mostra che l’attivismo di questi organi tende,come è del resto ovvio, a crescere con l’espandersi, il coordinarsi e il con-solidarsi degli assetti normativi.
Certo, il futuro della giustizia penale internazionale è tutt’altro cheassicurato. Uno dei contenziosi che negli ultimi anni hanno segnato i rap-porti tra Europa e Stati Uniti riguarda proprio la funzione e il futurodell’ICC. La via giudiziaria è la strategia che la potenza civile europea,affiancata con convinzione (e non per scelta di campo antiamericana) dapochi altri paesi che contano, intende contrapporre alle politiche coerciti-ve di una grande potenza militare. Anche la lotta contro il terrorismo vienecondotta dagli Stati europei sul piano giudiziario: il processo che si stacelebrando a Madrid (primavera 2005) contro 24 presunti terroristi di AlQaida sta a simboleggiare l’alternativa europea alla soluzioneGuantanamo. Il ricorso al dispositivo giudiziario sostituisce alla logicapolemogena della colpa collettiva la logica politicamente neutralizzantedella responsabilità individuale. Nel suo rapporto all’Assemblea generale
8 Cfr. Tate/Vallinger 1995, Volcansek 1997, Treves 1999, Pedrazzi 2001, Rupprecht2003, Macedo 2004, Tolmein 2004.
9 Rupprecht 2003, p. 225 ss.10 Cfr. Volcansek 1997. Nel volume si dà conto dei numerosi organismi internazionali i cui
trattati istitutivi non prevedono la costituzione di istanze giudiziarie, per poi soffermarsi suorgani quali la European Court of Justice, la European Court of Human Rights, la Inter-American Court of Human Rights e sul processo di judicialization of dispute settlement delGATT. Si veda anche Trassl 1994.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
12
dell’ONU del novembre 1994 il primo presidente del ICTY, AntonioCassese, poneva l’accento proprio su questa contrapposizione: senza giu-risdizione internazionale finisce per prevalere il costrutto arcaico dellacolpa collettiva11.
Alla luce di quanto detto, occorre dunque accostarsi alla letteraturacercando di sfuggire al rischio di una pregiudiziale scelta di campo.Come giustamente ha osservato Antoine Garapon in un bel libro recente,«in tema di giustizia internazionale esistono essenzialmente due tipologiedi studi: da un lato, un’ampia letteratura apologetica che indefessamenteripropone la storia da Norimberga alla Corte penale internazionale,nutrita da numerosi esempi ma scarsamente problematizzata; dall’altro,un’analisi essenzialmente teorica che sottolinea la fragilità – se non addi-rittura l’impossibilità – di una tale impresa. Pertanto, il nostro tema soffrevuoi di un ottimismo eccessivo, vuoi di un riduttivo pessimismo (e nulla nelmezzo)»12. Le conclusioni a cui la presente disamina approderà, lo si devericonoscere subito, sono destinate ad avvicinarla al partito dei pessimisti.Ma una valutazione complessiva può avvenire solo se si colloca il proble-ma nel contesto di quella più generale giuridificazione e moralizzazionedelle relazioni internazionali che ha caratterizzato gli anni della disten-sione e poi ancora, con ulteriore intensificazione, l’ultimo decennio delsecolo scorso – in cui acquista visibilità un nuovo elemento ritualizzatodella politica internazionale, l’ammissione pubblica di colpe storiche13.
L’analisi deve prendere le mosse dalla definizione dei crimini rispettoai quali sono sorte nuove istituzioni con funzioni giurisdizionali.L’espressione più generale e comprensiva, anche se giuridicamente pro-blematica, è crimini di Stato o crimini politici. Tradizionalmente per crimi-ni politici s’intendevano crimini compiuti dai governati e aventi come fineil mettere a repentaglio la stabilità e l’integrità dello Stato o della classe digoverno. Erano crimini ex parte populi. Quelli che sono al centro dellepresenti considerazioni sono invece crimini ex parte principis, anche se in
11 Cit. in C.Fetscher, Vom Entstehen des Jugoslawiens-Tribunals. Der Fall Srebrenica, inBogoeva/Fetscher 2002, p. 15.
12 Garapon 2004, p. 8. Sulle controversie intorno alla giustizia internazionale (come giu-stizia politica) nella letteratura francese si veda anche il libro di Hazan 2000.
13 Cfr. Elazar 2000, Lübbe 2001.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
13
casi estremi la delega a commetterli arriva ad abbracciare una largaparte della popolazione. Come vedremo si è affermata per designarli l’e-spressione «macrocriminalità politica»: in essa va ricompresa l’interagamma dei crimini internazionali (§ 1. 2). Il passo successivo è costituitoda una ricostruzione storica delle vicende della giurisdizionale penaleinternazionale dalla prima guerra mondiale attraverso Norimberga eTokio fino alla nascita della ICC (§§ 2. 1-5), con un excursus su quellaesperienza senza precedenti e senza termini di confronto che è stata l’e-laborazione giudiziaria dei crimini del nazionalsocialismo (§ 2. 3). Laparte conclusiva si sofferma sulle resistenze a cui il nuovo paradigmadella giustizia penale internazionale va incontro (§ 3. 1), sulla propostadel più comprensivo, e per certi versi alternativo, paradigma della resto-rative justice (§ 3. 2) e sulla dimensione simbolica delle politiche di ricon-ciliazione (§ 3. 3).
La nascita della giurisdizione penaleinternazionale nel corso del XX secolo sispiega con ragioni che non richiedonoparticolare illustrazione. Rapportato all’or-
dinaria storia criminale del genere umano, l’ultimo secolo ha conosciutoinfatti vertici di violenza senza precedenti, riassumibili nelle categorie diguerra totale e genocidio. È stata la connessione tra queste modalitàdistinte di estremizzazione della violenza a rendere evidente la necessitàdi mettere in discussione un dogma fino a quel momento indiscusso deldiritto internazionale, il principio di sovranità. Per il diritto internazionaledell’epoca degli Stati sovrani la non imputabilità e di conseguenza l’im-punità dei rappresentanti pubblici era un dogma. Oggi la situazione ècambiata, come la dottrina quasi unanimemente riconosce. «The conceptof state criminality is an emergent general principle of international law»(Jørgensen 2000, p. 279).
La regolamentazione del diritto di guerra ha una lunga preistoria, checoincide con la codificazione del diritto internazionale classico. Pur nonavendo messo in discussione lo jus ad bellum, il diritto ottocentesco avevaavviato un processo di codificazione dello jus in bello, culminante nelleConvenzioni dell’Aia del 1899 e 1907. Ma quella regolamentazione non
1. 2. MACROCRIMINALITÀ POLITICA
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
14
tardò a rivelarsi fallimentare, in considerazione del fatto che le norme cheimponevano agli Stati obblighi di natura sostanziale non erano (sufficien-temente) affiancate da norme che definissero le condizioni del verificarsidi un illecito internazionale e le conseguenze giuridiche del medesimo:inoltre, il diritto di guerra aveva appena conosciuto le sue prime sistema-zioni positive che già appariva svuotato dall’evoluzione delle armi e dellestrategie militari. Con il primo conflitto mondiale la guerra, lungi dal sot-tomettersi ad una disciplina umanitaria, diventa «totale». Ciò significa cheè potenziata anche la sua criminosità14. Ma l’appello ai tribunali per con-trastare i crimini di guerra restava all’indomani di quel conflitto sostan-zialmente inascoltato, fin quando altri crimini internazionali – crimini con-tro la pace, crimini contro l’umanità e genocidio – non producevano lamassa critica che avrebbe consentito il decollo, sia pure in condizionieccezionali, della giurisdizione penale internazionale. A determinare lasvolta era dunque l’esperienza dei totalitarismi: a questo punto i tribuna-li, in particolare tribunali istituiti ad hoc, erano chiamati a farsi carico adun tempo delle responsabilità di guerre totali e regimi genocidari.
Si può dire che il genocidio abbia spostato il baricentro del dirittopenale internazionale dall’ambito militare a quello politico. È in relazionead esso che è divenuto corrente riferirsi alle fattispecie di nuovi criminiricorrendo ad un’espressione nuova: «macrocriminalità politica» (Jäger1989). Ma la coscienza della novità del genocidio e della necessità dicombatterlo con lo strumento giudiziario si fa comunque strada lentamen-te. Solo ad un bilancio conclusivo il XX secolo si è consegnato alla storiacome il «secolo dei genocidi»15. Il genocidio vi appare non come un feno-meno eccezionale, un atto di sconsiderata ferocia legato ad una concate-nazione di tragedie collettive, ma come «la faccia perversa del modernomonopolio statale della violenza con il suo intreccio di competenze politi-
14 Sui crimini di guerra nella prima guerra mondiale si vedano Wette 2001 e Seidler/deZayas 2002. Il più ampio repertorio bibliografico relativo alla prima metà del secolo restaTutorow 1986.
15 Cfr. in particolare Ternon 1997 e Bruneteau 2004. Per una campionatura bibliograficasul genocidio e le politiche di pulizia etnica almeno Chalk/Jonassohn 1990, Fein 1993,Jonassohn/Björnson 1998, Naimark 2001, Mann 2005. Per la trattazione di casi Yuki1996, Chang 1997, Dallaire 2005, Stockhammer 2005.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
15
co-amministrative e tecnico-economiche» (Vest 2002, p. 21). La sua spe-cificità, come Arendt aveva riconosciuto, sta nell’essere un crimine dimassa compiuto burocraticamente. Certo, come attesta una sterminata let-teratura, gli eccidi di massa perpetrati su popolazioni altre, considerateinferiori o barbare, sono una costante della storia universale. Ma è nel-l’ultimo secolo che il crimine del genocidio si è imposto alla coscienzaumana con una crudezza e nettezza di contorni che sembrano non avereprecedenti nella storia. È così che il binomio modernità e barbarie domi-na da qualche tempo la letteratura sociologica e storiografica. La moder-nità aveva scommesso sull’eccezionalizzazione dei grandi crimini attra-verso il progetto della giuridificazione. Con la sua crisi, l’eccezione sem-bra diventare la norma. La barbarie della guerra viene introiettata nellesocietà.
Dalla concatenazione di queste tragedie storiche ha origine anche lanuova tipologia dei crimini internazionali. La tripartizione di crimini con-tro l’umanità, crimini di guerra e crimine contro la pace risale all’art. 6dello Statuto del Tribunale militare internazionale (IMT) instituito dall’ac-cordo di Londra dell’ 8 agosto 1945. Essa è stata ribadita negli artt. 16-20 del Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankinddel 1996 e negli art. 5-8 del Rome Statute of the International CriminalCourt del 1998. Nell’art. 6 dello Statuto dell’IMT veniva affermato un prin-cipio rivoluzionario per il diritto internazionale, perché la definizione diquei crimini metteva radicalmente in discussione il principio di sovranità.Nella sentenza del Tribunale (30. 9/1. 10. 1946) non era però ancoravalorizzata la possibilità di distinguere il crimine contro l’umanità dai tra-dizionali crimini di guerra, rispetto ai quali esso appariva accessorio. Èsolo con la legge del Consiglio di controllo nr. 10 del 20 dicembre 1945che quel crimine cessa di essere considerato accessorio, rispetto agli even-ti bellici, e diventa un crimine autonomo. Assente era invece in entrambiquei documenti ogni riferimento al genocidio, assurto comunque pochianni dopo a categoria centrale della criminologia politica e del dirittopenale internazionale con la Convention on Genocide (1948)16. Da allo-
16 All’art. 2 vi leggiamo la seguente definizione: «genocide means any of the followingacts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or reli-gious group, as such: a) Killing members of the group; b) Causing serious bodily or mental
ra il crimine di genocidio ha trovato riconoscimento in una pluralità didocumenti internazionali. Anche lo Statuto di Roma dell’ICC ha estrapo-lato come fattispecie particolare il genocidio dai crimini contro l’umanità,dando così definitiva configurazione ad una tipologia quadripartita.Questa quadripartizione è oggi assunta alla base delle più recenti – e perimpostazione più moderne – trattazioni sistematiche del diritto penaleinternazionale17.
La tipologia giuridica dei crimini internazionali si è ormai saldamentecollocata al centro di ogni indagine sulla macrocriminalità collettiva esarebbe assurdo metterne in discussione l’utilità. Potrebbe essere utile tut-tavia cercare di ampliare la prospettiva adottando un punto di vista poli-tologico. Dibattendo la questione dei crimini di guerra, Bert Röling, cheera stato giudice al Tribunale militare internazionale di Tokio, distinguevala criminalità individuale, consistente nei crimini commessi dai combattentidi propria iniziativa (omicidi, stupri, saccheggi), dalla criminalità di siste-ma, comprendente i crimini commessi su ampia scala su ordine o con latolleranza delle autorità politiche o militari18. Ora, a costituire la specifi-cità del crimine politico è proprio la sua natura sistemica, l’intreccio traresponsabilità individuale e collettiva. Se è fuor di dubbio che la nascitadella giurisdizione penale è intimamente legata al superamento della vec-chia dottrina della (intangibile) personalità dello Stato e all’adozione di unparadigma individualistico, volto ad accertare la responsabilità dei singolianche nelle azioni tradizionalmente imputate ad organi pubblici protettidallo scudo dell’impunità, è altrettanto evidente che la responsabilitàpenale per crimini politici pone tutti i problemi che la letteratura riscontraquando si accinga all’analisi della responsabilità nelle organizzazionicomplesse (Lübbe 1998).
L’adozione di un modello penalistico che prescindesse dalla conside-
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
16
harm to members of the group; c) Deliberately inflicting on the group conditions of life cal-culated to bring about its physical destruction in whole or in part; d) Imposing measuresintended to prevent births within the group; e) Forcibly transferring children of the group toanother group».
17 Cfr. Ahlbrecht 1999, Bassiouni 1992 e 1999a, Dinstein/Tabory 1996, Greppi 2001,Werle 2003, Cassese 2004, pp. 145-71.
18 B. Röling, The Significance of the Law of War, in Cassese 1975, pp. 137-39.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
razione della specifica natura di quelle organizzazioni complesse chesono i sistemi politici avrebbe fatalmente come esito la legalizzazione del-l’impunità. È tipica infatti anche della macrocriminalità politica la divisio-ne dei ruoli che caratterizza le organizzazioni burocratiche: chi ordina leatrocità abitualmente non le commette, chi le commette abitualmenteobbedisce soltanto agli ordini. Fatta eccezione per una, situazionalmentee storicamente variabile, fascia di quadri intermedi, che, eseguendo e altempo stesso impartendo ordini, viene a trovarsi a così diretto contatto congli esecutori ultimi da non potersi esimere dal commettere esemplarmentele efferatezze che i subordinati dovranno poi ripetere in modo seriale,negli apparati complessi le due funzioni possono essere esercitate con unaseparatezza capace di favorire la quasi totale caduta delle barriere inibi-torie. L’assassinio di migliaia o milioni ordinato ma non agito né pensatoné visto resta un evento astratto proiettato sulla scena tragica della storiauniversale. L’assassinio concreto di decine o centinaia eseguito meccani-camente nel quadro di un’organizzazione sociale complessa che ha laprecisione di una macchina pone l’esecutore nella (autoillusoria) condi-zione d’irresponsabilità di un inerte ingranaggio. Come è noto, la strate-gia difensiva dei grandi e piccoli criminali nazisti, che ha definito unparadigma della discolpa che ha conosciuto rapida universalizzazione(anche perché favorito dalla cultura dell’impunità tipica delle gerarchiemilitari), era fondata proprio su quella divisione dei ruoli.
Una ricostruzione accurata della storia della letteratura sulla crimina-lità politica purtroppo non è stata ancora tentata. A una conferenzamadrilena di penalisti, Raphael Lemkin, l’ideatore del concetto, proponenel 1933 di considerare «atti di barbarie e di vandalismo come delictajuris gentium» (Selbmann 2002, p. 31), distinguendo in particolare tradelicta juris gentium che si rivolgono contro l’individuo in quanto tale edelicta juris gentium contro l’individuo in quanto membro del gruppo: unadistinzione in cui possiamo vedere prefigurata quella, destinata ad affer-marsi, tra crimini contro l’umanità e genocidio. Su questa base seguirànella sua più celebre opera del 1944, Axis Rule in Occupied Europe, l’in-troduzione del concetto di genocidio19. Edificata sulla base della nuova let-
WPAP
ERS
ORKING
17
19Lemkin 1944, p. 79. È significativo che nel momento della sua introduzione, il concetto
teratura sui crimini internazionali cresciuta a ridosso della seconda guer-ra mondiale è l’opera di un giurista olandese (negli anni cinquanta docen-te a Giacarta), Pieter N. Drost, The Crime of State (1959): un’opera nonpriva di un ampio retroterra filosofico-giuridico e di una visione comples-siva della storia come progressiva neutralizzazione istituzionale dei malisociali. A sottolineare l’originalità rispetto alle tradizionali trattazioni deldiritto internazionale sono i titoli dei due volumi in cui l’opera è suddivi-sa: il primo porta il titolo Humanicide, il secondo Genocide20. A dire ilvero, la distinzione concettuale, per molti versi problematica, è il prodot-to di un semplice sdoppiamento di prospettiva: «humanicide differs inprinciple from either genocide or crimes against humanity as establishedunder post-war treaty provisions. Genocide is a passive group crime;humanicide an active group crime. The former is directed against particu-lar groups; the latter is directed by a special group. Humanicide refers toa group of criminals … genocide refers to a group of victims» (Drost1959, I, p. 349). L’autore intende sottolineare con questa duplicazioneconcettuale tanto il nesso evidente che esiste tra crimini contro l’umanità egenocidio quanto la necessità di disporre di un concetto più generale diquello di genocidio per designare ogni forma di criminalità di Stato.L’umanicidio discende dall’abuso della sovranità e consiste in un eserciziocriminale della medesima.
Tutta la letteratura sulla categoria di crimini internazionali che si svi-luppa dagli anni cinquanta, pur accogliendo nella sostanza le definizionie le classificazioni che sono state messe a punto tra l’accordo di Londradel 1945 e la Convenzione sul genocidio del 1948, si troverà a fare i conticon due problemi irrisolti: la problematicità del concetto di aggressionecome crimine contro la pace e l’inadeguatezza del concetto di genocidio
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
18
tradisca ancora la sua derivazione dall’ambito della riflessione sui crimini di guerra.«Genocide is the antithesis of the Rousseau-Portalis Doctrine, which may be regarded asimplicit in the Hague Regulations. This doctrine holds that war is directed against sovereignsand armies, not against subjects and civilians» (Ivi, p. 80). Sull’opera principale di Lemkin siveda Selbmann 2002, p. 33 ss.
20 Cfr. Drost 1959, I, p. 285: «International crimes of state have a political character in thedouble sense of being committed by the members of the government and their subordinate,military and civilian, officials on the one hand and of being directed against the internatio-nal public order on the other».
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
19
a designare fattispecie criminose strutturalmente e funzionalmente analo-ghe a quelle da esso definite. Sul primo punto, occorre riconoscere, comeavremo modo di vedere, che i progressi in dottrina non sono stati signifi-cativi, men che mai risolutivi. Sul secondo aspetto, va invece riconosciutoche, a fronte di un sostanziale (ma motivato) conservatorismo della dog-matica giuridica, le scienze sociali hanno fatto uno sforzo considerevoleper dotarsi di uno strumentario analitico più flessibile di quello elaboratonella prima metà del secolo per definire quella «macrocriminalità politi-ca» che i regimi totalitari hanno posto al centro dell’attenzione.
Nella dottrina penalistica più direttamente influenzata dalle scienzesociali è stato introdotto anche il concetto di «criminalità rafforzata dalloStato» (staatsverstärkte Kriminalität), intendendo fare riferimento a criminiche implicano un’azione di Stato o una politica di Stato favorevole allaloro commissione. Crimini che sotto il profilo materiale e processuale nonsono di natura diversa dalla criminalità comune, pur presentando, a dif-ferenza di questa, difficoltà insormontabili per i tradizionali apparati giu-diziari imbevuti di ideologia giuspositivistica: con la conseguenza che leistruttorie sono avviate con molta riluttanza, i processi condotti con estre-ma cautela, le pene comminate insolitamente miti, le richieste di amnistiaun corollario obbligato (Naucke 1996, p. 7). Non mancano poi in lette-ratura tipologie anche sofisticate di queste forme di criminalità – David O.Friedrichs ha proposto ad esempio di distinguere tra governmental, poli-tical e state crime21 –, a cui la fiorente branca delle ricerche sulla violenzapolitica continua a fornire materiale empirico e integrazioni teoriche.Un’altra è però la questione fondamentale.
Il problema che la dottrina giuridica lascia aperto concerne la defini-zione di fattispecie di macrocriminalità politica che non possono esseredefinite in senso stretto genocidio (in quanto la persecuzione non è moti-vata etnicamente o religiosamente). Come è stato autorevolmente osser-vato, «una singola uccisione unita al necessario intento di “distruggere intutto o in parte”, richiesto dall’articolo II della Convenzione sul genocidio,
21 D. O. Friedrichs, State Crime or Governmental Crime: Making Sense of the ConceptualConfusion, in Ross 1995, pp. 53- 79. Cfr. anche, per l’analisi di una casistica tratta da diver-se nazioni, Ross 2000. Si vedano inoltre Schafer 1974, Roebuck/Weeber 1978, Barak1991, Friedrichs 1998.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
20
è sufficiente perché quel singolo atto sia considerato genocidio. Ma l’uc-cisione di circa due milioni di cambogiani non è genocidio, perché nonperpetrata da un gruppo etnico, religioso o nazionale ai danni di un altro,ma dallo stesso gruppo nazionale, religioso ed etnico contro i suoi mem-bri, e per motivi politici. Poiché i gruppi sociali e politici non sono com-presi tra quelli protetti nella Convenzione sul genocidio, una simile ucci-sione di massa non è considerata genocidio, se non si può dimostrare che,di fatto, vi è una differenza tra i gruppi degli esecutori e delle vittime»(Bassiouni 1999b, pp. 70-1).
Proprio per aggirare questa imbarazzante difficoltà, che nascondevanaturalmente dietro il paravento della terminologia un’imbrogliata matas-sa ideologica, sociologi e politologi si sono avventurati sulla via di unateoria generale delle forme di criminalità collettiva. In un saggio del 1988,Barbara Harff e Ted Gurr hanno cercato di superare il limite della tradi-zionale nozione di genocidio, che lascia fuori gli eccidi politici di massae le persecuzioni totalitarie quando dirette contro gli oppositori politiciappartenenti allo stesso gruppo etnico, introducendo il concetto di politi-cidio (politicide)22. Il politologo Rudolph J. Rummel ha ripreso questa inno-vazione, proponendo in un libro ambizioso, anche se certo discutibile nel-l’uso disinvolto delle statistiche sui grandi crimini storici, Death byGovernment, l’adozione di un più generale concetto – democidio (demo-cide) – per sussumere le fattispecie chiamate genocidio, politicidio e mas-sacro (Mass murder)23. Tutte queste fattispecie configurano dal punto di
22 Cfr. Harff/Gurr 1988.23 Cfr. Rummel 1995. Questo libro sintetizza i risultati di una trilogia dedicata ai maggio-
ri regimi genocidari della storia universale, tutti appartenenti al XX secolo: Rummel 1990,1991, 1992. In queste opere e in Rummel 1998 l’A. porta la contabilità dei morti assassi-nati per ragioni politiche nel XX secolo ad una cifra vertiginosa: 169.198.000. Va rilevatoche, per quanto tragicamente plausibile, questa somma precisa risulta da addendi incerti.Rummel sottovaluta sistematicamente le difficoltà di ordine metodologico e relative alle fonti,su cui la più accorta storiografia sul genocidio ebraico ci ha messo in guardia. Gli va peròdato atto dello sforzo di obiettività, che lo porta ad includere fra i democidi il bombarda-mento su Hiroshima e Nagasaki e ad imputare al governo Usa nel corso del XX secolo583.000 vittime civili. È interessante inoltre che su un totale di 214 regimi politici del XXsecolo analizzati, ne individui 141 che hanno commesso democidi, contro una minoranzaincruenta di 73 (Rummel 1998, p. 1).
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
21
vista giuridico modalità specifiche – ed aggravate – dei crimini contro l’u-manità (nel caso della più indeterminata, il massacro, che di preferenzasi verifica in guerra contro prigionieri e popolazioni civili, si tratta pari-menti di un crimine di guerra); la loro distinta designazione consente peròdi evidenziare una soglia oltre la quale la quantità trapassa in qualità(scongiurando il rischio che si vedano alcuni alberi ma non la foresta) edi specificare i contenuti della macrocriminalità politica.
Una volta ricondotti sia il genocidio che il democidio al comune alveodei crimini contro l’umanità, si potrebbe obiettare che il ricorso a que-st’ultima categoria è sufficiente per designare tutti quegli atti di violenza edi atrocità che rientrano in un disegno complessivo e fanno parte di unapratica generalizzata. E in effetti gran parte dei crimini di natura politicacon i quali tribunali nazionali e internazionali devono fare i conti posso-no essere adeguatamente perseguiti limitando l’incriminazione deiresponsabili al capo d’accusa dei crimini contro l’umanità. Tuttavia, laquestione non può essere liquidata in questi termini: anche se non è statoancora adeguatamente elaborato dalla dottrina e dalla prassi giudiziaria,il ricorso alle categorie di genocidio e democidio si rivela necessario perincriminare gli ideatori, i pianificatori e gli organizzatori di quei crimini,coloro che secondo la dottrina anglosassone sono responsabili della con-spiracy.
Da un punto di vista generale, si può addirittura affermare che solo icrimini contro la pace, il genocidio e il democidio possono essere consi-derati crimini politici sia per il loro contenuto (l’oggetto delle decisioni,azioni e persecuzioni) sia perché a commetterli (il soggetto delle decisio-ni, azioni e persecuzioni) sono detentori del potere internazionalmentericonosciuti e rappresentanti dello Stato (li si potrebbe definire criminidella classe politica in senso lato)24. Crimini di guerra e crimini contro l’u-manità sono invece gli unici crimini di natura politica che possono essere
24 Dove sia in atto un processo di dissoluzione statale, soggetti del crimine possono esse-re anche attori non riconosciuti internazionalmente. Vest fa osservare che sempre più spes-so tali crimini vengono compiuti da organizzazioni parastatali e bande organizzate da unwarlord (Vest 2002, p. 89). Il Tribunale sui crimini della Yugoslavia ha allargato il raggiodella definizione, riconoscendo che per commettere genocidio è sufficiente il controllo di fattosul territorio.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
22
commessi, in esecuzione di ordini superiori oppure in maniera spontanea,anche da appartenenti a livelli inferiori dell’apparato amministrativo civi-le e militare o da gruppi sociali organizzati in modo relativamente spon-taneo (e qui naturalmente i confini si perdono nella misura in cui questidiventano apparati para-statali al servizio dei poteri legittimi). Per la guer-ra d’aggressione, il genocidio e il democidio, che presuppongono non sol-tanto la consapevolezza del contesto entro cui si svolgono le azioni, maanche la partecipazione alla loro pianificazione e organizzazione, èinvece sempre meno plausibile l’incriminazione man mano che si discen-de nella scala gerarchica e si è chiamati a giudicare i meri esecutori.
Un’ulteriore complicazione discende poi dall’inadeguatezza, da moltiriscontrata, della coppia nazionale/internazionale per definire la com-plessa fenomenologia della macrocriminalità politica. Accanto alla cate-goria di crimini internazionali ha trovato riconoscimento in letteraturaquella di crimini transnazionali, che finisce per ricomprendere fattispeciepiuttosto eterogenee come il terrorismo, la riduzione in schiavitù e la trat-ta delle donne, il traffico di armi, di droga, di organi25. Ma in alcuni casiassistiamo anche ad una contaminazione delle due categorie. Così PeterStoett ha proposto una tipologia dei transnational crimes against huma-nity, suggerendo che la qualificazione di questi crimini come transnazio-nali permette di abbracciare anche le diverse manifestazioni di complicitànei confronti di crimini compiuti da terzi che godono di una qualche formadi appoggio economico o di assistenza tecnico-militare da parte degliStati egemoni, complicità che includono a) resonant complicity, b) indiffe-rence and selective intervention, c) material contributions e d) direct par-tecipation26. Di norma, la complicità si riduce ad una politica, giustificatapragmaticamente, di indifferenza e tolleranza (e rientra, in termini gene-rali, nella categoria di ingiustizia passiva), talora tuttavia include una taci-ta delega a compiere il lavoro sporco che onorati membri del Consiglio di
25 Cfr. Zappalà 2005, pp. 17-18.26 P. Stoett, Schades of Complicity: Towards a Typology of Transnational Crimes against
Humanity, in Jones 2004, pp. 31-55: «I include the adjective transnational to suggest thatwe are dealing, ultimately, with the impact and guilt of actors and structures external to theimmediate vicinity of atrocity, whether they be distanced by space and time, or are purpo-seful visitors» (p. 31).
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
23
Sicurezza e ancor meno corpi armati di missioni umanitarie non possonosvolgere in prima persona. Accanto alla categoria delle guerre per pro-cura (proxy wars) può così trovare posto qui la categoria dei crimini perprocura (proxy crimes).
2. UN CAMMINO CONTRASTATO
La battuta d’avvio nella storia della giu-stizia penale internazionale è costituitadalla prima guerra mondiale, che sfocia
nell’incriminazione dell’imperatore Guglielmo II per violazione dellamoralità internazionale e della sacralità dei trattati27. Se si guarda agliesiti, non vi è dubbio trattarsi di una malriuscita partenza. Nondimeno, variconosciuto che, all’indomani della prima guerra mondiale, il problemafu posto a livello politico-diplomatico, scientifico e di opinione pubblica.Dalla denuncia della responsabilità della Germania nello scatenamentodella guerra sarebbe nato il dibattito sulla guerra d’aggressione cheavrebbe portato ai grandi progetti per la messa al bando della guerra eal patto Briand-Kellogg. Ma la questione della colpa era destinata a resta-re controversa28: intorno ad essa si sarebbero sprigionati quei veleni ideo-logici che avrebbero pregiudicato negli anni del dopoguerra ogni evolu-zione giuridica in senso cosmopolitico e che anzi avrebbero favorito l’as-solutizzazione dell’ideologia nazionalista fino agli estremi del fascismo edel nazionalsocialismo29.
La criminalità politica degli Stati non aveva mai trovato efficaci deter-renti all’interno, se non laddove essa configurava reati d’insubordinazio-ne o la minaccia per l’ordine esistente. Alla fine della prima guerra mon-diale gli Stati occidentali non potevano attendersi che la Germania di suainiziativa facesse giustizia dei crimini commessi durante il conflitto. D’altra
2. 1. ESORDI FALLIMENTARI
27 Cfr. Ahlbrecht 1999, pp. 27-45, Schmitt 1991, p. 335 ss.28 Sulla criminalizzazione del nemico come rottura delle regole dello Jus publicum euro-
paeum il riferimento obbligato è naturalmente a Schmitt 1991, 1994 e 2005.29 Per una ricostruzione del dibattito cfr. Dreyer/Lembcke 1993.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
24
parte la dottrina giuridica continuava a tener fermo l’assunto dualistico el’intangibilità della sovranità degli Stati, sacrario che le norme del dirittointernazionale non potevano violare. Nonostante l’attacco sferrato daKelsen alla teoria dualistica del diritto pubblico nella sua opera del 1920,la dottrina continentale continuava a postulare, pur nella consapevolezzadei cambiamenti che stavano interessando le relazioni internazionali, l’im-punità per violazioni del diritto internazionale compiute da chiunque agis-se in qualità di organo dello Stato.
La violazione della neutralità dell’Olanda e del Belgio, il trattamentodei civili belgi come franc-tireurs, il sacco di Lovanio, che il primo ministrobritannico Herbert Asquith definì «the greatest crime against civilizationand culture since the Thirty Years’ War»30, l’affondamento il 7. 5. 1915 daparte di un sottomarino tedesco della nave passeggeri britannicaLusitania, con 1198 morti, costituivano atti di inaudita barbarie, avvenutiin spregio del diritto internazionale delle civilized nations sancito dalleConvenzioni dell’Aja, e che proprio per questa ragione non potevanoessere lasciati impuniti. La consueta clausola di amnistia dei trattati dipace lasciava così il posto nel trattato di Versailles ad articoli di oppostotenore (artt. 227-30)31. Ma a quello stadio di sviluppo mancavano le con-dizioni per l’attuazione dell’ancor rudimentale diritto penale internazio-nale: accanto a norme primarie che vietavano determinati comportamen-ti qualificandoli come crimini di guerra le Convenzioni esistenti non pre-vedevano ancora norme secondarie che disponessero concrete sanzionipenali. Le norme del trattato di Versailles testimoniano pertanto, più che diun orientamento nuovo, di una condizione di universale smarrimento. Essenon dischiudono una stagione di attivismo giudiziario internazionale enemmeno la soluzione di compromesso di una giustizia eterocefala, cheopera attraverso processi nazionali attivati su pressione internazionale.Quello a cui, nonostante ogni tentativo di criminalizzazione dei vinti, laprima guerra mondiale mette capo è un’«amnistia apocrifa»32.
30 Cit. in Willis, pp. 9-10. Non va sottaciuto, per altro, che molti crimini furono costruiti oingigantiti dalla propaganda.
31 Hankel 2003, p. 31 ss. Sulle norme di Versailles si veda inoltre Schwengler 1982.32 Così Quaritsch 1995, p. 100 ss (critico nei confronti di questa tesi Hankel 2003, pp.
14-15).
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
25
La letteratura storiografica sulla genesi della giurisdizione penalenazionale e internazionale come strumento per contrastare la macrocri-minalità politica è cresciuta considerevolmente nel corso degli anni e offreormai solidi elementi di conoscenza e di giudizio. Nel 1982 James F.Willis ha pubblicato una dettagliata ricostruzione del tentativo intrapresodai vincitori della prima guerra mondiale – e notoriamente fallito – di sot-toporre a giudizio il Kaiser e i maggiori criminali di guerra tedeschi,Prologue to Nuremberg. The Politics and Diplomacy of Punishing WarCriminals of the First World War; nel 1998 Ariel J. Kochavi ha ricostruitonel suo Prelude to Nuremberg. Allied War Crimes Policy and the Questionof Punishment il complesso processo diplomatico e il contesto di argomentipolitici, giuridici e morali che hanno portato alla creazione dei tribunalimilitari internazionali sui crimini commessi nel corso della seconda guer-ra mondiale33. Parallelamente, sono ormai disponibili fondamentali lavorisui processi ai responsabili del genocidio armeno nella Turchia del 1915e ai criminali di guerra tedeschi della prima guerra mondiale: TanerAkçam ha dato alle stampe nel 1996 la prima documentata monografiasui processi di Instambul, Armenien und das Völkerrecht. Die InstambulerProzesse und die türkische Nationalbewegung, Gerd Hankel nel 2003 DieLeipziger Prozesse. Deutsche Kriegsverbrechen und ihre strafrechtlicheVerfolgung nach dem Ersten Weltkrieg, una ricostruzione cui va il meritodi essere fondata per la prima volta su una minuziosa analisi non solodelle sentenze ma degli atti processuali34.
Accanto a questi contributi di carattere più specialistico, sono venutimoltiplicandosi nel corso degli ultimi anni lavori che, operando con meto-do storico-comparativo, mirano a trarre conclusioni più generali sullemodalità di esercizio della giurisdizione per crimini internazionali neiregimi politici del Novecento. Stay the Hand of Vengeance (2002) di GaryJonathan Bass è il libro da cui occorre partire. Vi si ricostruisce la storiadella giurisdizione penale internazionale dai suoi problematici inizi (ilmancato processo a Napoleone)35 fino ai tribunali ad hoc degli anni ’90
33 Cfr. Willis 1982, Kochavi 1998. 34 Cfr. Akçam 1996, Hankel 2003. 35 Bass 2000, p. 5, significativamente definisce in questi termini tali esordi: «abortive trea-
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
26
e si analizzano le ragioni che hanno portato nella storia del XX secologoverni a istituire, sostenere o boicottare tribunali internazionali.Prendendo le mosse dai dibattiti sui crimini politici in Ruanda, Bosnia oKosovo vi si riconoscono «partial echoes of political disputes from 1815,1918, and 1944»36. Dalla lettura di questa ricostruzione di lungo periodosi ricava l’impressione che le continuità prevalgano sulle discontinuità, percui l’apparenza del dischiudersi di una nuova epoca potrebbe risultareillusoria. La vera discontinuità va riscontrata a monte, nell’origine rivolu-zionaria della giustizia politica: il processo di criminalizzazione dellapolitica viene avviato dalla rivoluzione francese, nel duplice senso che gliattori rivoluzionari si erigono a giudici dell’ancien règime e lo processa-no nella persona dei regnanti ma anche nel senso che, così facendo, essisi rendono responsabili di crimini politici (si ricordino le pagine kantianesul sommo crimine rivoluzionario). La lotta politica su larga scala vienefatta con lo strumento del processo giudiziario. Non è un caso che il ciclorivoluzionario si chiuda con una condanna ma non con un processo: ilCongresso di Vienna dichiara Napoleone nemico del genere umano, mail confino dell’imperatore a Sant’Elena non è preceduto da un procedi-mento giudiziario37.
La storia della Commission on the Responsability of the Authors of theWar and the Enforcement of Penalties, di cui fanno parte anche autorevoliinternazionalisti (primo fra tutti l’americano James Brown Scott), è piutto-sto istruttiva. In essa si riflettono le divergenti posizioni degli alleati, cia-scuna delle quali fortemente condizionata da ragioni di politica interna.Del resto, la linea politica dei vari governi democratici non è affatto uni-voca. Anche se la domanda di retribuzione penale dei criminali di guer-ra tedeschi era forte nella società americana, Wilson aveva mantenuto
son trials of Bonapartists in 1815 after the Hundred Days; botched trials of German war cri-minals after World War I; an abortive prosecution of some of the Young Turk perpetrators ofthe Armenian genocide».
36 Bass 2000, p. 5.37 In ogni modo, quello di Napoleone costituisce il precedente moderno di punizione di un
capo di Stato che non sia la risultante di un atto rivoluzionario ma di un accordo interna-zionale. Sui rapporti tra politica e giustizia internazionale anche Beigbeder 1999 e Maogoto2004.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
27
sempre una posizione ambigua se non ostile nei confronti di tale doman-da: in ogni caso la punizione di war crimes non era per lui un obiettivoprimario38. L’uomo più autorevole della Commissione, il Segretario diStato americano Robert Lansing, si rivela per parte sua il più acerrimodifensore della concezione vetero-europea della sovranità e un implaca-bile nemico di ogni codificazione di laws of humanity39. All’interno diquell’organismo operano tre sottocommissioni: la prima raccoglie la docu-mentazione sulle atrocità e stila il catalogo delle 32 categorie di war cri-mes, suffragando così la tesi della colpa tedesca, ma non conduce e nonpuò condurre una nuova inchiesta. La seconda si occupa delle conse-quenze giuridiche dell’aggressione, per concludere che, dato il «caratterepuramente opzionale» delle disposizioni del diritto dell’Aia, la guerrad’aggressione non può essere considerata un atto direttamente contrarioal diritto positivo. La terza sui crimini di guerra è praticamente paralizza-ta dalla logica rigorosamente statalistica di Lansing. «The Americansrejected as unprecedented: (1) an international court, (2) the trial of ahead of state, (3) the doctrine of negative criminality, and (4) the laws ofhumanity» (Willis 1982, p. 75).
Nel quadro di questa contrastante vicenda trovano collocazione i pro-cessi di Leipzig sui crimini commessi da militari tedeschi nel corso del con-flitto. Per quanto essi costituiscano un interessante laboratorio nella ricer-ca di una definizione giudiziaria del crimine di guerra, si tratta nel com-plesso di un fallimento, risultato deludente di quella che è stata felicemen-
38 Per Willis 1982, p. 23, l’appoggio dei governi alleati all’idea di «postwar prosecutions»rimase nel corso di tutta la prima guerra mondiale complessivamente «inconstant». «Britishleaders proved more receptive to demands to make war crimes trials a war aim» (p. 15), ilche vale anche per Winston Churchill, il quale in questi anni è deciso nel ritenere gli attac-chi dei sottomarini tedeschi atti illegali da sottoporre a processo e nel considerare criminalidi guerra i prigionieri degli U-Boot. Quanto ai piani di pace di Wilson, essi erano focaliz-zati «almost entirely upon creation of a League of Nations, not upon international war cri-mes trials» (p. 47).
39 In seno alla Commissione Landing sosteneva che l’essenza della sovranità era «theabsence of responsability. When the people confided it to a monarch or other head of State,it was legally speaking to them only that he was responsible, although there might be a moralobligation to mankind. Legally, however, there was no super-sovereignty» (cit. in Willis 1982,p. 74).
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
28
te definita «giustizia dei vinti in concessione»40. I processi di Leipzig pos-sono essere considerati un documento paradigmatico della resistenzaopposta dal nazionalismo e dal corporativismo militare all’elaborazionegiudiziaria della storia. Alla base della riluttanza dei tribunali tedeschi neiconfronti della richiesta di giustizia dei vincitori si ergeva tetragona laconvinzione che le direttive impartite da uno Stato in condizioni di neces-sità non fossero giustiziabili e che il soldato tedesco non potesse commet-tere crimini di guerra. In presenza di un ordine impartito da un superioree in assenza della coscienza di commettere un’azione contraria al dirittorisultava per i giudici impossibile individuare la componente soggettivadell’atto criminale (Hankel 2003, p. 519). La strategia difensiva cheavrebbe portato all’amnistia consisteva pertanto non solo nel tentativo dinegare nella misura del possibile i fatti (l’actus reus) come costruzionedella propaganda nemica, ma nell’escludere ogni intenzionalità crimino-sa (la mens rea).
Anche il trattato di Sèvres (1920), che concludeva la pace con laTurchia, conteneva disposizioni (artt. 226-230) sulla prosecuzione dei cri-mini commessi durante il conflitto, che in questo caso andavano al di làdei meri crimini di guerra per includere le atrocità perpetrate contro gliarmeni (il concetto di genocidio, come si è visto, all’epoca non è ancorastato coniato). Ma anche in questo caso i processi non ebbero luogo, per-ché il trattato non fu ratificato dalla Turchia bensì sostituito dal trattato diLosanna (1923) che conteneva invece una Dichiarazione d’amnistia pertutti i crimini commessi tra il 1 agosto 1914 e il 20 novembre 1922.Processi-farsa avevano nel frattempo avuto luogo, in condizioni di totaleconfusione politica e amministrativa, a Instambul41. L’inconcludenza deglialleati, e in particolare dei britannici (gli unici per altro ad aver preso sulserio la questione dei crimini contro gli armeni), avrà, in questo caso, untragico epilogo, a dimostrazione dei costi politici che anche la rinuncia aiprocessi può storicamente comportare: la mancata giustizia nazionale einternazionale alimenta la vendetta di tipo terroristico; la sequela di omi-
40 Müller 2001, pp. 202-222.41 Sul radicale fallimento di questo primo tentativo di processare i responsabili di un geno-
cidio, per altro sempre negato dai governi turchi, informa Akçam 1996, p. 92 ss.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
29
cidi di leader turchi che ha luogo in vari paesi tra il 1921 e il 1922 è laviolenta e provvisoria chiusura di un conto che gli accordi di pace nonerano riusciti a incanalare in procedure giudiziarie42.
Arenatisi così, come prevedibile, i processi all’interno delle singolenazioni, l’impegno per una giustizia penale nei confronti dei crimini inter-nazionali prosegue in ambito internazionale. Con la fondazione dellaSocietà delle Nazioni prende avvio un processo deliberativo che ha comeobiettivo l’evoluzione del diritto internazionale in materia di crimini con-nessi alla guerra e, anche se con minore convinzione, la creazione di unorgano di giurisdizione penale internazionale. Il Comité consultatif deJuristes previsto dall’art. 14 dello Statuto della Società delle Nazioni eincaricato di predisporre lo Statuto della Corte permanente di giustizianon tarda, sotto la guida di Descamps, a porre sul tavolo le questioniormai incombenti di un diritto penale internazionale. Ma il rapporto delComitato viene respinto dall’Assemblea generale, che soffoca così sulnascere ogni possibile processo di istituzionalizzazione. La discussionesulla definizione e sull’estensione della categoria di crimini di guerra esulle prospettive di una giustizia penale internazionale continua comun-que, anche grazie allo stimolo di penalisti quali Vespasien Pella eQuintiliano Saldaña, all’interno dell’International Law Association,dell’Association de droit pénal e in seno del 23° Congresso dell’Unioneinterparlamentare (Washington 1925): si tratta di una discussione che tut-tavia non conduce a conclusioni univoche, né ad una proposta che possacostituire la base per una concreta trattativa tra Stati43.
Sul piano degli accordi multilaterali vanno qui menzionate laConferenza panamericana dell’Havana (febbraio 1928), il patto Briand-Kellog per la messa al bando della guerra sottoscritto nell’agosto 1928 danove Stati (fra cui la Germania, l’Italia e il Giappone) e firmato nei mesiseguenti complessivamente da 63 Stati, la Conferenza per la lotta al ter-rorismo del novembre 1937, con le due Convenzioni «per la prevenzionee la repressione del terrorismo» e «per la creazione d’una Corte penale
42 Willis 1982, p. 163: a Berlino vengo assassinati Talaat Pasha e in seguito BehaeddinShakir e Djemal Azmi, a Roma il principe Said Halim Pasha, a Tiflis Djemal Pasha, oltre aEnver Pasha caduto probabilmente per mano armena sul fronte caucasico.
43 Ahlbrecht 1998, pp. 46-54.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
30
internazionale», che non sarebbero però entrate in vigore per la manca-ta ratificazione da parte degli Stati firmatari (eccetto l’India). L’indicatorepiù significativo della fragilità di questi accordi è il fatto che il pattoBriand-Kellog sarebbe stato impunemente violato tre volte negli anniseguenti: con l’aggressione sovietica alla Cina (1929), con l’occupazionegiapponese della Manciuria (1931) e con l’invasione della Colombia daparte del Perù (1932). Gli interessi di potenza degli Stati continuavano acostituire un ostacolo insormontabile non solo alla nascita di un dirittopenale internazionale ma anche all’evoluzione del diritto di guerra44.
Sono le atrocità commesse dal regi-me nazista a segnare la svolta. A giudi-care con il senno di poi si potrebbe
affermare che, all’indomani della seconda guerra mondiale, è l’orrore peril genocidio a costituire la motivazione che spinge a sottomettere la politi-ca al vaglio dei tribunali e creare le condizioni per l’evoluzione del dirit-to penale internazionale. Ma nella coscienza dei contemporanei le cosenon furono probabilmente così chiare. La percezione della natura e dellacorrelazione dei crimini che occorreva mettere al bando si fece strada sololentamente nell’opinione pubblica mondiale e alla rottura rivoluzionaria diaudaci scelte internazionali seguì un certo conservatorismo politico e giu-risprudenziale. Del resto, l’unicità del crimine totalitario sembrava richie-dere risposte eccezionali e perentorie, non l’apertura di un cantiere digraduale sperimentazione giudiziaria. La chiusura dei conti con il passa-to e l’apertura di nuove prospettive di sviluppo istituzionale non tardaro-no ad essere prese nella morsa dei contingenti imperativi politici del pre-sente.
I processi di Tokio e Norimberga segnano una svolta, ma si può diredavvero che inaugurino un nuovo paradigma? La questione è notoria-mente controversa. Per un verso, la novità strutturale di tribunali interna-zionali che giudicano crimini commessi da individui nella loro qualità diorgani di Stato è d’indiscutibile rilevanza. Per altro verso, la precarietàdelle basi giuridiche su cui sono fondati i procedimenti e la composizione
44 Ahlbrecht 1998, pp. 54-58.
2. 2. NORIMBERGA E TOKIO
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
31
della corte esclusivamente con giudici designati dai paesi vincitori haindotto non soltanto i vinti a pensare che quella non fosse altro che unaforma sofisticata di vendetta: i processi ai massimi responsabili fungeva-no da prodromo alla criminalizzazione morale di due popoli. Il fatto cheper molti decenni tale precedente fosse rimasto senza seguito è parso amolti una conferma del carattere esclusivamente «politico» di quella giu-stizia.
In virtù delle questioni irrisolte e dei falliti precedenti, anche la storiache conduce alla costituzione dei Tribunali militari internazionali delsecondo dopoguerra e ai cosiddetti princìpi di Norimberga è segnata dal-l’improvvisazione e dalla contingenza. Per un verso, nel corso stesso delconflitto le posizioni degli alleati circa l’opportunità di un processo resta-no soggette a molte oscillazioni e incertezze. Per altro verso, controversarimane fino all’ultimo la questione di quali crimini debbano essere pro-cessati e quale rilevanza debba essere loro attribuita. Rispetto al primodopoguerra, le posizioni britanniche e americane si presentano pratica-mente rovesciate. Se nel 1918 i britannici con Lloyd George, ma anchecon Churchill, avevano proposto di processare l’imperatore e i criminali diguerra tedeschi, mentre Wilson aveva messo in guardia da un tribunaledei vincitori e dal rischio di spingere i tedeschi verso il comunismo, ora iruoli sono cambiati ed è Churchill ad avanzare le maggiori perplessitàcirca l’ipotesi di un processo internazionale a carico dei gerarchi nazisti.
In queste oscillazioni si riflette evidentemente anche l’esperienza delfallimento della giustizia penale, interna e internazionale, concernente icrimini della prima guerra mondiale45. La Commission on theResponsability of the Authors of War del primo dopoguerra aveva soste-nuto che «a war of aggression may not be considered as an act directlycontrary to positive law». Ancora vent’anni dopo, quando il 20 ottobre1943 gli Alleati danno vita a Londra alla Commissione dei crimini di guer-ra delle Nazioni Unite (United Nations War Crimes Commission), in cuigli esperti dibattono la possibilità di includere fra i capi d’accusa «the
45 Per una comparazione di come il problema fu posto nei due dopoguerra cfr. K.-H.Janssen, Versailles und Nürnberg. Zur Psychologie der Kriegsschuldfrage in Deutschland, inFriedrich/Wollenberg 1987, pp. 26-42 e Kochavi 1998.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
32
waging of aggressive war», americani e britannici in un primo tempo sioppongono. Solo sei mesi dopo, alla Conferenza di Londra, le posizionisarebbero cambiate e i crimini contro la pace inclusi nello Statuto46. Anzi,a conclusione del processo l’aggressione sarebbe diventata il «supremeinternational crime», anche se, come è stato da più autori osservato, aNorimberga i giudici avrebbero mantenuto una certa prudenza nel farericorso a questo capo d’accusa: «when the judges came to impose the“supreme penalty”, aggressive war no longer figured as the “supremecrime”». Nessuno che fosse stato riconosciuto colpevole solo di questo cri-mine e non contemporaneamente degli altri due venne condannato amorte, come documenta il caso di Rudolf Hess47.
La costruzione del «prosecutorial bullet» fu al vertice delle preoccupa-zioni degli Alleati. Il paradosso della futilità del dispositivo giudiziariotradizionale nei confronti dei massimi responsabili di crimini era ben pre-sente ai decisori dello Statuto di Londra. Gli incriminati nei processi diLeipzig non erano stati generali e ammiragli. Occorreva pertanto undispositivo d’incriminazione che impedisse ai maggiori responsabili disfuggire alla pena. Lo Statuto definì all’art. 6. 2 le tre fondamentali cate-gorie di crimine su cui il tribunale avrebbe avuto competenza (crimini con-tro la pace, crimini di guerra e crimini contro l’umanità), complicando ilquadro nel successivo comma (6. 3) con la fattispecie della conspiracy48.Su questa base si sarebbero costruiti quattro capi d’accusa, includendoanche il piano o la congiura, ma interpretando quest’ultima solo in riferi-mento all’aggressione (in questo modo si sarebbe però pregiudicata lapossibilità di tematizzare il genocidio)49.
46 Cfr. W. A Schabas, Origins of the Criminalization of Aggression: How Crimes AgainstPeace Became the “Supreme International Crime”, in Politi/Nesi 2004, p. 18 ss.
47 Cfr. Schabas, Origins of the Criminalization of Aggression cit., p. 31: «Aggressive warwas a kind of prosecutorial bullet capable of ensuring the conviction of those at the very top».
48 Sulla problematicità del cospiracy charge Röling/Cassese 1993, p. 58: «To covereverything that happened before and during the war, this charge of conspiracy contendedthat if you were involved, you were responsible for everything. So you don’t need to provethat someone was connected with a specific outrage or killing, but just that he was part of aconspiracy».
49 Cfr. Ahlbrecht 1999, pp. 71-73. Va tenuto presente, per altro, che nel corso dei lavori
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
33
Sulla portata di queste innovazioni la dottrina non ha notoriamentelesinato le critiche. Più di un autore, in polemica contro la tesi che stilizzaNorimberga a «forerunner of universal justice», ha sostenuto che, perquanto concerne la definizione dei crimini di guerra e contro l’umanità, lagiurisprudenza di Norimberga non è stata, rispetto alle elaborazioni deidecenni precedenti, sostanzialmente innovativa, mentre il crimine controla pace è rimasto vago: alla base della condanna di Doenitz stava unadefinizione di aggressione che, se accettata in tale generalità, avrebbepotuto portare davanti ad una corte internazionale qualsiasi comandantedi sottomarino di qualsiasi Stato belligerante50. In effetti, l’esecuzione del-l’aggressione era una fattispecie non riconosciuta universalmente e con-travveniva al divieto di retroattività delle norme penali. Bert Röling, percitare soltanto un internazionalista d’indubbia autorevolezza, è rimastosempre dell’avviso che all’inizio della seconda guerra mondiale la guerrad’aggressione non potesse essere considerata un crimine di diritto inter-nazionale, per cui quell’imputazione violava il principio nullum crimen,nulla poena sine lege51 – un principio riconosciuto anche dal diritto inter-nazionale almeno dalla prima guerra mondiale.
Ciò che consentì di aggirare la più rigida dogmatica continentale, perla quale il principio nullum crimen, nulla poena sine lege valeva (quasi)
preparatori dello Statuto il concetto di conspiracy era stato inserito dagli esperti, in partico-lare dall’americano Murray Bernays, per poter procedere nei confronti dei crimini commes-si dai nazisti prima dell’inizio della guerra: v. Douglas 2001, p. 43.
50 Così Davidson 1973, pp. 278 e 295-6: «Insofar as Nuremberg was dealing with genui-ne crimes, as it did in points three and four of the indictement – war crimes and crimes again-st humanity – it had little new to say. War crimes were crimes long before the Nurembergtrials, as were crimes against humanity – mass murder as barbarous treatment of a peopleon a major scale – which violate both domestic and international law. Aggressive warremains a crime in embryo or in theory; as a full-blown criminal act it rarely, if ever, is iden-tificable as much by both sides, as well as neutrals, and has been nowhere clearly detecta-ble in the cases we have examined». Si può ricordare qui che anche Taylor (1970, p. 89) hasostenuto che i processi di Norimberga e Tokio hanno gettato «little new light on the laws ofwar relating to the use of weapons». La tesi è largamente condivisa: Ahlbrecht 1999, p. 94.
51 Röling/Cassese 1993, p. 98. Inoltre Maser 1977, p. 521, Ahlbrecht 1999, p. 46 ss: giànei dibattiti dei giuristi impegnati negli anni ’20 all’interno del Comité Consultatif de Juristes,istituito dall’art. 14 dello Statuto della Società delle Nazioni, la questione era stata affronta-ta ed era emerso il problema della violazione di questo principio.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
34
incondizionatamente con le sue specificazioni a) sine lege scripta, b) sinelege praevia, c) sine lege stricta, d) sine lege certa, fu il prevalere delladottrina anglo-americana, che dava maggior peso alle consuetudini52. Aquesta dottrina si deve anche, come è noto, l’inserimento nello Statutodella categoria di conspiracy. La perseguibilità della conspiracy era rico-nosciuta dal diritto americano e da quello sovietico, ma non dal dirittopenale continentale (che ne criticava l’indeterminatezza), e di conseguen-za nemmeno dal diritto internazionale. Analogamente, a differenza dellatradizione romano-civilistica, per la quale solo le persone fisiche e non lepersone giuridiche possono essere considerate penalmente responsabili,la tradizione di common law, avendo sviluppato norme per la responsa-bilità anche delle persone giuridiche, consentiva l’imputazione di orga-nizzazioni criminali (come le SS o la Gestapo).
Non solo per queste ragioni l’eredità di Norimberga resta controver-sa53. Fra i capi d’accusa più ricorrenti, accanto alla violazione del princi-pio di irretroattività (che concerneva, oltre al crimine contro la pace,anche i crimini contro l’umanità), è annoverato il fatto che a dettare lenorme fossero gli stessi giudici e procuratori, che gli imputati fossero scel-ti (anche con una certa arbitrarietà) esclusivamente tra i vinti, che i giudi-ci fossero insediati solo dai vincitori, e che questi avessero determinatometodi e procedure e tenuto nelle loro mani l’intero svolgimento proces-suale, che la difesa fosse rimasta in balia della benevolenza dei giudici,che le pene fossero state comminate non in base a regole preesistenti maa discrezione dei giudici (Ahlbrecht 1999, pp. 73-4). Il fatto poi che l’ar-gomento del tu-quoque fosse stato respinto in linea di principio dal tribu-nale (trovò solo limitato riconoscimento in riferimento alla guerra sotto-marina, del che beneficiarono Raeder e Dönitz), ha legittimato l’accusa,soprattutto nei confronti dell’Unione Sovietica, di unilaterale giustizia deivincitori. Persino la tesi restrittiva dell’art. 8 dello Statuto, secondo la quale
52 Cfr. Ahlbrecht 1999, p. 31. Non è un caso che Carl Schmitt riservasse ampio spazio delsuo Gutachten preparato nel 1945 per la difesa di Flick alla dimostrazione dell’eterogeneitàdi quelle tradizioni dottrinali (e vi insiste ancora Helmut Quaritsch nell’introduzione allapostuma edizione di quello scritto: v. Schmitt 1994).
53 Sulla controversa valutazione del processo cfr. Maser 1977, Friedrich/Wollenberg1987, Taylor 1996, Ahlbrecht 1999, Douglas 2001, pp. 39-64.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
35
l’agire sulla base di un comando poteva essere considerato solo comeattenuante, non come elemento di discolpa, non corrispondeva ai princì-pi internazionalmente riconosciuti. Anche l’assunto di una responsabilitàpenale di organizzazioni criminali come la Gestapo o le SS (art. 9) viola-va il divieto di retroattività (Id., p. 80 ss).
Un bilancio più equilibrato dovrebbe differenziare. Per quanto sia opi-nione prevalente in dottrina che la posizione del tribunale in materia diretroattività fosse debole (gli autori che, come Gustav Radbruch, sostene-vano che in un ordinamento giuridico come quello internazionale, in cuimanca un codice di leggi, il divieto di retroattività non può trovare appli-cazione, sono rimasti in minoranza), va riconosciuto che i giudici e l’ac-cusa si guardarono bene dal negare la validità del principio nullum cri-men sine lege nel diritto internazionale. Il pubblico accusatore RobertJackson argomentò piuttosto che gli imputati avevano violato in modo cosìgrave il diritto da aver pregiudicato la possibilità di appellarsi a quel prin-cipio. Dietro a quella affermazione stava il riconoscimento che in una fasedi rivoluzione dell’ordinamento giuridico internazionale, in cui a seguitodi una netta regressione degli standard di civiltà giuridica si voleva stabi-lire un nuovo inizio, il diritto consuetudinario e il diritto convenzionaledebbono essere sottoposti alla verifica di princìpi superiori. In positivo nonsi dovrebbe sottovalutare il fatto che sotto il profilo simbolico, nonostantel’atmosfera piuttosto burocratica in cui si svolsero i dibattimenti, il proces-so ebbe un notevole impatto sull’opinione pubblica internazionale.
Analoghe considerazioni, con qualche attenuazione per quanto con-cerne l’interesse internazionale, valgono per il processo che si tenne aTokio davanti all’International Military Tribunal for the Far East (IMTFE):anche in questo caso un processo che si doveva fare54, per quanto al paridel precedente problematico nelle sue basi giuridiche e nella modalitàd’instaurazione. A differenza del tribunale di Norimberga, quello di Tokionasce sulla base di un atto unilaterale della potenza occupante america-
54 Si veda il giudizio di Bert Röling, uno dei membri della Corte che espresse un’opinionedissenziente , in Röling/Cassese 1993, p. 86: «I am still convinced that the Trial was a kindof milestone in legal development, and the attitude on which the judgements were based isabsolutely necessary in an atomic era».
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
36
na, senza preliminare consultazione degli Alleati55. Anche dal punto divista procedurale, se si prescinde dalla più ampia composizione (e dallemaggiori garanzie d’imparzialità) della Corte, esso presenta una mag-giore dipendenza dalla volontà politica del vincitore, come documentatogià dal fatto che non vi hanno luogo preliminari dibattiti tra accusa e dife-sa56. Nel processo di Tokio nessuno degli imputati si trincera dietro l’ar-gomento dell’esecuzione di un ordine superiore (andava tutelata la sacra-lità dell’imperatore), ma anche qui si afferma il principio che gli individuihanno doveri che trascendono la loro obbligazione nazionale57. Lontanadai riflettori della vecchia Europa, la giustizia internazionale dell’EstremoOriente risente più fortemente dei condizionamenti dell’amministrazionemilitare, preoccupata di una chiusura dei conti rapida e senza strascichi.All’ombra di Hiroshima e Nagasaki un’enfasi eccessiva sarebbe statainopportuna. Paradigmatico di quello scenario è il processo a Yamashita,esemplare per la severità con cui un capo militare, di cui non era statadimostrata la responsabilità nell’ordinare le atrocità, è stato punito58.
A pesare sul bilancio della giustizia dei vincitori resta comunque – edè questo sicuramente l’aspetto che più ha compromesso l’eredità di queiprocessi e mostrato gli insormontabili limiti di una giustizia militare post-bellica – il fatto che sulla questione dei crimini commessi dagli alleati, coni bombardamenti delle città e delle popolazioni civili e in particolare conle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, fu per statuto interdetto altribunale indagare59. Sotto questo profilo occorre riconoscere che la
55 Cfr. Minear 1971, p. 20: «Long negotiations among the Big Four at the LondonConference had produced the Nuremberg Charter. No similar conference preceded the pro-mulgation of the Tokyo Charter. Instead, the Tokyo Charter was an executive decree ofGeneral Douglas Mac Arthur … The Charter itself had been drawn up by Americans, pri-marily by Chief Prosecutor Joseph B. Keenan. America’s allies were consulted only after thecharter had been issued». Ma la Carta di Norimberga offre il modello.
56 Ahlbrecht 1999, pp. 103-23. La differenza di cultura e sistema politico tra il Giappone(«a system of palace politics») e gli Stati Uniti o l’Europa rendeva in questo caso particolar-mente necessaria la presenza di un giudice giapponese nella Corte: cfr. Röling/Cassese1993, p. 87.
57 Röling/Cassese 1993, p. 107. 58 Cfr. Lael 1982. Ma anche Taylor 1970, p.91 ss, Röling/Cassese 1993, p. 85, Ahlbrecht
1999, p. 122.59 Cfr. Maser 1977, p. 522 ss. Per una rassegna dei crimini alleati in Europa v.Seidler/de
Zayas 2002, p. 55 ss.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
37
seconda guerra mondiale ha esemplificato in modo tragico una correla-zione che ad ogni considerazione realistica della storia non dovrebbesfuggire: il fatto cioè che, in presenza di pandemie di violenza, la vendettaprecede e spesso ancora accompagna la resa dei conti giudiziaria.Quest’ultima, a voler considerare le cose con il necessario disincanto,costituisce anche una legittimazione ex post di quelle azioni di vendetta.
Come è noto, il caso tedesco resta il piùindagato e il più significativo per far lucesulle questioni che interessano in questepagine, e che riguardano le modalità di una
resa dei conti giudiziaria con un passato politico criminale, il ruolo chequesta svolge nei processi d’integrazione di una nazione provata da un’e-sperienza totalitaria e bisognosa di ridefinire la sua identità, le ricadutesulla cultura politica del paese e la configurazione dei cleavages che laconnotano. Non è un caso che la letteratura sui processi di Norimbergasia incomparabilmente più ampia di quella sul processo di Tokio. I volumiche documentano il processo dell’IMT nei confronti degli Hauptverbrecherapparvero in rapida successione nelle diverse lingue processuali, mentrela documentazione su Tokio è rimasta a lungo poco accessibile alla con-sultazione60. Anche per quanto riguarda i processi sui crimini nazisti chehanno avuto luogo davanti a tribunali tedeschi nel dopoguerra si disponedell’eccezionale raccolta a cura di Adelheid Rüter-Ehlermann e ChristiaanF. Rüter, che è giunta nel frattempo al 34° volume61.
Che cosa determina l’unicità, anche sotto il profilo del diritto penale,del caso tedesco? Il fatto che vi sia stata la volontà internazionale di farluce e, almeno nei primi anni, anche la volontà di punire, il che non è statopossibile, o non è stato voluto, nei confronti di altri casi di macrocrimina-
60 Cfr. l’ed. tedesca: Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem InternationalenMilitärgerichtshof Nürnberg 14. November 1945 – 1. Oktober 1946, Nürnberg 1947-49.Telford Taylor, il rappresentante americano dell’accusa a Norimberga, aveva progettatoanche l’edizione tedesca dei Nachfolgeprozesse, ma il progetto non fu realizzato per man-canza di finanziamenti e disinteresse ormai del governo americano: Brochhagen 1994, p.27.
61 Rüter-Ehlermann/Rüter 1968-2005.
2. 3. L’«UNICITÀ» DEL CASO TEDESCO
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
38
lità politica. Di conseguenza, anche il fatto che per cinque decenni l’im-magine che di sé si sono fatti i tedeschi (e che è stata percepita dalle altrenazioni) è stata plasmata dall’elaborazione giudiziaria del passato62.L’occupazione ha reso possibile un esperimento di resa dei conti con ilpassato che non ha precedenti e non ha eguali nella storia. Che questoesperimento sia stato spesso considerato fallito alla luce delle ragionipragmatiche che rapidamente indussero le potenze occupanti (occidenta-li) a fare marcia indietro e a progressivamente temperare la radicalità deiloro intenti, accettando progressivamente la domanda di amnistia cheveniva da gran parte della società tedesca, non toglie evidenza al fattoche l’esito è stato positivo per quanto concerne la nascita e il consolida-mento della democrazia di Bonn. Non può sorprendere pertanto che suquesto tema sia cresciuta negli anni un’enorme letteratura, che la riunifi-cazione, riproponendo la questione della resa dei conti con i crimini poli-tici di una dittatura, ha contribuito a rinfocolare63.
Occorre tenere presente che anche la strumentario analitico concer-nente questi problemi è ormai largamente tributario del lessico scientificotedesco (i cui termini sono spesso di difficile traduzione in altre lingue):neologismi come Geschichtspolitik, Erinnerungspolitik, Vergangenheitspo-litik, Geschichtsaufarbeitung, e soprattutto Vergangenheitsbewältigungsono ormai entrati a far parte del linguaggio specialistico. A definire ilconcetto di Vergangenheitsbewältigung concorrono quattro elementi: laconoscenza di quello che è accaduto, parametri morali e giuridici per lavalutazione di quanto è accaduto, la solidarietà nei confronti delle vittimee la volontà che quanto è accaduto non si ripeta64. Da ciò risulta che ilsuperamento del passato è un processo di lungo periodo che la società
62 König 2003, p. 167 ss. 63 Cfr. Friedrich 1983 e 1994, Giordano 1987, Kielmannsegg 1989, Henke/Woller 1991,
Brochhagen 1994, Herbert/Groehler 1995, Frei 1996, Herf 1997, Heydemann/Jesse1998, Freudiger 2002, Weinke 2003, König 2003, Cornelissen/Klinkhammer/Schwentker2003, Miquel 2004, Frei 2005.
64 Così una definizione dello storico israeliano Michael Wolffsohn, cit. in Brochhagen1994, p. 11: «Zur Vergangenheitsbewältigung gehören Wissen, Werten, Weinen, Wollen,als vier Ws. Wissen, was geshah. Das Werten der Taten als Untaten. Das zumindest symbo-lische Weinen über die Opfer. Das Wollen eines anderen, als besser und moralischer emp-fundenen Allgemeinwesens».
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
39
interessata dai crimini, in particolare la società o il gruppo sociale a cui icrimini debbono essere imputati, deve attraversare per riaffermare la pro-pria identità collettiva di soggetto moralmente oltre che giuridicamentericonosciuto dalla comunità delle nazioni. Quasi dialetticamente, laVergangenheitsbewältigung presuppone il momento della punizioneimposta dall’esterno (a differenza degli individui, le società non conosco-no impulsi masochistici autopunitivi – o meglio, li conoscono, ma sannocontenerli) e il momento della rimozione che cresce dall’interno e si auto-legittima rivendicando un diritto allo sgravio dal passato.
La storia tedesca esemplifica, con qualche variante di decisiva impor-tanza, questa dialettica della negazione e del ritrovamento di sé. Il primomomento è rappresentato da quello che i contemporanei e poi la storio-grafia hanno definito processo di «denazificazione». A costituirlo inter-vengono la dura disciplina dell’occupazione e le misure di punizione deicolpevoli – che comprendono un’ampia gamma che va dal semplice inter-namento cautelativo ai procedimenti giudiziari. Ma esso è caratterizzatoaltresì da un precoce e lungimirante investimento nella nuova democraziache si va ad instaurare sulle macerie della dittatura. Negli anni dell’occu-pazione si intrecciano infatti tre componenti: i processi alleati ai criminalidi guerra (le cui basi sono poste dalla legge sul Consiglio di controllo nr.10 del 1945), le misure amministrative di epurazione (la Entnazifizierungin senso stretto) e i provvedimenti finalizzati alla reeducation. La fase delladenazificazione può considerarsi compiuta con la fine del 1948, quandogli alleati sono costretti a constatare che senza la riabilitazione della mag-gioranza dei funzionari epurati il paese rischia di precipitare nel caos enell’ingovernabilità. Dalla storiografia questa fase è prevalentemente giu-dicata fallimentare, almeno per quanto riguarda le procedure di epura-zione65: e senza dubbio il fallimento è particolarmente clamoroso nell’am-bito dell’amministrazione della giustizia, dove gli alleati si trovano benpresto davanti al dilemma di rimangiarsi le epurazioni o di capitolare difronte al dilagare della criminalità indotta dal mercato nero, deviandocosì dalla linea dura adottata nel Juristenprozess di Norimberga66.
A fronte delle nuove minacce della guerra fredda, americani e britan-
65 Vollnhals 1991.66 Miquel 2004, p. 23 ss.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
40
nici non tardano ad adottare, già all’inizio del 1947, una politica di cle-menza. La svolta decisiva arriva nell’autunno 1949, anche in relazionealle pressioni del nuovo governo tedesco. Nel 1953 l’«Interim MixedParole and Clemency Board for war criminals in American custody» (com-posto da 3 americani e 2 tedeschi) accelera (imitato da britannici e fran-cesi) i rilasci. Quando con la restituzione della sovranità (5.5.1955) s’in-sedia un nuovo comitato paritario, il «Mixed Board for War Criminals» (3tedeschi e 3 rappresentanti delle potenze occupanti), i prigionieri britan-nici a Werl e francesi a Wittich sono già stati tutti liberati e a Landsbergrestano solo 45 prigionieri (gli ultimi 4 saranno liberati il 9.5.1958).Restano i prigionieri di Spandau (ma per ragioni di salute sono dimessiNeurath 1954, Raeder 1955 e Funk 1957). Già dalla fine del 1945 i tri-bunali tedeschi erano stati autorizzati dagli alleati a processare conna-zionali per crimini contro tedeschi e apolidi; dal 1950 l’autorizzazione siestende a tutti i crimini nazisti, anche a quelli commessi contro gli alleati.
Dopo l’esperienza traumatica e, come si è detto, per certi versi falli-mentare, della denazificazione operata dalle potenze occupanti, si affer-ma in Germania il desiderio di normalizzazione, che trova elaborazioneideologica nella tesi che al periodo di legittima resa dei conti con i gran-di criminali tedeschi deve far seguito una chiusura dei conti con il passa-to, per scongiurare l’eventualità che la nascente democrazia venga tra-volta dall’insorgere di una guerra civile fredda. Questo della volontà dichiudere i conti è il secondo passaggio, che in anni recenti è stato defini-to «politica del passato», del cammino percorso dalla società tedesca(occidentale) nel dopoguerra. Con questo termine si designa quel proces-so politico, sostenuto da un ampio consenso sociale, che nei primi anni divita della BRD consente alla società di riaffermare il proprio diritto adautogovernarsi senza essere schiacciata dal peso del proprio passato.Amnistia, integrazione ed emarginazione ne sono le direttrici: amnistiageneralizzata nei confronti di un passato che si vuole ormai lontano, inte-grazione dell’esercito di fiancheggiatori (ma non solo di essi), emargina-zione di quei gruppi ancora ideologicamente legati al nazionalsociali-smo67. Elementi tra loro concatenati, perché solo la scelta di chiudere i
67 Frei 1996, pp. 13-4.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
41
conti con il passato consentiva l’avvio di una politica di reintegrazione chenon andasse troppo per il sottile (prendendo ormai le distanze dalle tipo-logie imposte con la denazificazione) e di una politica di esclusione dallavita democratica di quei soggetti che si rifiutassero di considerare conclu-sa la guerra civile ideologica che aveva portato la Germania alla cata-strofe.
Caratteristica precipua di questa fase è lo smantellamento dei disposi-tivi punitivi della denazificazione. Il governo tedesco non riconosce la vali-dità dei verdetti alleati, per cui nei documenti ufficiali si continua a parla-re non di criminali di guerra ma di Kriegsverurteilten (condannati per cri-mini di guerra), di sog. Kriegsverbrechern (cosiddetti criminali di guerra)o addirittura di politische Gefangene (prigionieri politici) (Brochhagen1994, p. 19). Le negoziazioni tra tedeschi e alleati nei primi anni cin-quanta hanno in questa materia come oggetto principale proprio la revi-sione delle sentenze dei processi alleati sui criminali di guerra68. I tribunalitedeschi poi, anche nelle zone d’occupazione occidentali, soprattutto conla recuperata sovranità, si rifiutano di applicare il diritto degli alleati e sirichiamano in maniera sempre più esplicita alla tradizione giuridicanazionale69. Le indagini giudiziarie sui crimini nazisti vengono pratica-mente accantonate per dar corso all’amnistia de facto della prescrizionedei reati. Si è parlato a ragione per questa fase di «amnistia fredda».Rispetto ad una stima di 200-250.000 tedeschi (e austriaci) coinvolti nel-l’organizzazione e nell’esecuzione dello sterminio degli ebrei europei (edelle altre minoranze), per alcune decine di migliaia dei quali esistevanoi presupposti concreti per un’incriminazione, i tribunali tedesco-occiden-tali pronunciarono non più di 500 condanne70. Anche a considerarlo nellaprospettiva del lungo periodo, il bilancio della giustizia tedesca sui crimi-ni nazisti appare gravemente inadeguato: dalla fine della guerra al 1992i pubblici ministeri hanno dato inizio a 103.823 procedimenti: da questisono risultate solo 6.487 condanne, 13 a morte, 163 all’ergastolo, 6.197ad altre pene detentive (Kochavi, pp. 242-47).
68 Brochhagen 1994, p. 19. 69 Weinke 2002, p. 335.70 Cfr. Miquel 2004, p. 11.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
42
In questi anni maturano anche nell’opinione pubblica le giustificazionidella rimozione, in particolare la tesi della sua necessità per la trasfor-mazione dei camerati nazisti in cittadini democratici71. La pressione con-giunta di questa opinione pubblica e di una corporazione giudiziariacaratterizzata da forte continuità personale con il passato nazista, esostanzialmente passata indenne attraverso il processo di denazificazio-ne72, porta così rapidamente alla richiesta di reintegrazione delle «vittime»della denazificazione. La politica dei primi cinque anni di vita dellarepubblica, caratterizzata da alto consenso di tutte le forze politiche, unacerta sommarietà delle misure adottate e tempi accelerati della loro attua-zione (Frei 1996, p. 397), può così essere simbolicamente incorniciata dadue amnistie. La prima, del 31. 12. 1949, a fatica dissimula i caratteri diuna manovra fraudolenta: dichiarando di mirare ad una normativa checonsentisse di amnistiare reati prevalentemente di carattere economicocommessi nella situazione di tracollo di legalità dell’immediato dopoguer-ra (mercato nero etc.), reati per i quali erano previste pene di 6 mesi (eper i quali già si erano dati a livello dei Länder provvedimenti di amni-stia), si arrivava in realtà ad amnistiare tutti quei fiancheggiatori eMinderbelastete che nel dopoguerra avevano falsificato la loro identità osi erano dati alla macchia per sfuggire alle procedure di denazificazione(i cosiddetti Untergetauchten) nonché una folta schiera di individui impli-cati in crimini contro l’umanità73. Di questa legge al 31. 1. 1951 avreb-bero beneficiato ben 792.176 persone (e fra queste, anche in termini disospensione delle indagini, decine di migliaia di responsabili di crimininegli anni della dittatura nazista); mentre va detto che il fine di regolariz-zare gli illegali non sarebbe stato raggiunto (solo 241 si sarebbero avval-si della norma per uscire dall’illegalità), in quanto la maggior parte sape-va che non avrebbe potuto beneficiare dell’amnistia in relazione alla gra-vità dei crimini commessi (Frei 1996, pp. 50-52). L’atto aveva però unavalenza politico-simbolica molto forte, perché apriva la stagione della
71 Per una ricostruzione del dibattito poggiante su un’amplissima letteratura Frei 1996, p.8ss.
72 Cfr. B. Diestelkamp, Die Justiz nach 1945 und ihr Umgang mit der eigenenVergangenheit, in Diestelkamp/Stolleis, 1988, pp. 131-49, Miquel 2004, p. 371.
73 Frei 1996, p.29 ss.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
43
rimozione e dell’assoluzione del passato; ad essa avrebbe fatto seguito ilprogressivo smantellamento dei risultati del processo di denazificazione,con la riabilitazione della burocrazia e dell’esercito e con la legge d’am-nistia del 17. 7. 1954, che condonava reati commessi tra il 1. 10. 1944e il 31. 7. 1945 e punibili fino a 3 anni.
Sarà soltanto con la Blutrichter-Kampagne orchestrata nel 1957 dallaDDR con finalità di autolegittimazione, l’Einsatzgruppen-Prozess di Ulmdel 1958 e con l’istituzione nel 1958 della «Zentrale Stelle derLandesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen» inLudwigsburg che il terzo momento della Vergangenheitsbewältigung pren-derà il suo corso nelle istituzioni e nella società civile74. Con la mostra«Ungesühnte Nazijustiz» organizzata nel 1959 da studenti politicamenteimpegnati, il film di Wolfgang Staudte Rosen für den Staatsanwalt, gliscandali intorno ad una amministrazione che era rimasta in buona misu-ra nelle mani di funzionari legati al passato regime (il che consentiva allaDDR di denunciare propagandisticamente la BRD come «Staat desJustizmordes und der Justizmörder»75) si avvia la genesi di una sfera pub-blica critica. Negli anni ’60 sarà il convergente impatto del processoEichmann a Gerusalemme (1961-62) e del primo Auschwitzprozess aFrancoforte (1963-65) a far compiere un salto di qualità alla presa dicoscienza dei crimini della recente storia tedesca e a porre le premesseper una «politica della memoria» e per la rivolta delle giovani generazio-ni. Non è un caso ad ogni buon conto che, ancora una volta, fossero statieventi di natura giudiziaria a indirizzare il corso della Vergangenheits-bewältigung.
A paragone della praticamente generaliz-zata impunità dei crimini della prima guerramondiale, e ad onta della riluttanza della magi-stratura tedesca a processare propri concittadi-
ni, il bilancio della giustizia penale a conclusione della seconda, perquanto incommensurabile alla gravità dell’accaduto, si presenta piuttosto
74 Frei/van Laak/Stolleis 2000, p. 19. 75 Così in un libello di Albert Norden, cit. in Miquel 2004, p. 29.
2. 4. IL SILENZIO DELLA GIUSTIZIA
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
44
imponente. Se si prescinde dai dati relativi a processi e condanne nei ter-ritori occupati dai sovietici (su cui non esistono attendibili statistiche), sipuò ricordare che americani, britannici e francesi mettono sotto processo,a Norimberga e in altri tribunali (in Germania), circa 5.000 individui,comminando poco meno di 800 condanne a morte, di cui quasi 500 ese-guite (a cui vanno aggiunti processi e condanne in altri paesi: Italia,Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Olanda, Norvegia)76. Quellache emerge così non è però che la punta dell’iceberg, che dà solo som-mariamente un’idea dell’enormità dei crimini commessi. La più parte diessi è rimasta sommersa, per cui meriterebbe di essere soppesata sull’al-tro piatto della bilancia la quantità di istruttorie che vennero insabbiate edi processi che non ebbero luogo.
A contrastare con lo scenario tedesco è innanzitutto proprio il caso ita-liano, dove l’eredità sotto il profilo criminale assai meno pesante della dit-tatura fascista e il lascito politicamente esplosivo di una situazione di guer-ra civile fa maturare rapidamente la domanda di amnistia (anche se nonuna cultura della riconciliazione). Non è un caso, del resto, che soltantoin anni recenti la letteratura storiografica nazionale, debitamente pungo-lata da fondamentali contributi tedeschi77, abbia iniziato a scandagliare ilproblema del perché il capitolo dei crimini di guerra del nostro paese nonsia mai stato seriamente affrontato e abbia ricostruito la vicenda dellamancata Norimberga italiana nelle sue motivazioni interne e internazio-nali78. Solo a cinquant’anni di distanza il tragico bilancio della criminalitàpolitica del ciclo totalitario che ha attraversato la storia del Novecento hacominciato ad assumere contorni precisi anche per la metà dell’Europache non era stata lambita dalla seconda ondata della democratizzazione.
A prescindere dalle varianti nazionali, è comunque un fatto che la
76 Una sintesi complessiva sull’Europa è ora fornita da Frei 2005.77 Nel corso degli ultimi due decenni, sulla base dei risultati conseguiti dalla letteratura
sulla elaborazione giudiziaria del proprio passato nazionale, la storiografia tedesca haassunto un ruolo di guida anche nella ricerca sulle «politiche del passato» di altre nazionieuropee, a cominciare dalla Francia e dall’Italia. Sul caso italiano, va segnalato in partico-lare il volume di Woller 2004. Sulla Francia Moisel 2004, Urselmann 2000 ; v. anche H.Rousso, Juger le passé? Justice et histoire en France, in Brayard 2000, pp. 261-87.
78 Battini 2003, Focardi 2000 e Id., I mancati processi ai criminali di guerra italiani, inBaldissara/Pezzino 2005, pp. 185-214. Inoltre Schreiber 1996.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
45
guerra fredda ferma in Europa il processo di elaborazione giudiziariadella storia – o meglio ridimensiona fortemente nelle élites politiche l’inte-resse a condurre alla sbarra gli ormai inoffensivi nemici di ieri. Gli allea-ti cedono, come si è detto, alla domanda di amnistia dei tedeschi, preoc-cupati di garantirsi un docile alleato e una testa di ponte sulla fragile giun-tura europea. Nell’area di dominio sovietico la giustizia dei vincitori cono-sce un’estremizzazione, in quanto i conti con il passato vengono fattiricorrendo a quei metodi della giustizia politica totalitaria che erano statisperimentati in Unione Sovietica soprattutto negli anni delle «purghe» sta-liniane. Ma anche negli Stati Uniti si assiste a un’ondata di processi poli-tici che sfidano i princìpi del rule of law e contribuiscono a gettare cattivaluce sull’elaborazione giudiziaria della storia79. I veti incrociati, le conve-nienze e la controversa evoluzione del diritto internazionale sulla base delprecedente di Norimberga creano poi le condizioni per il declino dellagiurisdizione internazionale. I vincitori non hanno più interesse ad usareuno strumento che facilmente può essere ritorto contro di loro. I vinti, dal-l’altra parte, o i non allineati, restano diffidenti nei confronti di uno stru-mento che si è realizzato come giustizia dei vincitori. In quest’arco ditempo vale poi quanto un internazionalista, Georg Schwarzenberger,amava ripetere a proposito della Convenzione sul Genocidio: «theConvention is unnecessary when applicable and inapplicable when neces-sary»80.
Con la fine della seconda guerra mondiale si pone per la prima voltala questione della competenza universale dei tribunali in materia di crimi-ni contro l’umanità (Peyró Llopis 2003, p. 109): ma nei decenni seguenti,anche nelle democrazie più consolidate, il potere giudiziario sarà estre-mamente timido nell’esercitare questa sua competenza. Sarà ancora unavolta un procedimento giudiziario a cui si arriva a prezzo di una viola-zione del diritto internazionale a segnare, con il suo esorbitante valoresimbolico, un nuovo inizio. È infatti con il processo ad Adolf Eichmann cheil principio di giurisdizione universale in materia di crimini internazionali
79 Non è un caso che l’opera classica sulla giustizia politica di Otto Kirchheimer dedichiun’ampia parte non solo alla trattazione dei processi-farsa dei regimi totalitari ma anche aiprocessi politici negli Stati Uniti negli anni della guerra fredda: cfr. Kirchheimer 1981.
80 Cit. in Shabas 2000, p. 544.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
46
trova la sua prima clamorosa affermazione. Nella sua sentenza del 29maggio 1962 la Corte suprema di Israele affermava: «Non soltanto tutti icrimini attribuiti all’imputato hanno carattere internazionale, ma i loroeffetti feroci e sanguinari sono stati così diffusi ed estesi da scuotereprofondamente, nelle sue fondamenta, la comunità internazionale nel suoinsieme. Lo Stato di Israele ha dunque il diritto, secondo il principio di giu-risdizione universale, agendo come guardiano delle norme internaziona-li e come organo della loro attuazione coercitiva, di giudicare l’imputa-to»81.
Come, a partire dagli anni ’60, si avvia a livello nazionale inGermania un processo di elaborazione del passato che rimette in discus-sione la mentalità del colpo di spugna degli anni ’50, così a livello inter-nazionale, spronata dal movimento pacifista che leva la sua voce controla guerra del Vietnam, nasce progressivamente un’opinione pubblicamondiale che s’interroga criticamente sull’eredità della seconda guerramondiale. Sul piano istituzionale essa si esprime nell’attività normativadell’ONU e in tutti i documenti internazionali sui diritti dell’uomo, i crimi-ni contro l’umanità, le politiche di discriminazione razziale e la tortura, incui i princìpi di Norimberga trovano comunque ulteriore elaborazione82.Uno degli ambiti di maggior successo di questo attivismo dei soggettisovranazionali sarà la lotta contro l’apartheid in Sudafrica. Ma nel com-plesso l’Onu deve anteporre l’interesse della pace a quello della giustizia.Anche la Convenzione sul Genocidio non apre la via alla giurisdizioneuniversale, anzi la esclude esplicitamente: in caso contrario, le tensioni tragli stati sarebbero diventate destabilizzanti83.
È piuttosto la lenta e segmentaria formazione di una società civile mon-diale a creare le condizioni per quell’espansione del potere giudiziarioche si sarebbe dispiegata più tardi e con la fine della guerra freddaavrebbe dato i suoi frutti politici anche nella crescente istituzionalizzazio-
81 Cit. in Cassese 2004, II, p. 107. Sul processo ad Eichmann v. Yablonka 2004 e Douglas2001, p. 95 ss.
82 Cfr. Ahlbrecht 1999, pp.124-226. 83 Röling/Cassese 1993, p. 95. La posizione di Röling è prudente, la Convenzione sul
genocidio statuisce uno standard morale esposto a strumentalizzazioni politiche: «if you pur-sue justice single-mindedly, then there will be no peace in the world» (96).
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
47
ne di «commissioni verità» chiamate a far luce sui crimini politici delrecente passato84. In questa fase nascono i Tribunals of Opinion, i tribunalimorali della società civile o dei popoli. Nel 1966 Bertrand Russell creauna commissione, presentata come «International War Crimes Tribunal»,per indagare sui crimini di guerra americani in Vietnam, chiamando afarne parte intellettuali e politici come Günther Anders e Jean- Paul Sartre,Vladimir Dedijer e Simone de Beauvoir, Isaac Deutscher e LaurentSchwartz, Lelio Basso e Lawrence Daly, Lazaro Cardenas e Mahmud AliKasuri. I processi che seguono a Stoccolma e a Copenhagen hanno ungrande impatto sull’opinione pubblica mondiale. Fra i capi d’accusa, ilcrimine di aggressione, crimini di guerra, fra cui la sperimentazione dinuove armi, la tortura e «the pursuit of genocidal policies» (Russell 1967,p. 126). Nel maggio 1967 il tribunale sentenzia che gli Usa sono colpe-voli di 3 crimini internazionali: guerra di aggressione contro il Vietnam,violazione della sovranità, integrità territoriale e neutralità dellaCambogia, crimini di guerra (bombardamento sistematico di obbiettivicivili). Sette mesi più tardi il catalogo verrà esteso all’aggressione controil popolo cambogiano, sperimentazione di armi illegali, trattamento disu-mano dei prigionieri di guerra e delle popolazioni civili, genocidio neiconfronti del popolo vietnamita85.
Nell’opinione pubblica internazionale, con i crimini di guerra nelVietnam gli Stati Uniti perdono il ruolo di giudici per assumere quello diaccusati. «As the principal sponsor, organizer and executant of theNuremberg trials, the United States is more deeply committed to their prin-
84 Non si può dar conto qui dell’enorme letteratura sulla società civile transnazionale o glo-bale o mondiale che si è sviluppata in questi ultimi decenni. Si vedano M. Kaldor,Transnational civil society, in Dunne/Wheeler 1999, pp. 195-213 e i saggi raccolti inBaker/Chandler 2005.
85 Cfr. S. B. Willson, Bob Kerrey’s Atrocity, the Crime of Vietnam and the Historic Patternof US Imperialism, in Jones 2004, pp. 164-80. A questo hanno fatto seguito, negli anni set-tanta, un secondo tribunale Russell sulle repressioni e sui crimini internazionali in Americalatina, il War Crimes Tribunal on Central America and the Caribbean, che nel 1984 avreb-be presentato un rapporto all’United Nations Center for Human Rights, e analoghe iniziati-ve statunitensi sui crimini in Vietnam: the National Veterans’ Inquiry (1970), the WinterSoldier Investigation (1971), the Dellums Ad Hoc Committee Hearings on U. S. War Crimesin Vietnam (1971). Cfr. Ramshaw/Steers 1987.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
48
ciples than any other nation» (Taylor 1970, p. 14). Di conseguenza, in piùoccasioni, i tribunali americani si sono dovuti confrontare con crimini diguerra di propri connazionali commessi nel Vietnam e con l’ereditàingombrante di Norimberga86. La convinzione, tipica del resto di unapotenza imperiale, di trovarsi impegnati in quel conflitto per le ragionidella perdurante battaglia epocale delle democrazie contro i regimi tota-litari, ha legittimato tuttavia anche in questo caso l’autoimmunizzazioneda ogni (anche solo ipotetica) giustizia penale internazionale. E nondi-meno le violazioni dei princìpi stabiliti dallo Statuto di Londra (e configu-ranti crimini internazionali) sono apparse evidenti. Blechman e Kaplanhanno elencato, tra il 1.1.1946 e il 31.10.1975, 216 casi in cui gli StatiUniti hanno fatto uso della forza militare anche solo a fini d’intimidazio-ne. Ora, poiché la Carta, all’art. 2, proibisce sia l’uso che la minacciadella forza e, all’art. 39, fa una distinzione (voluta in particolare daisovietici) tra threats to the peace, breaches of the peace e acts of aggres-sion (interpretando questi ultimi come atti che possono non implicare com-battimenti), ne consegue che vanno considerate in contrasto con il dirittointernazionale le tattiche della diplomazia coercitiva impiegata dagli Usanella più parte di quei 216 casi87.
Davanti a queste violazioni, in assenza di un competente tribunalepenale internazionale, si è levata nella comunità mondiale solo la voce deitribunali morali delle cittadinanze. Essi hanno svolto un ruolo di denunciae anche un ruolo propulsivo sul cammino che ha portato alla giurisdizio-ne penale internazionale degli anni ‘90. Con il senno di poi, si può anzisostenere che essi sono stati il pungolo che ha costretto le istituzioni sovra-nazionali a colmare una lacuna che si era ormai fatta intollerabile. Diquesti tribunali va però anche detto che non hanno giuridicamente la legit-timità e i poteri di organi creati da Stati o da trattati internazionali, noncreano diritto internazionale e le loro sentenze non sono vincolanti né pergli individui né per gli Stati88. «International citizens’ tribunals help toenhance participatory democracy and universal jurisdiction, and are an
86 Per un processo esemplare cfr. Solis 1997.87 Cfr. Röling/Cassese 1993, p. 101.88 Beigbeder 1999, pp. 137-45. Inoltre Fischer-Lescano 2005, p. 154 ss.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
49
effective means of holding major powers to account»89. A loro detrimentooperava negli anni della guerra fredda il sospetto di una loro ideologicaparzialità, avendo indirizzato le loro indagini contro il neo-imperialismooccidentale, non contro i paesi socialisti90. Ad analoghe politicizzazioni edi conseguenza al pericolo di strumentalizzazioni essi restano espostianche nell’attuale mondo imperfettamente unipolare (con crescenti ten-denze centrifughe).
Le novità per il diritto penale internazio-nale arrivano con gli anni ’90, anche se nonin seguito alla prima operazione militare
condotta sotto l’egida dell’Onu contro l’invasione irakena del Kuwait, perquanto questa configurasse le tre tipologie di crimini definite dallo Statutodell’IMT e si fosse sviluppato un modesto dibattito sull’opportunità di unprocesso internazionale per accertarne i responsabili. Il Consiglio diSicurezza ha piuttosto istituito con le risoluzioni 687 e 692 la UnitedNations Compensation Commission preposta all’amministrazione di unfondo per la riparazione dei danni al Kuwait (Ahlbrecht 1999, p. 231), ilche ha comunque costituito un precedente a cui si sarebbe richiamato ilSegretario dell’Onu contro l’argomento che la Carta non autorizza a legi-ferare (e quindi neppure alla creazione di tribunali). Anche dopo laseconda guerra del Golfo, che ha abbattuto il regime dittatoriale irakeno,l’ipotesi di un tribunale internazionale, come è noto, è stata scartata perprivilegiare quella di un processo nazionale.
La svolta è segnata invece nel 1993 dall’istituzione dell’ICTY, con larisoluzione 827 del Consiglio di Sicurezza, che ha fondato la sua com-petenza sull’argomento che, a fronte dei tanti moniti andati a vuoto, solo
2. 5. UN NUOVO INIZIO?
89 Cfr. A. J. Klinghoffer, International Citizens’ Tribunals on Human Rights, in Jones 2004,pp. 346-60 (qui p. 358), Id./Klinghoffer, J. A., 2002, International Citizens’ Tribunals:Mobilizing Public Opinion to advance Human Rights, Palgrave, New York. «Since such a tri-bunal is an alternative institution, with no power to see that its judgements are carried out,its power lies mostly in its ability to publicize the evidence and its findings in an attempt toappeal to public opinion and conscience at home and abroad» (Ramshaw/Steers 1987, p.XIX).
90 Beigbeder 1999, p. 144.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
50
la minaccia realistica di un’azione penale poteva servire la causa dellapace91. Con l’istituzione del tribunale, il Consiglio di Sicurezza, avvalen-dosi degli art. 29 e 7.2 della Carta, ha fatto uso, per quanto la cosa fossecontroversa92, di un proprio diritto d’organizzazione sovranazionalecome misura per garantire la pace. Preoccupazione primaria della comu-nità internazionale era evitare di venirsi a trovare, a conflitto concluso, inuna situazione che potesse essere paragonata alla «giustizia dei vincito-ri» della seconda guerra mondiale. A questo stadio di evoluzione del siste-ma giuridico internazionale alcuni presupposti ancora assenti all’indoma-ni di quella erano per altro dati: una consensuale definizione dei criminiinternazionali era entrata a far parte del diritto comune delle nazioni (siapure con le difficoltà di cui ora si dirà), mentre il diritto penale interna-zionale aveva in parte superato l’originario squilibrio dovuto all’assenzadi un corpus di norme secondarie che disciplinasse la punibilità della vio-lazione delle norme primarie (Zappalà 2005, p. 18).
La specifica modalità d’istituzione di questi organi sussidiari delConsiglio di Sicurezza, che non detiene un potere legislativo, aveva comeinevitabile conseguenza non solo la limitazione della loro competenza(che ha condizionato la loro capacità di svolgere indagini anche su even-tuali crimini di guerra della Nato) ma anche, pena l’inoperatività, il rico-noscimento di ampi margini di autonomia e creatività ai giudici. Anchenelle istituzioni sovranazionali il vacuum di potere legislativo non può cheessere colmato o dal potere esecutivo o dal potere giudiziario.L’autonomia concessa ai giudici ha consentito un passo avanti significati-vo: con la sentenza sul «caso Tadic», nel 1995, la Camera d’Appello delTribunale per l’ex Jugoslavia ha stabilito che anche violazioni particolar-mente gravi del diritto umanitario commesse nel corso di un conflittoarmato non internazionale dovevano essere qualificate come crimini diguerra.
91 Ahlbrecht 1999, pp. 232-301, Beigbeder 1999, pp. 146-68.92 Contestando la facoltà del Consiglio di Sicurezza di legiferare, si è argomentato che l’i-
stituzione di un tribunale è una misura legislativa, che va oltre le sue competenze di ‘polizia’internazionale e non rientra nelle misure coercitive previste dall’art. 41 della Carta. Ma pre-vale l’opinione favorevole, che obietta che l’istituzione di un tribunale ad hoc non è unamisura di carattere primariamente legislativo (cfr. Ahlbrecht 1999, pp. 240-3).
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
51
Con la risoluzione 955, e procedura analoga al caso precedente, si èpoi istituito nel 1994 l’ICTR93. La marginalità di quest’ultimo, lontanodagli interessi dei custodi del diritto occidentale (come lontano era statol’evento del genocidio), non è sfuggita agli osservatori, e non a torto èstato riscontrato un parallelismo nei rapporti tra Norimberga e Tokio daun lato e L’Aja e Arusha dall’altro (Ahlbrecht 1999, p. 327). Come espe-rimento istituzionale, non vi è dubbio, l’ICTR è stato meno innovativo, inquanto, per ragioni di tempo e di costi organizzativi, si è recepita buonaparte del lavoro preparatorio già compiuto all’Aja. Nondimeno unanovità importante va segnalata: la sua istituzione è di particolare impor-tanza perché per la prima volta un tribunale penale internazionale vienechiamato ad occuparsi di crimini commessi nel corso di un conflitto infra-statale. Ciò non era stato ancora possibile per il genocidio armeno (solola Convenzione sul genocidio, il Trattato di Ginevra del 1949 e il II pro-tocollo aggiuntivo del 1977 lo avrebbero consentito), ma non era avve-nuto nemmeno per il genocidio cambogiano (Ahlbrecht 1999, p. 329).La dimensione del genocidio ruandese impartisce però una lezione nega-tiva sulla capacità di un organo giudiziario internazionale di perseguiretutti i crimini che abbiano luogo in società dilaniate dall’odio etnico edalla guerra civile. L’orientamento a perseguire soltanto i cosiddetti corecrimes, facendo per il resto ricorso ad altre misure politiche di compen-sazione delle vittime e di riconciliazione, evidenzia i limiti dello strumen-to giudiziario nella resa dei conti con un passato di macrocriminalitàsistemica.
Il bilancio di queste esperienze consente di parlare di un cammino evo-lutivo che si compie per graduali progressi. Se con la sentenza dell’ICTYdel 1995 ha trovato riconoscimento il principio che le norme sui crimini diguerra possono essere applicate anche in riferimento ai conflitti interni,con l’istituzione dell’ICTR si è dato vita ad un organo con esclusiva giuris-dizione su crimini commessi nel corso di una guerra civile priva di rilevantiimplicazioni internazionali94. Anche in questi casi, tuttavia, sono state
93 Ahlbrecht 1999, pp. 302-34, Beigbeder 1999, pp. 169-85.94 Cfr. Cassese/Chiavario/De Francesco 2005 ; S. Meseke, La contribution de la jurispru-
dence des tribuneaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda à la con-crétisation de l’incrimination du crime contre l’humanité, B. Lüders, L’incrimination de géno-
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
52
avanzate riserve sulla legalità delle procedure. Un internazionalista auto-revole come Heiko Ahlbrecht, ad esempio, non ha dubbi sul fatto che ilConsiglio di Sicurezza, istituendo tali tribunali, sia andato oltre il dirittopenale internazionale vigente, senza disporre per questo di un’autorizza-zione della Carta o dei membri delle Nazioni Unite. Inoltre, se le normesul genocidio configurano ormai un terreno acquisito, l’assenza di unaconvenzione internazionale di natura generale sui crimini contro l’uma-nità rende più problematica la giurisprudenza in materia, fornendo argo-menti a coloro che sostengono che anche questi tribunali continuano aviolare il divieto di retroattività (Ahlbrecht 1999, pp. 330-33).
La tappa ulteriore nel processo di codificazione del diritto penale inter-nazionale è costituita dall’approvazione dello Statuto dell’ICC, che rap-presenta il coronamento di uno sviluppo cui si è pervenuti sulla base degliormai decennali lavori della Commissione di diritto internazionale inse-diata dalla Carta dell’Onu. Il passo avanti è decisivo: mentre l’ICTY el’ICTR restavano tribunali istituiti extra ordinem ed ex post facto, e quindiin sostanza giurisdizioni commissarie in stato d’eccezione, ora si tratta diuna corte permanente la cui competenza non si limita ad una ristretta areageografica ma investe il territorio di tutti gli Stati che abbiano aderito alloStatuto95. A differenza dei precedenti piuttosto parchi, lo Statuto della ICCprevede ampie norme di parte generale e di procedura, svolgendo unruolo di codificazione di norme consuetudinarie che non ha precedenti neldiritto internazionale. Ma la materia controversa e i problemi aperti get-tano ombre preoccupanti sul futuro della sua giurisdizione.
Già durante i lavori della Conferenza di Roma non tarda ad emerge-re una serie di dissensi che divide su alcune questioni fondamentali i mem-bri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o almeno quelli di essi che sonoa pieno titolo “sovrani imperiali”, dal gruppo degli Stati “giustizialisti”
cide dans la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et leRwanda, in Chiavario 2003, pp.173-222 e 223-257.
95 Per la ricostruzione del cammino storico che ha condotto allo Statuto di Roma Ahlbrecht1999, pp. 335-90, Beigbeder 1999, pp. 186-99, Schabas, op. cit. in Bekou/Cryer 2004,p. 8 ss. Per un’analisi dello Statuto e delle prospettive Cassese/Gaeta/Jones 2002,Chiavario 2003, Bekou/Cryer 2004, Cassese/Chiavario/De Francesco 2005. Una sintesiessenziale in Zappalà 2005, pp. 89-111.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
53
guidati dal Canada96. Alla fine 120 Stati votano in favore, 7 contro (tracui Usa, Israele e Cina) e 21 si astengono (prevalentemente Stati arabi). Ilconcetto di guerra d’aggressione torna ad essere al centro dello scontro,non superato ma congelato con una soluzione di compromesso: lo Statutoriconosce la giurisdizione della Corte sul crimine di aggressione, ma nerimanda l’esercizio al giorno in cui si sarà pervenuti ad una definizioneconsensuale. Dalla Commissione insediata a Londra nel 1943 anche quel-la di Roma sembra aver ereditato le stesse incertezze. Come è stato auto-revolmente osservato, nulla garantisce che la clausola dell’art. 5. 2 rendail suo inserimento nello Statuto una mera questione di facciata97. Neldibattito sulla delimitazione della giurisdizione ratione materiae è poi pre-valsa la posizione di chi ha voluto escludere dalla competenza della Cortei crimini internazionali “minori”, o crimini transnazionali, come la pirate-ria, il mercenarismo, il traffico di essere umani, di armi e di droga, la ridu-zione in schiavitù, il terrorismo. Dopo l’11 settembre 2001 l’opportunitàdell’esclusione del terrorismo è stata rimessa in discussione dagli eventi:ma al momento è piuttosto improbabile che gli Stati siano indotti a intra-prendere altri passi su un cammino dagli esiti incerti.
L’ostacolo principale resta comunque il fatto che la ICC è «un foro giu-diziario internazionale, ma non un sistema globale di giustizia penaleinternazionale» (Bassiouni 1999b, p. 189). In termini generali, il dirittopenale internazionale può trovare attuazione secondo due modalità, cheBassiouni definisce direct/indirect Enforcement Model: il primo modelloopera attraverso l’instaurazione di organi giudiziari internazionali, ilsecondo attraverso l’applicazione di diritto penale internazionale mate-riale da parte di tribunali nazionali. Un sistema di esecuzione diretta pre-
96 Così le enumera Schabas, op. ult. cit., p. 16: «an inherent jurisdiction of the court overthe core crimes, the elimination of a Security Council veto on prosecutions, an independentprosecutor with the power to initiate proceedings proprio motu, prohibition of reservations tothe statute».
97 L’art. 5. 2 dello Statuto infatti recita: «The Court shall exercise jurisdiction over the crimeof aggression once a provision is adopted in accordance with articles 121 and 123 definingthe crime and setting out the conditions under which the Court shall exercise jurisdiction withrespect to this crime». Schabas op. ult. cit., p. 31: «there is no guarantee that its presence inarticle 5 (1) may only be pure symbolism»; cfr. anche, nello stesso volume, M. A. Shukri, WillAggressors Ever be Tried Before the ICC?, pp. 33-42.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
54
supporrebbe un livello di centralizzazione del sistema internazionaleparagonabile ad uno Stato federale mondiale. Poiché invece il regimegiuridico internazionale non è «un sistema giuridico sovra-nazionale,tranne per quanto gli Stati convengano di attribuire a certe istituzionicostituite a livello internazionale quella caratteristica»98, i soggetti interna-zionali devono ricorrere all’approccio di «esecuzione indiretta», che siestende alle sei modalità di cooperazione internazionale: estradizione,mutua assistenza giudiziaria, trasferimento dei detenuti, sequestro e con-fisca di proventi illeciti, riconoscimento di sentenze penali straniere, tra-sferimento dei procedimenti penali. Il modello dell’esecuzione indirettatrova la sua originaria fondazione nel principio, già riconosciuto daGrozio, dell’aut dedere aut iudicare: sugli Stati grava il dovere di dareesecuzione, secondo il diritto interno, agli obblighi che derivano dal dirit-to penale internazionale.
Ad avvicinarsi al modello dell’esecuzione diretta è stata la giustizia diNorimberga e Tokio: in questi casi le potenze occupanti controllavano ilterritorio e detenevano nelle loro mani gli accusati e il materiale probato-rio. Ma se si prescinde da questo esordio eccezionale, è evidente che losviluppo del diritto penale internazionale è affidato a soluzioni intermediee compromessi pragmatici: i tribunali penali internazionali rappresentanosolo in parte un sistema di esecuzione diretta, perché dipendono dallavolontaria cooperazione degli Stati. Anche la ICC, che avrebbe potutoessere modellata sull’IMT, deve fare assegnamento sulla cooperazionedegli Stati per lo svolgimento delle indagini, per la raccolta e la produ-zione delle prove, per l’arresto e la consegna degli imputati, per l’assi-stenza giudiziaria e per l’esecuzione delle sentenze. Data la perdurantenatura pluralistica del sistema internazionale, sostiene ancora Bassiouni,il «sistema ideale di esecuzione per il diritto penale internazionale è rap-presentato da una combinazione tra un sistema di esecuzione diretta,sotto forma di un tribunale internazionale permanente, piuttosto che di
98 Bassiouni 1999b, p. 1. Cfr. anche Id., The History of Universal Jurisdiction and Its Placein International Law, in S. Macedo (Ed.), Universal Jurisdiction. National Courts and theProsecution of Serious Crimes under International Law, Un of Pennsylvania Press,Philadelphia 2004, pp. 39-63. In questo volume sono pubblicati i risultati del PrincetonProject sulla giurisdizione universale.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
55
organi istituiti ad hoc, e di un efficiente sistema di esecuzione indiretta»99.Problematico appare però, per quanto equilibrate possano apparire lesoluzioni organizzative adottate per la Corte, proprio il requisito dell’effi-cienza. È inoltre evidente che questa soluzione della competenza comple-mentare, avendo la Corte giurisdizione in ordine a persone fisiche solo selo Stato di nazionalità della persona sottoposta a procedimento o lo Statoterritoriale (ove cioè sono stati commessi i crimini) siano parti delloStatuto, non può funzionare de jure quando l’uno e l’altro Stato non abbiasottoscritto lo Statuto e de facto in situazioni di guerra civile.
Fino a che punto l’affermazione del principio di complementarietàcostituisca un avanzamento rispetto alla soluzione della supremazia giu-risdizionale dei tribunali ad hoc degli anni ‘90 resta da vedere.Sicuramente, l’adozione di una supremazia dell’ICC rispetto ai giudicinazionali, nel caso beninteso di un organo che ha competenza universa-le sui crimini internazionali (e non soltanto sui massimi responsabili diessi), avrebbe comportato il rischio permamente di un’inflazione di pro-cedimenti e di paralisi operativa. Perché la Corte possa svolgere efficace-mente il suo ruolo di organo di controllo sulla primaria giurisdizione degliStati è necessario tuttavia un livello di cooperazione internazionale e ungrado di omogeneità nelle culture e pratiche del diritto penale che sonolontani dalla realizzazione. Non è azzardato prevedere pertanto che, allecondizioni date del sistema internazionale, essa eserciterà le sue funzioniin maniera selettiva, incorrendo nelle accuse di parzialità e discreziona-lità e quindi nell’opposto rischio di una sua delegittimazione.
Resta conseguentemente il fatto che, a fronte delle emergenze genoci-darie causate da politiche di pulizia etnica, quelli finora esperiti si rivela-no in ultima analisi modelli di giustizia penale non sostenibile. Il Frontepatriottico ruandese, dominato dai Tutsi, che si è insediato al governodopo il genocidio, ha inizialmente imboccato la via giudiziaria, avan-zando all’Onu la richiesta di un tribunale internazionale sulla base del-l’originaria previsione che gli imputati per genocidio avrebbero dovutoessere all’incirca 2000: la realtà avrebbe invece rivelato un diverso ordi-
99 Bassiouni 1999, p. 20, dove si conclude: «Lo Statuto della Corte penale internazionaleha creato un ibrido, per effetto del quale la Corte è “complementare” alla giurisdizionepenale nazionale».
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
56
ne di grandezza, mettendo la comunità internazionale davanti non adun’organizzazione estesa e ramificata di criminali di Stato ma ad una«criminal population»100. Di qui le insormontabili difficoltà del tribunale diArusha, che hanno certo contribuito al ripensamento internazionale circal’opportunità di una supremazia dei tribunali internazionali. Di qui ancheil fallimento dei tribunali interni, che dopo 6 anni dall’inizio dei procedi-menti si trova ad aver processato 6.000 sospetti, mentre altri 120.000restano nelle prigioni. Si è calcolato che i tribunali ruandesi necessitereb-bero di un secolo per dare esecuzione a tutti i processi – e questo in unpaese in cui l’aspettativa media di vita non supera i 49 anni (Harrell2003, p. 8).
Nel tentativo di sfuggire alla morsa delle difficoltà a cui vanno incon-tro i modelli fin qui delineati, lo scenario di una giustizia penale interna-zionale è stato in anni recenti ulteriormente complicato dall’istituzione ditribunali misti, vale a dire tribunali nazionali con la partecipazione di giu-dici ed esperti di altri paesi. Ma allo stato attuale le esperienze fatte nonsembrano troppo incoraggianti. Inaugurata dalle lunghe e in definitivafallimentari trattative avviate nel 1997 dal governo cambogiano conl’ONU per l’istituzione di un tribunale che facesse luce sul genocidio delpopolo cambogiano e sui crimini del regime di Pol Pot, e accertasse lerelative responsabilità penali, questa via è stata poi imboccata dall’ammi-nistrazione dell’UNTAET a Timor Est con l’istituzione di camere – SpecialPanels for Serious Crimes – competenti per crimini che vanno dal genoci-dio alla tortura. Ma l’attività di queste camere penali si è scontrata, oltreche con la non collaborazione di fatto del governo indonesiano in mate-ria di estradizione, con gravi carenze finanziarie e di personale (e condi-zioni di lavoro disincentivanti per giudici di formazione occidentale). Glistessi problemi materiali che affliggono la Special Court for Sierra Leoneistituita nel 2002 da un accordo tra l’ONU e il governo di Sierra Leone efinanziata da contributi facoltativi (e largamente insufficienti) della comu-nità internazionale. A tacere del fatto che tutta una serie di materieappaiono controverse, a cominciare dalla limitazione della giurisdizione
100 Harrell 2003, p. 8. Cfr. anche W. A. Shabas, Le Rwanda, le Burundi, et la maladied’impunité, in Verdier/Decaux/Chrétien 1995, pp. 115-23.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
57
della corte per crimini commessi a partire dall’accordo di pace del 30. 11.1996 e non, come ragionevolmente richiesto da ONG come HumanRights Watch, a partire dall’inizio della guerra civile (1991), passandoper l’amnistiabilità di certe categorie di reati per finire alla questione dellaresponsabilità penale dei «baby-soldati»101.
Se si persegue la finalità di evitare un sovraccarico di procedimenti acarico della ICC, questa via può apparire senza alternative in situazionicaratterizzate da a) paralisi del sistema giudiziario nazionale e b) assen-za di un potere politico in grado di tutelare l’imparzialità dei processi,garantendo protezione a giudici, testimoni e vittime102. L’interesse di que-sti esperimenti va ravvisato nel tentativo di «conciliare le esigenze di uncontrollo internazionale sui processi per crimini internazionali con l’ideadi portare l’amministrazione della giustizia il più vicino possibile allecomunità che sono state colpite da quei crimini» (Zappalà 2005, p. 69).Ma perché sia possibile il funzionamento di un modello di giurisdizionemista che non si risolva in una sorta di simbolico protettorato giudiziariodelle istituzioni sovranazionali è necessaria la collaborazione dello Statoin cui i crimini hanno avuto luogo. La vicinanza dei processi alle popola-zioni coinvolte aumenta infatti i rischi di interferenze esterne e di una loropoliticizzazione. Per converso, la distanza dai centri di potere internazio-nale può favorire il disinteresse della comunità internazionale e, in parti-colare, il suo disimpegno finanziario103.
101 Cfr., su Osttimor, Sierra Leone e Cambogia, Rupprecht 2003, pp. 258-73. 102 Rupprecht 2003, p. 269 ss. La pretesa che in condizioni di paralisi istituzionale e per-
durante conflittualità politica sia garantita l’indipendenza dei procedimenti attraverso l’e-sclusione di ogni interferenza governativa sui componenti nazionali dei tribunali appare tut-tavia poco realistica.
103 Zappalà 2005, p. 70: «Parrebbe opportuno, per il futuro e in una prospettiva de iurecondendo, che anche tali organi fossero in qualche modo collegati o sottoposti al controllodella Corte penale internazionale. Si potrebbe, ad esempio, ipotizzare un processo di primogrado decentrato e la successiva possibilità di un appello, o di altra forma di impugnazio-ne, davanti alla Corte penale internazionale».
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
58
3. QUESTIONI APERTE
«If the courtroom is the appropriatelaboratory to test the consequences ofinternational law, one of the tragedies of
the Second World War was the Allies’ unwillingness to subject the conductof their soldiers and generals to investigation» ha scritto l’autore di un belvolume sui processi canadesi contro criminali di guerra (che furono pochi,ma risposero ad alti standard di legalità giuridica)104. Per decenni si èlavorato, per lo più nell’ombra, per superare questo ostacolo. Si potevapensare che la fine della guerra fredda avrebbe spianato la via a decisi-vi progressi. Tuttavia l’esperienza degli ultimi anni, dopo l’approvazionedello Statuto della ICC, non appare sotto questo profilo confortante.L’interesse politico all’impunità continua ad essere una delle determinantidella politica internazionale.
Credibilità e successo della strategia giudiziaria dipendono dalladisponibilità di tutti gli attori rilevanti, in primo luogo i membri permanentidel Consiglio di Sicurezza, a cooperare. Nel corso dei lavori preparatoridello Statuto della ICC sono state proprio le grandi potenze, in primoluogo gli Stati Uniti, ad esigere (art. 16) che il Consiglio di Sicurezzapotesse sospendere le inchieste per un anno rinnovabile sine die. La posi-zione degli USA, che hanno ripetutamente minacciato (piuttosto prete-stuosamente) di ritirare i loro soldati dalle missioni di peacekeeping e pea-ceenforcing e alla fine, con l’amministrazione Bush, hanno revocato laloro firma in calce allo Statuto, rappresenta sotto questo profilo un vulnusconsiderevole alle aspettative di effettività del dispositivo penale interna-zionale105. Ma, naturalmente, ad essere in questione non è solo l’atteg-giamento degli Stati Uniti. Se la Russia e la Cina (che come India ePakistan, altre potenze nucleari, non hanno firmato) si sono mantenutefino ad oggi piuttosto defilate nella controversia circa la ICC, pare noninfondato il sospetto che ciò sia dettato semplicemente da una prudentevolontà di non esporsi, lasciando agli USA la responsabilità di un even-
3. 1. IMPUNITÀ À LA CARTE
104 Brode 1997, p. 217.105 Cfr. Rupprecht 2003, p. 281.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
59
tuale fallimento di questo ambizioso esperimento di giurisdizione penaleinternazionale.
È accaduto così che il paese della Corte Suprema e della giustizializ-zazione della politica, il paese in cui si riscontra nel dopoguerra un note-vole attivismo delle corti nel perseguire crimini commessi all’estero (inclu-se violazioni dei diritti umani commesse da organi di Stati stranieri) – atti-vismo fondato su una tradizione che si fa risalire all’Alien Torts Claim Actdel 1789 – si è trovato a svolgere il ruolo di sostenitore di una «justiceinternationale à la carte»106. In realtà la contraddizione non dovrebbe sor-prendere. Occorre infatti tener presente che, almeno fino alla guerra civi-le, grande è stata nella cultura politica degli Stati americani la resistenzaad accettare anche la giurisdizione della Corte federale107. L’attivismodelle corti dell’ultimo dopoguerra sembra rispondere poi più al modello diuna giustizia imperiale (investita della sua missione di mettere ordine nelmondo) che all’imperativo di spianare la via ad un’autentica giustizia uni-versale. A ragione si è ravvisato qui il pericolo di un «imperialismo uma-nitario», che si manifesta nella tendenza delle corti ad assumere il ruolodi «giudici universali delle atrocità commesse all’estero»108. Per questaideologia il diritto penale internazionale si riduce ad essere un diritto spe-ciale per rogue states – come tale superfluo per le democrazie. Tuttaviaandrebbe tenuto nella debita considerazione anche il fatto che l’atteggia-mento di crescente chiusura degli Usa nei confronti della giurisdizionepenale internazionale è legato alla crescente criminalizzazione della suapolitica. L’etica umanitaria della società civile mondiale e la politica emer-genziale degli Stati sovrani (dove a restare pienamente sovrani nel mondocontemporaneo sono soltanto gli Stati imperiali) entrano fatalmente inrotta di collisione. La categoria di complicità nei confronti dei crimini con-
106 Cfr. Biegi 2004, pp. 125-61, Bouquemont 2003, p. 130: «Il est difficile de compren-dre comment un Etat peut être, à la fois, le principal instigateur des tribunaus ad hoc et refu-ser toute participation à une institution qui fait de ces tribunaux un acquis permanent». Cfr.Clark 1992, p. 168 : «International law, as practiced by American foreign policy makers, isnot a coherent set of principles and procedures».
107 L. Friedman Goldstein, State Reaction in Two Trans-State Courts. The European Court ofJustice (1958-1994) and the U. S. Supreme Court (1789-1860), in Volcansek 1997, pp. 20-32.
108 Cassese 2004, II, p. 109.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
60
tro l’umanità spalanca un baratro, in quanto diventa un passe-partout perogni genere di criminalizzazione.
Con le nuove guerre degli anni ’90, e ovviamente con particolare viru-lenza dopo le rappresaglie militari susseguitesi all’11 settembre 2001,dopo Guantanamo e la tortura nel carcere di Abu Ghraib, la politica este-ra degli Stati Uniti non ha lesinato in fatto di scelte che sembravano per-seguire il fine dell’autodenigrazione. Tra i crimini di guerra, contro la pacee contro l’umanità perpetrati dall’Occidente, l’Olocausto, se pur studiatoe tematizzato come mai in passato, comincia così a cedere la scena deldibattito pubblico ai crimini di guerra (e di guerra civile) americani. AdamJones, Executive Director del Gendercide Watch, ha curato nel 2004 unampio volume sui crimini internazionali di cui l’Occidente (ma in primoluogo gli Stati Uniti) si è reso responsabile o complice109. La criminalizza-zione degli Usa è andata di pari passo con la tendenza della superpo-tenza americana a qualificare dell’infamante epiteto di rogue states sog-getti scomodi della politica internazionale110. Si è così arrivati a scomoda-re anche Lemkin per sostenere, ad esempio, che l’ex-segretario di StatoHenry Kissinger è responsabile degli stessi crimini che sono stati proces-sati a Norimberga111.
Negli anni della guerra fredda la giurisprudenza di Norimberga, conla sua definizione della guerra d’aggressione come «supremo crimineinternazionale», era del resto stata ripetutamente chiamata in causa con-tro gli Stati Uniti, come si è già ricordato a proposito del Tribunale Russell.A riprova del fatto che quella amministrata a Norimberga fosse stata«giustizia dei vincitori» si è spesso rilevato che, dopo la seconda guerramondiale, tutti i presidenti americani avevano intrapreso, senza il consen-so del Congresso, azioni militari all’estero, Truman in Corea, Eisenhower
109 Cfr. A. Jones, Introduction: History and Complicity, in Jones, 2004, p. 22: «Genocide,War Crimes and the West aims to be the most comprehensive collection of its kind ever publi-shed». Ma il repertorio di questo genere di letteratura, anche a limitarsi ai contributi miglio-ri, occuperebbe qui molte pagine: oltre agli innumerevoli scritti politici di Noam Chomskyricordo almeno George 1990, Glover 1999, Blum 2001, Henderson 2002.
110 Cfr. Blum 2001, Minnerop 2004.111 Cfr. S. L. Jacobs, Indicting Henry Kissinger: The Response of Raphael Lemkin, in Jones
2002, pp. 214-229.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
61
in Libano, Kennedy a Cuba, Johnson in Vietnam e nella RepubblicaDomenicana, Nixon in Cambogia (Maser 1977, p. 531). In anni piùrecenti, sono poi state notizie circa i crimini di guerra commessi in occa-sione della prima guerra del Golfo, degli interventi Nato contro laJugoslavia, dell’attacco all’Afghanistan e soprattutto della guerra control’Irak (a proposito della quale, non potendo essere addotta nessuna delletre superstiti legittimazioni della guerra oggi: 1) autorizzazione dell’Onu,2) legittima difesa e 3) intervento umanitario, si è con insistenza, e nonsolo da parte islamica, evocato il crimine contro la pace), a rinfocolare ildibattito112.
La diffidenza della superpotenza americana nei riguardi della giuris-dizione penale internazionale ha poi altrettanto comprensibili radici nellasua esposizione al rischio di essere chiamata a rendere conto di sceltestrategiche che configurano complicità con politiche criminali di governipiù o meno apertamente sostenuti dal Dipartimento di Stato o quantome-no dagli apparati, in larga misura sottratti a controllo democratico, deiservizi segreti. Un capitolo centrale riguarda qui le (cor)responsabilitànelle sistematiche violazioni dei diritti umani (nella forma di veri e propricrimini contro l’umanità) perpetrate nell’America latina nella secondametà del XX secolo113. L’ampio e piuttosto elastico concetto di conspiracy,che a Norimberga era servito ad aggirare ostacoli frapposti dalla dottri-na giuridica continentale, rischia infatti di poter essere utilizzato controogni potenza democratica che eserciti una diretta influenza politica inun’area tormentata da guerre civili, colpi di Stato e dittature.
Si dovrebbe aprire a questo punto un’ampia digressione sul problemadell’impunità dei crimini politici nell’«età dei diritti», vale a dire dal
112 Cfr. D. B. MacDonald, The Fire in 1999? The United States, NATO and the Bombing ofYugoslavia, in Jones 2004, pp. 276-98, A. Jones, Afghanistan and Beyond, ivi, pp. 383-403 e D. J. Halliday, US Policy and Iraq: A Case of Genocide?, ivi, pp. 264-76, che sostie-ne esplicitamente la tesi del carattere genocidario delle sanzioni economiche comminateall’Irak. Si veda anche Lutz/Giessmann 2003, Kress 2003 e Mandel 2004, p. 5: «In techni-cal terms this was a war of ‚aggression’ – the legal word for a war that does not fall withinthe narrow confines of the right of self-defence and has not been authorized by the SecurityCouncil as absolutely necessary in the collective interest of international peace and security».
113 Cfr. Clark 1992, Jones, 2004.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
62
momento in cui i diritti umani sono stati codificati e positivizzati anche daldiritto internazionale. Pars pro toto ci limiteremo qui a qualche conside-razione su uno specifico contesto. Uno degli aspetti problematici delletransizioni alla democrazia che si sono compiute nel corso degli ultimidecenni nell’America latina riguarda proprio il problema dell’impunità (untema su cui è cresciuta negli anni una notevole letteratura, ma su cui illavoro più importante e rigoroso resta la monografia, apparsa nel 1997,di uno specialista tedesco di diritto penale internazionale, Kai Ambos,Straflosigkeit von Menschenrechts-verletzungen. Zur “impunidad” in süda-merikanischen Ländern aus völkerstrafrechtlicher Sicht). Senza la pretesaallora irrealizzabile (oggi più realistica alla luce dei passi avanti compiu-ti nei singoli paesi e dalle Nazioni Unite) di affrontare la questione in tuttii paesi dell’America latina, Ambos ha analizzato in questo volume le vio-lazioni dei diritti umani (massacri, esecuzioni extra-legali, sparizioni, tor-ture) commesse in Colombia, Perù, Bolivia, Cile e Argentina nel corsodegli anni ‘70 e ‘80. Partendo da una classificazione delle diverse formedi impunità proposta da Gabriel Gutiérrez (impunidad de hecho, quandol’azione penale non è neppure presa in considerazione, impunidad inve-stigativa, quando il non luogo a procedere discende da intenzionali omis-sioni nelle indagini, impunidad por congestión, per sovraccarico o para-lisi del sistema giudiziario, impunidad legal, sulla base di particolarinorme di diritto penale processuale o di leggi speciali, impunidad delic-tuosa, quando sono messi in atto comportamenti intimidatori o coercitivinei confronti di persone coinvolte – testimoni, congiunti delle vittime), l’au-tore mostra in particolare come le ampie prerogative accordate alla giu-risdizione militare, da un lato, e l’adozione di provvedimenti politici diamnistia e clemenza, dall’altro, concorrano nel determinare situazioninelle quali la punizione di gravi lesioni dei diritti umani diventa pressochéimpossibile.
La distinzione tra impunità de facto e impunità de jure, parallelamen-te a quella tra impunità ex ante e impunità ex post, ha fondamentale rile-vanza per comprendere come alla base dell’illegalità diffusa stia la strut-turale extraterritorialità giuridica e costituzionale di interi settori dell’ap-parato dello Stato, che rivendicano per sé il diritto all’autoregolamenta-zione senza controlli democratici e giurisdizionali: extraterritorialità giuri-
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
63
dica che appunto produce una subcultura corporativa di onnipotenza, col-lusione, omertà e in definitiva impunità. Rispetto a questa dimensionestrutturale dell’impunità, provvedimenti di amnistia costituiscono semplice-mente la sanzione legale di una licenza di esercitare il terrore. In molticasi, soprattutto quando vi sia continuità istituzionale, lo Stato criminalenon ha neppure bisogno di fare ricorso a norme di assoluzione o di depe-nalizzazione generalizzata. È sufficiente il conformismo politico dellamagistratura giudicante e l’esistenza di un dispositivo di garanzia per icrimini di Stato quale offerto dai tribunali militari – che accanto alla fun-zione di disciplinamento interno esercitano da sempre una funzione diautotutela corporativa nei confronti dei poteri civili.
Leggi d’amnistia e giurisdizione militare confliggono con le norme deldiritto penale internazionale. Essendo integrata nella struttura gerarchicadelle forze armate, la giurisdizione militare è di per sé un fattore struttu-rale d’impunità delle medesime. Il fatto che talora gli stessi sospetti di cri-mini contro l’umanità o crimini di guerra si trovino a giudicare dei mede-simi in qualità di membri delle corti militari costituisce la violazione ecla-tante di uno dei princìpi fondamentali del diritto penale, quello sintetizza-to dalla massima: nemo judex in sua causa. In regimi formalmente demo-cratici (o comunque in tutti i regimi che non siano dittature militari) il fattoche le gerarchie militari siano subordinate al potere politico favorisce ulte-riormente l’affermarsi di condizioni d’impunità perché i tribunali militari,dopo aver accertato che i membri delle forze armate si sono limitati adeseguire ordini delle superiori istanze politiche, si dichiarano incompeten-ti a perseguire queste ultime e demandano la decisione ultima a tribunalicivili, spesso privi dell’autonomia necessaria a reggere le pressioni delpotere politico. Quando, in presenza non di sporadici casi ma di una cri-minalità politica sistemica, la giurisdizione militare si rivela uno strumen-to insufficiente a garantire un’impunità generalizzata, il potere esecutivoe il potere legislativo introducono garanzie d’impunità universali, ema-nando decreti e leggi d’amnistia. Come terza istanza assolutrice, dopo lecorti militari e il potere politico, possono intervenire da ultimo le supremecariche dello Stato con provvedimenti particolari di clemenza nei confrontidi coloro che non abbiano potuto beneficiare dei vantaggi di quella benorganizzata macchina burocratica dell’impunità.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
64
Quando siano in gioco crimini contro l’umanità, provvedimenti diamnistia non possono essere applicati in ragione della natura imperativa(jus cogens) delle norme internazionali su tali crimini. Nel casodell’America latina il decreto ley 2.191 del 1978 in Cile, la legge argen-tina 23.492 del 1986 (Ley de Punto Final) e la legge peruviana d’amni-stia 26.479 del 1995 sono manifestamente illegali dal punto di vista deldiritto internazionale. Ma collide con il diritto internazionale anche lalegge argentina 23.521 del 1987 (Ley de Obediencia Debida) che consi-dera non punibili coloro che hanno agito in ottemperanza di un ordinesuperiore114. In base alla Convention against Torture and Other Cruel,Inhuman or Degrading Treatment or Punishment del 1984 l’argomento del«Superior Order» non può essere invocato come fattore d’impunità. Essopuò semmai, come altre risoluzioni internazionali a partire dalla Charterof the Nuremberg Tribunal (1949) prevedono, essere invocato come cir-costanza attenuante.
L’oggetto prevalente delle considera-zioni svolte nei precedenti paragrafi èstata la resa dei conti giudiziaria con una
passato criminale, in particolare le esperienze e le aspettative legate allagiurisdizione penale internazionale. Ma il problema della giustizia in unprocesso di transizione da un regime caratterizzato da un alto tasso di cri-minalità politica ad un regime democratico fondato sul rispetto dei dirittiumani è posto in termini del tutto insoddisfacenti se ci si limita alla tratta-zione del problema della macrocriminalità collettiva in una prospettivapenalistica. Enorme è la sottostante questione delle riparazioni, materialie simboliche, che determinati gruppi, nazioni, Stati o anche la comunitàinternazionale nel suo complesso considerano dovute alle vittime di cla-morose ingiustizie storiche. Questa questione, è evidente, va oltre ladimensione dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi da regimitotalitari o dittature militari e investe l’intera eredità del colonialismo occi-dentale.
Elazar Barkan ha dedicato un libro importante, The Guilt of Nations.
114 Cfr. Ambos 1997, p. 109 ss. Inoltre, su questa problematica, Osiel 1997 e 1999.
3. 2. RESTORATIVE JUSTICE?
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
65
Restitution and Negotiating Historical Injustice (2000), alla ricostruzionestorica delle varie forme di politiche restitutive che sono state messe inopera nella seconda metà del secolo XX (dalla Germania al Giappone,dalla questione dello schiavismo ai nativi americani e agli aborigeniaustraliani). Accanto ad una nozione larga di restitution, inclusiva di tuttele modalità, materiali e simboliche, di giustizia compensativa, Barkanadotta una nozione più specifica, che distingue dalle riparazioni e dallescuse ufficiali. «Restitution strictly refers to the return of the specific actualbelongings what were confiscated, seized, or stolen, such as land, art,ancestral remains, and the like. Reparation refers to some form of mate-rial recompense for that which cannot be returned, such as human life, aflourishing culture and economy, and identity. Apology refers not to thetransfer of material items or resources at all but to an admission of wrong-doing, a recognition of its effects, and, in some cases, an acceptance ofresponsibility for those effects and an obligation to its victims»115. La tipo-logia corrisponde ad una classica tripartizione giuridica, in base allaquale si distingue tra restitutio in integrum, quando si tende a ripristinarela situazione sussistente anteriormente alla violazione del diritto, compen-satio quando si effettua un risarcimento, e satisfactio, quando si offre unacompensazione simbolica attraverso il riconoscimento del torto commes-so116. Nel caso di crimini contro l’umanità la restitutio in integrum non èovviamente possibile: proprio questa impossibilità alimenta però unadomanda di soddisfazione simbolica destinata ad essere perennementefrustrata.
Anche sotto questo profilo occorre riconoscere che gli anni ’90 hannosegnato una svolta, come una serie di iniziative e conferenze internazio-nali documenta in modo eloquente. Basti citare qui la London Nazi GoldConference del 1997, la Washington Conference on Holocaust-Era Assetsdel 1998, lo Stockholm International Forum on the Holocaust del 2000 el’iniziativa del premier svedese Göran Persson, che ha dato vita nel 1998ad una Task Force for International Cooperation on Holocaust Education,
115 Barkan 2000, p. XIX. 116 Cfr. Trassl 1994, p. 15: nel diritto anglosassone si distingue tra restitution in kind, com-
pensation e satisfaction. Nel novero della prima rientrano sia la material che la legal resti-tution.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
66
Remembrance and Research, cui nel frattempo hanno aderito 20 Stati (inmaggioranza europei). Tutto ciò configura un’istituzionalizzazione trans-nazionale della memoria dell’Olocausto117. Ancora una volta la vicendatedesca costituisce il precedente paradigmatico: nei confronti delle vittimedella dittatura nazionalsocialista, il governo della BRD (non quello dellaDDR, che ha fin dalla sua nascita rivendicato la sua estraneità rispetto aicrimini commessi dal precedente regime) aveva avviato un programma diriparazioni e riconciliazione che non ha eguali nella storia. L’esperienzatedesca è dunque significativa non solo per quanto riguarda l’ampiezzadella resa dei conti giudiziaria ma anche per l’intero complesso delle ripa-razioni, in cui i tribunali hanno comunque svolto un ruolo di primo piano,accanto alle decisioni legislative e alle misure amministrative. Molti lavorisono apparsi nel corso degli anni su questa tematica e da ultimo il bilan-cio complessivo proposto da Constantin Goschler in Schuld und Schulden(2005)118.
Ma se l’Olocausto costituisce il precedente decisivo, il problema haacquistato ormai una valenza globale. Rispetto alle riparazioni imposte aconclusione di un conflitto, oggetto tradizionale del diritto internazionale,la questione ha assunto infatti una nuova dimensione in anni recenti,quando sulla base dei dibattiti sulle riparazioni nei confronti delle vittimedell’Olocausto, sono state avanzate rivendicazioni che hanno comeoggetto ingiustizie storiche più remote nel tempo e di più problematicadefinizione e che hanno alimentato una nuova retorica dei risarcimenti. Sipensi alle dichiarazioni sulle responsabilità americane in materia di schia-vismo del presidente Bill Clinton in occasione del suo viaggio in Africa nel1998 («We were wrong in that») e alla sua visita alla Slave House aGoree Island (Senegal); ma anche alla «solemn offer of reconciliation» delgoverno canadese in occasione del varo dell’Aboriginal Action Plan(1998) o all’istituzione del Council for Aboriginal Reconciliation australia-
117 Cfr. Kroh 2005, Eder/Spohn 2005. 118 Cfr. Fisch 1992, Goschler/Herbst 1989, Goschler 1992, Brodesser/Fehn/
Franosch/Wirth 2000, Goschler/Ther 2003, Goschler 2005. Sull’espropriazione della pro-prietà ebraica e i problemi ad essa connessi cfr. Zweig 1987, Aalders 2000, Goschler/Ther2003; una buona sintesi in G. D. Feldman, Der Holocaust und der Raub an den Juden. EineZwischenbilanz der Restitution und Entschädigung, in Goschler/Ther 2003, pp. 225-37.
no (1991). Il fenomeno si colloca nell’ambito della transizione, come haargomentato Hermann Lübbe, da una morale fondata sulla presunzioneassoluta di verità propria delle ideologie ad una più esigente morale delriconoscimento della realtà storica119. È bene naturalmente non dimentica-re che questa morale politica ha come corollario l’assunzione di impegnifinanziari, che a sua volta acquista una dimensione strategica sia per ildebitore-donatore sia per i creditori eredi delle vittime.
Tra questi casi per così dire paradigmatici – quello dell’Olocaustocome responsabilità specifica di un regime politico ben identificato nellospazio e nel tempo, per il quale un regime successivo si è fatto carico degliobblighi della riparazione e della riconciliazione, e quello del dominiocoloniale dell’Occidente, rispetto al quale meno chiaro è chi rappresentiesecutori e vittime e come possano configurarsi atti di riparazione e ricon-ciliazione – si colloca un gran numero di casi storici di regimi di transi-zione che si trovano ad essere confrontati con domande di restituzione,riparazione, risarcimento che richiedono risposte non sporadiche ma isti-tuzionali. A fronte di queste complesse fattispecie la tipologia presentatain apertura deve essere modificata ed integrata. Intanto va osservato chedelle sei modalità di resa dei conti con un passato criminale prospettate(vendetta, rimozione, amnistia, giustizia nazionale, giustizia internazio-nale dei vincitori e giustizia internazionale di corti indipendenti), le ultimedue costituiscono, come abbiamo potuto vedere, l’eccezione e non laregola (la regola è un mix, variabile di situazione in situazione, delleprime quattro modalità). Alla costituzione, in senso proprio, di tribunaliinternazionali dei vincitori si è arrivati solo dopo la seconda guerra mon-diale, a Norimberga e Tokio. La sperimentazione di corti internazionaliindipendenti è stata avviata solo in due casi negli anni ’90 ed ora si atten-de alla prova, consapevoli della difficoltà del cammino, la ICC.
L’analisi politologica dei processi reali di transizione mostra una
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
67
119 Lübbe 2001, pp. 9, 17 e 27. Si può discutere se questo nuovo orientamento sia giàstato affossato dalla politica della successiva amministrazione americana; è un fatto che essostenta invece ad avviarsi in altre grandi potenze imperiali responsabili di macroingiustizie,come evidenzia la recente «politica del passato» russa. Il saggio di Lübbe affronta corretta-mente anche il problema delle matrici religiose di questa nuova morale e dei suoi «riti di pen-timento».
varietà di opzioni e una stratificazione di strategie all’interno delle quali iprocessi penali svolgono un ruolo importante ma certo non esclusivo. Giàdi per sé le funzioni della resa dei conti giudiziaria con il passato appaio-no, sotto il profilo politico, molteplici e non sempre facilmente conciliabili:fornire un’alternativa alla resa dei conti violenta e al tempo stesso conse-guire il risultato di rimuovere dal potere i responsabili di gravi crimini, for-nire una legittimazione ai vincitori e favorire il processo di democratizza-zione, dare giustizia alle vittime e creare le condizioni per la riconcilia-zione, servire la causa della verità e consolidare lo stato di diritto. Al rag-giungimento di questi obiettivi coopera in ogni transizione necessaria-mente una pluralità di altri strumenti politici, legislativi e amministrativi,che operano sia a livello simbolico che in ambito materiale. Una buonasintesi della recente letteratura sulle politiche di riparazione del passato èofferto dalla monografia di Ruti G. Teitel, Transitional Justice (2000), cheanalizza il problema nel quadro dei processi di transizione dai regimiautoritari e totalitari alla democrazia. La teoria della giustizia di transi-zione, a cui stanno lavorando molti studiosi delle ultime generazioni, sicaratterizza proprio per l’attenzione riservata alle strategie politico-ammi-nistrative e ai dispositivi costituzionali messi in atto, sia pure sotto pres-sioni internazionali, dai governi nazionali – strategie e dispositivi che nonsi limitano appunto a misure legislative di amnistia o a procedimenti giu-diziari, ma includono provvedimenti di riparazione e riabilitazione dellevittime e politiche dell’integrazione, della memoria e dell’identità articola-te a diversi livelli120.
In corrispondenza a questa letteratura, ma sul piano normativo, haconseguentemente acquistato importanza nel corso degli ultimi anni unindirizzo di pensiero critico nei confronti della resa dei conti giudiziariacon la storia, dello strumento della giustizia penale, e favorevole ad altremisure e a quella che è stata chiamata restorative justice, giustizia ripara-trice. Contro il modello penalistico della retributive justice si fa valere chequesta si concentra sui perpetratori (e vive dell’illusione della deterrenzadella pena, la cui efficacia a livello internazionale resta in effetti tutta dadimostrare – vi è anzi chi arriva a sostenere che essa sia fondamental-
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
68
120 La documentazione più ampia dei problemi connessi è in Kritz 1995.
mente controproducente121), mentre la restorative justice adotta il punto divista delle vittime e persegue come finalità primaria quello della riconci-liazione tra le fazioni opposte di una nazione divisa dalle tragiche espe-rienze di una guerra civile o di una dittatura122. Chi propone questa via lofa nella convinzione che l’elaborazione giudiziaria del passato debbalasciare il posto a commissioni d’indagine chiamate a fare luce sull’acca-duto senza pervenire alla criminalizzazione di una parte della società oalla condanna di singoli individui.
All’interno di questo mutamento complessivo di paradigma, da un’e-laborazione del passato concentrata sugli esecutori del crimine si passapertanto ad un’altra che mette al centro le vittime. La nascita della vitti-mologia nel corso degli ultimi decenni è un indizio ulteriore di questa svol-ta123. È naturalmente presto per stabilire quali prospettive di successo pos-sano essere attribuite alle politiche ispirate a questo principio. Ma a dueproblemi è necessario fare riferimento. Il primo riguarda la dimensionemateriale: laddove manchi la volontà politica e non siano messe a dispo-sizione le risorse per attuare un vincolante programma di risarcimentodelle vittime, il potenziale simbolico di reintegrazione rischia nel medio-lungo periodo di capovolgersi nel suo opposto. Il secondo concerne la
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
69
121 Circa l’eventualità che la minaccia di processi futuri serva efficacemente da deterrenteBiegi 2004, p. 40. Anche nel caso di un’alta probabilità che a conclusione del processo siarrivi a delle sanzioni non simboliche, il valore di deterrenza della giurisdizione penale inconseguenza della lunga durata delle indagini risulta «illusorio». Cfr. anche Jäger 1989, p.81 e Yacoubian 1998, p. 49. Per una posizione più favorevole Risse/Ropp/Sikking 1999.
122 Secondo Johnstone 2002, p. IX, questa concezione della giustizia poggia sull’idea«that crime is, in essence, a violation of a person by another person (rather than a violationof legal rules); that in responding to a crime our primary concerns should be to make offen-ders aware of the harm they have caused, to get them to understand and meet their liabilityto repair such harm, and to ensure that further offences are prevented; that the form andamount of reparation from the offender to the victim and the measures to be taken to preventreoffending should be decided collectively by offenders, victims and members of their com-munities through constructive dialogue in an informal and consensual process; and thatefforts should be made to improve the relationship between the offender and victim and toreintegrate the offender into the law-abiding community». Cfr. anche l’ampio Reader curatodallo stesso Johnstone 2003. Inoltre Braithwaite 2002, Lutz 2002, Weitekamp/Kerner 2003,Walgrave 2003.
123 Cfr. Hassemer/Reemtsma 2002, Stella 2001.
riconciliazione come equivalente sul piano collettivo del perdono nell’am-bito privato. Va infatti considerato che il perdono costituisce l’atto di unindividuo nei confronti di un altro individuo o di un gruppo relativamenteridotto di individui: l’elemento personale e spontaneo di questa pratica èessenziale per la sua definizione. Singolarmente la vittima può perdona-re il suo torturatore. Le cose stanno diversamente nel caso di processi col-lettivi. La riconciliazione presuppone il reciproco riconoscimento e quindiun rapporto di simmetria tra le parti. Questo riconoscimento, già di per séproblematico quando si confrontano tra loro vittime e aguzzini, viene peròpregiudicato quando il costo della riconciliazione consista nell’impunitàdei criminali di Stato. La rinuncia a misure retributive finisce per aprire lavia all’amnistia.
Presupposto della riconciliazione è chesi faccia luce sull’accaduto, attraverso l’i-stituzione di quelle che sono state chiama-
te Commissioni verità. Si tratta di esperimenti istituzionali avviati nel corsodegli anni ottanta e che si intensificano o danno risultati nel decennio suc-cessivo, a partire dalla Comisión Nacional para la Desaparicion dePersonas in Argentina (1983-84, rapporto pubblicato nel 1995), laComisión Nacional para la Verdad y Reconciliation in Cile (1990-91), lecommissioni sudafricane, in particolare la Truth and ReconciliationCommission (1995-98). Queste istituzioni presentano le seguenti caratte-ristiche: 1. analizzano il passato, 2. per fornire un quadro complessivodelle violazioni dei diritti, 3. hanno un arco di vita limitato, che si conclu-de con la presentazione di un rapporto, 4. hanno accesso privilegiato alleinformazioni e sono protette durante le indagini124. A differenza dei pro-cedimenti giudiziari (e, sul versante opposto, delle amnistie), le conclusio-ni stilate nei rapporti lasciano in realtà aperti tutti gli sviluppi, salvo quel-lo della rimozione (dimenticare non è più consentito laddove esiste unaverità riconosciuta consensualmente). La loro funzione primaria consistecomunque nell’affermazione di un’identità collettiva capace di volontàpolitica e di rigenerazione morale.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
70
3. 3. VERITÀ PER LE VITTIME
124 Cfr. Hayner 1994.
Il ricorso a queste commissioni risponde all’esigenza di rimediare ailimiti strutturali di una resa dei conti giudiziaria con il passato, data l’im-possibilità, nelle condizioni di dissolvimento istituzionale conseguenti allacolonizzazione criminale della sfera pubblica, a) di aprire contempora-neamente migliaia di procedimenti giudiziari, b) di dare comunque sod-disfazione alle vittime. Esse devono stabilire con l’accertamento dellaverità anche le coordinate per misure legislative di riconciliazione e per ilripristino della legalità giudiziaria. La letteratura – che sintetizza così leloro funzioni: «creating an authoritative record of what happened, provi-ding a platform for the victims to tell their stories and obtain some form ofredress, recommanding legislative, structural or other changes to avoid arepetition of past abuses, establishing who was responsible and providinga measure of accountability for the perpetrators» (Christie 2000, p. 61) –rende manifesto come al ristabilimento della verità sia attribuita nei pro-cessi di transizione alla democrazia una funzione quasi-costituente.
Sulle commissioni verità non ha tardato a coagularsi un diffuso con-senso nell’opinione pubblica internazionale: l’ideologia che le ispira, ineffetti, sembra da un lato radicarsi in pratiche discorsive presenti e fun-zionanti in società tradizionali a basso tasso di giuridificazione, dall’altrovenire incontro a quell’orientamento normativo del paradigma dellacomunicazione che ha nel corso degli ultimi decenni egemonizzato scien-ze sociali e discorsi pubblici nelle democrazie occidentali – ed è evidenteche l’Organizzazione delle Nazioni Unite possa fornire l’ideale punto diincontro e di fusione di tali tendenze. A ciò si aggiunge il ruolo esercitatodalle chiese, con la loro secolare esperienza in materia di istituzionaliz-zazione delle colpe e dei castighi. Tuttavia non si dovrebbe sorvolare sulfatto che il ricorso a queste pratiche può essere facilmente strumentalizza-to da chi non aspiri ad altro che a scongiurare la resa dei conti con la giu-stizia e a perpetuare la condizione d’impunità. Per quanto in buona fedepossano essere molti dei suoi sostenitori, la strategia delle commissioniverità e della riconciliazione finisce tuttavia in molti casi per fungere difatto da variante soft, per così dire politically correct, di una politica del-l’impunità: un’impunità ottenuta in questo caso attraverso il riconoscimen-to simbolico delle vittime.
L’analisi comparativa delle diverse esperienze – africane e latinoame-
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
71
ricane – di politiche della verità non fornisce, a dire il vero, elementi peraffermare che questa sia la via più promettente della giustizia nella tran-sizione. Di fronte alla paralisi della giustizia o al rischio di un’inflazioneingovernabile del contenzioso giudiziario, la soluzione delle politiche diriconciliazione a partire dalla ricostruzione del passato può essere unastrategia senza alternative. Ma i costi che essa presenta sono comunquealti. Nel caso del Sudafrica, che dell’esperienza delle commissioni veritàcostituisce il paradigma e anche il caso che si considera più riuscito,siamo in realtà davanti ad una istituzione complessa che fonde insiemeprocedimento giudiziario, inchiesta storica, pratica della confessione eterapia analitica125. I giuristi criticano il fatto che sia stato dato corso a rac-conti senza troppa precisione negli addebiti, molte vittime si lamentanoche sia stata prestata attenzione soltanto alle violazioni più gravi126. Ma lecommissioni verità, ribadiscono i loro sostenitori, non hanno solo una fun-zione strumentale di accertamento delle verità di fatto – in questo i tribu-nali sono sicuramente più adatti –, devono funzionare da grande labora-torio di assunzione di consapevolezza della colpa. Sono istituzioni perelaborare la colpa a livello individuale e collettivo neutralizzandone altempo stesso gli effetti politici.
La richiesta di commissioni verità caratterizza in particolare l’espe-rienza dell’America Latina, dove l’ingiustizia andava sul conto della crip-topolitica e degli arcana imperii. L’eliminazione degli oppositori politiciattraverso l’arresto e la loro scomparsa è un ingrediente di una politicache ricorre a «colpi di Stato» nell’accezione che Naudé dava a questotermine. Rientra nella natura del «doppio Stato» albergare sotto le par-venze di un ordinamento quasi-democratico (o a democrazia controllatao a democrazia temporaneamente sospesa) un altro ordinamento, che èuno Stato criminale. Lo smantellamento delle barriere pseudo-legali cheimpediscono l’accesso alla verità è in questo caso la precondizione per-ché il meccanismo giudiziario possa rimettersi in moto. Ma alla propostadelle commissioni verità un ministro ruandese, Charles Murigande,avrebbe opposto che non di quello il Ruanda aveva bisogno: si sapeva
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
72
125 Cfr. Hahn-Godeffroy 1998, Ruge 2004, p. 223. 126 Ruge 2004, pp. 223-4.
benissimo chi aveva fatto che cosa, perché tutto era avvenuto alla luce delsole127.
Un tale modello non può evidentemente funzionare perseguendo lemedesime finalità e con eguali prospettive di successo in situazioni cosìdiverse fra loro come il Cile o l’Argentina da un lato, la Cambogia o ilRuanda dall’altro. Nel primo caso le vittime delle dittature ammontano adalcune migliaia (forse 30.000 nel caso argentino) e le responsabilità sonosostanzialmente circoscritte all’esercito e all’apparato repressivo, nell’altrole vittime sono dell’ordine di milioni e centinaia di migliaia sono i cittadi-ni coinvolti come parte attiva nei massacri, o come fiancheggiatori e pro-fittatori del crimine. È assurdo poi pensare che uno stesso modello possaessere applicato in situazioni tanto diverse anche in relazione ai livelli diorganizzazione e funzionalità del sistema giudiziario e sotto il profilodelle finalità perseguite. Nel caso del Cile i procedimenti giudiziari dove-vano servire a preservare il rule of law, consolidare la democrazia e scon-giurare altri colpi di Stato, nel caso del Ruanda si tratta invece di avviareun processo di riconciliazione che coinvolga tutti gli strati e le componen-ti della società e di sradicare una cultura politica e una morale disposte atollerare il genocidio o a considerarlo un mezzo necessario per risolvereil conflitto sociale128.
La retorica della restorative justice dissimula il fatto che qui si stafacendo di necessità virtù: in presenza di sistemi giudiziari incapaci difunzionare (nel caso ruandese una giustizia che era praticamente giàparalizzata alla vigilia del genocidio si trova a giudicare oltre 100.000individui coinvolti nei crimini della guerra civile e incarcerati dopo il con-flitto) appare inevitabile la scelta del ricorso a modalità diverse di restau-razione di un ordine giuridico che oltre ai requisiti di validità ed efficien-za presenti anche un minimo di giustizia simbolica per le vittime. Ciò chenon poteva avere successo nella Germania del 1945, in uno Stato cioè
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
73
127 Vedi la citazione in Christie 2000, p. 50. Sulle differenze tra la situazione latinoame-ricana, in cui i conflitti sono maggiormente segnati dalla frattura ideologica tra governanti egovernati (e in cui i militari sono i maggiori responsabili delle violazioni dei diritti), e la situa-zione africana, in cui prevalgono i conflitti etnici (e in cui i crimini contro l’umanità sonospesso imputabili a semplici civili) cfr. Hayner 1994.
128 Harrell 2003, p. 7.
con una solida tradizione burocratica, e una magistratura ideologica-mente deviata ma altamente professionale, a maggior ragione appareimproponibile entro un contesto istituzionale debole e comunque lontanodai paradigmi di legalità occidentali.
A fronte della paralisi giudiziaria (al genocidio sono sopravvissuti sol-tanto 14 pubblici ministeri e 39 «criminal investigators»), il governo ruan-dese ha così deciso nel 2000 d’imboccare una terza via facendo ricorsoalla forma tradizionale di risoluzione delle dispute di villaggio, il gacaca,istituendo 11.000 giurisdizioni locali, i cui giudici (oltre 250.000) sonostati eletti dalla popolazione nel 2001. Proprio in riferimento al casoruandese, Harrell argomenta come sia presto per parlare di un modellouniversalmente condiviso di transitional justice, anche se si stanno deli-neando «the outlines of a three-fold model: an international tribunal toprosecute top level regime members, national-level prosecution of theirsubordinates, and a truth commission to document a regimÈs crimes forposterity» (Harrell 2003, p. 5). Quel che è certo è che l’analisi del casoruandese serve ancor meglio di quello sudafricano per documentare i limi-ti del «liberal-prosecutorial model of transitional justice» e l’emergere diun modello diverso, che l’autore definisce «communitarian restorativemodel of transitional justice».
Va tenuto infine presente che la via della riconciliazione, quando nonsia semplicemente la conseguenza dell’impraticabilità di altre soluzioni,presuppone che la colpa sia collettivamente condivisa, vale a dire che laresponsabilità per pesanti violazioni dei diritti umani gravi su tutte le particoinvolte nel conflitto, come di norma accade in una guerra civile. ErnestoGarzón Valdés ha ragione nel rilevare che questa paritaria attribuzionedella colpa non può essere postulata nei casi di terrorismo di Stato, checonfigurano un «sistema asimmetrico di violenza», in cui isolati episodid’illegalità dal basso vengono assunti a pretesto per perseguitare con poli-tiche democidarie un’opposizione legittima – come è avvenuto nella piùparte dei regimi repressivi dell’America latina129. In questi casi l’unica viamoralmente, giuridicamente e politicamente raccomandabile e doverosa
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
74
129 E. Garzón Valdés, Prolog: Staatsterrorismus, Gerechtigkeit und Justiz, inAhlbrecht/Ambos 1999, p. 15.
resta quella dell’applicazione delle leggi penali vigenti e del rispetto delleobbligazioni internazionali. La politica della riconciliazione non puòdiventare un surrogato dell’amnistia e le commissioni verità non debbonotrasformarsi in uno strumento per la dispersione e per la collettivizzazio-ne della colpa. La democrazia costituzionale istituita a garanzia dei dirit-ti è figlia dell’individualismo moderno; e all’individualismo paga il suo tri-buto anche il diritto penale nell’accertare e sanzionare le responsabilità.
4. CONCLUSIONI
I non imprevedibili ostacoli sul cammino della giustizia penale inter-nazionale consentono, in sede di bilancio, qualche considerazione dicarattere generale. Come le guerre degli anni ’90 e soprattutto le rappre-saglie militari succedute all’11 settembre hanno non confutato ma certoindebolito le tesi sul carattere pacifico delle democrazie, così la strategiaostile degli Usa nei confronti dell’ICC induce a considerare con prudenzale tesi circa una naturale vocazione delle democrazie a sostenere la giu-risdizione internazionale. Se è vero infatti che l’iniziativa a sottoporre arisoluzione giudiziaria controversie internazionali e crimini politici è venu-ta nella storia dalle democrazie liberali, è altrettanto vero che gli impera-tivi della Realpolitik hanno sempre indotto queste ultime a contemperarele esigenze della giustizia con le esigenze della pace e della stabilità del-l’ordinamento internazionale. È poi probabile – ma la tesi dovrebbe esse-re approfondita – che le potenze imperiali sviluppino una particolare con-cezione della giustizia internazionale, in conflitto con quella degli Staticostituzionali a vocazione transnazionale e con quella delle organizza-zioni sovranazionali.
Qui si può ancora una volta rilevare che l’opposizione degli Stati all’e-spansione della giurisdizione penale internazionale non deve sorprende-re, perché questa mette in discussione quell’assunto fondamentale che è laloro sovranità, da cui anche gli Stati odierni (a sovranità sempre più limi-tata e condizionata) sono disposti a prendere congedo fin tanto che si trat-ti di esercitare la funzione promozionale del diritto (la cooperazione) manon, se non in casi particolari, quella repressiva (la retribuzione penale).
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
75
Poiché sono gli Stati a vocazione egemonica che continuano a esercitarela loro sovranità senza risentire in modo sostanziale delle limitazioni a cuisono sottoposti tutti gli altri attori internazionali, la loro (manifesta o dissi-mulata) strutturale ostilità alla risoluzione giudiziaria delle controversie eal principio che ogni grave violazione del diritto internazionale comportala responsabilità penale internazionale anche per chi riveste funzioni uffi-ciali costituisce un naturale corollario della loro compiaciuta ideologiadella pienezza del potere.
Sulla politica dei war crime tribunals Jonathan Bass ha formulato cin-que proposizioni generali, che concorrono ad integrare il profilo degliorientamenti di politica estera delle democrazie liberali nel segno di uninstabile equilibrio tra idealismo e realismo: «First, it is only liberal states,with legalist beliefs, that support bona fide war crimes tribunals (…)Illiberal states, in contrast, are more cynical: they may support a show trialonly as a way of pursuing a Carthaginian peace (…) As the second pro-position, even liberal states tend not to push war crimes tribunal if so doingwould put their own soldiers at risk. From the Napoleonic Wars to Bosnia,this is perhaps the single biggest impediment to the creation of robust insti-tutions of international justice. Third, there is a distinctly self-serving under-tone to liberal campaigns for international justice. Even liberal states aremore likely to be outraged by war crimes against their own citizens thanwar crimes against foreigners. The more a state has suffered, the morelikely is to be outraged. Fourth, even liberal states are most likely to sup-port a war crimes tribunal if public opinion is outraged by the war crimesin question. And they are less likely to support a war crimes tribunal if onlyelites are outraged. Finally, non state pressure groups can be effective inpushing for a tribunal, by shaming liberal states into action and providingexpertise»130. Queste tesi valgono a maggior ragione anche in riferimen-to al sostegno che le democrazie possono fornire a tribunali o ad organi-smi paragiudiziari chiamati a farsi carico dell’eredità di regimi criminalie di eventi genocidari.
Alla luce delle esperienze di tutti i tribunali internazionali che hannovisto la luce nel XX secolo (inclusa dunque anche la Corte internazionale
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
76
130 Bass 2000, pp. 28-9.
di giustizia) e soprattutto della soluzione prospettata dallo Statuto dell’ICC,non appare pertanto realistico sostenere che l’utopia penale mondialealberghi il rischio di uno Stato giurisdizionale globale. Per quanto que-st’esito possa apparire paradossale, lo sviluppo del sistema penale inter-nazionale basato sul principio di sussidiarietà finisce per rafforzare ilruolo degli Stati, esercitando una pressione diffusa perché questi adegui-no il loro strumentario giuridico alle esigenze di contrastare ogni forma dicriminalità politica. Alla base di questo sistema opera la convinzione cheoccorra guardarsi dal «trasporre in modo automatico il funzionamentodella giustizia interna a livello internazionale, quasi a cancellare l’insor-montabile ostacolo della sovranità degli Stati, che resta la sola dimensio-ne capace di coniugare la forza e il diritto». La funzione della giustiziainternazionale non è di negare la sovranità degli Stati ma di «responsa-bilizzarla ingiungendole di non reiterare i propri errori» (Garapon, p.257). La sua funzione rientra quindi nell’ambito della globalizzazione delprincipio di responsabilità, che accanto alla dimensione economica, eco-logica, politica, ha necessariamente anche una componente penale.
Come tutte le politiche, anche la resa dei conti giudiziaria con il pas-sato è tuttavia esposta al rischio di quegli esiti che Albert Hirschman hadefinito, in un saggio famoso, The Rhetoric of Reaction, «futilità», «effettiperversi» e «messa a repentaglio». Se si prescinde dai casi eccezionali diNorimberga e Tokio, da cui non è per altro possibile ricavare una lezionedi portata generale, l’esperienza dei tribunali internazionali è tropporecente e parziale perché si possa trarre qualche generalizzazione.Piuttosto alta appare tuttavia la probabilità che il sostegno delle opinionipubbliche nei confronti di procedimenti giudiziari ad alto costo e a bassorendimento scemi in proporzione al crescere della riluttanza dei governiad impegnarsi in politiche retributive universali a fronte della paralizzan-te inflazione locale del contenzioso giudiziario. Ciò darebbe ragione alpartito degli scettici, per il quale l’istituzione di tribunali internazionalirappresenta soltanto una misura di politica simbolica volta a dissimularel’incapacità della comunità internazionale di scongiurare che situazioni dicrisi degenerino in guerre e guerre civili.
Il futuro della giustizia penale internazionale sembra dunque affidatoad una difficile navigazione tra due opposti scogli: quello del prudenzia-
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
77
le rispetto della sovranità degli Stati e quindi della capitolazione a frontedelle manovre elusive d’insabbiamento o di ricatto strategico da questimesse in atto e quello di un crescente attivismo che porta con sé il rischiodi una globalizzazione dell’inflazione giudiziaria. Un rischio che puòessere soltanto aggirato, ma non scongiurato, da una prassi selettiva ine-vitabilmente esposta all’accusa di parzialità e quindi ad un processo didelegittimazione. I compromessi raggiunti dalle parti contraenti delloStatuto in sede di definizione dei poteri d’iniziativa lasciano aperti molte-plici sviluppi e quindi anche quelli di un naufragio sui suddetti scogli.
Occorre infine tenere presenti anche gli altri ostacoli a cui si è fattocenno nel corso dell’analisi: sul piano dell’elaborazione giuridica i pro-blemi che concernono la definizione della guerra d’aggressione e delgenocidio, i supercrimini politici, non sono affatto risolti. Qui si apreindubbiamente uno spazio in cui ONG e associazioni transnazionali pos-sono svolgere una funzione costruttiva. Tuttavia il ruolo giocato dallasocietà civile non è affatto univoco: serve da sprone alle organizzazioniinternazionali, che hanno negli Stati più un freno che un motore, ma favo-risce anche quella tendenza alla criminalizzazione della politica che fini-sce per ritorcersi contro la causa stessa della giurisdizione internaziona-le. Il conflitto tra Realpolitik e tutela dei diritti umani è destinato a restareuna costante del sistema internazionale anche in una fase di transizioneverso un nuovo ordine cosmopolitico (di cui per altro oggi nessuno è ingrado di pronosticare i contorni). Vi sono molti motivi per dubitare dellecapacità e della volontà degli Stati (di tutti gli Stati) di sottomettersi adun’imparziale giurisdizione internazionale. Ma è dubbio anche che orga-nizzazioni della società civile portatrici di radicali istanze morali, ispira-te più da un’etica dei princìpi che da un’etica della responsabilità, pos-sano costituire il sostrato ideale per la coniugazione di quelle opposte esi-genze.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
78
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
79
BIBLIOGRAFIA
Aa. Vv., 2003, Memoria. Comisiones de la verdad, Comisión de DerechosHumanos del Distrito Federal, México, D. F.
Aa.Vv., 2005, The New Punitiveness. Trends, Theories, Perspectives, Willan,Cullompton (Davon).
Aalders, G., 2000, Geraubt. Die Enteignung des jüdischen Besitzes im ZweitenWeltkrieg, Köln.
Ahlbrecht, H., 1999, Geschichte der völkerrechtlichen Strafgerichtsbarkeit im 20.Jahrhundert. Unter besonderer Berücksichtigung der völkerrechtlichenStraftatbestände und der Bemühungen um einen Ständigen InternationalenStrafgerichtshof, Nomos, Baden-Baden.
Id./Ambos, K. (Hg.), 1999, Der Fall Pinochet(s). Auslieferung wegen staatsver-stärkter Kriminalität?, Nomos, Baden-Baden.
Akçam, T., 1996, Armenien und das Völkerrecht. Die Instambuler Prozesse und dietürkische Nationalbewegung, Hamburger Edition, Hamburg.
Aly, G., 1995, “Endlösung”. Völkerverschiebung und der Mord an den europäi-schen Juden, Fischer, Frankfurt a. M.
Ambos, K., 1997, Straflosigkeit von Menschenrechtsverletzungen. Zur “impuni-dad” in südamerikanischen Ländern aus völkerstrafrechtlicher Sicht, editioniuscrim, Freiburg.
Id., 2002, Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts. Ansätze einerDogmatisierung, Duncker & Humblot, Berlin.
Id./Othman, M. (Ed.), 2003, New Approaches in International Criminal Justice:Kosovo, East Timor, Sierra Leone and Cambodia, edition iuscrim, Freiburg.
Andreopoulos, G. J. (Ed.), 1994, Genocide: Conceptual and HistoricalDimensions, Philadelphia.
Asmal, K./Asmal, L./Roberts, R. S., 1997, Reconciliation through Truth. AReckoning of Apartheid’s Criminal Governance, Philip, Cape Town.
Baker, G./Chandler, D. (Eds.), 2005, Global Civil Society. Contested Futures,Routledge, London.
Baldissara L./Pezzino P. (a cura di), 2004, Crimini e memorie di guerra. Violenzecontro le popolazioni e politiche del ricordo, L’ancora del mediterraneo,Napoli.
Id. (a cura di), 2005, Giudicare e punire. I processi per crimini di guerra tra dirit-to e politica, L’ancora del mediterraneo, Napoli.
Barak, G. (Ed.), 1991, Crimes by Capitalist State. An Introduction to StateCriminality, State University of New York Press, Albany (N. Y.).
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
80
Barkan, E., 2000, The Guilt of Nations. Restitution and Negotiating HistoricalInjustices, Norton, New York.
Bass, G. J., 2000 Stay the Hand of Vengeance. The Politics of War CrimesTribunals, Princeton University Press, Princeton.
Bassiouni, M. C., 1992, Crimes Against Humanity in International Criminal Law,Nijoff, Dordrecht.
Id., 1997, From Versailles to Rwanda in Seventy-Five Years: The Needs to Establisha Permanent International Criminal Court, «Harvard Human Rights LawJournal» 11, pp. 11-62.
Id. (Ed.), 1999a, International Criminal Law, 3 voll., Transnational, New York.Id., 1999b, Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale. Un quadro teo-
rico, Giuffrè, Milano.Id./Wise, E. M., 1995, Aut dedere aut judicare. The Duty to Extradite or Prosecute
in International Law, Nijhoff, Dordrecht.Bauer, Fritz, 1945, Die Kriegsverbrecher vor Gericht, Europa Verlag, Zürich.Beigbeder, Y., 1999, Judging War Criminals: The Politics of International Justice,
St. Martin’s Press, New York.Id., 2002, Judging Criminal Leaders: The Slow Erosion of Impunity, Nijhoff, The
Hague 2002.Bekou, O./Cryer, R. (Ed.), 2004, The International Criminal Court, Ashgate-
Dartmouth, Aldershot.Bell-Fialkoff, A., 1999, Ethnic Cleansing, St. Martin’s Griffin, New York.Bernstorff, J. v., 2001, Der Glaube an das universale Recht. Zur
Völkerrechtstheorie Hans Kelsens und seiner Schüler, Nomos, Baden-Baden.Biegi, M., 2004, Die humanitäre Herausforderung. Der International Criminal
Court und die USA, Nomos, Baden-Baden.Bloxham, D., 2001, Genocide on Trial. War Crimes Trials and the Formation of
Holocaust. History and Memory, Oxford University Press, Oxford.Blum, W., 2001, Rogue State: A Guide to the World’s only Superpower, Zed
Books, London.Bogoeva, J./Fetscher, C. (Hg.), 2002, Srebrenica. Ein Prozess, Suhrkamp,
Frankfurt a. M.Bosch W. J., 1970, Judgment on Nuremberg. American Attitudes Toward the
Major German War-Crime Trials, The University of North Carolina Press,Chapel Hill.
Braithwaite, J., 2002, Restorative Justice & Responsive Regulation, OxfordUniversity Press, Oxford.
Braun, J. (Hg.), 1999, Versöhnung braucht Wahrheit. Der Bericht der südafrikani-schen Wahrheitskommission, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh.
Brennecke, G., 1970, Die Nürnberger Geschichtsentstellung. Quellen zur
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
81
Vorgeschichte und Geschichte des 2. Weltkrieges aus den Akten der deutschenVerteidigung, Verlag der deutschen Hochschullehrer-Zeitung, Tübingen.
Brodesser, H.-J./Fehn, B. J./Franosch, T./Wirth, W., 2000, Wiedergutmachungund Kriegsfolgenliquidation. Geschichte – Regelungen – Zahlungen, Beck,München.
Bouquemont, C., 2003, La Cour Penale Internationale et les Etats-Unis,L’Harmattan, Paris.
Brochhagen, U., 1994, Nach Nürnberg. Vergangenheitsbewältigung undWestintegration in der Ära Adenauer, Junius, Hamburg.
Brode, P., 1997, Casual Slaughters and Accidental Judgements. Canadian WarCrimes Prosecutions, 1944-1948, University of Toronto Press, Toronto.
Brohmall, H., 2003, International Justice and the International Criminal Court:Between Sovereignty and the Rule of Law, Oxford University Press, New York.
Bruneteau, B., 2004, Le siècle des génocides. Violences, massacres et processusgénocidaires de l’Arménie au Rwanda, Colin, Paris.
Brunkhorst, H. (Hg.), 2005, Völkerrechtspolitik. Hans Kelsens Staatsverständnis,Nomos, Baden-Baden.
Brunner B., 2004, Der Frankreich-Komplex. Die nationalsozialistischenVerbrechen in Frankreich und die Justiz der Bundesrepublik Deutschland,Wallstein, Göttingen.
Buruma, I., 1994, The Wages of Guilt. Memoires of War in Germany and Japan,New York.
Calvetti, G./Scovazzi, T. (a cura di), 2004, Dal tribunale per la ex-Jugoslavia allaCorte Penale Internazionale, Giuffrè, Milano.
Cassese, A. (a cura di), 1975, Current Problems of International Law, Giuffrè,Milano.
Id., 2004, Diritto internazionale, 2 voll., il Mulino, Bologna.Id./Chiavario, M./De Francesco, G., 2005, Problemi giuridici attuali della giusti-
zia penale internazionale, Giappichelli, Torino.Id./Gaeta, P./Jones, J., 2002, The Rome Statute for the International Criminal
Court. A Commentary, 3 voll., Oxford University Press, Oxford.M. Cattaruzza, 2002, La ricerca storica sul nazionalsocialismo e le fonti giudizia-
rie, «Storia della storiografia», 41, pp. 101-115.Id./S. Zala, Negoziare la storia? Commissioni storiche bilaterali nell’Europa del
XX secolo, «Storia della storiografia» 45 (2004), S. 129-155.Cesarani, D., 2002, Eichmann. His Life and Crimes, Heinemann, London.Chalk, F./Jonassohn, K., 1990, The History and Sociology of Genocide. Analyses
and Case Studies, New Haven.Chang, I., 2000, Lo stupro di Nanchino. L’olocausto dimenticato della seconda
guerra mondiale, Corbaccio, Milano.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
82
Charny, I. W. (Ed.), 1984, Toward the Understanding and Prevention of Genocide,Boulder, London.
Id. (Ed.), 1999, Encyclopedia of Genocide, ABC-CLIO, Santa Barbara (Cal.)Chiavario, M. (dir.), 2003, La justice pénale internationale entre passé et avenir,
Giuffrè, Milano.Clark, R., 1992, The Fire This Time. U.S. War Crimes in the Gulf, Thunder’s Mouth
Press, New York.Clark, S./Sann, M. (Eds.), The Prosecution of International Crimes, Transaction
Publishers, New Brunswick 1996.Conforti, B./Francioni, F., 1997, Enforcing International Human Rights in Domestic
Courts, Nijhoff, The Hague.Cornelissen, C./Klinkhammer, L./Schwentker, W. (Hg.), 2003,
Erinnerungskulturen. Deutschland, Italien und Japan seit 1945, Fischer,Frankfurt a. M.
Dallaire, R., 2005, Handschlag mit dem Teufel, Zweitausendeins, Frankfurt a. M.Davidson, E., 1973, The Nuremberg Fallacy. Wars and War Crimes Since World
War II, Macmillan, New York.Deak, I./Gross, J. T./Judt, T. (Eds.), 2000, The Politics of Retribution in Europe.
World War II and Its Aftermath, Princeton University Press, Princeton.Donnedieu de Vabres, H., 1928, Les principes modernes du droit pénal interna-
tionale, Sirey, Paris.Dawn Askin, K., 1997, War Crimes Against Women. Prosecution in International
War Crimes Tribunals, Nijhoff, Dordrecht.Demandt, A. (a cura di), 1996, Processare il nemico. Da Socrate a Norimberga,
Einaudi, Torino.Dinstein, Y./Tabory, M. (Ed.), 1996, War Crimes in International Law, Nijhoff, The
Hague.Doehring, K./Fehn, B. J./Hockerts, H. G., 2001, Jahrhundertschuld,
Jahrhundertsühne: Reparationen, Wiedergutmachung, Entschädigung fürnationalsozialistisches Kriegs- und Verfolgungsunrecht, Olzog, München.
Douglas, L., 2001, The Memory of Judgment. Making Law and History in the trialsof the Holocaust, Yale University Press, New Haven.
Dreyer, M./Lembcke, O., 1993, Die deutsche Diskussion um die Kriegsschuldfrage1918/19, Duncker & Humblot, Berlin.
Drost, P. N., 1959, The Crime of State. Penal Protection for Fundamental Freedomsof Persons and Peoples, vol. I, Humanicide. International Governmental CrimeAgainst Individual Human Rights, vol. II, Genocide. United Nations Legislationon International Criminal Law, Sythoff, Leiden.
Dunne, T./Wheeler, N. J. (Eds.), 1999, Human Rights in Global Politics,Cambridge University Press, Cambridge.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
83
Dyzenhaus, D., 1998, Judging the Judges, Judging Ourselves. Truth,Reconciliation and the Apartheid Legal Order, Hart, Oxford.
Eder, K./Spohn, W (Eds.), 2005, Collective Memory and European Identity. TheEffects of Integration and Enlargment, Ashgate, Aldershot.
Eder, W., 2002, Das italienische Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato undder deutsche Volksgerichtshof,Lang, Frankfurt a. M.
Eser, A./Kreicker H. (Hg.), 2003, Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicherVerbrechen, vol. 1, edition iuscrim, Freiburg i. B.
Fein, H., 1979, Accounting for Genocide. National Responses and JewishVictimization during the Holocaust, The Free Press, New York.
Id.,1993, Genocide. A Sociological Perspective, Sage, London.Ferencz, B. J., 1975, Defining International Aggression. The Search for World
Peace. A Documentary History and Analysis, 2 voll., Oceana, New York.Id., 1980, An International Criminal Court. A Step toward World Peace. A
Documentary History and Analysis, Oceana, New York.Fisch, J., 1979, Krieg und Frieden im Friedensvertrag, Klett, Stuttgart 1979.Id., 1992, Reparationen nach dem Zweiten Weltkrieg, Beck, München.Fischer-Hübner, H. (Hg.), 1990, Die Kehrseite der “Widergutmachung”. Das
Leiden von NS-Verfolgten in den Entschädigungsverfahren, Bleicher,Gerlingen.
Fischer-Lescano, A., 2005, Globalverfassung. Die Geltungsbegründung derMenschenrechte, Velbrück Wissenschaft, Weilerswist.
Flores, M. (a cura di), 2001, Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo, BrunoMondadori, Milano.
Focardi, F., 2000, La questione della punizione dei criminali di guerra in Italiadopo la fine del secondo conflitto mondiale, in «Quellen und Forschungen ausitalienischen Archiven und Bibliotheken», 80, pp. 544-624.
Id./Klinkhammer, L., 2001, La questione dei “criminali di guerra” italiani e unaCommissione di inchiesta dimenticata, «Contemporanea» 4, pp. 497-528.
Frei, N., 1996, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und dieNS-Vergangenheit, Beck, München.
Id., 2005, Transnationale Vergangenheitspolitik: der Umgang mit deutschenKriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Wallstein,Göttingen.
Id./van Laak, D./Stolleis, M. (Hg.), Geschichte vor Gericht. Historiker, Richter unddie Suche nach Gerechtigkeit, Beck, München 2000.
Id./Steinbacher, S. (Hg), 2001, Beschweigen und Bekennen. Die deutscheNachkriegsgesellschaft und der Holocaust, Wallstein, Göttingen.
Freudiger, K., 2002, Die juristische Aufarbeitung von NS-Verbrechen, Mohr,Tübingen.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
84
Friedrich, J., 1983, Freispruch für die Nazi-Justiz. Die Urteile gegen NS-Richterseit 1948. Eine Dokumentation, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg.
Id., 1994, Die kalte Amnestie. NS-Täter in der Bundesrepublik, Piper, MünchenId., 1995, Das Gesetz des Krieges. Das deutsche Heer in Russland 1941 bis1945. Der Prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht, Piper,München.
Id./Wollenberg, J. (Hg.), 1987, Licht in den Schatten der Vergangenheit. ZurEnttabuisierung der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, Ullstein,Frankfurt a. M.
Friedrichs, D. O. (Ed.), 1998, State Crime, 2 voll., Ashgate, Aldershot (UK).Garro, A./Dahl, H., 1987, Legal Accountability for Human Rights Violations in
Argentina: One Step forward and two Steps backward, «Human Rights LawJournal» 8, pp. 293-344.
George, A. (Ed.), 1990, Western State Terrorism, Polity Press, London.Giordano, R., 1987, Die zweite Schuld oder Von der Last Deutscher zu sein,
Hamburg.Goldberg, D. T., 2002, The Racial State, Blackwell, Oxford.Goldensohn, L. N., 2004, The Nuremberg Interviews, Knopf, New York.Goschler, C., 1992, Wiedergutmachung. Westdeutschland und die Verfolgten
des Nationalsozialismus (1945-1954), Oldenbourg, München.Id., 2005, Schuld und Schulden. Die Politik der Wiedergutmachung für NS-
Verfolgte seit 1945, Wallstein, Göttingen.Id./Herbst, L. (Hg.), 1989, Wiedergutmachung in der Bundesrepublik
Deutschland, Oldenbourg, München.Id./Ther, P. (Hg.), 2003, Raub und Restitution. “Arisierung” und Rückerstattung
des Jüdischen Eigentums in Europa, Fischer, Frankfurt a. M. 2003.Greppi, E., 2001, Crimini di guerra e contro l’umanità nel diritto internaziona-
le. Lineamenti generali, Utet, Torino.Grewe, W., 1991, Machtprojektionen und Rechtsschranken. Essays aus vier
Jahrzehnten über Verfassungen, politische Systeme und internationaleStrukturen, Nomos, Baden-Baden.
Gutiérrez, T. G., 1991, Reflexiones sobre la impunidad, Consejería Presidencialpara los Derechos Humanos, Bogotà, pp. 219-51.
Hahn-Godeffroy, E., Die südafrikanische Truth and Reconciliation Commission,Nomos, Baden-Baden.
Hankel, G., 2003, Die Leipziger Prozesse. Deutsche Kriegsverbrechen und ihrestrafrechtliche Verfolgung nach dem Ersten Weltkrieg, Hamburger Edition,Hamburg.
Id./Stuby, G. (Hg.), 1995, Strafgerichte gegen Menscheitsverbrechen,Hamburger Edition, Hamburg.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
85
Harrell, P. E., 2003, Rwanda’s Gamble. Gacaca and a New Model of TransitionalJustice, Writers Club Press, New York.
Hassemer, W./Reemtsma, J. P., 2002, Verbrechensopfer. Gesetz undGerechtigkeit, Beck, München.
Hauer, N., 1994, Die Mitläufer. Oder die Unfähigkeit zu fragen. Auswirkungendes Nationalsozialismus für die Demokratie von heute, Leske & Budrich,Opladen.
Hazan, P., 2000, La Justice face à la guerre: de Nuremberg à La Haye, Stock, Pa-ris.
Hayner, P. B., 1994, Fifteen Truth Commissions – 1974 to 1994: A ComparativeStudy, «Human Rights Quaterly» 4, pp. 597-655.
Id., 2001, Unspeakable Truths. Confronting State Terror and Atrocity, Routledge,London.
Heinrich, C., 2004, Grundriss zu einer Philosophie der Opfer der Geschichte,Passagen, Wien.
Henderson, E. A., 2002, Democracy and War: The End of an Illusion?, LynneRienner, Boulder.
Henke, K.-D./Woller, H. (Hg.), 1991, Politische Säuberung in Europa. DieAbrechnung mit Faschismus und Kollaboration nach dem Zweiten Weltkrieg,dtv, München.
Herbert, U./Groehler, O. (Hg.), 1995, Zweierlei Bewältigung. Vier Beiträge überden Umgang mit der NS-Vergangenheit in den beiden deutschen Staaten,Ergebnisse-Verlag, Hamburg.
Herde, R., Command Responsability. Die Verfolgung der “Zweiten Garde” deut-scher und japanischer Generäle im alliierten Prozessprogramm nach demZweiten Weltkrieg, Nomos, Baden-Baden.
Herf, J., 1997, Divided Memory. The Nazi Past in the Two Germanys, HarvardUniversity Press, Cambridge (Ma.).
Heydemann, G./Jesse, E. (Hg.), 1998, Diktaturvergleich als Herausforderung.Theorie und Praxis, Duncker & Humblot, Berlin.
Hilger, A./Schmidt, U./Wagenlehner, G. (Hg.), 2001, SowjetischeMilitärtribunale, vol. I, Die Verurteilung deutscher Kriegsgefangener 1941-1953, Böhlau, Köln.
Hirsch, R., 2001, Um die Endlösung. Prozessberichte, Dietz, Berlin.Hirschfeld, Gerhard, 2001, Der Völkermord im zwanzigsten Jahrhundert –
Plädoyer für eine vergleichende Betrachtung, in Hummel 2001, pp. 78-90.Hockerts, H. G., 2001, Widergutmachung in Deutschland. Eine historische Bilanz
1945-2000, München.Id./Kuller C. (Hg.), 2003, Nach der Verfolgung. Wiedergutmachung national-
sozialistischen Unrechts in Deutschland?, Wallstein, Göttingen.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
86
Id./Moisel, C./Winstel, T. (Hg.), 2005, Die Entschädigung für Verfolgte des NS-Regimes in West- und Osteuropa 1945-2000, ?,.
Horowitz, I. L., 1989, Taking Lives. State Power and Mass Murder, New Brunswick(NJ).
Hummel, H. (Hg.), 2001, Völkermord – Friedenswissenschaftliche Annäherungen,Nomos, Baden-Baden.
Illuminati, G./Stortoni, L./Virgilio, M. (a cura di), 2000, Crimini internazionali tradiritto e giustizia: dai tribunali internazionali alle commissioni verità e riconci-liazione, Giappichelli, Torino.
Isensee, J. (Hg.), 1992, Vergangenheitsbewältigung durch Recht. DreiAbhandlungen zu einem deutschen Problem, Duncker & Humblot, Berlin.
Jäger, Herbert, 1982, Verbrechen unter totalitärer Herrschaft. Studien zur natio-nalsozialistischen Gewaltkriminalität, Frankfurt a. M.
Id., 1989, Makrokriminalität, Suhrkamp, Frankfurt a. M.Jaggi, D., 2004, Das sudafrikanische Gesetz zur Förderung der Nationalen
Einheit und Versöhnung im Spannungsfeld zwischen Konfliktentschärfung,Rechtsstaatlichkeit und Demokratisierung, Lang, Bern.
Johnstone, G., 2002, Restorative Justice. Ideas, Values, Debates, Willan,Cullompton (Davon).
Id. (Ed.), 2003, A Restorative Justice Reader. Texts, sources, context, Willan,Cullompton (Davon).
Jørgensen, N. H. B., 2000, The Responsability of States for International Crimes,Oxford University Press, Oxford.
Jonassohn, K./Björnson, K. S., 1998, Genocide and Gross Rights Violations inComparative Perspective, Transaction, New Brunswick.
Jones, A. (Ed.), 2004, Genocide, War Crimes & the West. History and Complicity,Zed Books, London.
Karsten, P.,1978, Law, Soldiers, and Combat, Greenwood Press, Westport (Ct.).Katz, Steven T., 1994, The Holocaust in Historical Context, I, The Holocaust and
Mass Death before the Modern Age, Oxford UP.Kempner, R. M. W., 1964, SS im Kreuzverhör, Rütten & Loening, München.Id., 1983-1986, Ankläger einer Epoche, Ullstein, Frankfurt a. M.Kiefl, W./Lamnek, S., 1986, Soziologie des Opfers. Theorie, Methoden und
Empirie der Viktimologie, Fink, München.Kielmannsegg, 1989, Lange Schatten – Vom Umgang der Deutschen mit der natio-
nalsozialistischen Vergangenheit, Berlin.Kirchheimer, O., Politische Justiz. Verwendung juristischer Verfahrensmöglichkei-
ten zu politischen Zwecken, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a. M. 1981.Kittel, M., 1993, Die Legende von der “Zweiten Schuld”. Vergangenheitsbewälti-
gung in der Ära Adenauer, Ullstein, Frankfurt a. M.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
87
Klinghoffer, A. J., 1998, The International Dimension of Genocide in Rwanda,New York University Press, New York.
Id./Klinghoffer, J. A., 2002, International Citizens’ Tribunals: Mobilizing PublicOpinion to Advance Human Rights, Palgrave, New York.
Klumpp, G., 2001, Vergangenheitsbewältigung durch Wahrheitskommissionen –das Beispiel Chile, Berlin Verlag, Berlin.
Knigge, V./Frei, N. (Hg.), 2002, Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzungmit Holocaust und Völkermord, Beck, München.
Kochavi, A. J., 1998, Prelude to Nuremberg: Allied War Crimes Policy and theQuestion of Punishment, University of North Carolina Press, Chapel Hill.
Köchler, H., 2003, Global Justice or Global Revenge? International CriminalJustice at the Crossroads, Springer, Wien-New York.
König, H., 2003, Die Zukunft der Vergangenheit. Der Nationalsozialismus im poli-tischen Bewusstsein der Bundesrepublik, Fischer, Frankfurt a. M..
König, H./Kohlstruck, M./Wöll, A. (Hg.), 1998, Vergangenheitsbewältigung amEnde des Zwanzigsten Jahrhunderts, Westdeutscher Verlag, Opladen.
König, K.-M., 2003, Die völkerrechtliche Legitimation der Strafgewalt internatio-naler Strafjustiz, Nomos, Baden-Baden.
Koop, V., 2004, Das Recht der Sieger. Absurde alliierte Befehle imNachkriegsdeutschland, be.bra verlag, Berlin.
Kress, C., 2003, Strafrecht und Angriffskrieg im Licht des “Falles Iraks”, «Zeitschriftfür die gesamte Strafrechtswissenschaft» 115, pp. 294-351.
Kritz, N. J. (Ed.), 1995, Transitional Justice. How Emerging Democracies Reckonwith Former Regimes, 3 voll., United States Institute of Peace Press,Washington, D. C.
Kroh, J., 2005, Holocaust transnational. Zur Institutionalisierung des Holocaust-Gedenkens, «Blätter für deutsche und internationale Politik» 50/6, pp. 741-50.
Kuper, Leo, 1982, Genocide. Its Political Use in the Twentieth Century, YaleUniversity Press, New Haven-London.
Id., 1985, The Prevention of Genocide, Yale University Press, New Haven-London.Labanca, N., 2002, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, il
Mulino, Bologna.Lael, R. L., 1982, The Yamashita Precedent. War Crimes and Command
Responsability, Scholarly Resources Inc., Wilmington (Delaware).Lattanzi, F./Sciso, E. (a cura di), 1996, Dai Tribunali internazionali “ad hoc” a una
corte permanente, Editoriale Scientifica, Napoli.Lattimer, M./Sands, P. (Eds.), 2003, Justice for Crimes Against Humanity, Hart
Publishing, Oxford.Lauf, E., 1994, Der Volksgerichtshof und sein Beobachter. Bedingungen und
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
88
Funktionen der Gerichtsberichterstattung im Nationalsozialismus, Westdeut-scher Verlag, Opladen.
Lee, R. S. (Ed.), The International Criminal Court. The Making of the Rome Statute.Issues, Negotiations, Results, Kluwer, The Hague 1999.
Id., 2001, The International Criminal Court. Elements of Crimes and Rules ofProcedure and Evidence, Transnational Publ., Ardsley (N. Y.).
Lehmler, L., 1999, Die Strafbarkeit von Vertreibungen aus ethnischen Gründen imbewaffneten nicht-internationalen Konflikt. Zugleich ein Beitrag zur neuerenEntwicklung des Völkerstrafrechts, Nomos, Baden-Baden.
Lemkin, R., 1944, Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation – Analysisof Government – Proposal for Redress, Carnegie Endowment for InternationalPeace, Washington.
Lingen v., K., 2004, Kesselrings lezte Schlacht. Kriegsverbrecherprozesse,Vergangenheitspolitik und Wiederbewaffnung: Der Fall Kesselring, Schöningh,Paderborn.
Little, , 1999, A Different Kind Of Justice: Dealing with Human Rights Violations inTransitional Societies, in «Ethics & International Affairs» 13, pp. 43-80.
Litvin, A./Keep, J., 2005, Stalinism. Russian and Western Views at the Turn of theMillennium, Routledge, London.
Ludwig, J., 1989, Boykott – Enteignung – Mord. Die “Entjudung” der deutschenWirtschaft, Facta, Hamburg.
Lübbe, H., 2001, “Ich entschuldige mich”. Das neue politische Bussritual, Siedler,Berlin.
Lübbe, W., 1998, Verantwortung in komplexen kulturellen Prozessen, Alber,Freiburg.
Lutz, D. S./Giessmann, H. J. (Hg.), 2003, Die Stärke des Rechts gegen das Rechtdes Stärkeren. Politische und rechtliche Einwände gegen eine Rückkehr desFaustrechts in die internationalen Beziehungen, Nomos, Baden-Baden.
Lutz, T., 2002, Restorative Justice – Visionäre Alternative oder Version des Alten?,Lit, Hamburg.
Macedo, S. (Ed.), 2004 Universal Jurisdiction. National Courts and theProsecution of Serious Crimes under International Law, University ofPennsylvania Press, Philadelphia.
Maguire, P., 2000, Law and War. An American History, Columbia UniversityPress, New York.
Mandel, M., 2004, How America Gets Away With Murder. Illegal Wars,Collateral Damage and Crimes Against Humanity, Pluto Press, London.
Mann, M., 2005, The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing,Cambridge University Press, Cambridge.
Manoschek, W. (Hg.), 1996, Die Wehrmacht im Rassenkrieg. Der Vernichtungs-krieg hinter der Front, Picus, Wien.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
89
Maogoto, J. N., 2004, War Crimes and Realpolitik. International Justice fromWorld War I to the 21st Century, Lynne Rienner, Boulder (Col.)
Marxen, K., 1994, Das Volk und sein Gerichtshof. Eine Studie zum nationalsozia-listischen Volksgerichtshof, Klostermann, Frankfurt a. M.
Id./Werle, G., 1999, Die Strafrechtliche Aufarbeitung von DDR-Unrecht. EineBilanz, de Gruyter, Berlin.
Maser, W., 1977, Nürnberg. Tribunal der Sieger, Econ, Düsseldorf.Melson, R., 1992, Revolution and Genocide. On the Origins of the Armenian
Genocide and the Holocaust, University of Chicago Press, Chicago.Messerschmidt, M., 2005, Die Wehrmachtjustiz 1933-1945, Schöningh,
Paderborn.Minear, R. H., 1971, Victors’ Justice. The Tokyo War Crimes Trial, Princeton
University Press, Princeton.Minnerop, P., 2004, Paria-Staaten im Völkerrecht?, Springer, Berlin.Minow, M., 1998, Between Vengeance and Forgiveness. Facing History after
Genocide and Mass Violence, Boston.Miquel, M. v., 2004, Ahnden oder amnestieren? Westdeutsche Justiz und
Vergangenheitspolitik in den sechziger Jahren, Wallstein, Göttingen.Mohler, A., 1989, Der Nasenring. Im Dickicht der Vergangenheitsbewältigung,
Essen.Moisel, C., 2004, Frankreich und die deutschen Kriegsverbrecher. Politik und
Praxis der Strafverfolgung nach dem zweiten Weltkrieg, Wallstein, Göttingen.Morris, V./Scharf, M. P., 1998, The International Criminal Tribunal for Ruanda,
Transnational Publishers, Irvington-on-Hudson (N. Y.).Müller, K., 2001, Oktroyerte Verliererjustiz nach dem Ersten Weltkrieg, in «Archiv
für Völkerrecht» 39, pp. 202-222.Müller, R. M., 1994, Normal-Null und die Zukunft der deutschen Vergangenheits-
bewältigung. Ein Essay, SH-Verlag, Schernfeld.Naimark, N., 2001, Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth-Century
Europe, Harvard University Press, Cambridge.Naucke, W., 1996, Die strafjuristische Privilegierung staatsverstärkter Kriminalität,
Klostermann, Frankfurt a. M.Nill-Theobald, C., 1998, “Defences” bei Kriegsverbrechen am Beispiel
Deutschlands und der Usa, edition iuscrim, Freiburg i. B.Nolte, D. (Hg.), 1996, Vergangenheitsbewältigung in Lateinamerika, Vervuert,
Frankfurt a. M.Nürnberger Menschenrechtszentrum (Hg.), 1996, Von Nürnberg nach Den Haag.
Menschenrechtsverbrechen vor Gericht. Zur Aktualität des NürnbergerProzesses, Hamburg.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
90
O’Shea, A., 2002, Amnesty for Crime in International Law and Practice, Kluwer,The Hague.
Osiel, M. J., 1997, Mass Atrocity, Collective Memory and Law, Transaction, NewBrunswick.
Id., 1999, Obeying Orders. Atrocity, Military Discipline and the Law of War,Transaction, New Brunswick.
Id., 2001, Mass Atrocity, Ordinary Evil, and Hannah Arendt. CriminalConsciousness in Argentina’s Dirty War, Yale UO, New Haven.
Overy, R., 2001, Interrogations, Penguin Press.Pastore, B., 2001, International Law in a Changing World: Towards a Judge-made
Law?, «Ars Interpretandi» 6, pp. 151-185.Pedrazzi, M., 2001, Corti internazionali, «Enciclopedia delle Scienze Sociali», IX,
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 76-91.Peyró Llopis, A., 2003, La compétence universelle en matière de crimes contre
l’humanité, Bruylant, Bruxelles 2003.Plack, A., 1974, Plädoyer für die Abschaffung des Strafrechts, List, München.Politi, M./Nesi., G. (Eds.), 2004, The International Criminal Court and the Crime
of Aggression, Ashgate, Aldershot 2004.Posel, D./Simpson, G. (Ed.), 2002, Commissionin the Past. Understanding South
Africa’s Truth and Reconciliation Commission,Witwatersrand University Press,Johannesburg.
Pross, C., 1988, Wiedergutmachung. Der Kleinkrieg gegen die Opfer, Athenäum,Frankfurt a. M.
Quaritsch, H, 1995, Giustizia politica. Le amnistie nella storia, a cura di P. P.Portinaro, Giuffrè, Milano.
Ramshaw, P./Steers, T. (Ed.), 1987, Intervention on Trial. The New York WarCrimes Tribunal on Central America and the Caribbean, Praeger, New York.
Reydams, L., 2003, Universal Jurisdiction. International and Municipal LegalPerspectives, University Press, Oxford.
Rigby, A., 2001, Justice and Reconciliation. After the Violence, Lynne Rienner,Boulder.
Risse, T./Ropp, S./Sikking, K. (Eds.), The Power of Human Rights. InternationalNorms and Domestic Change, Cambridge University Press, Cambridge.
Robertson, G., 2002, Crimes Against Humanity. The Struggle for Global Justice,The New Press, New York.
Roebuck,J./Weeber, S. C., 1978, Political Crime in the United States. AnalyzingCrime by and against Government, Praeger, New York.
Röling, B. V. A./Rüter, F., 1977, The Tokio Judgment, Amsterdam University Press,Amsterdam.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
91
Röling, B. V, A./Cassese, A., 1993, The Tokyo Trial and Beyond, Polity Press, Lon-don.
Ronzitti, N., 2001, Diritto internazionale dei conflitti armati, Giappichelli, Torino.Ross, J. I. (Ed.), 1995, Controlling State Crime. An Introduction, Garland, New
York 1995.Id. (Ed.), 2000, Varieties of State Crime and ist Control, Criminal Justice Press,
Monsey (N. Y.).Rotberg, R./Thompson, D. (Eds.), 2000, Truth v. Justice, Princeton University Press,
Princeton.Roxin, Claus, 2000, Täterschaft und Tatherrschaft, Berlin.Rückerl, A., 1984, NS-Verbrechen vor Gericht. Versuch einer
Vergangenheitsbewältigung, Müller, Heidelberg.Ruge, C., 2004, Versöhnung durch Vergangenheitsbewältigung? Die südafrikani-
sche Wahrheits- und Versöhnungskommission und ihr Versuch zurFriedenssicherung, Lang, Frankfurt a. M.
Rummel, R. J., 1990, Lethal Politics: Soviet Genocide and Mass Murder since1917, Transaction, New Brunswick.
Id., 1991, China’s Bloody Century: Genocide and Mass Murder since 1900, ivi.Id., 1992, Democide: Nazi Genocide and Mass Murder, ivi.Id., 1995, Death by Government, ivi.Id., 1998, Statistics of Democide. Genocide and Mass Murder since 1900, Lit,
Münster.Rupprecht, J., 2003, Frieden durch Menschenrechtsschutz. Strategien der
Vereinten Nationen zur Verwirklichung der Menschenrechte weltweit, Nomos,Baden-Baden.
Rusconi, G. E./Woller, H. (a cura di), 2005, Italia e Germania 1945-2000. Lacostruzione dell’Europa, il Mulino, Bologna.
Russell, B., 1967, War Crimes in Vietnam, Allen & Unwin, London.Rüter-Ehlermann, A./Rüter, C. F. (Hg.), 1968-2005, Justiz und NS-Verbrechen, 34
voll., Amsterdam.H. Satzger, 2005, Internationales und Europäisches Strafrecht, Nomos, Baden-
Baden.Schabas, W. A., 2000, Genocide in International Law. The Crimes of Crimes,
Cambridge University Press, Cambridge.Id., 2004, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge UP,
Cambridge.Schafer, S., 1974, The Political Criminal. The Problem of Morality and Crime, The
Free Press, London.Schaal, G. S./Wöll, A. (Hg.), 1997, Vergangenheitsbewältigung. Modelle der
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
92
politischen und sozialen Integration in der bundesdeutschen Nachkriegsge-schichte, Nomos, Baden-Baden.
Scharf, M. P., 1997, Balkan Justice. The Story Behind the First International WarCrimes Trial Since Nuremberg, Carolina Academic Press, Durham.
Scherrer, C. P., 1997, Ethnisierung und Völkermord in Zentralafrika. Genozid inRwanda, Bürgerkrieg in Burundi und die Rolle der Weltgemeinschaft, Campus,Frankfurt a. M.
Schlüter, H., 1995, Die Urteilpraxis des nationalsozialistischen Volksgerichtshofs,Duncker & Humblot, Berlin.
Schlunck, A., 2000, Amnesty versus Accountability. Third Party InterventionDealing with Gross Human Rights Violations in Internal and InternationalConflicts, Berlin Verlag, Berlin.
Schmitt, C., 1991, Il nomos della terra nel diritto internazionale dello “jus publi-cum europaeum”, Adelphi, Milano,
Id., 1994, Das internationalrechtliche Verbrechen des Angriffskrieges und derGrundsatz “Nullum crimen, nula poena sine lege”, hg. v. H. Quaritsch,Duncker & Humblot, Berlin.
Id., 2005, Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internatio-nalen Politik 1924-1978, hg. v. G. Maschke, Duncker & Humblot, Berlin.
Schneckener, U., 2002, Auswege aus dem Bürgerkrieg. Modelle zur Regulierungethno-nationalistischer Konflikte in Europa, Suhrkamp, Frankfurt a. M.
Schneider, P., 2003, Internationale Gerichtsbarkeit als Instrument friedlicherStreitbeilegung. Von einer empirisch fundierten Theorie zu einem innovativenKonzept, Nomos, Baden-Baden.
Schreiber, G., 1996, Deutsche Kriegsverbrechen in Italien. Täter, Opfer,Strafverfolgung, Beck, München.
Schwan, G., 1997, Politik und Schuld. Die zerstörerische Macht des Schweigens,Fischer, Frankfurt a. M.
Seidler, F. W./de Zayas, A. M. (Hg.), 2002, Kriegsverbrechen in Europa und inNahen Osten im 20. Jahrhundert, Mittler, Hamburg.
Selbmann, F., 2002, Der Tatbestand des Genozids im Völkerstrafrecht, LeipzigerUniversitätsverlag, Leipzig.
Sewall, S. B./Kaysen, C., 2000, The United States and the International CriminalCourt, National Security and International Law, Rowman & Littlefield, Lanham.
Shklar, J., 1986, Legalism: Law, Moral and Political Trials, Harvard UniversityPress, Cambridge.
Smith, B. F., 1976, Reaching Judgement at Nuremberg. The Untold Story of Howthe Nazi War Criminals Were Judged, Basic Books, New York.
Smith, G. (Hg.), 2000, Hannah Arendt Revisited: “Eichmann in Jerusalem” und dieFolgen, Suhrkamp, Frankfurt a. M.
Id./Margalit, A. (Hg.), 1997, Amnestie oder Die Politik der Erinnerung in derDemokratie, Suhrkamp, Frankfurt a. M.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
93
Solis, G. D., 1997, Son Thang. An American War Crime, Naval Institute Press,Annapolis.
Stella, F., 2001, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tuteladelle vittime, Giuffrè, Milano.
Stohl, M./Lopez, G. A. (Ed.), 1984, The State as Terrorist. The Dynamics ofGovernmental Violence and Repression, London.
Strang, H., 2002, Repair or Revenge. Victims and Restorative Justice, Clarendon,Oxford.
Süss, F., 2001, Studien zur Amnestiegesetzgebung, Duncker & Humblot, Berlin.Tangermann, C., 2002, Die völkerrechtliche Immunität von Staatsoberhäuptern –
Grundlagen und Grenzen, Duncker & Humblot, Berlin.Tanner, J./Weigel, S. (Hg.), Gedächtnis, Geld und Gesetz. Vom Umgang mit der
Vergangenheit des Zweiten Weltkrieges, Zürich 2002.Tarantino, A. /Rocco R. (a cura di), 1998, Il processo di Norimberga a cin-
quant’anni dalla sua celebrazione, Giuffrè, Milano.Tate, C. N./Vallinger, T., 1995, The Global Expansion of Judicial Power, New
York.Taylor, T., 1970, Nuremberg and Vietnam: an American Tragedy, Quadrangle
Books, Chicago.Id., 1981, A Trial of Generals: Homma, Yamashita, MacArthur, Icarus, South
Bend.Id., 1996, Anatomia dei Processi di Norimberga, Rizzoli, Milano.Teitel, R. G., 2000, Transitional Justice, Oxford University Press, Oxford.Ternon, Y., 1997, Lo Stato criminale. I genocidi del XX secolo, Corbaccio, Milano.Tolmein, O., 2000, Welt Macht Recht. Konflikte im internationalem System nach
dem Kosovo-Krieg, Konkret Literatur, Hamburg. Id., 2004, Richten im Namen der Menschheit. Der Internationale Strafgerichtshof
und die Neuordnung der Welt, Campus, Frankfurt.Torpey, J. (Ed.), 2003, Politics and the Past. On Repairing Historical Injustices,
Lanham.Totten, S. (Hg.), 1995, Genocide in the Twentieth Century. Eyewittness Accounts
and Critical Views, Garland, New York.Trassl, M., 1994, Die Wiedergutmachung von Menschenrechtsverletzungen im
Völkerrecht, Duncker & Humblot, Berlin.Treves, T., 1999, Le controversie internazionali. Nuove tendenze, nuovi tribunali,
Giuffrè, Milano.Triffterer, O, 1999, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal
Court, Nomos, Baden-Baden.Tutorow, N. E. (Ed.), 1986, War Crimes, War Criminals, and War Crimes Trials.
An Annotated Bibliography and Source Book, Greenwood Press, New York.
WPAP
ERS
ORKINGDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO
94
Ueberschär, G. R. (Hg.), 1999, Der Nationalsozialismus vor Gericht. Die alliiertenProzesse gegen Kriegsverbrecher und Soldaten 1943-1952, Fischer, Frankfurta. M.
Uildriks, N./van Reenen, P., 2003, Policing Post-Communist Societies. Police-Public Violence, Democratic Policing and Human Rights, Intersentia, Antwerp.
Urselmann, K., 2000, Die Bedeutung des Barbie-Prozesses für die französischeVergangenheitsbewältigung, Lang, Frankfurt a. M.
Valentino, B. A., Final Solutions. Mass Killing and Genocide in the TwentiethCentury, Cornell University Press, Ithaca.
Vassalli, S., 1995, La giustizia internazionale penale, Giuffrè, Milano.Id., 2001, Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei “delitti
di Stato” nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista, Giuffrè,Milano.
Vest, H., 2002, Genozid durch organisatorische Machtapparate. An der Grenzevon individueller und kollektiver Verantwortlichkeit, Nomos, Baden-Baden.
Voiculescu, A., 2000, Human Rights and Political Justice in Post-CommunistEastern Europe. Prosecuting History, The Edwin Mellen Press, Lewiston.
Volcansek, M. L. (Ed.), 1997, Law above Nations. Supranational Courts and theLegalization of Politics, University Press of Florida, Gainesville.
Vollnhals, C., 1991, Entnazifizierung. Politische Säuberung und Rehabilitierung inden vier Besatzungszonen 1945-1949, dtv, München.
Walgrave, L. (Ed.), 2003, Repositioning Restorative Justice, Willan, Cullompton(Davon).
Wallimann, I./Dobkowski, M. N. (Ed.), 1987, Genocide and the Modern Age:Etiology and Case Studies of Mass Death, New York.
Weber, H. v., 1934, Internationale Strafgerichtsbarkeit, Dümmlers, Berlin 1934.Weinke, A., 2002, Die Verfolgung von NS-Tätern im geteilten Deutschland.
Vergangenheits-bewältigungen 1949-1969 oder: Eine deutsch-deutscheBeziehungsgeschichte im kalten Krieg, Schöningh, Paderborn.
Weitekamp, E. G. M./Kerner, H.-J. (Ed.), 2003, Restorative Justice in Context.International Practice and Directions, Willan, Cullompton (Davon).
Wenzl, I., 2001, Der Fall Pinochet. Die Aufarbeitung der chilenischenMilitärdiktatur, Isp, Köln.
Werle, G., 2003, Völkerstrafrecht, Mohr Siebeck, Tübingen.Wette, W., 2001, Kriegsverbrechen im 20. Jahrhundert, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt.Wieviorka, A. (dir.), 1996, Les procès de Nuremberg et Tokyo, Complexe,
Bruxelles.Williams, P. R./Scharf, M. P., 2002, Peace with Justice? War Crimes and
Accountability in the Former Yugoslavia, Rowman & Littlefield, Lanham.
PIER PAOLO PORTINARO – CRIMINI POLITICI E GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
WPAP
ERS
ORKING
95
Willis, J. W., 1982, Prologue to Nuremberg: The Policy and Diplomacy ofPunishing War Criminals of the First World War, Greenwood, Westport(Conn.).
Wink, W., 1998, When the Powers Fall: Reconciliation in the Healing of Nations,Minneapolis 1998.
Wolf, B., 2004, Die Sorge des Souveräns. Eine Diskursgeschichte des Opfers,diaphanes, Zürich.
Woller, H., 2004, I conti con il fascismo. L’epurazione in Italia 1943-1948, ilMulino, Bologna.
Yablonka, H., 2004, The State of Israel vs. Adolf Eichmann, Schocken Books, NewYork.
Yacoubian, G. S. jr., 1998, Sanctioning Alternatives in International Criminal Law.Recommendations for the International Criminal Tribunals for Rwanda and forthe Former Yugoslavia, «World Affairs» 161, pp. 48-54.
Yuki, Tanaka, 1996, Hidden Horrors. Japanese War Crimes in World War II,Westview Press, Boulder (Col.).
Zappalà, S., 2005, La giustizia penale internazionale, il Mulino, Bologna.Zoglin, K., 2005, The Future of War Crimes Prosecutions in the Former Yugoslavia:
Accountability or Junk Justice?, «Human Rights Quarterly» 27, pp. 41-77.Zolo, D., 1995, Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale, Feltrinelli,
Milano.Id., 2000, Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale, Einaudi, Torino.Id., 2001, I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico, Carocci,
Roma.Zweig, R. W., 1987, German Reparations and the Jewish World: A History of the
Claims Conference, Westview Press, Boulder (Col.).