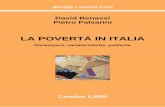Delli Zotti 2007 Are you experienced…? Trasformazione di variabili e creazione di indici con Spss
Delli Zotti 2000 Invidia, giustizia e povertà relativa
Transcript of Delli Zotti 2000 Invidia, giustizia e povertà relativa
INDICE
Nota introduttiva, di Bernardo Cattarinussi 11
Parte Prima APPROCCI SOCIOLOGICI ALLE EMOZIONI
Sentimenti ed emozioni nella riflessione sociologica, 15 di Bernardo Cattarinussi
Premessa 15 1. La disattenzione dei classici 16 2. Alcuni precursori 17 3. Gli approcci contemporanei 19 4. Impatto sociale dei sentimenti 24 5. Emozioni e cultura 28 6. Le norme emozionali 29 7. Devianza emozionale 31 8. I sentimenti nell’età post-moderna 33
Le emozioni come processi sociali. Considerazioni teorico-epi- 37 stemologiche, di Sergio Manghi
Premessa 37 1. La rappresentazione individualistica delle emozioni 39 2. Verso una teoria sociale delle emozioni 41 3. Le emozioni dei sociologi 41
Il colore delle esperienze e delle azioni. Le emozioni nell'analisi 47 sociologica della vita quotidiana, di Italo De Sandre
1. Intersezione di saperi e valore aggiunto dell’analisi sociologica 47 2. Un approccio “ologrammatico” 48 3. Le emozioni tra l’essere soggetti e l’essere attori 49 4. Analisi sociologica dell’esperire oltre che dell’agire 51 5. Emozioni e comunicazione: interrogativi 53 6. Emozioni in una società con codici simbolici caotici 54 7. Indicatori di emozioni nella sociologia sulla vita quotidiana? 56
Emozioni e strutture sociali, di Alfredo Milanaccio 59 Premessa 59 1. Le emozioni e la tarda modernità 59 2. Le emozioni e la teoria sociologica 62 3. Sul problema della universalità/specificità culturale 64 4. Un’emozione giapponese: amae 66
Emozioni e buone maniere, di Valentina D'Urso 73
1. Di cosa parliamo quando parliamo di emozioni 73 2. Le buone maniere 74 3. La competenza emotiva 76 4. Competenza emotiva e competenza sociale 80 5. Quali emozioni stanno alla base del galateo? 84
Sentimenti e selfish part nella crisi della modernità, 89 di Nino Salamone
Premessa 89 1. La soggettivizzazione 90 2. La libertà privata 96 3. Democratizzazione della sfera privata? 100
Lo spettacolo delle emozioni, di Gabriella Turnaturi 103
1. Le culture emozionali 103 2. Il rapporto esperienza-emozioni 106 3. L’esibizione delle emozioni 107
L'emozione della ragione, di Maria Cristina Marchetti 111
1. L’agire emozionale e le radici della modernità 111 2. Ragione e sentimento: il destino della razionalità 114
La grammatica weberiana delle passioni, di Andrea Sormano 119
Premessa 119 1. Analisi concettuale e ricerca empirica 120 2. I vocabolari dell’attore sociale 122 3. Il vocabolario della “creatività”. La critica weberiana alla 124 “psicologia metafisica” di Wundt 4. “Comprensione” e “interpretazione”. La critica weberiana 128 al “linguaggio psicologistico” di Simmel 5. Identità locale e personalità totale. L’analisi weberiana dei 132 processi di mostrificazione e di idolizzazione 6. Sentimenti, emozioni, regole 137
Emozioni e teoria mimetica di René Girard, 141 di Stefano Tomelleri
Premessa 141 1. Il tabù dell’invidia 141 2. L’idea di imitazione reciproca 143 3. L’invidia tra paradosso e morfogenesi 144
Parte Seconda L'ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI
Uno studio sulla regolazione delle emozioni in ambiente carce- 149 rario, di Rosanna Trentin, Maria Grazia Monaci, Monica Areddia
Premessa 149 1. Metodo 151 2. Risultati 153 3. Discussione 161
Il lessico emozionale nelle lingue neolatine. Un confronto tra 165 catalano e castigliano, di Dario Galati, Fausto Massimini, Bar- bara Sini
Premessa 165 1. Obiettivi e ipotesi della ricerca 167 2. Metodo 167 3. Fase di selezione dei termini emozionali 167 4. Fase sperimentale 170 5. Discussione e conclusioni 181
Tracce nella memoria. Odori ed emozioni, di Lucia Zanuttini, 185 Loredana Hvastja, Renata Kodilja
Premessa 185 1. Esperimento 1 186 2. Esperimento 2 190 Conclusioni 192 Appendice A 195 Appendice B 197
Parte Terza
I SENTIMENTI SOCIALI
La dimensione “religioide” della fiducia istituzionale e inter- personale nella sociologia di Georg Simmel, di Riccardo 201 Prandini
1. Introduzione al problema e sommario 201 2. L’unità dell’insieme sociale come garanzia del processo di 202 simbolizzazione del denaro 3. Le radici fiduciarie metateoriche dell’economia monetaria 206 4. Le due analogie: fede pratica/fede trascendente, unità di 209 Dio/unità del gruppo sociale 5. La società perfetta, la divisione del lavoro e il sentimento 214 di solidarietà: il “Regno di Dio” come rappresentazione dell’unità sociale 6. Dentro la modernità, oltre il processo di funzionalizzazio- 217 ne. Il ritorno dell’umano e la logica della supererogazione
La fiducia nella comunicazione interpersonale, 227 di Mariselda Tessarolo
Premessa 227 1. La vergogna 231 2. L’imbarazzo 232 3. La simulazione 233 4. L’ambiguità 235
Conclusioni 237
Fiducia e democrazia deliberativa, di Luigi Pellizzoni 241 Introduzione 241 1. Virtù e problemi della democrazia deliberativa 243 2. Democrazia deliberativa e fiducia 251 Conclusione 259
Elogio dell'inganno. Le funzioni sociali della menzogna e della 267 mezza verità, di Guido Gili
1. Sull’inganno 267 2. I “paradossi” della verità e della menzogna 269 3. Sull’utilità sociale della menzogna 273 4. Funzioni e limiti della “parvenza della sincerità” 274
"Uva acerba". Lo sguardo traverso del risentimento, 277 di Francesca Ursula Bitetto
1. Il sottosuolo dell’uomo 277 2. Uva acerba 278 3. Lo sguardo traverso del risentimento 280 4. Cattiva coscienza 282 5. Invidiosi e vanitosi 282 6. Sguardi reciproci e paradossi 284 7. La cattiva infinità 285 8. Le promesse impossibili 286 9. Pietre di scarto 287 10. Risentimento e morale 289 11. Risentimento e cultura 291
Invidia, giustizia sociale e povertà relativa, di Giovanni 295 Delli Zotti
1. L’invidia nei rapporti interpersonali 295 2. L’invidia nei rapporti tra gruppi sociali 299 3. L’invidia nei rapporti internazionali 301 4. Popoli e sentimenti 304 5. Invidia e giustizia sociale 306 6. Invidia e povertà relativa 308
È la ragione una serva della paura?, di Francesco Sidoti 313 Premessa 313 1. La calcolabilità della paura 314 2. La sociobiologia della paura 316 3. Paura ed eccedenza di percezione 317 4. L’ansietà informativa 319 5. Paura e tipologie di società 321 6. Dalla paura di Dio alla paura del Comunismo 323 7. All’inizio della terza ondata: la paura del futuro e di noi 325 stessi 8. Paura e odio 329 9. Insicurezza e istituzioni 330
Corpo e alimentazione nella cultura tardo-moderna. La paura 337 di ingrassare, di Michaela Liuccio
1. La lipofobia 337 2. Le ragioni socio-culturali 338 3. La dietetica 341 Alcune conclusioni 343
Parte Quarta LA RAPPRESENTAZIONE DELLE EMOZIONI
L'arte come raffigurazione delle emozioni, di Raimondo Strassoldo 347
Introduzione 347 1. Il Classicismo: arte come raffigurazione della verità 348 2. La rappresentazione dei sentimenti nell’arte occidentale 350 3. Breve storia della fisionomica 352 4. La pittura come proiezione della soggettività: il caso del 360 Giudizio di Michelangelo Conclusione 361
Pro e contro la razionalizzazione nell'arte, di Laura Verdi 363 1. Emotività e modernità 363 2. Emozioni calde e fredde. Il caso dell’arte 366
Per uno studio sulle emozioni nel "Mastro-Don Gesualdo" 373 di Verga, di Ada Neiger
Premessa 373 1. Collera 373 2. Imbarazzo 376 3. Invidia 378 4. Paura 379 5. Tristezza 380
INVIDIA, GIUSTIZIA SOCIALE E POVERTÀ RELATIVA
di Giovanni Delli Zotti
«Ci si fa spesso un vanto delle passioni, anche delle più delit-tuose; ma l'invidia è una passione timida e vergognosa che non si osa mai confessare» (La Rochefoucauld, Massime)
1. L'invidia nei rapporti interpersonali L'invidia non gode certo di buona fama: tra tutti i sentimenti è probabilmente
quello più riprovevole o, per lo meno, quello più riprovato. Come ha fatto notare in uno dei suoi arguti aforismi La Rochefoucauld, citato in epigrafe, noi siamo spesso vanitosi anche delle nostre passioni più sfrenate, ma ci vergogniamo del-l'invidia.
Pur essendo uno dei sette peccati capitali, Dante si limita a trovare un posto nel Purgatorio (canto XIII) per coloro che se ne macchiano, ma il tormento che viene loro inflitto è abbastanza pesante e del tutto appropriato (legge del contrappasso): gli invidiosi hanno le palpebre cucite. Invidia, infatti, dal verbo “invidere” che si-gnifica “guardare con inimicizia”, da in- (=contro) e videre (=guardare) (Colonna 1979: 195).
La spiegazione del “trattamento di favore” riservato da Dante agli invidiosi, al confronto con la sorte toccata agli altri peccatori “capitali”, ci viene suggerita da D'Urso e Trentin, le quali “insinuano” che il sommo poeta abbia previsto la possi-bilità di una redenzione finale «forse in considerazione della pena che questo sen-timento già apporta al vizioso, a differenza di molti peccati praticati perché sicu-ramente e subito apportatori di piacere» (1998: 261). In effetti, l'invidioso già paga su questa Terra, proprio a causa dello stigma sociale che rende massimamente ri-provevole colui che si macchia di questo peccato. Inoltre, si tratta di un peccato che, a differenza di tutti gli altri, non porta, almeno apparentemente, alcun vantag-gio al peccatore.
Il confronto tra i diversi peccati è in effetti stato tentato e dimostrerebbe pro-prio la particolare “insanità” del sentimento dell’invidia (Nosei 1996). I sette pec-cati capitali - orgoglio, lussuria, gola, avidità, ira, pigrizia, invidia -, sui quali si regola la morale occidentale e cristiana, sarebbero da rivedere in base alla teoria di un gruppo di medici che, nell'ultimo numero del 1996 del British Medical Journal, hanno “aggiornato” gli assiomi morali delle grandi religioni monoteiste.
Emozioni e sentimenti 295 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
«La lussuria non sarebbe un semplice desiderio sessuale senza freni, ma una forza della natura necessaria alla procreazione, che ci spinge ad essere più decisi e attraenti. L'orgoglio è un valore positivo che rappresenta un'emozione necessaria al consolidamento della sicurezza di un individuo. La gola non è solo abbuffarsi, ma anche godere di semplici piaceri. Non ha, inoltre, cadute socialmente negative e comunque è meglio dell'anoressia, che induce invece a respingere ossessivamente il cibo. L'avidità non è solo avarizia, ma anche sete di potere e di successo. È in-somma il motore del progresso che ha dato il benessere all'uomo contemporaneo. Non va nemmeno demonizzata l'ira, che può avere anche risvolti positivi, come quella che porta un cittadino a insorgere contro le ingiustizie o un giudice a punire un crimine in nome della comunità. L'accidia non è solo pigrizia, ma riflette a volte il bisogno di una pausa, il prendersi uno spazio per pensare o distrarre la mente. L'invidia è l'unico dei sette peccati capitali privo di caratteristiche positive» (Nosei 1996).
Forse quest'ultima affermazione è un po' eccessiva perché anche la valenza (positiva o negativa) dell'invidia può essere problematizzata, in quanto anch'essa (come l'ira o l'avarizia) può essere “sublimata” in qualche forma e diventare un po-tente motore del mutamento sociale.
Continuando, comunque, ad analizzare la natura di questo sentimento, dobbia-mo chiederci: chi e perché “guardare contro” quando si è invidiosi? Della questio-ne si sono occupati ampiamente, come è ovvio, gli psicologi, ma anche la rifles-sione sociologica vi si è soffermata, perché si tratta di un sentimento, come vedre-mo, con profonde implicazioni sociali.
L'invidia appare una caratteristica congenita, universale, inevitabile e inelimi-nabile (Foglia 1990: 197). Tutto ciò fa pensare che sia profondamente radicata nel-la natura umana e di ciò sono convinti i sociobiologi, che ne danno una spiegazio-ne in chiave evoluzionistica. Si parte dalla considerazione che gli uomini (ma an-che le donne) si ritrovano a dover fare fronte ad esigenze contraddittorie: devono al tempo stesso competere e cooperare con altri individui ed è qui che si inserisce l'invidia. Per il “gene egoista” la cooperazione, l'amore e la fedeltà non sono “fun-zionali”. Se un uomo con tre mogli ne fosse pienamente soddisfatto cesserebbe di competere per le giovani adolescenti. L'invidia per chi di mogli ne ha ben quattro lo spingerà allora a prendersi una quarta compagna, al di là del fatto che sia o me-no soddisfatto, «per poter continuare a camminare a testa alta. E così i suoi geni si moltiplicano» (Kealey 1998: 45).
«Allo stesso modo, una donna il cui marito possiede dieci pecore può avere tut-ta la lana che le serve, ma se la sua “migliore amica” è sposata con un tizio che sa fare meglio il pastore e di pecore ne ha undici, l'invidia può spingerla ad andare a letto con lui, giusto per vendicarsi. Dunque l'invidia, aiutandola a catturare i geni di un maschio superiore, migliorerà il patrimonio genetico della sua prole. L'invi-dia si è evoluta in modo che la felicità ci sia negata, per quanto generose con noi siano state natura e fortuna. E questo perché, essendo il mondo dei geni relativo, l'invidia è appunto ossessionata dal relativo» (ibidem).
Emozioni e sentimenti 296 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
Quest'ultimo è un punto importante, sul quale dovremo necessariamente ritor-nare, ma può essere utile intanto citare un'altra notizia apparsa sulla stampa di di-vulgazione scientifica in cui si afferma che i ricercatori (in questo caso economisti) sarebbero riusciti a misurare empiricamente l'esistenza del sentimento dell'invidia.
In alcuni esperimenti condotti ad Harvard da Robert Reich, la stragrande mag-gioranza degli studenti di economia, messi di fronte a tale alternativa, hanno infatti scelto uno sviluppo degli Stati Uniti e del Giappone all'1%, piuttosto che uno degli Stati Uniti al 2% e del Giappone al 3%. Preferivano cioè essere assolutamente po-veri ma relativamente ricchi, piuttosto che il contrario (Kealey 1998).
Troviamo di nuovo citato il problema del relativismo, cui l'invidia appare stret-tamente legata, ma, a parte ciò, riteniamo che questo esperimento faccia sorgere più interrogativi di quanti apparentemente ne sciolga. È del tutto lecito, infatti, chiedersi se sia veramente l'invidia la molla che ha fatto scattare quel tipo di scelta. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un ragionamento perfettamente razionale che ha indotto gli studenti a pensare alle conseguenze (politiche, sociali, culturali, ecc.) di uno sviluppo differenziale del Giappone. Nel lungo periodo - potrebbero aver pen-sato gli studenti - si creerebbero squilibri tali da mettere in dubbio i “relativi” van-taggi di una crescita, apparentemente pur favorevole, degli Stati Uniti. Ciò induce alla massima cautela nel trattare un sentimento non poi così facilmente definibile, in particolare nelle sue conseguenze sociali.
Possiamo comunque intanto definire l'invidia come «un sentimento di malani-mo, più o meno intenso o duraturo, nei confronti di un'altra persona che ha qualco-sa che noi vorremmo, e non pensiamo di poter avere» (Castelfranchi, Miceli, Parisi 1988: 127). Non invidiamo però qualsiasi persona, perché «nessuno ha invidia se non del proprio simile», come sostengono Spinoza ed anche Aristotele, nella Reto-rica: «Gli uomini invidiano coloro che sono vicini ad essi nel tempo, nello spazio, nell'età e nella reputazione». Invidiamo, insomma, più facilmente e intensamente chi conosciamo direttamente, o crediamo di conoscere, e cioè coloro che costitui-scono, come teorizzano i sociologi, il nostro “gruppo di riferimento”.
Infatti, se coloro con cui ci confrontiamo sono troppo diversi da noi, il succes-so o l'insuccesso possono essere troppo condizionati da fattori al di fuori del con-trollo di entrambi. Dunque, il confronto è semplicemente improponibile ed è per-ciò più difficile che si alimenti il sentimento dell'invidia (Castelfranchi, Miceli, Pa-risi 1988: 139).
Condizione essenziale dell'invidia è un rapporto societario. «I parenti stretti e i colleghi di ufficio, nonché coloro che sono stati educati insieme sono particolar-mente inclini a invidiare i loro pari quando questi progrediscono. La ragione è da ricercarsi nel fatto che ciò costituisce per loro un rimprovero, poiché essi pure hanno avuto occasioni favorevoli che ritornano spesso alla loro memoria; si stabi-lisce così la spinta a compararsi con gli altri» (Schoeck 1974: 183). L'invidia si innesca perciò soprattutto nelle fasce orizzontali della società: per Bacone i re pos-sono invidiare solo i re (Foglia 1990: 192).
Emozioni e sentimenti 297 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
Quando valutiamo noi stessi guardiamo “istintivamente” agli altri e ben rara-mente abbiamo la serenità mentale che ci consente di comprendere se siamo felici senza confrontarci con il nostro prossimo. Se il paragone è sfavorevole proviamo il cosiddetto “morso d'invidia” (Alberoni 1991), che reprimiamo prontamente in quanto siamo consapevoli della sua meschinità (Elster 1995). Si tratta comunque di una reazione debole e infelice di fronte alla superiorità altrui che preclude attivi-tà quali la rivalità, l'imitazione o l'emulazione (Farber 1994) ed è perciò sterile. Nell'emulazione non vi è, ad esempio, malanimo, perché l'emulatore pensa che con l'impegno potrà avere quello che possiede la persona “invidiata” (Castelfranchi, Miceli, Parisi 1988: 145).
Sintetizzando, si può sostenere che l'invidia sarebbe composta dai seguenti stati affettivi: a) emulazione: viene percepita l'eccellenza di qualcun altro e l'ammirazione per
questa persona porta al desiderio di uguagliarla, imitarla o superarla; b) ferita narcisistica: si avverte un sentimento di inferiorità e di autostima ferita
che può essere vissuto come una semplice delusione oppure come mortifica-zione ed umiliazione;
c) bramosia per la proprietà desiderata; d) sentimento di rabbia verso chi possiede: si passa dall'infelicità o scontentezza,
al risentimento o rancore, ma, nei casi più gravi, anche al dispetto, malignità, malevolenza, odio o desiderio di dare del male a colui che possiede la cosa in-vidiata; nelle forme estreme può ingenerare impulsi di distruzione dell'oggetto invidiato (Spielman 1994). Vorrei concludere questa puntualizzazione iniziale sulla natura dell'invidia con
un piccolo, ed illuminante, excursus nella “saggezza popolare”. In Friuli (ma non dovrebbe essere difficile trovare altre varianti locali) circola una storiella in cui il protagonista è un tipico montanaro arretrato cui si attribuisce un comportamento “insano”, ma particolarmente significativo in questo contesto. Richiesto dal Genio della lampada di esprimere un unico desiderio, e con l'ulteriore limitazione che qualsiasi cosa avesse chiesto l'avrebbe ricevuta, raddoppiata, il suo vicino di casa, dopo avere soppesato l'opportunità di chiedere un certo numero di vacche, o di campi (ipotesi prontamente scartate di fronte all'insostenibile prospettiva che il vi-cino di casa avrebbe ricevuto il doppio), si risolve a chiedere al Genio l'asporta-zione di un occhio, nella prospettiva, questa sì attraente, che al vicino sarebbero stati cavati entrambi.
Che questo tipo di comportamento, pur estremizzato nella storiella, non sia poi così infrequente, sembra dimostrarlo la “codificazione” di Cipolla che, in un diver-tissement, che appare però realisticamente inquietante, definisce la piuttosto nota Terza (ed aurea) Legge Fondamentale della stupidità umana: «Una persona stupida è una persona che causa un danno ad un'altra persona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita» (1988: 58). Il comportamento tipico dell'invidioso.
Emozioni e sentimenti 298 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
2. L'invidia nei rapporti tra gruppi sociali È persino banale rilevarlo, ma è più facile convivere quando le cose vanno be-
ne, specialmente dal punto di vista economico. Quando la situazione volge al peg-gio, si cercano le cause, che spesso vengono imputate agli “altri”, comunque defi-niti. Da qui la sensazione che da soli le cose potrebbero andare meglio e tutto ciò accade più probabilmente se ci si trova in una fase di attenuazione delle motiva-zioni che hanno portato alla formazione del gruppo (familiare, aziendale, naziona-le, internazionale o quant'altro).
Poco importa, tra l'altro, che la situazione non sia poi così tragica come la si vuole far apparire. È spesso una facile, e falsa, suggestione quella insinuata da chi sostiene che “si stava meglio quando si stava peggio”, dimenticando i progressi reali che in tutti i campi la società, per lo meno quella occidentale, è riuscita a rea-lizzare. Non sono state certamente rimosse tutte le ingiustizie ed i motivi di insod-disfazione e vi sono tuttora patologie che dovranno essere affrontate decisamente, tra le quali, in primis, l'emergenza ambientale. Ciononostante, i livelli di benessere che ancora vengono garantiti nelle nostre società sono incommensurabilmente più elevati di quanto le generazioni precedenti avrebbero solo potuto sperare. Forse il problema risiede nel fatto che il livello delle aspettative si è elevato oltre ogni limi-te di ragionevolezza e sostenibilità e ci si ostina a considerare diritti acquisiti ciò che è stato possibile ottenere, almeno per quanto riguarda l'Italia, solo in virtù di scelte politiche, che è eufemistico definire poco lungimiranti.
Ma, come ci ammonisce il “teorema di Thomas”, poco importa che la situazio-ne non sia poi così difficile “in assoluto”: se l'emergenza viene percepita come rea-le, anche se non lo è, lo sarà, se non altro, nelle sue conseguenze. E tra le conse-guenze bisogna registrare la quasi automatica ricerca di un capro espiatorio: se l'economia ristagna è, ad esempio, certamente colpa della Germania, oppure degli americani (quando non degli extra-comunitari). Per i soggetti che elaborano queste tesi (individui o gruppi sociali che siano), si tratta di una spiegazione perfettamen-te razionale. Gli extra-comunitari, secondo questa logica, “portano via il lavoro” anche quando, in realtà, il loro lavoro sottopagato permette di mantenere in vita imprese che altrimenti sarebbero costrette ad uscire dal mercato e a licenziare tec-nici, impiegati e dirigenti prevalentemente, se non totalmente, italiani.
Osservatori consapevoli potrebbero sottolineare l'irrazionalità di chi non vede nell'interdipendenza, nell'allargamento dei mercati, nell'intensificazione dei rap-porti e dei contatti, nella divisione del lavoro internazionale una necessità, ma an-che la possibilità di una più sicura crescita economica per tutti. La valorizzazione del proprio particulare, appare invece purtroppo perfettamente razionale ad una analisi meno “sofisticata” e ad una logica che sembra affondare le sue radici nella cultura rurale o comunque tradizionale, che tende a “drammatizzare” gli eventuali maggiori vantaggi che alter può ricevere dallo scambio e a non apprezzare adegua-
Emozioni e sentimenti 299 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
tamente i vantaggi che l'agire cooperativo comunque garantirebbe a tutti i parteci-panti (1).
I momenti di difficoltà economica e sociale sarebbero dunque, un po' come tut-te le situazioni di crisi, momenti rivelatori di meccanismi fondamentali dell'agire sociale. Come lo studio della devianza può essere la strada maestra attraverso cui riusciamo a comprendere bene il funzionamento e la vera essenza della norma, co-sì nei momenti di crisi riusciamo a scorgere con maggiore nitidezza il funziona-mento “normale” della società (2).
La prima molla che scatta è perciò quella della ricerca di un capro espiatorio e, comunque, anche in mancanza di questo, e forse ancora di più se non lo si trova, può scattare il meccanismo dell'invidia. Se non si individua un capro espiatorio esterno alla “comunità” su cui dirottare i sentimenti di ostilità, piuttosto che am-mettere le proprie inadeguatezze o le proprie difficoltà, si preferisce infatti occu-parsi di chi ha un immeritato, a nostro avviso, successo.
A sostegno dell'ipotesi che alla base dei fenomeni disintegrativi vi possa essere (anche) un meccanismo di invidia sociale si può segnalare che questa sarebbe, se-condo un'opinione corrente, una grossa palla al piede che tuttora impedirebbe il decollo dell'economia sovietica. L'invidia sociale penalizza infatti coloro che ten-tano di emergere, anche al prezzo di danneggiare coloro che potrebbero ricavare vantaggi indiretti dallo sviluppo innescato dai più intraprendenti.
La stessa rivoluzione comunista, tra l’altro, non avrebbe fatto altro che inne-starsi su una cultura popolare che avrebbe favorito l'entusiastica adesione all'idea di eliminare non la povertà e perciò i poveri, ma i ricchi. In un volume di Revelli e Rotelli (1993: 137) viene riportano l'aneddoto della contessa che, allo scoppio del-la Rivoluzione russa, chiede cosa vogliano i rivoluzionari. Alla risposta “Che non ci siano più i ricchi”, la contessa ribatte: “Strani rivoluzionari questi. I miei antena-ti decabristi volevano fare la rivoluzione perché non ci fossero più i poveri”.
«L'egualitarismo di fondo - sostengono i due autori - è, per certi versi, una mentalità precedente al socialismo, sempre esistita in forma istintiva in quella cul-tura contadina, e consistente in una forma tenace di fastidio per il successo dell'al-tro. Nell'ostilità verso l'ascesa» (ibidem: 93).
Possiamo andare anche più indietro, sempre ricorrendo ad esempi che affonda-no le radici nelle società agro-pastorali: secondo Ranulf (citato da Elster 1993), anche l'ostracismo greco traeva origine dal sentimento dell'invidia, tipico della classe media più povera, piuttosto che dal timore della tirannia. L’ “inammissibile” sentimento dell'invidia ha infatti bisogno di ragioni più accettabili per penetrare negli animi umani: «Proprio perché l'invidia è spregevole talvolta si vuol passare per invidia il senso di giustizia o viceversa» (Castelfranchi, Miceli, Parisi 1988).
1. Della questione si occupano, come è noto, gli studiosi della “teoria dei giochi”. Si veda, ad esempio, Axelrod (1985).
2. Ciò è stato dimostrato, ad esempio, dalla sociologia dei disastri, che studia uno dei momenti in cui maggiormente il sistema sociale viene messo in crisi: si vedano Cattarinus-si, Pelanda (1981) e Dynes, De Marchi, Pelanda (1987).
Emozioni e sentimenti 300 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
Anche il già citato Elster sostiene che: «Un fatto deprimente riguardo a molte società contadine è che la gente che ha un maggiore successo è spesso bollata co-me pericolosa e perciò trascinata al livello degli altri o persino al di sotto» (1993: 76). Per Elster: «Il primo desiderio dell'invidia non è “voglio quello che ha lui”, ma “voglio che lui non abbia quello che ha, poiché il fatto che lui l'abbia mi fa sen-tire che valgo meno”. Ci sono differenti tipi di invidia. Una forma debole è “se non lo posso avere io, nessuno lo avrà”. Una più malvagia implica la disponibilità a danneggiare se stessi per nuocere agli altri; accettare di meno per se stessi se così gli altri vengono abbassati al proprio livello» (ibidem: 87). La prova che ciò possa accadere, come abbiamo visto, si sarebbe trovata nel citato, e per noi controverso, esperimento con gli studenti di Harvard.
3. L'invidia nei rapporti internazionali Una “prova” più consistente dell'agire di questi meccanismi nei rapporti tra
gruppi sociali la possiamo trovare effettuando un ulteriore salto di livello, appro-dando a quello dei rapporti internazionali.
La situazione socio-politica dell'Europa di fine millennio è alquanto problema-tica, con prospettive inquietanti e tali da adombrare che nel comportamento dei popoli e dei governi vi siano elementi di “irrazionalità” (un aggettivo da non accet-tare comunque in maniera acritica), tra i quali il sentimento dell'invidia sociale può essere un protagonista non marginale.
Con il crollo del Muro di Berlino, la situazione nazionale al di là della vecchia Cortina di ferro si è messa immediatamente in movimento: si è divisa la Cecoslo-vacchia, è crollata l'Unione Sovietica e si è dissolta, e continua a disintegrarsi, la Jugoslavia con potenzialità distruttive per l'intera Europa, oltre che per i popoli che vivono nell'area interessata più direttamente. Sono contestati, con maggiore o minore decisione, quasi tutti i confini tra gli stati ex-comunisti del Centro e del-l'Est-Europa, dove sono collocate diverse minoranze che le circostanze storiche hanno diviso dalle rispettive nazioni di appartenenza.
Il processo di integrazione europea, realizzato in parte con la creazione del-l'Euro e della Banca centrale europea, non trova analogo riscontro sul piano politi-co. Tra i due fenomeni, in parte correlati (dell'integrazione continentale e della riaffermazione delle nazioni/etnie/culture locali) al momento appare più vitale, a volte tragicamente, proprio quest'ultimo.
Un esempio calzante può essere rappresentato dalla vicenda paradossale e lar-gamente autolesionista della separazione della Slovacchia dalla Repubblica Ceca. Altre componenti politico-ideologiche e culturali possono avere certamente gioca-to un ruolo, ma la decisione di intraprendere una strada autonoma e diversa è forse imputabile all'insopportabilità, da parte degli slovacchi, di una situazione che ve-deva il resto del paese avviarsi rapidamente verso la conquista di qualche vantaggio economico. La loro parte del paese era invece attardata dalla presenza di un'industria
Emozioni e sentimenti 301 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
pesante molto obsoleta, oltre che da altri fattori, come il minore interesse della Germania ad investire in questa parte della Federazione. L'invidia, insomma, può avere giocato un certo ruolo.
Passando al caso della ex-Jugoslavia, vale la pena di considerare un intervento di Panic, un osservatore attento ed informato, avendo ricoperto la carica di primo ministro dell'ex-Jugoslavia. Panic afferma che: «gli osservatori più informati della Jugoslavia credevano che il paese fosse in procinto di entrare velocemente nella corrente principale dell'economia europea. L'inflazione era stata portata a zero, il dinaro jugoslavo si era stabilizzato tanto che non esisteva più il mercato nero per le valute estere, le riserve monetarie erano alte, mentre la disoccupazione andava da meno del 2% in Slovenia al 15% nelle regioni meridionali più povere del Kos-sovo e della Macedonia. Gli jugoslavi godevano di standard di vita che si avvici-navano ai livelli di paesi europei quali la Spagna e il Portogallo e il paese era invi-diato da tutti gli altri dell'Est europeo. Oggi, dopo due anni di eccessi nazionalisti-ci, di divisioni, secessioni e guerra civile, l'economia dell'ex-Jugoslavia è in sface-lo. L'economia jugoslava integrata è stata divisa in cinque mini-colonie disfunzio-nali, separate l'una dall'altra dalla paura e dall'odio» (Panic 1993: 4).
Una delle chiavi di spiegazione della disgregazione della Federazione jugosla-va è molto probabilmente da ricercarsi proprio in quella “forbice” fra 2 e 15% di disoccupazione, citata solo di passaggio da Panic. La forbice di Panic evidenzia due dati estremi: se la percentuale riferita alla disoccupazione slovena era estre-mamente positiva, non era poi così drammatico nemmeno quel 15% riguardante il Kossovo e la Macedonia, perché si tratta di un valore che alcune zone del nostro Meridione forse sarebbero, ancor oggi, disposte a sottoscrivere. Insomma, la cosa veramente insopportabile non era probabilmente tanto il peso del 15% di disoccu-pazione nel Kossovo, quanto piuttosto il fatto che in Slovenia essa fosse solo del 2%.
Notiamo anche, di passaggio, che Panic stesso utilizza il termine “invidia” a proposito dei sentimenti degli altri paesi dell'Est-europeo. Inoltre, Panic sostiene che è assurdo - riemerge la tesi dell'irrazionalità - quanto stava accadendo, perché la Jugoslavia godeva di un relativo benessere. Ma Panic, come stiamo tentando di dimostrare, si sbaglia, perché il benessere è sempre relativo e sappiamo che la chiave del mutamento sociale non è nel livello di sviluppo assoluto raggiunto, ma proprio nell'eventuale sentimento di deprivazione relativa (reale o percepita) che più facilmente si genera in una situazione di aspettative crescenti e poi frustrate (3).
Il problema, con le vicende legate alla dissoluzione della Jugoslavia, è che i prezzi che si sono pagati sono di gran lunga superiori alla semplice rinuncia ad un vantaggio, pur di impedire che l'avversario si avvantaggi ancora di più, come “pre-vede” la teorizzazione sul meccanismo dell'invidia. Il conflitto, infatti, si è risolto in un drammatico gioco che non è nemmeno possibile definire a somma zero (il
3. È nota, al proposito, la teoria di Davies (1962), sintetizzata, in buona sostanza, re-
centemente da Elster: «il cambiamento sociale è il risultato di aspettative insoddisfatte» (1993: 192).
Emozioni e sentimenti 302 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
che potrebbe renderlo comprensibile), ma è diventato un gioco a somma negativa, con grosse perdite per tutti (tale sarà certamente anche la conclusione di quello in corso nel Kossovo e in Serbia).
Infatti, si può parlare di gioco a somma zero quando una delle due parti riesce a prevalere sull'altra, tanto che le perdite di un giocatore diventano guadagni per l'altro. Nel caso jugoslavo, in realtà, nessuno è in grado di vincere veramente per-ché ostacolato da contrapposte pressioni internazionali che impediscono che una parte rischi di prevalere troppo sull'altra. E quando nessuno vince veramente, il gioco diventa a somma negativa perché tutti alla fine avranno perso qualcosa.
Lasciando il caso evidente dell'ex-Jugoslavia, cerchiamo di vedere come questa logica perversa si applichi al caso dell'ex-Unione Sovietica. Nelle prime analisi post-‘89 si tendeva ad affermare che ben difficilmente (a parte il caso particolare delle Repubbliche baltiche) l'Unione Sovietica avrebbe potuto dissolversi. Questo perché, si sottolineava, il Comunismo aveva reso estremamente interdipendenti le economie delle diverse repubbliche, che non avrebbero potuto essere vitali se a-vessero tentato di rendersi autonome. Altri poi invocavano il ruolo unificante del-l'esercito ed anche i pericoli che sarebbero potuti sorgere dalla proliferazione di nazioni nucleari (4).
Nulla invece ha potuto fermare l'irresistibile volontà di separazione delle re-pubbliche, che sono andate avanti per la loro strada nell’illusione, ad esempio, che si potesse risolvere il problema etnico. Ma si è trattato di un colossale errore di va-lutazione. La spaccatura della multietnica Unione Sovietica (e lo stesso vale per la situazione jugoslava) non ha fatto altro che generare quindici nuove repubbliche multietniche dove si ripropongono, moltiplicati, gli stessi problemi di convivenza (5).
Irrazionalità, dunque, connaturata all’invidia o errore di calcolo? Forse en-trambe le componenti sono state presenti e comunque la tesi dell'irrazionalità non può essere soddisfacente per il sociologo che dovrà esperire tutte le strade per rea-lizzare ciò che “pretende” Boudon (1993): il compito del sociologo sarebbe quello di cercare le buone ragioni dell'attore. Accontentarsi dell'etichetta di irrazionalità - anche quando mitigata dal sospetto di un errore di calcolo, per difetto di informa-zione, da parte dell'attore che si credeva razionale - equivale quasi ad abdicare dal proprio compito (6).
Possiamo allora tentare di riformulare l’ “accusa” di irrazionalità, nel senso che gli attori sono individualmente razionali e l'irrazionalità potrebbe essere l'effetto
4. Si veda, ad esempio, Bakirov (1994). 5. Per una stima puntuale sulla consistenza delle diverse minoranze etniche in tutti i
paesi Est-europei, si veda Bregantini (1996). 6. «La nozione di razionalità soggettiva è fondamentale per le scienze sociali, poiché,
come Max Weber e Karl Popper, tra gli altri, hanno indicato, lo sforzo di sostituire una spiegazione razionale (...) di un certo comportamento o di una certa credenza alla spiega-zione “irrazionale”, che il senso comune con ogni probabilità darebbe loro, è uno dei com-piti fondamentali delle scienze umane e una delle loro principali fonti di legittimità» (Bou-don 1993: 386).
Emozioni e sentimenti 303 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
emergente delle azioni individuali non coordinate. Si può, infatti, chiamare in cau-sa l'elaborazione teorica di Hirsch (1981), per il quale si deve distinguere tra beni materiali e beni posizionali. Una caratteristica dei beni posizionali è il fatto che, se sono molti gli individui che tentano di impossessarsene, il risultato degli sforzi è tale che tutti si ritroverebbero alla fine al livello di partenza, con l'unica differenza che nel frattempo si sono sprecate energie e risorse di ogni genere. Una delle meta-fore utilizzate è quella della folla allo stadio: se un individuo si alza per vedere meglio, riuscirà nel suo intento, ma se tutti lo imitano, alla fine nessuno vedrà me-glio di prima.
Si può sostenere che qualcosa di analogo sia accaduto nell'Est-europeo, in par-ticolare nell'ex-Jugoslavia. Il bene per cui hanno lottato i diversi attori emersi dalla dissoluzione della Federazione jugoslava è un bene posizionale: essenzialmente si tratta dello status di nazione indipendente, riconosciuta ed accettata nel contesto delle altre nazioni. Ricorrendo ad un vecchio detto, si potrebbe affermare che tutti hanno cercato un “posto al sole”. Le nazioni si sentivano probabilmente all’ “om-bra” nel contesto della Federazione e qualcuno ha tentato di sollevarsi in piedi. Il gioco sarebbe riuscito, se solo uno, o pochi, si fossero “alzati in piedi”; ma il fatto è che nessuno ha voluto rinunciare ad alzarsi.
4. Popoli e sentimenti Affidandoci a questo tipo di spiegazione, abbiamo lasciato per il momento sul-
lo sfondo un problema epistemologico di non poco peso: esso riguarda l’ammis-sibilità, ed anche la fecondità, di applicare ad interi gruppi sociali qualità (i senti-menti) che sono certamente nate per descrivere e spiegare comportamenti indivi-duali.
Del fatto che tale “salto di livello” possa essere plausibile sembra essere con-vinta Serena Foglia, la quale, partendo dall’analisi di psicologia infantile di Mela-nie Klein (1969), utilizza il livello collettivo per trarre conferma di ciò che è diffi-cilmente verificabile esaminando le emozioni dei neonati e cioè il fatto che «più si dipende da qualcuno più si è portati a provare per costui sentimenti di malanimo, animosità, rancore, rabbia, originati dall'invidia» (Foglia 1990: 195). Secondo la Foglia: «gli aiuti dati alla fine della Seconda guerra mondiale dai vincitori ai vinti e dai paesi ricchi a quelli in via di sviluppo (…) sono stati accolti con ingratitudine tanto maggiore quanto più consistenti erano i benefici ricevuti. Il pluriennale, radi-cato, feroce livore, sconfinante a volte nel disprezzo e nell'odio, con cui sono stati gratificati gli Stati Uniti è una prova di come l'ingratitudine si colleghi con l'invi-dia» (ibidem).
Il “livello collettivo” è comunque composto di singoli individui e bisogna allo-ra precisare, innanzitutto, che dire, ad esempio, che “gli slovacchi sono invidiosi” è una breve locuzione che ne sostituisce una più lunga la quale nasconde una con-cezione “frequentista” del tipo: «tra gli slovacchi si riscontra una percentuale di
Emozioni e sentimenti 304 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
individui, che possono essere classificati come invidiosi, superiore rispetto a quel-la che possiamo trovare in altri gruppi sociali, comunque definiti». Si tratta di un risultato che potrebbe emergere, ci muoviamo sempre a livello ipotetico, da un'in-dagine comparata di tipo survey, condotta utilizzando anche dei test di personalità.
Gli studi comparati condotti da Inglehart (1998) hanno rivelato l'esistenza in certi paesi di un maggior numero di individui con tratti valoriali che possono esse-re definiti post-moderni. Semplificando, potremmo definire questi popoli più “post-moderni” di altri e non si vede come ciò non possa essere fatto anche per altre caratteristiche valoriali o tratti della personalità come, ad esempio, l'autorita-rismo (vi sono popoli più autoritari di altri).
L'operazione può essere ripetuta agendo sulle rappresentazioni sociali: invece di far emergere tratti della personalità degli intervistati, possiamo rilevare gli ste-reotipi presenti nella mente della gente che si vede, e vede gli altri, secondo questi modelli “ideali”.
Gli stereotipi non sono infatti che rappresentazioni sociali e non hanno in sé, nonostante l'utilizzo corrente del termine, una connotazione positiva oppure nega-tiva. Gli stereotipi diventano positivi o negativi solo una volta qualificato con pre-cisione il loro contenuto e, cioè, una volta individuati, ad esempio, i termini che vengono utilizzati per descrivere sinteticamente gli oggetti che vengono classificati mediante queste immagini (7).
È curioso, a nostro avviso, che chi parla di popoli, o comunque gruppi, utiliz-zando stereotipi venga accusato di chissà quale misfatto, anche perché, come ab-biamo visto, gli stereotipi possono essere positivi. Ma il problema è più rilevante, in particolare per i sociologi, proprio perché l'utilizzo degli stereotipi è non solo legittimo, ma addirittura indispensabile per descrivere i gruppi sociali.
Si può rifiutare l'accusa di “razzismo” se si descrivono sinteticamente i popoli utilizzando queste “rappresentazioni” per almeno due motivi. Innanzitutto, perché la razza non c'entra nulla, in quanto gli stereotipi descrivono solitamente tratti cul-turali. In secondo luogo, se viene sottratta la possibilità di utilizzare gli stereotipi per definire i gruppi sociali, viene a cadere un elemento fondamentale proprio per distinguere tra razza ed etnia (una delle formazioni sociali per cui più frequente-mente utilizziamo gli stereotipi). L'etnia si distingue dalla razza, lo affermano tutti i manuali di sociologia, proprio perché vi sono connotati culturali, e tra questi an-che tratti della personalità plasmati dalla cultura, che ne caratterizzano i membri.
Può venire comunque spontaneo rifiutare di attribuire etichette descrittive delle caratteristiche di un popolo, perché, anche se non proprio quella di razzismo, po-trebbe scattare quasi automaticamente l'accusa di essere pervasi dai pregiudizi: ma si tratta di due cose affatto diverse. Affermare che gli scozzesi sono avari (meglio, parsimoniosi) o gli sloveni pessimisti è legittimo, anche se ciò non toglie che si
7. Un classico studio sugli stereotipi è quello condotto nella multietnica regione Friuli-Venezia Giulia (Boileau, Sussi 1981). Più recentemente, con un'ulteriore indagine si è sono cercati di misurare gli stereotipi (positivi e negativi) dei giovani della regione nei confronti dei popoli e paesi europei (Delli Zotti, Pellizzoni 1997).
Emozioni e sentimenti 305 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
possa trattare di uno stereotipo infondato e perciò di una rappresentazione cui non corrisponde un riscontro empirico.
Altra cosa è decidere che uno sloveno è “pessimista” solo perché sloveno (si tratterebbe di un giudizio “pregiudiziale”). In questo caso la possibilità di commet-tere un errore è doppia: all'errore precedente si assomma quello di inferire da un dato riferito ad una popolazione caratteristiche al livello individuale (si tratta del-l'errore che i metodologi delle scienze sociali chiamano “fallacia ecologica”).
Un ulteriore elemento di perplessità nell'affermare, ad esempio, che “gli slo-vacchi si sono comportati da invidiosi” potrebbe derivare dal fatto che tutto ciò potrebbe essere accusato di “reificazione” (gli “individualisti metodologici “ so-stengono che non esistono i popoli, ma solo le persone che ne fanno parte). Anche senza voler entrare nel merito del dibattito epistemologico, che in verità su questo punto è piuttosto acceso, dobbiamo però tenere presente che i popoli parlano per voce dei loro leader, si esprimono attraverso pubblicazioni e altri mass media (8). È in queste prese di posizione, che “danno voce” alla collettività, che possiamo individuare elementi che, analogamente con quanto accade al livello individuale, potremmo a volte tranquillamente definire come indizi della presenza del senti-mento dell'invidia. Questa analogia può essere considerata ancor più calzante in casi, come quello jugoslavo, in cui i leaders politici appaiono giocare un ruolo as-solutamente determinante (9).
5. Invidia e giustizia sociale Con queste ultime considerazioni ci siamo un po' allontanati dall'esame della
natura dell'invidia sociale che vorremmo completare per affrontare il tema, assai arduo in verità, del suo legame con le richieste di giustizia sociale.
Esaminando in precedenza alcune caratteristiche della cultura delle società “a base agraria”, abbiamo osservato che alla base delle rivendicazioni di giustizia so-ciale alcuni affermano vi possa essere (anche) l'invidia sociale. Ciò sarebbe dimo-strato dal fatto che spesso la richiesta non è tanto quella della ricchezza per tutti, quanto piuttosto quella di toglierla a chi ce l’ha. La questione è davvero spinosa e non si può facilmente risolvere, né bollando “da destra” le richieste di giustizia so-ciale, né liquidando la questione affermando la mala fede di chi con questo tipo di considerazioni vuole semplicemente perpetuare le disuguaglianze sociali.
Quest'ultima accusa, se formulata, si rivela del tutto semplicistica tenendo con-to che l'invidia è messa in relazione con il senso di giustizia da due, non certo di destra, come Freud e Marx. Freud, nel suo Psicologia delle masse a analisi dell'io, scrive che «gli originari sentimenti di gelosia e d'invidia vengono trasformati nel
8. Sulla relazione micro-macro si veda, ad esempio, Addario (1994). 9. Su questa linea si veda Aklaev e Dozhdev (1994), che analizzano il caso sovietico ed
affermano che la crisi dell'identità collettiva è spesso manipolata dai leaders etnici per inca-nalare il malcontento e l'ansietà nella lotta etno-politica.
Emozioni e sentimenti 306 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
sentimento sociale di aspirazione all'uguaglianza. Sembrerebbe infatti che l'energia sviluppata nell'invidia venga in questi casi utilizzata in attività che tendono a rag-giungere o mantenere uno stato di giustizia sociale. Questo non diminuisce certo né inquina il valore soggettivo del senso di giustizia. Anche Marx negli scritti gio-vanili affermava che le prime fasi del comunismo possono essere considerate come una derivazione o un'espressione dell'invidia» (D'Urso, Trentin 1998: 265).
Come correttamente annota Alberoni, ciò non significa che invidia e senso di giustizia siano la stessa cosa, perché il vero invidioso: «mentre si lamenta dell'in-costanza del mondo e della falsità dei giudizi umani, spera soltanto che muti la sor-te. Lui non vuole giustizia, vuole fortuna, non vuole equità, vuole privilegio» (1991: 124). «La verità è che si invidia qualcuno anche quando si riconosce che merita quello che ha (…) L'invidia è disposta dunque ad andare anche contro l'e-quità e il giusto» (Castelfranchi, Miceli, Parisi 1988: 144).
La teoria sociologica che si può chiamare in causa è comunque, come abbiamo già accennato, quella dei gruppi di riferimento e delle aspettative sociali (che van-no ben distinte dalle più o meno legittime aspirazioni). Le aspettative non vengono sviluppate in assoluto, ma in relazione a coloro che per vari aspetti percepiamo come simili. Siamo, come si vede, all'interno del campo d'azione dell'invidia che “si nutre” di relazionalità e dunque di “relatività” mentre invece per stabilire delle regole di giustizia, secondo quanto afferma John Rawls (citato da Alberoni 1991: 123), ciascuno non dovrebbe conoscere la propria posizione in modo da non es-serne influenzato.
Se i nostri simili, o percepiti tali, progrediscono e noi no, vengono stimolati sentimenti di frustrazione che diventano richiesta di giustizia sociale se riteniamo che ciò sia frutto di un'ingiusta appropriazione o distribuzione di risorse (di qua-lunque genere esse siano). Ma può anche essere stimolata semplicemente la nascita e lo sviluppo di un sentimento di invidia che alla fine oscura le ragioni del non soddisfacente esito sociale del nostro sforzo di migliorare, se mai c'è stato.
Allora il problema diventa: quale è il confine tra l'ingiustizia reale e la semplice nostra inadeguatezza che può far sviluppare sentimenti di invidia? È lo stesso che riuscire a chiarire se ci troviamo di fronte ad una differenza o di fronte ad una di-seguaglianza (e cioè ad una differenza che, per lo meno in parte, giustificherebbe anche la diseguaglianza).
Quando parliamo di giustizia sociale viene spontaneo riferirsi mentalmente alle rivendicazioni delle classi inferiori che spesso hanno problemi ai limiti della stessa possibilità della sopravvivenza. Ma nel caso dell'invidia vengono coinvolti tutti gli strati della popolazione: nessuno è immune. «Simile a una belva mai sazia, l'invi-dia pascola dove può senza rispettare né classi né censo: se sono ricco non soppor-to i miliardari, se ho potere invidio chi invece ha la ricchezza» (Castellaneta 1986).
Non che non vi siano delle responsabilità anche da parte di coloro che sono oggetto dell'invidia: i meccanismi di provocare invidia e di godere dell'invidia al-trui occupano infatti un posto importante nella letteratura sul consumo ostentativo.
Emozioni e sentimenti 307 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
Del resto: «l'invidia sembra essere quasi “naturalmente” ancor più diffusa nella nostra società, dove si sollecitano sempre nuovi bisogni di beni materiali o di suc-cesso personale e diventa sempre più facile elaborare una lettura illegittima di quanto ci spetta che ci porta “arrogantemente” ad attribuirci diritti di possedere tutto quanto si desidera» (Slepoj 1996). Dello stesso parere è Serena Foglia che vede possibilità per lo sviluppo dell'autostima - l'unico vero antidoto all'invidia - «nelle attuali società affluenti che offrono molte possibilità ma poche certezze, nel-le quali l'ammirazione si orienta più verso i ruoli che verso i valori, dove la mobi-lità sociale sollecita illusioni sulla raggiungibilità delle mete, dove la competizione si fa subito conflitto, dove la contestazione svaluta le meritocrazia» (1990: 208).
Si tratta di una situazione che comunque viene da lontano e che, come nota Bodei (1995), era stata già rilevata da Tocqueville, il quale osservava che nella società americana l'invidia trova terreno fertile a causa della “necessità” di sentirsi realizzati privilegiando il mero accumulo di beni materiali.
Parlando di “classi agiate” siamo all'estremo opposto, rispetto alla “classica” richiesta di giustizia sociale proveniente dal proletariato urbano ottocentesco de-scritto da Marx (ma anche da Dickens) ed allora possiamo, molto approssimativa-mente per ora, sostenere che certamente non tutte le rivendicazioni sono legittime. Il problema è dunque trovare, tra le due situazioni schematicamente individuate, il limite al di sotto del quale si può parlare di richiesta di giustizia e al di sopra di nefasto sentimento di invidia sociale.
6. Invidia e povertà relativa Il problema è ovviamente sul tappeto, non si tratta di una mera esercitazione
accademica, ed è anche stato affrontato, perché lo stato sociale ha bisogno di fissa-re delle definizioni, che implicano confini e perciò limiti, se non altro per circo-scrivere l'ambito della sua azione e, nello specifico, individuare i soggetti portatori di specifici diritti “redistributivi”.
Uno di questi limiti, fissato un po' come tutti gli altri convenzionalmente, è quello che individua la “soglia di povertà”. Noi possiamo utilizzarlo in questa sede per sostenere che chi si trova sotto questa soglia ha pieno diritto a protestare per la propria condizione e dunque ad invocare maggiore giustizia sociale. Chi si trova al di sopra, potrebbe invece essere “indiziato” di invidia sociale. Una volta garantite a tutti condizioni di vita minime e comunque decorose (che non significa al livello della mera sussistenza) il resto si può ritenere che possa essere lasciato al campo libero dell'azione di altre forze che risiedono nelle diverse capacità, voglia di lavo-rare, achievement, gusto del rischio, disponibilità ad assumersi responsabilità, ma anche, ovviamente, volontà di potere, prestigio e ricchezza, in una concorrenza con gli altri che può essere anche “spietata”, ma che non può superare i limiti fissati dalla norma.
Emozioni e sentimenti 308 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
Una volta stabilito il principio, il difficile è sostanziarlo o operazionalizzarlo, se vogliamo utilizzare la terminologia lazarsfeldiana. Vi è ovviamente, una soglia al di sotto della quale si può parlare di povertà assoluta, in quanto verrebbero a mancare i mezzi basilari per la mera sopravvivenza. Si è però deciso che questo limite è troppo restrittivo e ciò anche in considerazione di quanto la riflessione so-ciologica ha prodotto in termini di gruppi di riferimento e di aspettative sociali. Si ritiene che in una società in cui crescono le basi materiali ed il sistema produce sempre maggiori beni non si possa stabilire un limite assoluto. In considerazione di questi progressi, ciò che una volta poteva essere ritenuto sufficiente in termini di beni posseduti e di accesso ai servizi, oggi non lo è più se, ad esempio, si elevano gli standard per poter considerare vivibili le abitazioni, diventano più elevate le “credenziali” scolastiche per poter accedere a lavori che non siano del tutto de-qualificati, diventano più sofisticate, e perciò costose, le cure e le misure di pre-venzione per poter giungere in buona salute alla sempre più tarda età cui si può aspirare in base alla crescente “aspettativa di vita alla nascita”.
Tutto ciò è ovviamente molto ragionevole, almeno in prima approssimazione, ma abbiamo volutamente esemplificato questioni e settori della vita sociale che certamente favoriscono l'impressione di ragionevolezza insita in questa concezio-ne. Si può invece manifestare qualche dubbio riguardo al fatto che si possa genera-lizzare e ritenere che ogni “conquista” che viene proposta come obiettivo da parte della società consumistica possa generare aspettative legittime. Più di tutto, può essere messa in discussione la “regola” secondo cui di tutte, o quasi, le aspettative insoddisfatte debba farsi carico il sistema della politica sociale: la crisi del welfare state starebbe a dimostrare che non può essere così o che, per lo meno, tutto ciò sia diventato “insostenibile”.
Per anni, insomma, «la sinistra ha sostenuto che la povertà non è assoluta, ben-sì relativa. Alcuni conservatori dissentono: una volta che i bisogni primari, quali il cibo e l'alloggio, sono stati soddisfatti, i beni di consumo, ad esempio il televisore a colori, si configurano come dei lussi. Come sempre, c'è del vero in entrambe le opinioni: un televisore a colori è senza dubbio un oggetto di lusso, ma chi possiede solo un televisore in bianco e nero può davvero sentirsi privato di qualcosa di es-senziale» (Kealey 1998: 45).
Se c'è del vero in entrambe le opinioni, si può allora sostenere che, almeno in parte, sia stata l'invidia a guidare la richiesta di giustizia sociale, magari con la consapevole o inconsapevole complicità dello stesso sistema che gli scontenti ed “invidiosi” vorrebbero abbattere. Il sentimento dell'invidia, benché connaturato alla società a base agricola è stato stimolato dal sistema capitalistico e consumisti-co attraverso la creazione di bisogni indotti e ciò ineluttabilmente, perché è pro-prio l'irrefrenabile consumismo a reggere il meccanismo della crescita continua, senza la quale il sistema si avviterebbe in paurose involuzioni recessive.
Il sistema dunque suggerisce sempre più elevati standard di vita e ciò giustifi-cherebbe l'abbandono di una concezione della povertà in termini assoluti. Una co-sa è però rivedere la nostra definizione di povertà assoluta adeguandola periodi-
Emozioni e sentimenti 309 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
camente, e perciò in qualche misura relativizzandola, sulla base di un'analisi pun-tuale e di una “certificazione”, per quanto fallibile, dell'esistenza di nuovi bisogni reali ed insoddisfatti, ed altro è affidarsi ad un calcolo statistico che prescinda completamente dai contenuti della definizione di povertà.
Se invece accettiamo come plausibile una concezione relativistica della povertà di tipo meramente statistico, ci troviamo in un bel guaio o, per lo meno, con le ma-ni legate da un paradosso. Ci condanniamo, infatti, a vivere in una società in cui nessun sistema di politiche sociali, per quanto sofisticato e costoso, riuscirà mai a sconfiggere la povertà. Per quanto si cerchi di migliorare le condizioni di vita di tutti e di rendere il sistema sociale il più egualitario possibile, non c'è soluzione al problema se la definizione di povertà abbandona ogni volontà di individuare un limite oltre il quale la pretesa povertà relativa sconfina nel consumismo.
Se si adotta, per definirla statisticamente, un valore posizionale come il quartile inferiore nella distribuzione dei redditi si fissa “per legge” che i poveri sono sem-pre e comunque un quarto dei componenti di una società. Ma anche le definizioni correnti che utilizzano il reddito medio di una popolazione definendo, ad esempio, come povero chi possiede la metà di questo reddito, fanno sì che vi saranno sem-pre poveri in una società che accetti acriticamente questa definizione (10). Il para-dosso risiede nel fatto che il numero dei poveri addirittura aumenterebbe in una società in cui aumentasse il benessere, perché esso farebbe innalzare la “soglia del-la povertà”. Molto acutamente, Sarpellon (1993), parla del passaggio dall’ “oblio” della vera povertà di Giobbe (assoluta), all’ “abuso” del concetto di povertà relati-va, “tirando in ballo” Sisifo, per alludere al fatto che in questo modo la meta (la sconfitta della povertà) sfugge ineluttabilmente proprio quando sembra possa esse-re più vicina.
Rivedere queste concezioni appare essere sempre meno “opzionale”, perché esse semplicemente non sono (più) sostenibili, né per un equo (che non vuol dire egualitario) e “sano” sistema di welfare state, né a livello globale. Della crisi dello stato del benessere si è detto molto e non è necessario ripeterlo. Ma non possiamo permetterci il lusso dell'invidia sociale, che guida una richiesta inesausta di miglio-ramenti sociali per inseguire i “progressi”, molto spesso illusori, delle classi af-fluenti, anche perché sono stati chiaramente individuati i “limiti dello sviluppo” ed è stata dimostrata l'insostenibilità dell'estensione indiscriminata degli attuali livelli di consumo dell'energia e delle altre risorse del pianeta (11). I problemi ambientali che crescono per diffusione sul territorio e gravità stanno ad indicarcelo quotidia-namente e ad ammonirci.
Questa revisione critica, tra l'altro, può essere fatta anche continuando ad ac-cettare, in parte, la logica della relativizzazione del concetto di povertà. Solo che, in un mondo che è sempre più globalizzato, può essere opportuno, e questa sareb-
10. Per una rassegna delle diverse tecniche utilizzate e proposte per “misurare” la po-vertà, si veda Zajczyk (1993).
11 Per una revisione critica de I limiti dello sviluppo, si vede il recente numero mono-grafico della rivista Futuribili (1998).
Emozioni e sentimenti 310 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
be veramente giustizia sociale, considerare come gruppo di riferimento non più la comunità nazionale, ma la comunità globale, all'interno della quale probabilmente tutti o quasi tutti coloro che fanno parte delle nazioni più evolute si troverebbero al di sopra della soglia di povertà così ridefinita.
Si può conclusivamente affermare che l'invidia, da non demonizzarsi in assolu-to visto che se ne può individuare una versione “benevola”, capace di fornire sti-moli emulativi in grado di fare progredire gli individui e i gruppi sociali, non è so-stenibile, per il sistema a livello globale, se ci induce ad una spirale senza limiti di rincorsa a mete sempre più irraggiungibili e, tra l'altro, non necessariamente con-divisibili.
La ridefinizione dei fini e la critica dei valori potrebbe essere fatta in nome di un “nuovo puritanesimo” o rispolverando forme di “austerity” di cui abbiamo scarsa memoria perché prontamente rimosse subito dopo avere provvisoriamente superato l'emergenza petrolifera ed avere allontanato da noi con fastidio i brividi di Chernobyl.
Non dovrebbe essere difficile per un sistema che sa come utilizzare tutte le ar-mi della persuasione più o meno occulta, ad esempio, insinuare sentimenti di scet-ticismo verso il fascino dei ricchi, piuttosto che di invidia per la loro sorte (al di là della facile ironia sul fatto che “anche i ricchi piangono”). È lecito però ritenere che ciò non avverrà se è vero che il sistema, come abbiamo richiamato, si regge anche sul sentimento dell'invidia che, contemporaneamente, si ostina a demonizzare.
Riferimenti bibliografici
Addario N. (cur.) (1994), Il rapporto micro-macro nelle teorie sociologiche contempora-nee, Angeli, Milano.
Aklaev A.R., D.D. Dozhdev (1994), La conflittualità inter-etnica nelle repubbliche post-sovietiche: alcune considerazioni su legittimità etno-politica e crisi d'identità, in L. Bergnach, G. Delli Zotti (cur.), Etnie, confini, Europa, Angeli, Milano.
Alberoni F. (1991), Gli invidiosi, Garzanti, Milano. Axelrod R. (1985), Giochi di reciprocità. L'insorgenza della cooperazione, Feltrinelli, Mi-
lano. Bakirov V. (1994), Le nuove relazioni etniche: il caso dell'ex-Urss, in L. Bergnach, G. Del-
li Zotti (cur.), op. cit. Bodei R. (1995), Il rosso, il nero, il grigio: il colore delle moderne passioni politiche, in S.
Vegetti Finzi (cur.), Storia delle passioni, Laterza, Bari. Boileau A.M., E. Sussi (1981), Dominanza e minoranza. Immagini e rapporti interetnici al
confine nordorientale, Grillo, Udine. Boudon R. (1993), L'arte di persuadere se stessi, Rusconi, Milano. Bregantini L. (1996), I numeri e i luoghi delle minoranze etniche dall'Atlantico al Pacifico,
Isig, Gorizia.
Emozioni e sentimenti 311 Angeli, Milano, 2000
G. Delli Zotti Invidia, giustizia e povertà
Casiccia A. (1989), Razionalità, passioni, strategie, Angeli, Milano. Castelfranchi C., M. Miceli, D. Parisi (1988), Invidia. in C. Castelfranchi (cur.), Che figu-
ra. Emozioni e immagine sociale, Il Mulino, Bologna. Castellaneta C. (1986), Dizionario dei sentimenti, Rizzoli, Milano. Cattarinussi B., C. Pelanda (cur.) (1981), Disastro e azione umana. Introduzione multidi-
sciplinare allo studio del comportamento sociale in ambienti estremi, Angeli, Milano. Cipolla C.M. (1988), Allegro ma non troppo. Le leggi fondamentali della stupidità umana,
Il Mulino, Bologna. Colonna B. (1979), Dizionario etimologico della lingua italiana, Newton Compton, Roma. Davies J.C. (1962), “Toward a Theory of Revolution”, American Sociological Review, 27:
5-18. Delli Zotti G., L. Pellizzoni (1997), Giovani verso l'Europa, Isig, Gorizia. D'Urso V., R. Trentin (1998), Introduzione alla psicologia delle emozioni, Laterza, Bari. Dynes R.R., B. De Marchi, C. Pelanda (eds.) (1987), Sociology of Disasters. Contribution
of Sociology to Disaster Research, Angeli, Milano. Elster J. (1993), Come si studia la società. Una “cassetta degli attrezzi” per le scienze so-
ciali, Il Mulino, Bologna. Elster J. (1995), Il cemento della società. Uno studio sull'ordine sociale, Il Mulino, Bolo-
gna. Farber L.H. (1994), Aspetti dell'invidia, in L.H. Farber et al. (cur.), L'invidia, Bollati Bo-
ringhieri, Torino. Foglia S. (1990), I nostri sette peccati, Rizzoli, Milano. Hirsh F. (1981), I limiti sociali allo sviluppo, Bompiani, Milano. Inglehart R. (1998), La società post-moderna, Il Mulino, Bologna. Kealey T. (1998), “Invidia”, Scienza nuova, 5: 44-45. Klein M. (1969), Invidia e gratitudine, Martinelli, Firenze. La Rochefoucauld F. (1993), Massime, Newton Compton, Roma. Nosei A. (1996), “Tramutati in virtù i sette vizi capitali”, Il Gazzettino, 28 dicembre. Panic M. (1993), “Prospettive di cooperazione economica nel quadro di un nuovo 'piano
Marshall' ”, Isig, 2: 4-5. Rawls J. (1989), Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano. Revelli M., G. Rotelli (1993), La fiera dell'Est. Un imprenditore italiano nella Russia che
cambia, Feltrinelli, Milano. Sarpellon G. (1993), Ripensare la povertà. Dall'oblio all'abuso, ovvero da Giobbe a Sisifo,
in M. Palumbo (cur.), Classi, disuguaglianze e povertà. Problemi di analisi, Angeli, Milano.
Schoeck H. (1974), L'invidia e la società, Rusconi, Milano. Slepoj V. (1996), Capire i sentimenti, Mondadori, Milano. Spielman P.M. (1994), Invidia e gelosia: un tentativo di chiarificazione, in L.H. Farber et
al. (cur.), op. cit. Zajczyk F. (1993), Problematiche teoriche e metodologiche per la misurazione della po-
vertà, in M. Palumbo (cur.), op. cit.
Emozioni e sentimenti 312 Angeli, Milano, 2000