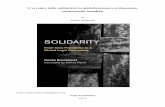Delli Zotti 1978 La solidarietà internazionale
Transcript of Delli Zotti 1978 La solidarietà internazionale
Anna Maria Boileau, nata a Casale Corte Cerro (Novara) nel 1943, si è laureata in sociologia nel 1969 presso l’Università di Trento. Dal 1969 lavora all’Istituto di sociologia internazionale di Gorizia, dove ha curato ricerche sui servizi socio-assistenziali e sui problemi delle minoranze etnico-linguistiche. Dal 1976 è incaricata di sociologia presso la Scuola superiore di servizio sociale di Verona. Bernardo Cattarinussi, nato a Marano Lagunare (Udine) nel 1946, è contrattista di sociologia presso la facoltà di scienze politiche di Trieste e collaboratore dell’Istituto di sociologia internazionale di Gorizia. Ha pubblicato studi e ricerche sull’associazionismo, sulle comunità di pescatori, sugli svantaggiati e sul pensiero utopico. Giovanni Detti Zotti, carnico, classe 1950, si è laureato in scienze politiche-indirizzo sociologico a Bologna nel 1974. E’ ricercatore dell’Istituto europeo di Firenze e collaboratore dell’Istituto di sociologia internazionale di Gorizia. Carlo Pelanda, nato a Tolmezzo nel 1951, è laureando in scienze politiche all’ Università di Trieste. Raimondo Strassoldo, friulano, nato a Roma nel 1942, ha studiato scienze politiche a Trieste e sociologia a Trento, dove ha lavorato dal 1968 al 1971. Dal 1972 è direttore dell’Istituto di sociologia internazionale di Gorizia e dal 1973 incaricato di sociologia urbana e rurale all’Università di Trieste. Ha pubblicato i volumi La suburbanizzazione della collina veneta e friulana (1971), Sviluppo regionale e difesa nazionale (1972), Sistema e ambiente. Introduzione all’ecologia umana (1977) e (come curatore) “Confini e regioni” (1973). E’ stato relatore a diversi congressi e consulente del Consiglio d’Europa. Bruno Tellia, nato a S. Possidonio nel 1943, si è laureato in sociologia a Trento e specializzato all’Università del Wisconsin (Usa). Attualmente è docente di sociologia delle comunicazioni presso l’Università di Trieste. Tra le sue pubblicazioni si segnalano le monografie Il comportamento politico-elettorale dei giovani (in collaborazione) (1972), Politica, classi sociali e personalità (1974), Gruppi di pressione e decisione politica (1975).
Attribuzioni Agli effetti di legge, le pp. 27-129, 285-308, 343-362 sono state scritte da R. Strassoldo; le pp. 133-158, 211-221, 241-285, da B. Cattarinussi; le pp. 221-240 da A.M. Boileau. Il cap. 7 è di B. Tellia, l’8 di G. Delli Zotti, l’11 di C. Pelanda.
Le fotografie sono state riprodotte per gentile concessione del “Messaggero Veneto”
Copyright ©1978 by Franco Angeli Editore, Milano, Italy È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata.
INDICE
Prefazione, di Achille Ardigò pag. 11 Presentazione, di Silvano Pagura, Angelo Candolini, Rino Snaidero “ 15 Il terremoto “ 15 Questo libro “ 19 Ringraziamenti “ 22
Parte I - Il Friuli: genesi e struttura
1. Una regione di frontiera: cenni geopolitici (macroecologici) “ 27 Origine e definizione “ 27 La patria e la lingua del Friuli “ 28 Il ruolo di Aquileia “ 29 Il ruolo della frontiera-barriera “ 32 Il ruolo della frontiera-cerniera “ 40 Conclusioni: diversità ed unità del Friuli “ 42 Note “ 46
2. Un piccolo compendio dell’universo: cenni geografici “ 48 I paesaggi del Friuli “ 48
a. La zona alpina e prealpina “ 52 b. La collina “ 54 c. La pianura “ 55
L’instabile equilibrio tra Europa Centrale e Mediterraneo e la sismicità del Friuli “ 55 Note “ 58
3. Una terra giovane e ingrata: cenni ecologico-umani “ 59 Lineamenti di storia del territorio e dell’insediamento “ 59 Lineamenti di storia agraria e della popolazione “ 66 Note “ 76
4. “Salt onest lavorador”: personalità, cultura e lingua in Friuli pag. 78
Introduzione: il problematico studio del “carattere nazionale” “ 78 Cultura e personalità del friulano nella pubblicistica corrente “ 79 Un’interpretazione a quattro dimensioni “ 82
a. Un popolo contadino “ 82 b. Un popolo nordico “ 83 c. Un popolo di frontiera “ 84 d. Un popolo di piccoli proprietari “ 85
Due ricerche sociologiche “ 87 a. Una ricerca sulla morale dei giovani friulani “ 88 b. Una ricerca sulle immagini reciproche delle comunità etniche dell’area frontaliera “ 92
La questione della lingua friulana “ 92 Conclusione “ 99 Note “ 101
5. Il Friuli oggi: alcune cifre “ 102 Introduzione “ 102 Struttura demografica “ 103 Strutture agricole “ 109 L’industria “ 116
a. L’organizzazione “ 118 b. I settori “ 118 c. La localizzazione “ 119 d. Conclusioni “ 120
Altri settori produttivi “ 122 Altri aspetti strutturali del Friuli “ 124
a. Il patrimonio edilizio residenziale “ 124 b. L’istruzione superiore “ 125 c. Le forze politiche “ 126
Note “ 129 Parte II - Il terremoto del Friuli.
Studi di traumatologia sociale
6. La sociologia dei disastri: il caso del Friuli “ 133 Premessa “ 133 Definizione e tipologia dei disastri “ 139 Le zone dei disastri “ 141 Le fasi dei disastri “ 143
a. Allarme “ 143 b. Impatto “ 144 e. Lotta di massa informale “ 145 d. Soccorso “ 146 e. Rimedio “ 147
f. Inventario o valutazione pag. 148 g. Ripristino o ricostruzione “ 150
Le reazioni psico-sociali “ 151 Note “ 157
7. Il comportamento organizzativo. Ruolo delle istituzioni for- mali e informali “ 167
Premessa “ 167 Definizione di disastro e conseguenze per la persona e la comunità “ 168 Comportamenti e risposte collettivi ed organizzati nel disa- stro “ 170 Le unità sociali nelle fasi del disastro “ 174
a. Organizzazioni comunitarie “ 174 b. Organizzazioni religiose “ 176 e. Organizzazioni formali “ 178 d. Organizzazioni territoriali “ 179
Conclusioni “ 187 Note “ 189
8. La solidarietà internazionale “ 190 Premessa “ 190 Gli aiuti internazionali al Friuli “ 194 Descrizione dei dati “ 195 Il contributo degli stati e delle nazioni “ 199
a. Paesi europei “ 199 b. Paesi extraeuropei “ 202
Il contributo delle organizzazioni transnazionali “ 204 Interpretazione dei dati “ 205 Note “ 213
Parte III - Le aspettative dei terremotati: alcune indagini sul campo
9. Gli sfollati “ 217 Premessa “ 217 Il piano di sfollamento “ 217 Scolari e studenti sfollati: atteggiamenti ed aspettative “ 220 Le condizioni dell’esodo “ 228
a. Premessa “ 228 b. I perché dell’esodo “ 229 c. L’arrivo e le condizioni di vita “ 233 d. Il futuro immediato “ 238 e. La ricostruzione “ 244 f. Alcune considerazioni conclusive “ 247
10. Le forze della ricostruzione pag. 256
Premessa “ 256 L’area d’indagine “ 258
a. La delimitazione “ 258 b. Aspetti demografici “ 261 c. L’agricoltura “ 263 d. Industria e artigianato “ 267
L’indagine sugli imprenditori “ 269 a. Metodologia “ 269 b. Risultati “ 271
Un’indagine regionale: comparazione “ 274 L’indagine presso gli addetti all’industria “ 276
a. Premessa “ 276 b. Il campione “ 277 c. Il lavoro “ 281 d. La famiglia “ 284 e. Il terremoto “ 287 f. Aiuti, bisogni, aspirazioni “ 290 g. Il paese “ 294 h. Osservazioni finali “ 298
I piccoli contadini “ 299 a. Introduzione “ 299 b. Tecnica e campione “ 305 c. Risultanze “ 307 Conclusioni “ 320 Note “ 323
11. Un’indagine monografica: Venzone “ 333 Cenni all’ambiente e alla storia di Venzone “ 333 La ricerca “ 336 Il metodo, l’universo, il campione “ 337 L’allarme “ 340 La scossa d’avvertimento delle 20.59 (7” grado scala Mercalli) “ 341 L’impatto. I comportamenti “ 343 Le voci e lo spirito nelle tendopoli “ 348 Il secondo terremoto “ 353
a. La scossa delle 5.15 “ 354 b. La scossa delle 11.23 (9” grado della scala Mercalli) “ 355
Atteggiamenti dei baraccati “ 358 a. La ricostruzione “ 358 b. Il conflitto nella comunità “ 359 c. La permanenza a Venzone “ 360 d. I prefabbricati “ 360 e. La permanenza nei prefabbricati “ 361
Note “ 363
Parte IV — Conclusioni
12. La prova del terremoto pag. 367 Aspetti generali: il contributo del caso friulano alla teoria sociologica “ 367
a. La funzione della tecnologia “ 367 b. La funzione del sistema sociale “ 359 c. La funzione dell’autorità e della gerarchia “ 369 d. La funzione del sacrificio “ 370 e. Le funzioni della famiglia “ 370 f. Le funzioni del territorio “ 371 g. La debolezza della comunità “ 371 h. Instabilità dei movimenti collettivi e dello “statu na- scenti” “ 372 i. La crescita della società globale; prossimità territoriale e sociale “ 372 l. La secolarizzazione _ “ 373 m. Il risveglio delle etnie “ 373 n. Le ipotesi della “sociologia dei disastri” “ 374
Aspetti particolari: effetti del terremoto sul Friuli “ 375 a. L’unità della regione “ 375 b. L’unanimità della regione “ 375 c. La continuità del Friuli “ 377
L’evoluzione del post-terremoto: cinque “scenari” “ 373 Problemi e prospettive “ 333
Bibliografia “ 387
Friuli: la prova del terremoto
8. LA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE
Premessa Ogni comunità locale è collegata da rapporti di vicinato con altre
comunità dello stesso livello e inserita in una gerarchia di sovrasistemi. Il mondo non è fatto di “società” o “nazioni” o “popoli” rigidamente racchiusi entro confini, come gli organismi entro la pelle; il mondo — cioè l’umanità, l’ecosistema globale — è un fittissimo intreccio di rapporti tra attori e centri decisionali, in un tessuto che si raddensa attorno ai grandi centri di potere socio-politico-economico, le aree urbano-industriali, e si dirada verso le periferie (1). I confini nazionali segnano delle discontinuità rilevanti in questo tessuto, ma non lo interrompono. I rapporti tra gli attori non sono solo internazionali, cioè mediati attraverso i centri degli stati-nazionali e filtrati attraverso i loro confini; ma sono anche trans- e sovra-nazionali, cioè diretti tra i diversi attori situati in società diverse. La sociologia internazionale è in realtà sociologia globale; considera cioè l’intera umanità come un’unica società molto complessa e articolata e differenziata e conflittuale; ma in sostanza un unico sistema societario, con tutto quello che tali termini implicano.
In ciò differisce profondamente dallo studio politologico delle relazioni internazionali, che, sulle tracce del diritto internazionale e della storia diplomatica, assume lo stato-nazionale a primattore e mattatore delle vicende mondiali (2).
Uno dei motivi principali per cui gruppi e comunità locali si aggregano ed integrano in sistemi sovraordinati è la ricerca della sicurezza e della difesa; questo dà ai sistemi politico-militari, cioè gli stati, la loro enorme importanza e spiega gran parte della dinamica socio-politica, ad ogni livello. Il patto sociale che ogni individuo ed ogni gruppo
La solidarietà internazionale 191
Angeli, Milano, 1978
stringe quotidianamente con lo stato, conformandosi alle sue norme pagando le tasse, comporta da parte dello stato l’obbligo di garanti difesa e sicurezza; in primo luogo dai nemici esterni, gli invasori. Ma anche le catastrofi naturali sono di solito considerate una sorta i nemico da cui la società deve difendere i suoi membri e, se il guasto stato già prodotto, deve indennizzarli (3). In altre parole l’appartenenza degli individui a gruppi più vasti, e in particolare allo stato, anche un meccanismo per distribuire in modo ordinato e prevedibile gli obblighi di solidarietà e responsabilità. La divisione dell’umanità in stati serve a stabilire chi sarà chiamato in via primaria a rispondere della sicurezza, del benessere, o della stessa vita delle vittime di catastrofi, naturali o meno (4). Così se una catastrofe avviene a duemila chilometri di distanza, ma entro confini nazionali, una comunità dovrà contribuire ai soccorsi e ricostruzione; se avviene a dieci chilometri di distanza, ma al di là di un confine, l’obbligo non esiste più.
Si tratta di un sistema che ha i suoi pregi e i suoi difetti, la sua logica e le sue distorsioni. Un meccanismo per fissare in modo generale e prevedibile obblighi e solidarietà è necessario. Solo in un mondo di angeli si può pretendere che ogni individuo sia direttamente responsabile di ogni altro; solo in un mondo di santi si può richiedere che il disastro che distrugge una tribù melanesiana mi sconvolga come quello che colpisce la mia famiglia.
Nel mondo attuale il modello tradizionale, per cui questi obblighi spettano alla comunità nazionale, convive con criteri nuovi ed emergenti, per cui si assiste all’insorgere di varie forme di solidarietà tran e sovranazionale; privati cittadini, villaggi, città, regioni, organizzazioni settoriali, nazioni, centri sovranazionali sparsi in tutto il mondo in varia misura si sentono in dovere di contribuire all’alleviamento delle sofferenze delle vittime dei disastri; e i loro soccorsi, di varia natura sono diretti a privati, villaggi, città, organizzazioni settoriali, governi locali dell’area disastrata, e passano attraverso i centri nazionali. Tal volta questi, peraltro, li rifiutano o esigono un controllo diretto e totale.
Ciò accade in varia misura in tutti i casi di grandi catastrofi, ben pubblicizzate dalla stampa mondiale, e le motivazioni di questi flussi di soccorsi sono le più varie, dall’interesse e dalla speculazione pubblicitaria ai più disinteressati sentimenti umanitari.
Uno studio delle risposte organizzative alla catastrofe non può certo fermarsi entro i confini nazionali; anche la comunità internazio-
192 G. Delli Zotti
Friuli: la prova del terremoto
nale, la società umana nel suo complesso, sono organizzazioni; e forse mai come in casi di catastrofi esse rivelano la loro natura sistemica.
Anche la sociologia internazionale può quindi contribuire alla comprensione dei fenomeni di risposta societaria ai disastri, e quindi all’affinamento della “traumatologia sociale”.
Nel caso del Friuli questo aspetto sembra decisamente di primaria importanza, anche se mancano termini di confronto. Nei giorni im-mediatamente seguenti al 6 maggio, quasi contemporaneamente ai pellegrinaggi delle autorità nazionali italiane, avvenivano quelli delle massime autorità del sistema occidentale: il vicepresidente degli Usa Rockefeller, e il capo dell’esecutivo della Cee Ortoli; mentre la Nato mobilitava i suoi reparti più vicini, di Aviano e della Baviera. I consolati dei paesi dove esisteva qualche comunità di immigrati friulani erano subissati dalle richieste di notizie; ovunque sorgevano comitati ed iniziative di solidarietà. Questa massiccia convergenza di persone, cose ed informazioni dall’estero verso il Friuli rendeva perfino necessaria la creazione, a fianco del commissariato straordinario del governo per il Friuli terremotato, di un embrionale “ministero degli affari esteri”, un ufficio con personale distaccato dalla Farnesina.
L’entità degli aiuti affluiti dall’estero, Cee compresa, può essere stima-ta in 100 miliardi di lire. Le cifre citate in questo capitolo rispecchiano la situazione al marzo 1977. Contributi e donazioni sono confluite anche in seguito. Nel dicembre 1977, ad es. gli Usa hanno stanziato ulteriori 25 milioni di dollari. A fronte dei quali stanno il 500 miliardi immediatamen-te stanziati dal governo di Roma per i soccorsi, e i 34 offerti alla regione da privati e organizzazioni non governative. Inoltre a fronte del volontariato affluito dall’estero sta il ben più massiccio lavoro di volontari nazionali.
Ma il rapporto fra flussi interni e flussi dall’esterno non è così basso come ci si potrebbe aspettare alla luce delle teorie deutschiane sull’au-mento dell’importanza dello stato nazionale e del declino dell’inter-dipendenza transnazionale (5). L’ipotesi avrebbe bisogno di analisi statistiche comparate impossibile da compiersi in questa sede. Ma i dati relativi alla solidarietà internazionale nel caso friulano sembrano molto suggestivi. Forse, malgrado tutto, il mondo sta veramente maturando verso forme di comunità solidaristica a livello globale.
Questa ipotesi ottimistica deve essere però ridimensionata dalla teoria delle regioni di frontiera e dai fenomeni del “buon vicinato”, che vigono anche nella comunità internazionale (6). Come si è già accennato, la regola fondamentale è che la distribuzione degli obblighi solidarietà è marcata dai confini nazionali; ma questa regola è tempe-
La solidarietà internazionale 193
Angeli, Milano, 1978
rata dal principio della prossimità o vicinanza, per cui gli stati limitrofi hanno qualche maggior propensione e obbligo morale a contribuire ai soccorsi, a prescindere dalla collocazione internazionale. Certamente, tuttavia, il caso del Friuli ha dimostrato che la solidarietà è gravemente bloccata dalle linee di divisione tra i blocchi politico-militari, e che i maggiori oneri e responsabilità per la sicurezza degli alleati competono alla nazione-guida delle coalizioni (7). Infatti praticamente nessun aiuto è venuto dal blocco orientale, mentre gli Usa da soli hanno contribuito quanto tutti gli stati europei messi insieme, e quasi la metà dell’intera somma di aiuti esteri.
L’importanza della formazione sovranazionale europea è ben evi-denziata dal fatto che il suo contributo ammonta a circa 40 miliardi di lire (pari a tutti i contributi di privati italiani alla regione). La teoria delle regioni di frontiera rende ben conto dell’importanza assunta dalla solidarietà internazionale nel caso del Friuli, sia per quanto riguarda gli aiuti in denaro e generi sia per quanto riguarda il ruolo dei reparti militari, italiani, alleati o semplicemente stranieri, come quelli austriaci. Ma non basta. L’altro grande fattore è il tessuto di rapporti transnazionali che lega il Friuli a molte vaste e lontane aree del resto del mondo dove vivono i suoi figli. Come si è visto, sono varie centinaia di migliaia i friulani nel mondo, cioè i cittadini stranieri di origine e lingua, o almeno memorie culturali, friulane, cui sono da aggiungere gli emigrati non permanenti. Questo è un fattore non direttamente legato alla posizione frontaliera, quanto piuttosto all’ecologia di questa regione. Ma s’inquadra bene nella teoria che vede nell’interpenetrazione culturale e genetica uno dei più promettenti elementi di costruzione della comunità mondiale. Il fatto che una parte considerevole dei flussi di soccorso transnazionali si svolgesse tra privati e comunità locali e organizzazioni non governative da ragione ai sostenitori della politica di “scavalcamento” dei centri nazionali, attraverso l’intreccio di rapporti diretti tra cittadini, città, autorità locali e così via. La validità dei tanto derisi “gemellaggi” tra città, della costituzione di assemblee e fori rappresentativi di queste entità attraverso le frontiere, e tutto quanto va sotto l’etichetta di cooperazione transfrontaliera” e di “rapporti transnazionali” ha trovato nel caso del Friuli una esaltante conferma (8).
Infine, la tempestività e dimensioni dell’interessamento della Cee costituisce la miglior prova della validità dell’informale “politica estere” perseguita dalla regione in questi anni, mediante una fitta serie di iniziative, contatti, convegni, incontri a diverso livello tra gli organi
194 G. Delli Zotti
Friuli: la prova del terremoto
regionali e quelli comunitari. Iniziative queste evidentemente non previste dalla lettera delle leggi istitutive delle regioni, ma rese inevitabili dal momento in cui le decisioni comunitarie hanno riflessi diretti sulla vita regionale. In questo modo il terremoto del Frulli ha dato un’ulteriore spinta alla costruzione dell’”Europa delle regioni” (9).
Gli aiuti internazionali al Friuli Nei primi giorni, immediatamente seguenti gli eventi sismici del 6
maggio 1976, gli aiuti esteri, inviati in vario modo dalle popolazioni vicine, sono cominciati a giungere al Friuli. Si è trattato per lo più, in questa prima fase, di iniziative private; di singoli, associazioni o ditte che hanno voluto accorrere per manifestare la solidarietà, la partecipazione al dolore dei friulani ed anche alleviare in maniera concreta le sofferenze delle popolazioni colpite. Il tipo degli aiuti è consistito in invii di materiale vario: generi alimentari, medicinali, vestiario, tende, coperte, ecc. Nei primi giorni c’è stato anche un notevole afflusso di volontari che partecipavano all’opera di rimozione delle macerie nel disperato tentativo di salvare ancora qualche vita umana. I soccorsi materiali “in natura” sono comunque giunti ai terremotati in due maniere diverse. Una via è stata quella indiretta che passava per grossi centri di raccolta istituiti in vari luoghi quali la caserma Cavarzerani di Udine, la zona fieristica del Cormor (specialmente per soccorsi fatti affluire dalla Croce rossa internazionale), l’Arcivescovado di Udine (specialmente per i soccorsi Charitas) come pure per i centri organizzati direttamente nei comuni terremotati in edifici risparmiati dal sisma. Un’altra parte dei soccorsi ha invece raggiunto i terremotati direttamente. I camion o i furgoni con il materiale giunto da varie parti, facevano il giro delle tendopoli e distribuivano loro “merce” dove la sensibilità dei soccorritori faceva ritenere che i fosse maggiore bisogno di aiuto.
Un bilancio preciso dell’ammontare degli interventi esteri, con pure di quelli attuati da enti o cittadini privati italiani, non si potrà mai certamente fare. Anche trascurando i già nominati interventi diretti “da soccorritore a terremotato”, che, se molto significativi sul piano umano, non sembrano essere comparabili quantitativamente a quelli che sono stati i seguenti interventi più organizzati, c’è però da
La solidarietà internazionale 195
Angeli, Milano, 1978
tenere presente che nemmeno per i soccorsi affluiti nei centri di raccolta è facile arrivare ad un bilancio. Specialmente per i centri istituiti nei comuni disastrati bisogna ricordare che le gravi necessità del momento facevano passare giustamente in secondo piano l’esigenza di tenere una accurata contabilità di quanto affluiva. La nostra analisi dei soccorsi internazionali giunta in Friuli in occasione del duplice evento sismico del maggio e del settembre del 1976 terrà dunque conto in maggiore misura degli interventi che sono stati attuati per vie più ufficiali e che comunque costituiscono la stragrande parte del totale. I dati sono ricavati dalla documentazione esistente presso il commissariato straordinario del governo, ed integrati con quelli raccolti presso la Croce Rossa, la Charitas e l’Ente Friuli nel Mondo.
Sfuggono poi ad ogni possibilità di accurata quantificazione anche gli interventi dei volontari che hanno operato nella fase della rimozione delle macerie ed in quella del recupero delle case aggiustabili. Questi interventi sono stati attuati da gruppi di giovani appartenenti ad organizzazioni di tipo scoutistico o di altro genere, da squadre di tecnici ed operai inviate da enti locali o aziende o venuti per iniziativa personale. Hanno anche operato alcuni reparti di eserciti alleati come quello tedesco, canadese e americano e vigili del fuoco stranieri e altri corpi specializzati, come il gruppo di tecnici francesi che hanno utilizzato sonde microfoniche nella ricerca di eventuali superstiti.
Molto spesso questi gruppi, che hanno agito nelle zone devastate dal sisma, hanno lasciato sul luogo materiali o macchine usate nei loro interventi e queste donazioni sono state comprese, quando quantificabili, nel totale relativo alla nazione di provenienza.
Descrizione dei dati La tab. 7 contiene un riassunto generale di tutti i dati sugli aiuti al
Friuli, compilata secondo i criteri e con le difficoltà fin qui esposte. I dati globali per nazione sono stati disaggregati in tre voci: gli aiuti governativi; quelli provenienti da amministrazioni locali di vario genere quali province, dipartimenti, länder, città ed anche stati componenti di federazioni; e contributi privati di vario genere.
I contributi governativi sono quelli che di più, in fase interpretativa si prestano a spiegazioni di tipo politico-internazionale. E’ da ritenere infatti che i governi centrali degli stati, nel decidere l’ammon-
196 G. Delli Zotti
Friuli: la prova del terremoto
Tab. 7 - Quadro riassuntivo degli aiuti internazionali al Friuli
La solidarietà internazionale 197
Angeli, Milano, 1978
198 G. Delli Zotti
Friuli: la prova del terremoto
tare degli invii di aiuti, abbiano presente i sentimenti e le reazioni delle rispettive popolazioni; ma essi tengono anche in debito conto considerazioni di opportunità politica, di schieramento a livello inter-nazionale, di partnership economica.
Nell’interpretazione dell’ammontare degli aiuti provenienti dalle amministrazioni locali pare invece che si possano abbandonare, o che diminuiscano d’importanza, le variabili più propriamente politiche e che, data la maggiore “vicinanza” di questo tipo di amministrazioni alle rispettive popolazioni, sia più utile adoperare le seguenti variabili: vicinanza geografica, attività culturale, presenza di emigrati friulani o italiani. Val qui la pena di ricordare che uno stimolo alla raccolta di fondi da parte delle amministrazioni locali è venuto anche da una iniziativa del Consiglio d’Europa che ha appunto sollecitato in tale senso le autorità regionali, le “Città d’Europa” degli stati membri e le componenti della Conferenza delle autorità locali e regionali d’Europa.
La voce “Contributi privati” raggruppa uno spettro abbastanza ampio di interventi attuati da attori diversi che vanno dal semplice cittadino alla grossa organizzazione di soccorso internazionale. Abbiamo preferito raggruppare sotto una stessa etichetta tutta una serie di contributi di provenienze disparate perché sarebbe stato difficile tracciare dei confini certi volendo disaggregare maggiormente.
Il problema deriva qui dal fatto che la maggiore parte delle somme raccolte e che cadono sotto questa voce derivano dall’indizione di collette pubbliche. Fra i promotori di simili iniziative vorremmo ricordare ad esempio: giornali locali, associazioni di friulani all’estero, comitati di soccorso sorti ad hoc, sedi di ambasciate italiane all’estero, organizzazioni sindacali, grosse organizzazioni internazionali di soccorso quali la Croce rossa e la Charitas. Nel totale delle somme raccolte in tutte queste sottoscrizioni è difficile distinguere le somme stanziate dalle organizzazioni stesse dai contributi privati che si sono poi aggiunti. Un altro motivo di incertezza deriva dal fatto che alcune volte somme raccolte da alcune organizzazioni sono poi state inoltra te tramite altre, o si sono aggiunte alle somme raccolte da altri. Ci è parso interessante comunque rendere conto delle iniziative più rilevanti che sono state intraprese e lo faremo in una parte di questo capitolo dedicata in particolare all’attività della Croce rossa, della Charitas e dei Fogolars Furlans.
Passiamo quindi ora ad esaminare, stato per stato, le caratteristiche principali degli aiuti che sono stati portati al Friuli.
La solidarietà internazionale 199
Angeli, Milano, 1978
Il contributo degli stati e delle nazioni
a. Paesi europei
San Marino — Il contributo di San Marino può sembrare a prima vista modesto, ma rapportato alla popolazione di questo piccolo stato, esso risulta essere il più ampio. Questo fatto ci fa anzi ritenere che San Marino si collochi piuttosto artificiosamente in questo discorso sugli aiuti internazionali in Friuli. Infatti, la popolazione sanmarinese non è stata seconda, in questa gara di solidarietà con il Friuli terremotato, alle altre città e regioni italiane, grazie anche allo stimolo di alcune sue autorità particolarmente sensibili ai problemi delle catastrofi da terremoto. I fondi raccolti dalla Repubblica di San Marino sono utilizzati per finanziare la costruzione dell’acquedotto di Prossenicco e per il restauro e l’ampliamento della casa di riposo “Sirch” di S. Pietro al Natisone.
Austria — Gli aiuti austriaci, sia in valore assoluto, che relativo alla popolazione e al reddito, sono stati davvero massicci ed immediati; bisogna infatti anche tenere presente che l’Austria stessa è il paese per il quale, forse molto più che per gli altri, è veramente impossibile fare un bilancio definitivo delle attività di soccorso. La sua vicinanza con la regione colpita ha permesso infatti, più che per altri paesi, lo svilupparsi del fenomeno delle iniziative di soccorso diretto alle popolazioni, iniziative che non sono state interamente censite. Vale qui la pena di ricordare la decisione del governo austriaco di raddoppiare le somme raccolte dai privati, iniziativa questa che ha concorso alla riuscita dell’opera di soccorso.
Difficile fare un quadro degli interventi, anche solo i più notevoli, attuati con le somme raccolte in Austria. E’ certo che quasi tutte le località distrutte o danneggiate dal sisma hanno potuto conoscere la solidarietà della popolazione austriaca.
Jugoslavia — Notevole è anche la presenza della Jugoslavia fra le nazioni che più hanno contribuito con invio di aiuti al Friuli; va infatti ricordato che, se da un lato la Jugoslavia confina con il Friuli e le relazioni economiche e di amicizia con la popolazione della vicina Slovenia sono molto sviluppate, gli eventi sismici hanno colpito, sep-
200 G. Delli Zotti
Friuli: la prova del terremoto
pure in maniera meno grave, anche alcuni centri della repubblica confinante. Nel totale degli aiuti jugoslavi è compresa la somma di lire 2.800.000.000 stanziata dal governo di Belgrado. La maggior parte degli altri aiuti sono stati stanziati dal governo della Slovenia e sono stati utilizzati per l’invio di case prefabbricate e di roulottes.
Svizzera — La Svizzera è in Europa seconda solo alla Germania come presenza di lavoratori friulani emigrati e questo fatto si è certamente riflesso sull’entità degli aiuti raccolti ed inviati al Friuli. Fra gli inter-venti di maggiore portata, e a parte le iniziative della Croce rossa, della Charitas e dei Fogolars Furlans di cui diamo notizia in altra parte di questo capitolo, si deve ricordare il piano del governo federale per la ricostruzione di alcune frazioni e l’invio ad Attimis di 51 baracche da parte del Dipartimento politico federale di Berna. Il governo federale ha poi anche promosso la raccolta da parte della Società svizzera degli imprenditori di 62 tonnellate di macchinari e materiali vari per l’edilizia, ed ha inviato, nella prima fase di soccorso, tramite aerei da carico, aerei militari e autotreni, generi di prima necessità, stoviglie, stivali e circa 250 tende. Una scuola prefabbricata è stata donata al comune di Tricesimo dalla Lia Rumantscha e un centinaio di roulottes sono state acquistate con i proventi di collette varie e trasportate gratuitamente dalle ferrovie svizzere.
Norvegia — L’impegno maggiore della Norvegia consiste nel piano del governo per l’invio di 252 case prefabbricate. La maggiore parte di esse sono state montate nel comune di Alesso dove sono andate al costituire un intero villaggio composto di 102 prefabbricati di 25, 50, 75 metri quadrati.
Germania federale — Il governo federale tedesco oltre ad un grosso invio di materiali vari con i primi soccorsi ha partecipato con più di 2.000.000 di marchi ai piani di intervento della Croce Rossa, Charitas e dell’Opera della Chiesa diaconale. Alle opere di soccorso ha partecipato anche un battaglione della Bundesweher che ha trasportato nelle zone terremotate tende e letti da campo messi a disposizione dalla Nato. Notevolissimo è stato anche l’apporto, a livello regionale, del Land della Baviera con un contributo di 1.000.000 di marchi da parte di quel governo ed il sorgere di altre iniziative importanti come quella del quotidiano Mùnchener Mercur che con una colletta ha
La solidarietà internazionale 201
Angeli, Milano, 1978
potuto raccogliere la somma di 350.000 marchi e altri fondi per la costruzione di 18 prefabbricati installati in seguito dalla Croce rossa bavarese. Molto caratteristico è poi il caso della città di Esslingen, città gemellata con Udine, che ha interamente mobilitato la sua popolazione e le sue associazioni volontarie per portare aiuto al Friuli. Ha operato nella zona una equipe di dentisti con un ambulatorio mobile, i cui strumenti sono poi stati donati a colleghi terremotati. 25 autobus con viveri ed indumenti sono stati inviati dall’Arbeiter-wohlfahrt della Baviera dopo le scosse di settembre.
Lussemburgo — I contributi lussemburghesi provengono per intero da una sottoscrizione aperta dal Fogolar Furlan locale che ha raccolto la somma di 28 milioni. Questo fondo è stato utilizzato per la costruzione, nel comune di Tramonti di Sopra, di 3 mini alloggi per coppie di persone anziane.
Belgio — Anche in questo paese hanno agito in notevole misura i Fogolars Furlans del luogo e le grosse organizzazioni internazionali di soccorso di cui diamo notizia in altra parte del capitolo. E’ intervenuto comunque anche il governo stesso con 6 voli di materiale vario da parte del Ministero della difesa e l’invio di militari specializzati nel montaggio delle tende.
Svezia — Per quanto riguarda la Svezia si ha notizia da un comunicato Ansa dei primi giorni seguenti il sisma del maggio dello stanziamento di 200.000.000 di corone, delle quali poi si sono perse le tracce.
Francia — Il contributo francese è stato per la verità inferiore a quanto ci si sarebbe potuti aspettare vista la vicinanza, i buoni rapporti e la notevole presenza di emigranti sia italiani che friulani in particolare. Non si ha notizia di stanziamenti da parte del governo centrale, mentre il contributo più grosso proviene dall’organizzazione Secours catholique. C’è stato anche l’impiego di duecento vigili del fuoco con i primi soccorsi.
Gran Bretagna - Essendo purtroppo sfumata l’offerta da parte della città di Londra di prefabbricati per 640.000.000 di lire, per l’alto costo del trasporto (400.000.000 di lire) che avrebbe dovuto essere a carico del governo italiano, gli aiuti inglesi non sono stati massicci. Il
202 G. Delli Zotti
Friuli: la prova del terremoto
governo inglese ha comunque stanziato 100.000 sterline che sono servite per l’acquisto di una trentina di case prefabbricate. L’esercito inglese ha anche fornito tende, letti da campo, coperte e la Raf ha fatto dei rilievi fotografici nella zona terremotata. Una simpatica iniziativa è stata certamente quella del giovane Paul Grivier che ha girato la Scozia in bicicletta raccogliendo 179 sterline per i friulani colpiti dal terremoto.
Altri paesi europei — Significative, anche se di minor ampiezza, le iniziative di solidarietà sorte in altri paesi europei. Fra queste vorremmo ricordare i quasi 14 milioni raccolti a cura della nostra ambasciata di Madrid fra la collettività italiana in Spagna, i 2.800.000 dalla associazione olandese per i prodotti dell’argilla e della ceramica a favore dei ceramisti di Buia e il milione circa raccolto fra i diplomatici accreditati presso la Santa Sede.
b. Paesi extraeuropei
Arabia Saudita — E’ dei primissimi giorni seguenti il sisma del 6 maggio 1976 la notizia dello stanziamento da parte del governo saudita di 5.000.000 di dollari per aiuti al Friuli.
Si tratta evidentemente di una cifra notevolissima. Essa colloca l’Arabia Saudita in testa a tutte le nazioni, escluso San Marino, se rapportiamo questa cifra alla popolazione e al prodotto nazionale dello stato. Questo fatto si spiega certamente con la larga disponibilità di eurodollari, ma è anche indice della volontà politica di quel governo di intrattenere buoni rapporti con i paesi dell’Occidente industrializzato.
Canada — Quasi tutti gli aiuti canadesi hanno fatto capo al National Congress of Italian Canadian Foundation che è riuscito in totale a raccogliere la cifra di 4.000.000 di dollari. Di questa cifra fanno parte 500.000 dollari stanziati dal Governo provinciale dell’Ontano. Le prime realizzazioni del Ncicf sono consistite nella costruzione in comune di Forgaria della “Borgata Canada” costituita da 72 casette unifamiliari. Interventi analoghi sono stati attuati anche nei comuni di Pinzano e Venzone e sono state anche costruite 2 case per anziani i nei comuni di Taipana e Bordano. Anche alcuni reparti militari delle
La solidarietà internazionale 203
Angeli, Milano, 1978
forze Nato canadesi si sono impegnate a lungo nell’opera di soccorso dando al Friuli anche un tributo di sangue: il militare morto a bordo dell’elicottero precipitato nella zona di Alesso durante un’operazione di soccorso.
Australia — Anche in Australia si è costituita una organizzazione che ha coordinato a livello nazionale le iniziative di soccorso: l’Australian Committee for Italian Earthquake Fund che è riuscito a raccogliere la somma totale di 950.000 dollari australiani. Anche in questo paese è stato notevolissimo l’apporto dei Fogolars Furlans molto attivi nel promuovere iniziative di solidarietà. Ricordiamo anche lo stanziamento di 250.000 dollari australiani da parte del governo di Camberra per la costruzione di asili d’infanzia.
Stati Uniti - Il governo degli Stati Uniti ha stanziato 25.000.000 di dollari. Di questi 1 milione sono stati spesi per i primi interventi in uomini, mezzi e materiale. Il resto delle somme stanziate viene utilizzato per un piano di costruzioni di scuole nelle province di Udine e Pordenone e servirà per la realizzazione di case di riposo per anziani nei comuni di Osoppo, Magnano, Buia, Majano e San Daniele. Fra le collette private ricordiamo i 500.000 dollari raccolti dal Fogolar Furlan di New York in collaborazione con il quotidiano locale Il Progresso Italo-Americano. E fra gli interventi di difficile monetarizzazione ricordiamo l’invio di 2.040 colli di vestiario da parte della Venetian Earthquake Relief Inc. del Connecticut.
Argentina — L’Argentina si potrebbe forse collocare fra le nazioni che hanno inviato in maggior misura aiuti al Friuli. I Fogolars Furlans sono stati anche in questo caso molto attivi e, organizzati in un coordinamento nazionale, hanno raccolto molti milioni di pesos. Non è stato però possibile quantificare il contributo argentino, che è stato certamente rilevante. La difficoltà deriva dal fatto che i pesos argentini sul mercato dei cambi hanno un valore molto basso e che quindi i Fogolars Furlans hanno preferito effettuare invii di aiuti “in natura”. Si ha notizia della spedizione di 2.800 coperte di lana, di 2.500 lenzuola e 500 paia di scarpe. Le somme ancora da utilizzare verranno probabilmente spese per l’acquisto di bestiame da destinare al ripopolamento zootecnico delle zone terremotate.
Altri paesi extraeuropei - Altre somme sono state raccolte in vari
204 G. Delli Zotti
Friuli: la prova del terremoto
altri paesi all’interno delle comunità di italiani emigrati. Ci sono anche da ricordare i contributi del governo dell’Iran di 50.000 dollari per il quale vale il discorso fatto a proposito dell’Arabia Saudita, e quello del governo della Nuova Zelanda che ha inviato 40.000.000 di lire circa, da utilizzarsi per il restauro del Museo delle arti e tradizioni carniche di Tolmezzo.
Per la completezza dell’informazione di cui siamo in possesso dob-biamo ancora riportare che il governo dello Sry Lanka (Ceylon) ha inviato al Friuli 549 kg di tè ed anche che l’Unesco ha donato macchinari del valore di 60/80 milioni che sono stati messi a disposizione di un costituendo dipartimento di “Habitat and Environment” tramite il Cism-Centre international des sciences mécaniques.
Il contributo delle organizzazioni transnazionali Fin qui l’esame e la descrizione dei dati nazione per nazione. Ora è il
caso di spendere qualche parola per le organizzazioni internazionali che molto hanno fatto per alleviare i grossi problemi del Friuli del dopo terremoto. Dell’attività e del ruolo, a volte determinante, dei Fogolars Furlans, che all’interno dei singoli stati sono stati a volta gli unici catalizzatori di iniziative di solidarietà, si è già parlato qui sopra. Ora ci soffermeremo in particolare sull’attività della Croce rossa e della Charitas che hanno visto impegnate in Friuli numerose consorelle di altre nazioni.
Innanzitutto la Croce rossa: l’elenco degli interventi di questa orga-nizzazione per essere completo dovrebbe essere molto lungo. Per quanto riguarda ad esempio la Croce rossa austriaca, essa ha realizzato un asilo ad Avasinis, uno a Tarcento ed un altro a Terzo di Tolmezzo. La Croce rossa svizzera ha costruito 12 appartamenti antisismici in cemento armato ad Avasinis e prefabbricati in legno per un totale di 50 famiglie a Taipana e Prossenicco. Ancora più notevoli gli interventi della Croce rossa tedesca che ha costruito un ospedale prefabbricato a Tolmezzo e prefabbricati in varie zone, e della Croce rossa tedesca-bavarese che, oltre a vari interventi di prefabbricazione, ha realizzato una scuola elementare, sempre prefabbricata, a Taipana. Anche la Lega delle Società di Croce rossa di Ginevra è intervenuta in prima persona o in collaborazione con la Croce rossa italiana in particolare nella realizzazione di un ambulatorio ad Alesso e Paularo, di
La solidarietà internazionale 205
Angeli, Milano, 1978
una palestra con mensa a Gemona e di scuole materne ed elementari a Magnano in Riviera, Tolmezzo e Resiutta. Alla Croce rossa italiana sono poi giunti contributi vari, anche di notevole entità, delle consorelle estere del Belgio, della Francia, e della Croce rossa americana.
Per la Charitas molto importante è stato l’impegno della Charitas tedesca che ha realizzato o sta per completare un vasto piano di prefabbricazione di case nelle comunità di Moggio Udinese, Tarcento, Osoppo, Gemona, Valeriano e Venzone. Sta anche per completa la costruzione di una scuola materna ad Ospedaletto ed ha in fase di progetto la costruzione di case per anziani a Prato di Resia, Resiutta, in Val Raccolana e a Roveredo. 250 case prefabbricate sono state allestite anche dalla Charitas austriaca, mentre la Charitas svizzera ha operato con l’allestimento di prefabbricati a Pinzano, Vito d’Asio ed ha in programma altri piani di intervento quali la costruzione di definitive per anziani e la prosecuzione di lavori di riparazione di edifici danneggiati.
Contributi in denaro sono giunti al Friuli anche da parte della Charitas belga.
Interpretazione dei dati Le cifre totali che si possono esaminare nella tab. 7 danno una idea
globale di quello che è stato lo sforzo dei singoli stati. Ci sono però stati grandi e stati piccoli, stati ricchi e stati che lo sono in misura molto minore. Per avere un’idea meno approssimativa dell’entità dei soccorsi bisogna allora che le cifre vengano rese maggiormente e comparabili e questo si può fare eliminando l’influenza delle variabili economiche e demografiche. Questo è quanto si è fatto per poter compilare la tab. 8, in cui le cifre globali degli aiuti sono state rapportate alla popolazione media dello stato considerato. Si è ottenuto così un indice che da l’immediata percezione di quello che è stato l’impegno medio pro capite della popolazione dello stato che ha inviato aiuti. È questo un indice abbastanza suggestivo e di immediata comprensione. In un’altra colonna abbiamo però voluto rapportare l’ammontare degli aiuti anche al prodotto nazionale lordo della nazione presa in considerazione ed è seguendo questo indice che abbiamo ordinai nazioni oggetto di questo studio.
Questo tipo di operazione non è stato attuato per tutte le nazioni
206 G. Delli Zotti
Friuli: la prova del terremoto
Tab. 8 - La solidarietà internazionale: quote pro capite e quote del pnl.
Totale aiuti (in lire)
Totale/pop. (dati del 1972)
Tot. x 1000 / pnl (dati del 1972)
San Marino 80.000.000 4210,52 — Austria 9.596.020.000 1251,54 612,86 Jugoslavia 3.471.294.000 165,64 243,24 Svizzera 3.655.000.000 568,34 173,94 Norvegia 668.181.000 170,94 60,62 Germania federale 5.740.347.000 84,78 32,31 Lussemburgo 28.000.000 79,77 29,41 Belgio 452.892.000 34,11 12,55 Francia 575.486.000 11,03 3,61 Gran Bretagna 330.322.000 5,90 2,58 Paesi Bassi 18.915.000 1,40 0,58
Arabia Saudita 4.325.000.000 512,25 1223,13 Canada 3.424.139.000 154,76 41,49 Australia 1.186.568.000 90,35 36,10 Usa 24.142.685.000 114,74 24,32 Venezuela 171.000.000 15,15 14,55 Nuova Zelanda 40.450.000 13,65 6,41 Brasile 200.000.000 1,97 4,52 Iran 43.250.000 1,38 3,34 Tunisia 4.591.000 0,90 2,85 Sud Africa 30.520.000 1,25 1,76
comprese nel quadro riassuntivo che, per completezza dell’informazione, contiene tutti gli aiuti, anche di minima entità, di cui ci sia notizia. Per alcune di queste nazioni infatti il discorso che svilupperemo non avrebbe senso data l’esiguità degli aiuti e il fatto che in certi casi solo una piccola parte della popolazione ha partecipato alle iniziative prese o è stata sufficientemente informata di quanto accadeva in Friuli. Il dato su San Marino è stato riportato in tabella solo come termine di confronto, ma non lo utilizzeremo nella discussione seguente, data la particolarità del caso.
Nell’interpretazione dei dati relativi agli aiuti dei paesi europei al Friuli riteniamo che due variabili svolgano un ruolo piuttosto cruciale. Una di queste è la “vicinanza” della nazione considerata alla
La solidarietà internazionale 207
Angeli, Milano, 1978
Fig. 30 – La solidarietà internazionale: A. valori assoluti; B. contributo pro-capite; C. quota del prodotto nazionale lordo (al 1972)
.
208 G. Delli Zotti
Friuli: la prova del terremoto
regione colpita e la seconda la presenza di emigranti friulani e/o italiani. L’importanza della variabile “vicinanza” deriva dal fatto che la
vicinanza geografica significa frequentemente anche una certa affinità culturale, cementata da continui scambi di ogni genere a livello internazionale e transnazionale. A questo si può aggiungere anche una maggiore partecipazione emotiva, dovuta alla maggiore quantità di informazione a cui le popolazioni vicine alla zona della catastrofe sono esposte da parte dei mass-media.
L’importanza della variabile “emigrazione”, specialmente friulana, può essere evidenziata essenzialmente con due considerazioni:
a. la consuetudine, la familiarità con i friulani fa aumentare nelle popolazioni ospitanti il senso di partecipazione agli eventi dolorosi che toccano parenti e amici di persone per le quali a propria volta si nutre amicizia e stima. E’ un luogo comune suffragato dai fatti, che i friulani all’estero hanno saputo conquistarsi la fama di persone oneste, lavoratrici, ecc.;
b. la presenza di emigrati significa il sorgere di iniziative di solidarietà, di collette alle quali partecipano gli stessi friulani all’estero, ma anche in larga misura le popolazioni delle città e dei paesi ospitanti. Vediamo ora, confrontandola con i nostri dati, quale è l’influenza
della variabile “vicinanza”. I due paesi stranieri che confinano con la regione Friuli-Venezia Giulia, l’Austria e la Jugoslavia, si trovano ai primi due posti della nostra graduatoria. E’ questa una prima conferma della nostra ipotesi. Se continuiamo a fare centro in Friuli ed allarghiamo il raggio fino a comprendere altre nazioni vicine incontriamo la Svizzera e la Germania federale. Anche questi due stati si trovano, con l’inserimento della Norvegia che costituisce un caso particolare che discuteremo in seguito, nei primi posti, immediatamente seguenti, della graduatoria. Per gli stati che vanno a completare la lista diventerebbe artificioso continuare l’analisi utilizzando la variabile della vicinanza. Riteniamo infatti che l’influenza di questa variabile si manifesti in maniera più che proporzionale e che cioè essa abbia una importanza cruciale per i paesi confinanti o molto vicini ma che la sua influenza si riduca notevolmente superata una certa soglia.
Prendiamo ora in considerazione la variabile “emigrazione”. Utiliz-
La solidarietà internazionale 209
Angeli, Milano, 1978
Tab. 9 - Presenza di emigranti italiani e friulani x mille sul totale della popola-zione dello stato Emigranti. Emigranti Friulani X 1000/pop Italiani X 1000/pop. Svizzera 4,97 91,32 Lussemburgo 2,86 114,59 Belgio 1,42 28,42 Francia 1,00 14,01 Austria 0,27 1,59 Germania federale 0,22 10,48 Olanda 0,09 1,02 Gran Bretagna 0,01 3,27 Argentina 4,43 53,95 Australia 1,82 23,02 Venezuela 0,63 18,53 Canada 0,51 11,29 Brasile 0,08 3,29 Sud Africa 0,09 1,91 Stati Uniti — 1,15 Fonte: nostre elaborazioni da dati Ministero Affari Esteri. zando i dati forniti dal Ministero degli Esteri, che riguardano la situazione dell’emigrazione italiana e friulana aggiornata al 1975, e dividendo le cifre ivi riportate per la popolazione, abbiamo potuto costruire un indice della presenza di emigranti negli stati presi in considerazione ed ordinare gli stati stessi seguendo questo indice, privilegiando quello che si riferisce in particolare alla presenza di emigranti friulani.
Confrontiamo ora l’indice della densità di emigrazione con la nostra graduatoria ponderata degli stati che hanno inviato aiuti al Friuli. L’Austria compare in una posizione relativamente bassa, al quinto posto in Europa, come presenza di emigranti e la Jugoslavia non è neppure considerata in questo indice, ma per queste due nazioni si è già visto come la variabile “vicinanza” riesca a spiegare in maniera soddisfacente l’importante ruolo che esse hanno avuto nell’ opera di soccorso. Non presenta grossi problemi nemmeno il caso del Lussemburgo. Si tratta di un paese ad alta presenza di emigrati, sia friulani che italiani in genere, e che compare comunque in una posi-
210 G. Delli Zotti
Friuli: la prova del terremoto
zione immediatamente seguente a quella degli stati che sono più “vicini” al Friuli.
Belgio e Germania occupano posizioni abbastanza simili in entrambe le graduatorie, solo che le posizione stesse sono invertite per la presenza della variabile “geografico-culturale” che esercita una influenza evidentemente molto maggiore, secondo quanto abbiamo precedentemente discusso, sulla Germania spingendola verso una po-sizione più alta di quella che sarebbe giustificata tenendo presente solamente il dato sull’emigrazione.
Mentre non presenta alcun problema il raffronto dei dati relativi alla Gran Bretagna ed ai Paesi Bassi (Olanda) vale la pena di soffermarsi per qualche attimo sul caso della Francia. E’ questa una nazione relativamente vicina al Friuli, confinante con l’Italia e con una presenza piuttosto rilevante di emigranti sia italiani in generale che friulani. I dati sugli aiuti che da questo stato sono stati inviati al Friuli la collocano, abbastanza inaspettatamente, in una posizione relativamente bassa. La sua posizione non apparirebbe tale in maniera così evidente, se nel nostro elenco avessimo compreso anche tutti gli stati europei che per varie ragioni hanno svolto un ruolo minore nel portare aiuto al Friuli, ma ciò nonostante la sua posizione appare comunque inferiore rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato dalla serie di considerazioni fin qui svolte.
Per spiegare questa discrepanza non vogliamo utilizzare discorsi centrati sul “carattere nazionale” dei francesi o cose del genere. Vale più la pena di esaminare in maggiore dettaglio la composizione degli aiuti provenienti da questo paese. Possiamo poi rilevare come sia venuto a mancare l’apporto di un contributo del governo centrale che in altri casi è stato abbastanza sostanziale. Di tono minore è stato anche, rispetto ad altri paesi, l’impegno delle grandi organizzazioni di soccorso internazionale (Croce rossa e Charitas) forse per una specie di “divisione del lavoro” all’interno delle organizzazioni stesse. La ragione principale è comunque da individuarsi, probabilmente, nella coscienza palese di aver già cospicuamente contribuito mediante la propria quota del donativo Cee (40 miliardi). Lo stesso ragionamento può valere per la Gran Bretagna. Anomalo è anche il caso della Norvegia; nazione distante geograficamente dal Friuli e con una irrilevante presenza di emigranti. La sua posizione nei primi posti della nostra graduatoria si può spiegare solamente, oltre che con gli intenti umanitari validi in generale, con il fatto che gli stanziamenti di fondi per
La solidarietà internazionale 211
Angeli, Milano, 1978
l’installazione di prefabbricati norvegesi nelle zone disastrate se serviti come “promozione” per il proseguimento di un interscambio economico sempre nel campo dei prefabbricati, con il commissariato del governo in una prima fase ed in seguito con gli enti locali e con i semplici cittadini. Inutile dire che questo discorso non è affatto rivolto a diminuire l’importanza dell’intervento norvegese, al quale popolazioni friulane sono certamente molto grate, ma solamente con lo scopo di spiegare una apparente incongruenza nel nostro se ma interpretativo.
Mancano totalmente, nel nostro quadro riassuntivo degli aiuti, i paesi dell’Est europeo, se si eccettua la Jugoslavia. Questo fatto ci porta immediatamente a considerare che anche la collocazione di uno stato, di una area colpita da disastri naturali, nel quadro delle alleanze internazionali politico-militari ha il suo peso quando si voglia cercare la spiegazione del diverso afflusso di aiuti.
E’ una variabile quest’ultima che utilizzeremo nella interpretazione degli aiuti dai paesi extraeuropei, che ora esamineremo. Abbiamo voluto distinguere e trattare a parte i paesi extraeuropei perché per questi ultimi viene totalmente a mancare l’influenza della variabile “vicinanza” che, come abbiamo già visto, riveste una notevole importanza, ma una importanza che decresce quasi in maniera geometrica aumentando la distanza dal “centro” considerato.
Vediamo ora se la variabile “emigrazione” può ancora svolgere suo ruolo esplicativo. Utilizzando sempre i dati sulla emigrazione forniti in questo stesso libro, abbiamo creato un indice anche per questi paesi dividendo il numero degli emigrati per il totale della popolazione del paese. Confrontando questo indice con la graduatoria dei paesi extraeuropei che hanno fornito aiuti possiamo notare immediatamente una cosa: tutti gli stati che, come abbiamo visto, ospitano un apprezzabile numero di italiani o friulani emigranti, appaiono anche nell’elenco dei maggiori fornitori di aiuti. Il fenomeno salterebbe all’occhio in maniera ancora più evidente se avessimo continua il nostro elenco fino a comprendere i cento e più stati che, almeno teoricamente, avrebbero potuto inviare aiuti al Friuli. Il confronto comunque fra le “teste” delle due graduatorie ci conferma che e una relazione diretta fra presenza di emigrati e invio di aiuti ai paesi da cui essi provengono. Non si tratta certo di una relazione meccanica, la presenza di altre variabili intervenienti fa sì che la corrispondenza dei posti occupati in graduatoria non sia proprio identica e di
212 G. Delli Zotti
Friuli: la prova del terremoto
una di queste possibili variabili, a cui abbiamo già accennato, parleremo fra poco.
C’è intanto da notare la mancanza dell’Argentina, che è la nazione con la maggiore presenza di emigranti, nell’elenco degli stati che hanno inviato aiuti. Questo è dovuto al fatto, già esposto, che è stato impossibile quantificare, anche con qualche approssimazione, quale sia stato l’apporto globale argentino. Se però facciamo una stima del valore dei materiali che sono già stati inviati dall’Argentina e presumiamo che almeno altrettanto grandi siano le somme ancora inutilizzate e che verranno impiegate per inviare in seguito aiuti, ci rendiamo conto che anche questo stato avrebbe figurato nei primi posti della graduatoria.
Ma vediamo ora quali sono le apparenti contraddizioni a questa corrispondenza che abbiamo individuato tra “emigrazione” e “aiuti”. Il caso della Nuova Zelanda non crea grossi problemi. L’aiuto che è stato inviato è frutto di un’iniziativa governativa e possiamo ritenere che comunque, anche se mancano dei dati precisi, nella Nuova Zelanda, per le analogie che questo paese ha con l’Australia, ci sia una presenza di emigranti che giustifichi in parte l’iniziativa del governo. Per la posizione degli Stati Uniti, relativamente più alta di quanto giustificherebbe la presenza di emigrati, come pure per la presenza dell’Arabia Saudita al primo posto ed anche per il fatto che nella gra-duatoria appare l’Iran, crediamo che invece si debba tenere in consi-derazione quella variabile di tipo politico-internazionale alla quale ab-biamo già accennato.
Gli Stati Uniti, infatti, nell’inviare aiuti al Friuli sono stati motivati probabilmente anche dalla necessità di far sentire vicina, in un momento difficile, la presenza dell’alleato militare e del leader dello schieramento delle nazioni dell’occidente industrializzato.
Per l’Arabia Saudita e per l’Iran invece le ragioni internazionali dell’aiuto sono state già indicate nella larga disponibilità finanziaria come pure nel desiderio di intrattenere buone relazioni con possibili partner di grosse operazioni economiche.
Un breve accenno anche alla presenza della Tunisia, paese che in un certo modo è il meno extraeuropeo fra quelli considerati e per il quale si può spiegare la presenza nella graduatoria con la sua relativa vicinanza all’Italia.
La solidarietà internazionale 213
Angeli, Milano, 1978
Note
1. J. Burton, World Society, Cambridge University Press, London, 1972. 2. A. Etzioni, The Active Society, The Free Press, New York, 1968; B. Landheer et al.
(eds), Worldsociety, Nijhoff, The Hague, 1971; R.O. Kehoane, J.S. Nye (eds), Transnational Relations and World Politics, Harvard University Press, 1972; G. Modelski, Principles of World Politics, The Free Press, 1972; A. Bruschi, U. Gori, F. Attinà, Relazioni internazionali Etas Kompass, Milano, 1973; A. Papisca, Introduzione allo studio delle relazioni internazionali; Giappichelli, Torino, 1973; RW. Sterling, Macropolitics. International Relations in a Global Society, Knopf, New York, 1974; L. Bonanate, Teoria politica e relazioni internazionali, Comunità, Milano, 1976.
3. La pratica è antica, sia che venga motivata in termini di generosità paternalistica del Principe o di carità cristiana. Per rimanere nell’ambito del Friuli, si ha notizia di diverse elargizioni concesse da Venezia alle popolazioni alluvionate dal Tagliamento, nei secoli XVII-XVIII.
4. K.E. Boulding, Conflict and Defense, Harper and Row, New York, 1963. 5. K.W. Deutsch, Relazioni internazionali, Il Mulino, Bologna, 1969; G. Kaufman, Il
sistema globale, Lint, Trieste, 1973. 6. R.A. Falk, Legal Order in a Violent World, Princeton University Press, 1968, p. 210. 7. W.H. Ryker, The Theory of Political Coalition, Yale University Press, 1962. 8. C.F. Alger, The International Relations of Cities e The Impact of cities on the
International Systems, relazioni presentate al X congresso mondiale dell’Ipsa, Edinburgo, 1976.
9. D. de Rougemont (ed), Naissance de l’Europe des regions, Aiee, Geneve, 1968; R. Strassoldo, Frontier Regions, Analitical Study, Council of Europe, Strasbourg, 1972; D. Sidjanskj (ed), Les régions transfrontalières de l’Europe, Aiee, Geneve, 1975; R Petrella, Les regions et l’Europe, di prossima pubblicazione.