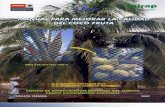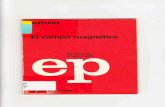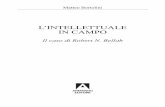Concorso omissivo colposo del danneggiato: il quasi inestricabile intreccio tra la causalità e la...
Transcript of Concorso omissivo colposo del danneggiato: il quasi inestricabile intreccio tra la causalità e la...
LA NUOVAGIURISPRUDENZA
CIVILECOMMENTATA
VITTORIO BACHELET
Concorso omissivo colposo del danneggiato: il quasi inestricabile intreccio tra la causalità
e la colpa e l’irruzione sul campo della solidarietà
Estratto:
ISSN 1593-7305N. 5 MAGGIO 2012 • Anno XXVIIIRIVISTA MENSILEde Le Nuove Leggi Civili Commentate
ticolare, per quanto riguarda la delega di cui all’art.54 e i suoi limiti (senza pretesa di completezza) Ba-lena, in Balena-Capponi-Chizzini-Menchini,
La riforma della giustizia civile, Utet, 2009, 237 ss.;Carratta, in Mandrioli-Carratta, Come cambiail processo civile, Giappichelli, 2009, 208 ss.; Salva-neschi, La riduzione del tempo del processo nellanuova riforma dei primi due libri del codice di rito, inRiv. dir. proc., 2009, 1563 ss.; Volpino, in Taruf-fo, Il processo civile riformato, Zanichelli, 2010, 564ss.
Fra gli interventi che hanno riguardato il d. legis.n. 150/2011, un approccio critico sullo schema didecreto può leggersi in Carratta, La semplificazio-ne dei riti civili: i limiti dello schema di decreto legi-slativo presentato del Governo, in www.treccani.it,2011 e, dopo l’approvazione, in Bove, Applicazionedel rito lavoro nel d. lgs. n. 150 del 2011, in www.ju-dicium.it, 2011 (di cui v. in particolare, per quantoqui interessa, il § 2) e Scarpa, Riduzione e semplifi-cazione dei procedimenti civili di cognizione, in Corr.merito, 2011, 1017 ss. Vedine, invece, una letturapiù favorevole in Consolo, Prime osservazioni in-troduttive sul d. lgs. n. 150/2011 di riordino (e relati-va «semplificazione») dei riti settoriali, in Corr. giur.,
2011, 1485 ss. Fra i volumi che si occupano in gene-rale del d. legis. n. 150/2011 (e quindi anche delladisciplina del mutamento di rito), v. in particolareSassani-Tiscini, La semplificazione dei riti civili,Dike, 2011; Cecchella-Ortolani, Il nuovo proces-so civile, Il Sole 24 Ore, 2011;Demarchi Albengo,Il processo civile semplificato, Giuffrè, 2011; Luiso,Diritto processuale civile, IV, Giuffrè, 2011, 104 ss.
Commenta, invece, in maniera più analitica la di-sciplina di cui all’art. 4 (mutamento di rito), pur nel-l’ambito di una raccolta di articoli sui vari aspetti deld. legis. n. 150/2011, Finocchiaro, Mutamento delrito disposto con ordinanza, in Guida al dir., 2011, n.40, 84 ss.
Sul tema della c.d. cameralizzazione del giudiziosu diritti vi sono numerose opere di alcuni fra i piùnoti processualisti italiani. Per un’analisi delle posi-zioni della dottrina e del dibattito con la giurispru-denza e per ulteriori riferimenti, v. Lanfranchi, Laroccia non incrinata. Garanzia costituzionale del pro-cesso civile e tutela dei diritti, Giappichelli, 2011,spec. 139 ss.
Gabriele Molinaro
CASS. CIV., sez. un., 21.11.2011, n. 24406Conferma Trib. Superiore delle acque pubbliche,11.3.2010
Responsabilità civile - Concorso di
colpa del creditore - Efficienza cau-sale omissiva - Illecito omissivo tipi-
co e atipico - Necessità di una norma
specifica - Esclusione (Cost., art. 2; cod.civ., artt. 2043, 2056, 1227, 1223, 1176, 1175; cod.pen., artt. 40, 41)
Ai sensi dell’art. 1227, comma 1o, cod.civ., la condotta omissiva del danneggiatosi pone come causa (esclusiva o concor-rente) del danno non solo quando l’obbli-go di impedire l’evento è specificamenteindividuato da una norma, ma anchequando è genericamente riconducibile al-la diligenza.
dal testo:
Il fatto. La Cepi Strutture s.r.l. convenne da-vanti al tribunale di Ancona il Comune di An-cona, assumendo che, nel mentre eseguiva la-vori edili di realizzazione di un complesso im-mobiliare in zona (Omissis), il 25.8.1995 dovet-te sospendere gli stessi a causa di allagamentodel cantiere per straripamento di un canalescolmatore di proprietà del Comune, per difet-ti di costruzione dell’argine del canale edomessa manutenzione dello stesso. L’attricechiedeva la condanna del Comune al risarci-mento del danno.
Il Comune chiamò in causa il suo assicurato-re della responsabilità civile, s.p.a. Ina Assita-lia, che eccepì l’incompetenza territoriale deltribunale ordinario, in favore del tribunale re-gionale delle acque pubbliche.
Il Tribunale dichiarò la nullità della chiama-
Cass., sez. un., 21.11.2011, n. 24406 Responsabilità civile
NGCC 2012 - Parte prima 431
c
ta in causa dell’assicuratore e l’incompetenzaper materia.
La Cepi, con atto del 29.6.2001, riassunse lacausa davanti al Tribunale regionale delle ac-que pubbliche di Roma, che, con sentenza del25.8.1995, dichiarò il Comune responsabile del50% dei danni, accolse la domanda di manlevadel Comune nei confronti di Ina Assitalia econdannò il Comune a pagare alla Cepi Euro35000,00.
Proponevano appello la Cepi Strutture s.r.l.ed appelli incidentali l’Ina Assitalia ed il Co-mune di Ancona.
Il Tribunale Superiore delle acque pubbli-che, con sentenza depositata l’11 marzo 2010,accoglieva l’appello della Cepi e condannava ilComune di Ancona al pagamento nei confrontidi questa della somma di Euro 70.000,00.
Riteneva il Tsap che, giusto quanto accertatodal c.t.u., per evitare l’allagamento era necessa-rio che l’argine posto sul lato del cantiere fossestato innalzato di ulteriori cm. 110 con unastruttura in cemento armato; che questa dove-va essere effettuata dal Comune proprietariodel canale e non dall’attrice; che l’impresa nonpoteva intervenire per modificare una proprie-tà pubblica; che, ove avesse innalzato l’argine,l’attrice sarebbe andata incontro a responsabi-lità penali, civili ed amministrative, anche te-nendo conto che il più alto argine avrebbe pro-vocato esondazioni a valle, danneggiando terzi;che nessuna responsabilità poteva ravvisarsinel fatto che l’erigendo fabbricato aveva unafondazione a platea e non a pali trivellati, per-ché al momento dell’avvio dei lavori la sceltadella fondazione su platea non poteva ritenersiimprudente o negligente.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricor-so per cassazione il Comune di Ancona.
Resistono con rispettivi controricorsi la CepiStruttura s.p.a. e l’Ina-Assitalia s.p.a. Quest’ul-tima ha anche proposto un ricorso incidentalecondizionato.
Il Comune di Ancona e la Cepi Strutturahanno presentato memorie.
I motivi. 1. Con il primo motivo del ricorsoprincipale il Comune ricorrente lamenta la vio-lazione e falsa applicazione della L. n. 696 del1994, art. 4, D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12,(ora D.Lgs. n. 81 del 2008), R.D. n. 523 del
1904, artt. 57 e 58 in relazione al R.D. n. 1175del 1933, art. 200; lamenta altresì l’eccesso dipotere per illogicità e contraddittorietà dellamotivazione R.D. n. 1175 del 1933, ex art. 200nonché L. 31 marzo 1877, n. 3761, ex art. 3 inrelazione alla negata corresponsabilità dellasoc. CEPI nella causazione dell’evento danno-so. Secondo il ricorrente ha errato il TSAP nelritenere che la CEPI strutture non poteva disua iniziativa innalzare di cm. 110 l’argine delcanale scolmatore, perché ciò costituiva un ille-cito civile (operando sulla proprietà pubblica)e penale, per costruzione abusiva. Ritiene il ri-corrente che l’attrice aveva l’obbligo, a normadell’art. 2087 c.c. e del D.Lgs. n. 494 del 1996,trasfuso nel D.Lgs. n. 81 del 2008, di predi-sporre il piano di sicurezza ed adottare tutti gliausili possibili per la sicurezza del cantiere. Se-condo il ricorrente la natura precaria dell’ope-ra comportava la non necessità della concessio-ne edilizia ed inoltre, poiché si trattava di ope-ra temporanea, l’innalzamento dell’argine delcanale di circa cm. 110 non necessitava di per-messo di costruzione.
Sostiene il ricorrente che, trattandosi di ope-re temporanee per quanto sulla sponda del ca-nale, esse non erano vietate a norma del R.D.n. 523 del 1904, art. 96.
2.1. Il motivo è infondato.Il nucleo centrale della censura, come emer-
ge anche dal titoletto del motivo, è costituitodalla doglianza avverso la sentenza impugnatanella parte in cui questa non ha rilevato chel’attrice aveva una corresponsabilità nella cau-sazione dell’evento dannoso, non avendo rea-lizzato l’innalzamento dell’argine del canale,idonea ad evitare l’esondazione, pur avendo unobbligo di realizzazione di tale misura di sicu-rezza. Sotto questo profilo il motivo di ricorsosi articola nell’individuazione delle norme giu-ridiche che fonderebbero l’obbligo giuridicodella società CEPI di innalzare il muro disponda del canale.
2.2. Va preliminarmente osservato che, in te-ma di risarcimento del danno, l’art. 1227 cod.civ., nel disciplinare il concorso di colpa delcreditore nella responsabilità contrattuale, ap-plicabile per l’espresso richiamo di cui all’art.2056 cod. civ. anche alla responsabilità extra-contrattuale, distingue l’ipotesi in cui il fattocolposo del creditore o del danneggiato abbia
Cass., sez. un., 21.11.2011, n. 24406 Responsabilità civile
432 NGCC 2012 - Parte prima
concorso al verificarsi del danno (comma 1),da quella in cui il comportamento dei medesi-mi ne abbia prodotto soltanto un aggravamen-to senza contribuire alla sua causazione (secon-do comma).
Secondo la dottrina classica nel nostro ordi-namento esisterebbe un principio di autore-sponsabilità, segnatamente previsto dall’art.1227 c.c., comma 1, oltre che da altre norme,che imporrebbe ai potenziali danneggiati dove-ri di attenzione e diligenza.
L’autoresponsabilità costituirebbe un mezzoper indurre anche gli eventuali danneggiati acontribuire, insieme con gli eventuali respon-sabili, alla prevenzione dei danni che potreb-bero colpirli.
2.3. Senza entrare nella questione dell’esi-stenza nel nostro ordinamento del detto princi-pio di autoresponsabilità, va solo rilevato chela dottrina più recente, che questa Corte ritie-ne di dover condividere, ha abbandonatol’idea che la regola di cui all’art. 1227 c.c.,comma 1, sia espressione del principio di auto-responsabilità, ravvisandosi piuttosto un corol-lario del principio della causalità, per cui aldanneggiante non può far carico quella partedi danno che non è a lui causalmente imputa-bile.
Pertanto la colpa, cui fa riferimento l’art.1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio diimputazione del fatto (perché il soggetto chedanneggia se stesso non compie un atto illecitodi cui all’art. 2043 c.c.), bensì come requisitolegale della rilevanza causale del fatto del dan-neggiato.
2.4. Una volta riconosciuta all’art. 1227 c.c.,comma 1, la funzione di regolare, ai fini dellacausalità di fatto, l’efficienza causale del fattocolposo del leso, con conseguenze sulla deter-minazione dell’entità del risarcimento, ed unavolta ritenuto che detta norma trova il suo in-quadramento nel principio causalistico, secon-do cui se tutto l’evento lesivo è conseguenzadel comportamento colposo del danneggiato,risulta interrotto il nesso di causalità con lepossibili cause precedenti, rimane solo da esa-minare quando il comportamento omissivo deldanneggiato possa essere idoneo a costituirecausa esclusiva o concausa dell’evento lesivo.
Va, anzitutto, rilevato che in tema di nessocausale per illeciti omissivi e con riferimento al
comportamento dell’autore dell’illecito (diver-so quindi dal comportamento del danneggiato)nella giurisprudenza di questa Corte coesisto-no due orientamenti ispirati rispettivamente al-la tipicità ed all’atipicità dell’illecito omissivo.
Secondo il primo di tali orientamenti (che facapo all’art. 40 c.p., comma 2, nella sua valenzaletterale: “non impedire un evento, che si hal’obbligo giuridico di impedire, equivale a ca-gionarlo”), ai fini della responsabilità per dan-ni da condotta omissiva non è sufficiente ri-chiamarsi al principio del “neminem laedere”o ad una generica antidoverosità sociale del-l’inerzia, ma occorre individuare, caso per ca-so, un vero e proprio obbligo giuridico di im-pedire l’evento che può derivare, oltre che dal-la norma, da uno specifico rapporto negozialeo di altra natura che leghi danneggiato e sog-getto chiamato a rispondere (Cass. 25.9.1998,n. 9590; Cass. 6.4.1992, n. 2134; Cass.9.1.1979, n. 116; Cass. 28 giugno 2005 n.13982;).
Secondo l’altro orientamento, un obbligogiuridico di impedire l’evento può derivare an-che da una specifica situazione che esiga unadeterminata attività a tutela di un diritto altrui(Cass. 8.1.1997, n. 72; Cass. 14.10.1992, n.11207; Cass. 29/07/2004, n. 14484; Cass. 23/05/2006, n. 12111).
2.5. Ritiene questa Corte di dover aderire aquesto secondo orientamento, tenuto contoche esso si appalesa più conforme al principiosolidaristico di cui all’art. 2 Cost., nonché aldovere di comportamento secondo correttez-za, che attiene anche alla fase genetica dell’ob-bligazione (art. 1175 c.c.) (indicazioni in que-sto senso emergono già da Cass. S.U. n. 576 del2008).
Già solo rapportando tale interpretazionedel nesso causale da comportamento omissivoalla situazione in cui tale condotta dannosa èdello stesso danneggiato, deve ritenersi chequesti è tenuto ad attivarsi per evitare che siverifichi un evento lesivo in suo danno, secon-do comuni principi di diligenza.
2.6. Sennonché vi è anche una più specificaragione per ritenere che, al fine di integrare lafattispecie di cui all’art. 1227 c.c., comma 1 ilcomportamento omissivo del danneggiato rile-vante non è solo quello tenuto in violazione diuna norma di legge, ma anche più generica-
Cass., sez. un., 21.11.2011, n. 24406 Responsabilità civile
NGCC 2012 - Parte prima 433
mente in violazione delle regole di diligenza ecorrettezza.
Proprio perché è rimasta superata la teoriadel principio di autoresponsabilità del danneg-giato, la colposità del comportamento del cre-ditore-danneggiato, pur richiesta dall’art. 1227c.c., comma 1, è l’unico elemento di selezionedei vari possibili comportamenti – eziologica-mente idonei – del danneggiato, qualunquepossa essere l’interpretazione dell’obbligo giu-ridico, cui si richiama l’art. 40 c.p.c., comma 2,allorché il danno trovi la sua causa nel compor-tamento omissivo di altro soggetto.
Così ristretta nella funzione la portata dellacolpa del creditore-danneggiato, stante la ge-nericità dell’art. 1227 c.c., comma 1 sul punto,la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazio-ne da parte del creditore-danneggiato di unobbligo giuridico, ma anche nella violazionedella norma comportamentale di diligenza, sot-to il profilo della colpa generica.
2.7. Ciò comporta che, ai fini dell’art. 1227c.c., comma 1, sussiste il comportamento omis-sivo colposo del danneggiato ogni qual voltatale inerzia contraria a diligenza, a prescinderedalla violazione di un obbligo giuridico di atti-varsi, abbia concorso a produrre l’evento lesivoin suo danno.
Né va trascurato il rilievo che la contraria te-si finirebbe per svuotare parzialmente di con-tenuto il principio di cui all’art. 1227 c.c., com-ma 1 (anche nell’ipotesi di causalità esclusiva)in tutti i casi di comportamento omissivo col-poso del danneggiato, in quanto generalmentel’ordinamento non pone obblighi giuridici acarico di un soggetto per la tutela delle posizio-ni giuridiche di questi, mentre la regola di cuiall’art. 1227 c.c. va inquadrata esclusivamentenell’ambito del rapporto causale ed è espres-sione del principio che esclude la possibilità diconsiderare danno risarcibile quello che cia-scuno procura a se stesso (Cass. 26/04/1994, n.3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988).
2.8. Non può, quindi condividersi il princi-pio rigido di Cass. 30/09/2008, n. 24320, se-condo cui il concorso del fatto colposo deldanneggiato, che ai sensi dell’art. 1227 c.c.,comma 1, esclude o limita il diritto al risarci-mento, non può essere invocato allorché la vit-tima del fatto illecito abbia omesso di rimuove-re tempestivamente una situazione pericolosa
creata dallo stesso danneggiante, dalla quale –col concorso di ulteriori elementi causali – siaderivato il pregiudizio del quale si chiede il ri-sarcimento. Anche in questo caso il giudice dimerito dovrà valutare se il comportamentoomissivo tenuto dal danneggiato, rilevante sot-to il profilo eziologico, sia stato connotato dacolpa sia pure generica, nei termini sopra detti.
3.1. Nella fattispecie correttamente la senten-za impugnata ha escluso che sussistesse un com-portamento colposo dell’attrice, per avere que-sta omesso di alzare l’argine del canale scolmato-re con una struttura in cemento armato alta cm.110, che avrebbe modificato l’immobile di pro-prietà di ente pubblico. Corretta in diritto ed im-mune da vizi motivazionali è l’osservazione chetale intervento non era esigibile nei confrontidell’attrice (e quindi il suo comportamento nonè carente di diligenza), poiché l’avrebbe espostaal rischio di incorrere in un illecito civile per vio-lazione del diritto di proprietà pubblica ed un il-lecito penale per la realizzazione di manufattinon previsti dalla concessione, nonché alla re-sponsabilità nei confronti dei terzi confinanti, acui veniva traslato da parte di un privato, ed inassenza di ogni autorizzazione, l’evento dannosodell’inondazione.
3.2. Inconferenti sono i richiami a pretesiobblighi giuridici per la sopraelevazione delmuro, che secondo il ricorrente deriverebberodall’art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. n. 494 del 1996.
Entrambe tali fonti normative attengono allasicurezza dei cantieri in relazione ai danni allapersona e non alla tutela dei beni privati inprossimità di corsi d’acqua.
Inoltre correttamente ha ritenuto il TSAPche l’innalzamento dell’argine di cm. 110 construttura in cemento armato, necessitava del-l’autorizzazione della P.A. competente. Le di-sposizioni dello stesso t.u. R.D. 25 luglio 1904,n. 523, artt. 57 e 58 mentre assoggettano alcontrollo della pubblica amministrazione “iprogetti per modificazioni di argini e per co-struzioni e modificazioni di altre opere di qual-siasi genere che possono direttamente o indi-rettamente influire sul regime dei corsi d’ac-qua, ecc.” (art. 57), consentono una eccezioneper “le opere eseguite dai privati per semplicedifesa, aderente alle sponde dei loro beni, chenon alterino in alcun modo il regime dell’al-veo” (art. 58).
Cass., sez. un., 21.11.2011, n. 24406 Responsabilità civile
434 NGCC 2012 - Parte prima
Sennonché nella fattispecie non si trattava diopera a difesa di bene privato aderente allesponde, ma di opera di un privato che modifi-cava direttamente l’argine, mediante innalza-mento dello stesso con opera in struttura ce-mentizia armata, e quindi, tutt’altro che preca-ria e transitoria, come assume il ricorrente, laquale opera finisce per influire sul regime delleacque, perché impedisce in quel punto le eson-dazioni, traslandole in altra zona e quindi neiterreni di terzi.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricor-rente lamenta la violazione e falsa applicazionedella L. n. 10 del 1977, art. 4 (ora in relazioneal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 12), in relazioneal R.D. n. 1175 del 1993, art. 200.
Assume il ricorrente che la sentenza impu-gnata erroneamente ha ritenuto che il Comuneavrebbe dovuto subordinare il rilascio dellaconcessione edilizia a specifiche opere di presi-dio, chiedendo al privato di intervenire sul be-ne pubblico con modalità e forme indicate nel-la concessione.
5. Il motivo è inammissibile.Infatti il TSAP, dopo aver ritenuto che i la-
vori non potevano essere effettuati dalla parteprivata in assenza di autorizzazione del Comu-ne, ha considerato che il Comune “avrebbe do-vuto semmai subordinare il rilascio della con-cessione edilizia a specifiche opere di presidio,chiedendo al privato di intervenire sul benepubblico con modalità e forme specificamenteautorizzate ed indicate nella concessione”.
Trattasi di un argomento di supporto a quel-lo su cui si basa la motivazione di accoglimentodell’appello e cioè che l’unico soggetto legitti-mato ad intervenire sugli argini del canale era ilComune.
Ne consegue che nella fattispecie l’argomen-tazione è adottata dalla corte ad abundantiam,consistente cioè in argomentazione rafforzativadi quella costituente la premessa logica dellastatuizione contenuta nel dispositivo.
Tali affermazioni vanno considerate di rego-la superflue e quindi giuridicamente irrilevantiai fini della censurabilità qualora, come nellafattispecie, l’argomentazione rafforzata sia persé sufficiente a giustificare la pronuncia adotta-ta.
Infatti le argomentazioni ad abundantiamnon sono suscettibili di impugnazione in sede
di legittimità indipendentemente dalla loroesattezza o meno, se il dispositivo sia fondatosu corretta argomentazione avente carattereprincipale ed assorbente.
È quindi inammissibile il motivo di ricorsoper cassazione che censura un’argomentazionedella sentenza impugnata svolta “ad abundan-tiam”, e pertanto non costituente “ratio deci-dendi” della medesima, non avendo nessunainfluenza sul dispositivo e, quindi, non produ-cendo effetti giuridici (Cass. 12/08/2004, n.15635; Cass. 17/02/2004, n. 3002; Cass. 4 ago-sto 2000, n. 10241; Cass. 10 giugno 1999, n.5714).
6. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrentelamenta l’eccesso di potere R.D. n. 1175 del1933, ex art. 200 nonché della L. 31 marzo1877, n. 3761, art. 3 per carenza, contradditto-rietà ed illogicità della motivazione con cui èstato rigettato l’appello incidentale condiziona-to del Comune in relazione all’affermata irrile-vanza del tipo di fondazione scelta dalla soc.Cepi: e cioè fondazione a platea invece che conpali trivellati profondi.
Secondo il ricorrente erroneamente la sen-tenza impugnata ha ritenuto che la realizzazio-ne della fondazione a platea, in luogo di quellasu pali trivellati non avrebbe avuto alcun rilie-vo.
7.1. Il motivo è infondato.Con esso, in buona sostanza, il ricorrente so-
stiene che se l’attrice avesse adottato il sistemadella fondazione con pali trivellati e non conplatea, non si sarebbero avuti gravi effetti de-formativi con l’esondazione e quindi ci sarebbestata una limitazione dei danni.
Anche in questo caso la prospettazione attie-ne ad un concorso della condotta colposa deldanneggiato nella causazione dell’evento dan-noso (sul quale istituto si è già detto).
7.2. Sul punto la decisione del Tsap è chiarae corretta.
Anzitutto va ricordato che avverso le senten-ze del Tribunale superiore delle acque pubbli-che – alle quali sia applicabile “ratione tempo-ris” il D.Lgs. n. 40 del 2006 –, il ricorso percassazione è ammesso anche per denunziare ilvizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 5 (Cass. Sez. Unite, 02/12/2008,n. 28547).
La sentenza impugnata ha rilevato che la
Cass., sez. un., 21.11.2011, n. 24406 Responsabilità civile
NGCC 2012 - Parte prima 435
questione del tipo di fondazione è irrilevante.Infatti, poiché la scelta di una fondazione aplatea risultava conforme ai canoni tecnici edera stata approvata dalle autorità competenti,secondo le conclusioni del ctu non poteva ad-debitarsi alla Cepi alcun profilo di colpa peraver adottato tale soluzione, in quanto non po-trebbe individuarsi una colpa per non averprevisto che in caso di alluvione del cantiere (equindi in corso d’opera senza carichi stabiliz-zanti la fondazione a platea) i danni per unafondazione su pali trivellati sarebbero stati in-feriori.
La questione, quindi, non è quale fosse lamigliore fondazione possibile, su cui si è diffu-so il ricorrente, ma se l’attrice fosse in colpa(quella rilevante ex art. 1227 c.c.) nell’averadottato la fondazione a platea.
Con la suddetta argomentazione, immune davizi logici o giuridici, il Tsap ha escluso l’esi-stenza di tale colpa nella fattispecie in esame.
Le contrarie censure del ricorrente si risolvo-no in una diversa lettura delle risultanze pro-cessuali, inammissibile in questa sede di sinda-cato di legittimità. (Omissis)
[Vittoria Presidente – Segreto Estensore – Gam-bardella P.M. (concl. conf.). – Comune di Ancona(avv.ti De Angelis e Fraticelli) – Cepi Strutture s.r.l.(avv.ti Leopoldo e Curzi)]
Nota di commento: «Concorso omissivo colpo-so del danneggiato: il quasi inestricabile intrec-cio tra la causalità e la colpa e l’irruzione sulcampo della solidarietà» [,]
I. Il caso
Un’impresa edile, costretta a sospendere i lavori acausa dello straripamento di un canale scolmatorecomunale, conviene in giudizio il Comune per il ri-sarcimento del danno.
Il giudizio di primo grado, ascrivendo l’eventodannoso anche all’omesso intervento dell’impresadanneggiata ex art. 1227, comma 1o, cod. civ., ridu-ce della metà la responsabilità del Comune, dovuta adifetti di costruzione e alla mancata manutenzionedell’argine del canale.
In appello, la decisione viene riformata e il Comu-ne condannato all’integrale risarcimento del danno,
ritenendosi che l’opera necessaria ad evitare l’allaga-mento spettasse al solo Comune proprietario. Si sa-rebbe trattato, infatti, secondo le conclusioni delCTU, di realizzare un consistente innalzamento del-l’argine, pari a 110 cm, mediante l’utilizzo di cemen-to armato. All’impresa danneggiata non poteva esse-re richiesto un tale comportamento, peraltro passi-bile di responsabilità penali (per costruzione abusi-va) e civili (per aver modificato la proprietà pubbli-ca e provocato, a danno di terzi, esondazioni a val-le).
La Cassazione si pronuncia a sezioni unite, comeprevisto dall’art. 200 del r.d. n. 1775/1933 per le de-cisioni rese, in grado di appello, dal Tribunale Supe-riore delle Acque Pubbliche. Nel confermare la sen-tenza di appello, i giudici si interrogano sui presup-posti di rilevanza delle omissioni del danneg-giato ai fini della riduzione del risarcimento,ex art. 1227, comma 1o, cod. civ. In particola-re, ci si domanda se l ’obbligo giuridico di impe-dire l ’evento dannoso, quale requisito di con-figurabilità della causalità omissiva, possascaturire solo da fonti individuate (le norme oi pregressi rapporti, negoziali e non, intercorrentifra le parti) o anche dai generici doveri di dili-genza.
L’aspetto di maggior interesse è dato dal fattoche, rovesciando un precedente (costituito da Cass.,30.9.2008, n. 24320, in Mass. Foro it., 2008), la pro-nuncia ritiene la disciplina del concorso colposo ap-plicabile all’ipotesi in cui il danneggiato – pur senzaesservi tenuto da una precisa disposizione – abbiaomesso di rimuovere una situazione pericolosa crea-ta dal danneggiante dalla quale, con il concorso diulteriori contributi causali, è derivato il danno. Ac-certata l’efficienza causale del comportamento omis-sivo, anche in questo caso il giudice (di merito) do-vrà, per applicare la norma in esame, valutare la sus-sistenza della colpa, quantomeno generica.
II. Le questioni
1. Solidarietà «verso se stessi» e correttez-za «extracontrattuale». Le sezioni unite inten-dono chiarire il funzionamento della regola sul con-corso di colpa del danneggiato. Ai sensi dell’art.1227, comma 1o, cod. civ., se il fatto del creditore – odel danneggiato ex art. 2056 cod. civ. – ha concorsoa causare il danno ed è colposo, il risarcimento cui ilcreditore-danneggiato ha diritto diminuisce secondola gravità della colpa e l’entità delle conseguenze(cfr. art. 122 cod. cons., in tema di responsabilità perdanno da prodotti difettosi). Dal punto di vista de-scrittivo, la norma richiede un duplice requisito di ri-levanza della condotta del danneggiato: che rappre-senti una concausa dell’evento e che sia colposa, os-[,] Contributo pubblicato in base a referee.
Cass., sez. un., 21.11.2011, n. 24406 - Commento Responsabilità civile
436 NGCC 2012 - Parte prima
sia adottata in violazione degli standard di diligenzamedi (colpa generica) o di puntuali regole cautelari(colpa specifica). In particolare, il S.C. è chiamato apronunciarsi sul caso in cui il «fatto» concorrentedel danneggiato è costituito da una omissione.
Riguardo alla questione della causalità in caso diilleciti omissivi, i giudici danno conto dell’esistenzadi opposti orientamenti giurisprudenziali. Il contra-sto riguarda, precisamente, l’individuazione dellefonti degli obblighi di impedire l’evento dannoso. Sitratta, come hanno recentemente osservato le sezio-ni unite (cfr. Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 576, infra,sez. III), di una operazione preliminare all’accerta-mento causale in senso stretto. Il nesso eziologico,infatti, sussiste qualora sia possibile immaginare chel’azione omessa avrebbe impedito la verificazionedell’evento. Tuttavia, l’equivalenza normativa tranon impedire e cagionare, in applicazione dell’art.40, cpv., cod. pen., vale soltanto in presenza dell’ob-bligo giuridico di impedire l’evento, evitando, così,che, dal punto di vista giuridico, una qualsiasi omis-sione risulti determinante la lesione (Capecchi, Ilnesso, 153 ss., infra, sez. IV). Accade, dunque, chel’apprezzamento della condotta omissiva, sul pianocausale, non basti a fondare la responsabilità, qualo-ra non si ravvisi alcun obbligo di impedire l’evento;specularmente l’omissione di un comportamentodovuto non è sufficiente a far sorgere la responsabi-lità se non «cagiona» il danno alla stregua dell’accer-tamento controfattuale (cfr. Cass., sez. un.,11.1.2008, n. 576, cit.).
Evidenziata la non perfetta coincidenza tra il pia-no della causalità omissiva e quello degli obblighi diimpedire l’evento, si può procedere all’esame deidue orientamenti illustrati dalla Corte, sorti con rife-rimento al comportamento del danneggiante. Allastregua del primo indirizzo, l’obbligo giuridico diimpedire l’evento potrebbe discendere dalle normedell’ordinamento ovvero dai rapporti negoziali, o dialtra natura, che legano il soggetto della cui respon-sabilità si tratta al danneggiato. Il secondo filone,meno rigido, si accontenta dell’obbligo giuridico de-rivante da una «specifica situazione che esiga una de-terminata attività a tutela di un diritto altrui». Il fattoche il primo orientamento reclami, «caso per caso»,l’individuazione di un obbligo giuridico «vero e pro-prio» non appare discriminante: nel riferirsi a un ob-bligo giuridico, entrambi gli indirizzi sembrerebberorichiamare la regola dell’art. 40, cpv., cod. pen.
Adoperando delle etichette imprecise, ma effica-ci, si può affermare che la questione controversa è sele fonti dell’obbligo di impedire l’evento costituisca-no un sistema tipico ovvero atipico. Il confine tra ledue posizioni, a ben vedere, non è marcato come leformule antitetiche lasciano intendere: se, da un la-to, il primo indirizzo include anche i rapporti non
negoziali, come quelli di cortesia (Cass., 14.1.1971,n. 66, infra, sez. III), il secondo non si accontenta diuna generica antidoverosità giuridica o sociale, re-clamando una situazione «specifica». Il conflitto,pertanto, vede contrapposti un sistema tendente allatipicità ed uno disposto, con maggiore apertura, ariconoscere obblighi di impedire l’evento (Alpa, Ilproblema, 141 ss., infra, sez. IV).
Per quanto riguarda la dottrina, essa è prevalente-mente orientata verso un sistema di illeciti omissivitipico e richiede, per la configurazione della respon-sabilità aquiliana, la violazione di obblighi codificatidi impedire l’evento (Scognamiglio, voce «Re-sponsabilità civile»; Trimarchi, voce «Illecito»; Vi-sintini, Trattato breve; Franzoni, L’illecito, tuttiinfra, sez. IV). Al cospetto del principio di libertà,anche alla luce dell’art. 41, comma 1o, Cost., la mag-gior parte degli interpreti è portata a qualificare co-me eccezionali gli obblighi di attivarsi a favore diterzi. Si ritiene, pertanto, che tali obblighi non sianoricavabili per estensione analogica delle previsioniespresse, né in applicazione di un principio dell’or-dinamento (contra Cian, 262 s. e Salvi, La responsa-bilità, 113 ss., entrambi infra, sez. IV). Si finisce, inquesto modo, per assegnare aprioristica prevalenzaall’interesse a non essere obbligato ad agire rispettoal qualsivoglia interesse leso dalla omissione, senzapossibilità di comparazione. Aderendo a questoorientamento, la dottrina segnala i vari inconvenien-ti che affliggerebbero il diverso sistema ispirato allaatipicità degli illeciti omissivi: esso risulterebbe, inprimo luogo, controproducente, perché indurrebbeuna sgradita ingerenza negli affari dei soggetti po-tenzialmente avvantaggiati; oltre a ciò, sarebbe diffi-cilmente applicabile, data la difficoltà pratica di in-dividuare i responsabili, tenuti a intervenire nel casoconcreto (Trimarchi, voce «Illecito», 99 s.). Da ul-timo, viene messo in evidenza il pericolo che, ad im-porre obblighi di agire oltre i casi previsti, senza labase legislativa richiesta dall’art. 41 Cost., lo Statopianifichi le attività umane (Franzoni, L’illecito,221).
La dottrina minoritaria parteggia per una rico-struzione atipica degli illeciti omissivi. Siccome lanozione giuridica di «fatto» include anche le con-dotte omissive, si osserva che la regola della atipicitàdell’illecito aquiliano, introdotta dall’aggettivo inde-finito «qualsiasi», non tollererebbe di essere appli-cata solo ai comportamenti attivi. Evocando, in ge-nerale, l’atipicità delle condotte, l’art. 2043 cod. civ.aspirerebbe a tutelare gli interessi meritevoli in ma-niera completa, di fronte ad ogni comportamento le-sivo, al di fuori dei rigidi schemi della tipicità. Lapienezza della tutela sarebbe decisamente frustratase, viceversa, della atipicità si desse una applicazionelimitata alle sole condotte commissive. L’argomento
Cass., sez. un., 21.11.2011, n. 24406 - Commento Responsabilità civile
NGCC 2012 - Parte prima 437
della pretesa eccezionalità e tipicità degli obblighi diattivarsi a favore di terzi viene superato mediante ilrichiamo alla solidarietà di cui all’art. 2 Cost. Una ri-lettura in chiave costituzionale del neminem laedere,si sostiene, imporrebbe di bilanciare i principi di li-bertà e di solidarietà, ricercando un equilibrio «trala regola individualista e liberale della inesistenza diun obbligo generale di agire e quella solidaristica,ma allo stato soltanto teorica, che, al contrario, po-stula un dovere generalizzato di intervento» (Cri-centi, 188 ss., infra, sez. IV). Superata l’idea che al-la libertà individuale spetti astratta preminenza, sa-rebbe possibile bilanciare l’interesse a non essereobbligato ad agire con quello leso dalla omissione. Ifautori della atipicità delle omissioni sottolineanocome, ragionando in questo modo, non si faccia al-tro che estendere alle omissioni colpose quanto giàavviene per quelle dolose. La rilevanza assegnata aqueste ultime, anche in assenza di obblighi tipizzati,starebbe a indicare che l’interesse a non agire, nel-l’esercizio della libertà individuale, non riceve tutelaassoluta, formando oggetto di comparazione conl’interesse leso dalla omissione (Cricenti, 163 ss.,contra Visintini, I fatti illeciti, 45, infra, sez. IV).Generalizzando questo discorso, l’art. 2043 cod. civ.verrebbe inteso come «fonte degli obblighi di agi-re», capace di imporre l’intervento «in tutti i casi incui l’utilità della omissione è minima per l’inerte, ilquale, agendo, potrebbe salvaguardare un altro sog-getto da un danno grave» (Alpa, Il problema, 142).Impiegare l’art. 2043 cod. civ. come norma prima-ria, contenente il precetto, anche per gli illecitiomissivi, consentirebbe di evitare che, rispetto adessi soltanto, esso venga adoperato come norma me-ramente secondaria, limitata a fornire la sanzioneper l’inosservanza di obblighi posti da altre previsio-ni. In questa maniera, verrebbe restituita all’ingiusti-zia del danno, anche rispetto alle omissioni, la fun-zione caratteristica delle clausole generali, cioè quel-la di presiedere al bilanciamento degli interessi coin-volti. L’obiezione per cui, così opinando, si finireb-be per funzionalizzare la libertà, mediante l’istitu-zione di limiti «interni», viene superata osservandoche, in realtà, si tratterebbe di limiti «esterni» al-l’esercizio della libertà, rappresentati dagli interessialtrui (Cricenti, 166 s.).
È stato sostenuto, peraltro, che il contrasto giuri-sprudenziale, oscillante fra tipicità e atipicità delleomissioni, sarebbe soltanto apparente. L’osserva-zione parte dal dato che diverse pronunce, fra lequali si ravvisa il conflitto, sono, in realtà, interve-nute su casi ascrivibili all’area della colpa commissi-va (Visintini, I fatti illeciti, 23 ss. e Id., Trattatobreve, 58 ss.). Anche in seno ad altri ordinamenti, siregistra la tendenza dei giudici a invocare il concet-to di omissione impropriamente, per indicare
l’omissione delle cautele richieste nel compimentodi un’azione. In tali casi, trattandosi di condotte at-tive, è pacifico che la responsabilità possa sorgerein assenza di specifici obblighi di impedire l’eventolesivo, per mera contrarietà a generici doveri diprudenza e diligenza. I principi giurisprudenzialiriguardanti le «omissions dans l’action», talora disegno opposto, non sarebbero, dunque, sintomaticidi un contrasto, perché non esprimono la ratio deci-dendi del caso.
Ad ogni modo, la sentenza in commento è signifi-cativa perché aderisce all’indirizzo giurisprudenzialesostenuto dalla dottrina minoritaria. In particolare, igiudici aderiscono all’orientamento della causalitàomissiva atipica perché «si appalesa più conforme alprincipio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., nonché aldovere di comportamento secondo correttezza».
È stato illustrato che proprio il richiamo alla soli-darietà consente, alla dottrina favorevole all’atipicitàdegli illeciti omissivi, di proporre una lettura costi-tuzionalmente orientata del principio del neminemlaedere di cui all’art. 2043 cod. civ. Si tratta di un te-ma, come si è avuto modo di notare, «nel quale con-fliggono i contrapposti principi della libertà indivi-duale (che consente di astenersi dai comportamentinon dovuti) e della solidarietà sociale (che chiede diattivarsi per prevenire danni a terzi)» (Salvi, La re-sponsabilità, 164).
A questo punto, però, è opportuno precisare che,mentre il contrasto esaminato riguarda gli omessi in-terventi a favore di terzi, il caso risolto dalla senten-za in commento riguarda condotte che il danneggia-to avrebbe potuto tenere a proprio vantaggio. Cala-to sulla fattispecie oggetto della nostra analisi, il rin-vio al principio di solidarietà, quale contrappeso allalibertà individuale, potrebbe lasciare perplessi. I ri-ferimenti alla libertà e alla solidarietà, infatti, in tan-to sembrano avere senso, in quanto siano rivolti airapporti intersoggettivi. Il delicato problema consi-ste, là, nello stabilire dove finisca la libertà dell’unoe dove cominci quella dell’altro. È indicativo, a taleproposito, che alcuni autori insistano sul concetto dialterità, ricordando che la versione più corretta delprincipio tramandato fino a noi fosse espresso daUlpiano mediante la formula «alterum non laedere»(Maiorca, 395, infra, sez. IV). Pertanto, ci si do-vrebbe domandare seriamente se la solidarietà costi-tuisca un principio invocabile, nel caso di specie,per assegnare rilievo giuridico alle condotte omissi-ve del danneggiato in assenza di previsioni espresse.Rispondere affermativamente equivarrebbe – si os-serva – ad esigere dal danneggiato una condotta«immediatamente» solidale rispetto alla propria sfe-ra, sì da poter risultare solidale, in via mediata, neiconfronti del danneggiante.
Quanto alla correttezza, essa costituisce un crite-
Cass., sez. un., 21.11.2011, n. 24406 - Commento Responsabilità civile
438 NGCC 2012 - Parte prima
rio chiamato a regolare il rapporto obbligatorio, giu-sta la previsione dell’art. 1175 cod. civ. Nell’evolu-zione dottrinale e giurisprudenziale, essa è finita persaldarsi con la clausola generale di buona fede, det-tata in materia contrattuale, entrambe espressionedel principio costituzionale di solidarietà. Si è anda-ta, via via, affermando la convinzione che correttez-za e buona fede dispieghino efficacia integrativa delrapporto obbligatorio, determinando la nascita diobblighi ulteriori rispetto a quelli formalmente pre-visti (Rodotà, infra, sez. IV). Tale clausola generale,cioè, è ritenuta idonea a far sorgere obblighi acces-sori alla prestazione principale, funzionali a garanti-re una certa collaborazione fra le parti, nei limitidell’apprezzabile sacrificio proprio.
Pertanto, il rinvio alla correttezza appare appro-priato per giustificare l’atipicità delle condotteomissive del creditore nell’ambito dei rapporti ob-bligatori, in vista dei quali l’art. 1227 cod. civ. è det-tato. L’entusiasmo di una parte della dottrina per laricostruzione in chiave atipica del sistema degli ille-citi omissivi si giustifica, sembrerebbe, proprio per ilfatto che si fa riferimento ai rapporti obbligatori(Visintini, I fatti illeciti, 45). Seguendo questo per-corso, si potrebbe ritenere che la condotta omissivadel creditore abbia contribuito a causare l’inadem-pimento perché un obbligo di buona fede, non ti-pizzato, gli imponeva di attivarsi.
Viceversa, la correttezza appare meno adatta agiocare un ruolo significativo in campo extracon-trattuale, all’interno del quale la norma esaminata siapplica in virtù del richiamo di cui all’art. 2056 cod.civ. Non solo la correttezza è prevista formalmenteper i rapporti obbligatori, ma, oltretutto, risulta pro-blematico immaginare l’integrazione del contenutodi un rapporto obbligatorio che, per definizione. Adire la verità, come è noto, il concetto è stato adope-rato per far sorgere doveri di protezione non espres-samente previsti (Castronovo, 443 s., infra, sez.IV). Tuttavia, si tratta di ipotesi in cui non è il dan-no a determinare il rapporto, come accade normal-mente nella materia extracontrattuale. La teoria va-le, infatti, in situazioni, diverse da quelle qui consi-derate, in cui un contatto sociale fra le parti, idoneoa ingenerare l’affidamento, preesiste al danno.
Dal momento che i richiami alla solidarietà e allacorrettezza non convincono del tutto, sembra do-versi ricercare, nell’ambito della motivazione esami-nata, altre ragioni che effettivamente giustifichino laricostruzione del sistema degli illeciti omissivi inchiave di atipicità.
2. La questione del fondamento causale
dell’art. 1227, comma 1o, e la sua pretesa pre-giudizialità rispetto al problema della atipi-
cità delle omissioni rilevanti. In premessa, la
Corte si era soffermata sul superamento della tesitradizionale, secondo cui la disciplina del concorsocolposo del danneggiato sarebbe espressione delprincipio di autoresponsabilità. La parziale perditadel risarcimento assumeva, in quella logica, valenzasanzionatoria per la condotta colposa con cui il dan-neggiato, sconsideratamente, aveva cagionato deidanni a sé. Lo scopo della norma pareva quello diindurre i potenziali danneggiati a prestare attenzio-ne alla propria sfera, contribuendo, così, al buonfunzionamento del sistema di responsabilità civile(De Cupis, Il danno, 252 ss., infra, sez. IV). Talefunzione dissuasiva si prestava ad essere svolta dallanozione classica di colpa, comprendente, oltre al-l’oggettiva violazione dello standard di diligenza, lavalutazione delle concrete possibilità di agire diver-samente che il soggetto aveva, tenute presenti le suecondizioni soggettive (Cattaneo, 501 ss., infra, sez.IV). Letta in chiave di (auto)responsabilità, la nor-ma, nel richiedere la colpa, si inscriveva perfetta-mente entro il sistema aquiliano tradizionale, gover-nato dal principio «nessuna responsabilità senzacolpa» (Visintini, Trattato, 8 ss., infra, sez. IV).
La tendenza della dottrina attuale, seguita dallagiurisprudenza anche passata, è, invece, quella diguardare all’art. 1227, comma 1o, come ad un sem-plice corollario del principio di causalità, in forzadel quale nessuno risponde dei danni che non ha ca-gionato (Bianca, Dell’inadempimento, 413, infra,sez. IV). Questo discorso, portato alle estreme con-seguenze, ha condotto alcuni autori a proporre unalettura abrogatrice del requisito della colpa, perce-pito come un ornamento tradizionale privo di effica-cia precettiva, perché fondato sull’erronea convin-zione che la norma incorpori un giudizio di (auto-)responsabilità (Salvi, voce «Responsabilità extra-contrattuale (dir. vig.)», 1256, infra, sez. IV). L’in-terpretazione della norma, ad ogni modo, si polariz-za sul dato obiettivo e il requisito della colpa, laddo-ve non lo si obliteri del tutto, viene accertato secon-do canoni rigorosamente oggettivi, alla luce di stan-dard comportamentali diffusi socialmente (colpa ge-nerica) ovvero formalizzati (colpa specifica).
La breve ricostruzione del dibattito dottrinaleconsente alla Corte, che condivide l’opinione oggidominante circa la ratio del concorso colposo, di fo-calizzare l’attenzione sull’aspetto causale delle omis-sioni (par. 2.4 della pronuncia). La motivazione, in-centrata sul requisito della causalità, esprime l’inten-to di escludere dall’analisi il secondo requisito ri-chiesto dall’art. 1227, comma 1o, costituito dall’im-putazione a titolo di colpa.
Il discorso offre il destro per giustificare l’adesio-ne all’indirizzo giurisprudenziale che ricostruiscel’omissione del danneggiato come tendenzialmenteatipica, ragionando come segue (par. 2.6). Il supera-
Cass., sez. un., 21.11.2011, n. 24406 - Commento Responsabilità civile
NGCC 2012 - Parte prima 439
mento della teoria dell’autoresponsabilità – secondola quale il decremento del risarcimento è diretto apunire il danneggiato per aver violato i doveri di di-ligenza verso se stesso – sta a dimostrare l’avvenutasvalutazione del ruolo della colpa ai fini del giudiziodi responsabilità. Nella prospettiva della teoria cau-salistica attualmente accreditata, infatti, la colpa nonsvolge più il ruolo di criterio di imputazione, perchéi principi causali sono sufficienti, da soli, a spiegarecome mai il danneggiante non debba rispondere deidanni che non ha cagionato. Escluso che operi comeregola di imputazione, la Corte si sforza di trovareuna funzione alla colpa e ravvisa in essa «l’unico ele-mento di selezione dei vari possibili comportamenti –eziologicamente idonei – del danneggiato». Il compi-to della colpa, genericamente richiamata dall’art.1227, comma 1o, sarebbe, dunque, quello di renderegiuridicamente rilevanti non soltanto le condotteomissive del danneggiato – che sarebbero valse a im-pedire l’evento – adottate in violazione di un obbli-go giuridico individuato, ma anche quelle assunte in«violazione della norma comportamentale di diligen-za, sotto il profilo della colpa generica».
Il ragionamento teso a valorizzare l’evoluzionecirca il fondamento dell’art. 1227, comma 1o, ripro-duce letteralmente i passaggi di precedenti sentenze(Cass., 6.7.2006, n. 15384, infra, sez. III) e rivela,forse, una qualche artificiosità. È, infatti, tutto da di-mostrare che la funzione della colpa, in seno allanorma in esame, sia proprio quella assegnata, quasiper esclusione, dai giudici.
In secondo luogo, viene da chiedersi se, affidandoalla colpa il ruolo di fonte degli obblighi generici diintervento, non si corra il rischio di sovrapporre lasfera soggettiva della colpevolezza e quella oggettivadella causalità. Adottando la diligenza come possibi-le fonte dell’obbligo di intervenire, infatti, si attri-buisce a quel concetto una duplice funzione: sul pia-no oggettivo, quella di selezionare le omissioni ezio-logicamente rilevanti e, sul piano soggettivo, quelladi criterio di imputazione del fatto. D’altra parte ènaturale che, nell’ambito delle fattispecie omissive,l’obbligo di impedire l’evento e il dovere di diligen-za si intersechino, arrivando praticamente a coinci-dere (Fiandaca-Musco, 615, infra, sez. IV).
Parte della dottrina avverte, però, l’esigenza di te-nere il giudizio di causalità separato da quello di col-pevolezza (Gigliotti, 920 s., infra, sez. IV). A taleproposito, si sottolinea che il giudice, per giungereall’affermazione della responsabilità omissiva, do-vrebbe, a rigore, compiere separatamente la seguen-te sequenza di operazioni logiche: i) individuare, incapo al supposto responsabile, l’obbligo giuridico diimpedire l’evento; ii) accertare l’efficienza causaledell’omissione, ipotizzando che l’intervento avrebbescongiurato l’evento lesivo; iii) ricondurre l’omesso
intervento a un contegno negligente, se non inten-zionale, del soggetto (Castelli, 441 ss., infra, sez.IV). Riservare alla diligenza margini di autonomiaapplicativa, nel giudizio di imputazione, sembrereb-be possibile mediante il ricorso ad una nozione dicolpa non strettamente obiettiva (Gazzoni, 721, in-fra, sez. IV). All’individuazione di un obbligo di di-ligenza violato, che doterebbe l’omissione di rilevan-za eziologica, potrebbe seguire, sul piano soggettivo,l’esclusione del carattere colposo, qualora l’obbligo,benché l’evento si sia verificato, sia stato adempiutocon la diligenza esigibile dal soggetto chiamato a ri-spondere.
Altra parte della dottrina non sembra preoccupa-ta dal problema e parla genericamente di colpaomissiva per qualificare le condotte omissive rile-vanti, senza peritarsi di analizzare distintamente iprofili della causalità e della colpevolezza (Bigliaz-zi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 788, infra, sez.IV).
La contiguità fra i due aspetti non ha distolto laCassazione, nel recente passato, dal tentare una di-stinzione. In particolare, le sezioni unite hanno cer-cato di tracciare una linea di demarcazione tra l’am-bito soggettivo della colpa e quello oggettivo dellacausalità quando, nella prospettiva della causalitàadeguata, il compito si presentava particolarmentearduo (cfr. Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 576, cit.).
La sentenza in commento, per contro, non sem-bra avvertire compiutamente i rischi derivanti dallaconfigurazione della diligenza come fonte degli ob-blighi di impedire l’evento, tanto è vero che non ef-fettua alcuna precisazione al riguardo. Peraltro, siavverte una certa contraddittorietà: se la Corte, at-traverso la premessa sulla ratio causale del concorsocolposo, pareva affermare l’esigenza di isolare l’ele-mento oggettivo, invocando la colpa generica comefondamento delle omissioni atipiche sembrerebbe,alla fine, tradire gli intenti iniziali.
A questo punto, affiora un ultimo argomento che,procedendo per assurdo, è volto a rafforzare la soli-dità dell’argomentazione precedente. Appositamen-te congegnato per la fattispecie in esame, esso risultaestremamente efficace e merita apprezzamento. Laconstatazione di fondo, elementare e persuasiva, èche «generalmente l’ordinamento non pone obblighigiuridici a carico di un soggetto per la tutela delle po-sizioni giuridiche di questi». Il risultato è che recla-mare obblighi di impedire l’evento tipizzati, anchein questo caso, finirebbe, di fatto, per rendere l’art.1227, comma 1o, inapplicabile alle condotte omissi-ve del danneggiato, che pure, astrattamente, rientra-no in quella previsione (Cass., 17.10.1969, n. 3402 eCass., 17.2.1968, n. 555, infra, sez. III; Monateri,118 e Cattaneo, 493, infra, sez. IV). La circostanzache l’ordinamento non imponga quasi mai ai conso-
Cass., sez. un., 21.11.2011, n. 24406 - Commento Responsabilità civile
440 NGCC 2012 - Parte prima
ciati di salvaguardare se stessi è dovuta alla constata-zione che gli individui capaci perseguono da soli, emeglio di chiunque altro potrebbe fare al loro posto,i propri interessi (costituisce un’eccezione l’obbligodi indossare le cinture di sicurezza ex art. 172 cod.della strada). Questo discorso appare, d’altronde,coerente con il sistema fondato sull’autoresponsabi-lità, nel quale le persone dotate di capacità naturalee d’agire, ritenute capaci di badare a se stesse, subi-scono le conseguenze, anche negative, dei loro atti.
L’ultimo argomento, adoperato per confermare lavalidità del discorso, sembra imporsi, nella sua sem-plicità, come l’effettiva ratio decidendi della motiva-zione analizzata.
All’esame dei vari argomenti adoperati nella sen-tenza in commento, segue uno spunto di riflessioneconclusivo. Si è riferito di come l’intervento dellaCorte valga a far penetrare la diligenza all’internodell’art. 1227, comma 1o, cod. civ., quale criterio or-dinario per selezionare le condotte omissive causal-mente efficienti a produrre l’evento lesivo. Si ram-menta che l’art. 1227, comma 2o, comunemente rife-rito alle conseguenze dannose, reca testualmente ilrichiamo alla diligenza quale criterio che esclude larisarcibilità dei danni evitabili. Ci si domanda, aquesto punto, se, almeno per quanto riguarda lecondotte omissive, la Corte non stia proponendouna rilettura unitaria della disposizione alla luce delcriterio della evitabilità mediante l’adozione dell’or-dinaria diligenza, come se dichiarasse irrisarcibilinon solo i danni evitabili tout court (comma 2o), ma,altresì, i danni derivanti da eventi evitabili, da partedel danneggiato, in base al medesimo criterio (com-ma 1o). Viene, allora, da chiedersi se ciò non equi-valga ad anticipare l’ambito di rilevanza dei doveridi mitigation di cui al cpv., raggiungendo, per altravia, il risultato ottenuto da alcuni autori attraverso lariconduzione del secondo comma anche agli eventidi danno (Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità,138, infra, sez. IV).
III. I precedenti
1. Solidarietà «verso se stessi» e correttez-za «extracontrattuale». Quanto alla priorità lo-gica dell’identificazione dell’obbligo di impedirel’evento rispetto all’accertamento causale vero eproprio, v. Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 576, in Cass.pen., 2008, I, 69 ss., par. 5.5, con nota di Blaiotta.
Seguono l’orientamento tradizionale ed esigonoobblighi individuati di impedire l’evento: Cass.,9.1.1979, n. 116, in Resp. civ. e prev., 1979, 515;Cass., 25.9.1998, n. 9590, in Giust. civ., 1999, I, 94;Cass., 28.6.2005, n. 13982, in Mass. Giust. civ.,2005. Vengono fatte risalire a questo orientamentoanche: Cass., 30.10.1980, n. 5856, in Resp. civ. e
prev., 1981, 390; Cass., 2.2.1983, n. 908, in Banca,borsa, tit. cred., 1984, II, 459; Cass., 14.4.1983, n.2619, in Resp. civ. e prev., 1984, II, 294; Cass.,9.3.1982, n. 1526, in Mass. Giur. it., 1982; Cass.,11.3.1991, n. 2555, in Foro it., 1991, 2802; Cass.,14.10.1992, n. 11207, in Giust. civ., 1993, 1870;Cass., 25.9.1998, 9590. Nel merito, cfr. Trib. Tori-no, 17.6.1995, in Resp. civ. e prev., 1996, 1014;Trib. Napoli, 5.3.1985, in Dir. e giur., 1985, 712;App. Roma, 5.3.1980, in Giur. merito, 1982, 91.
Come espressione dell’opposto orientamento, lasentenza in commento richiama, in ordine cronolo-gico, Cass., 14.10.1992, n. 11207, in Giust. civ.,1993, 1870; Cass., 8.1.1997, n. 72, in Banca, borsa,tit. cred., 1997, II, 653, con nota di Scognamiglio;Cass., 29.7.2004, n. 14484, in Mass. Giust. civ.,2004; Cass., 23.5.2006, n. 12111, ivi, 2006; nonchéCass., sez. un., 11.1.2008, n. 576, la quale richiamala «omissione di un comportamento imposto da unanorma giuridica specifica (omissione specifica), ovvero(...) di un generico dovere di intervento (omissione ge-nerica)». V. anche Cass., 27.11.1972, n. 3462, inGiust. civ., 1973, I, 439; Cass., 4.7.1975, 2613, inMass. Giur. it., 1975; Cass., 15.12.1976, n. 4643, inGiur. it., 1977, I, 222; Cass., 28.10.1978, n. 4943,ivi, 1979, I, 279; Cass., 9.1.1979, n. 116, cit.; Cass.28.4.1979, n. 2488, in Giust. civ., 1979, I, 2131. Nelmerito, cfr. App. Firenze, 12.2.1987, ivi, 1987, I,2081; Trib. Napoli, 24.5.1978, in Foro it., 1978, I,211.
Individua obblighi giuridici di impedire l’eventodannoso in base ad un rapporto non già contrattua-le, ma di cortesia, Cass., 14.1.1971, n. 66, in Casi equestioni di diritto privato, a cura di Bessone, Giuf-frè, 1973, 263 ss. e in Giur. it., 1971, I, 1, 501. Par-lare di atipicità è, tuttavia, affrettato, poiché ci si ba-sa su di una relazione, determinata dal «contatto so-ciale», sorta prima del verificarsi del danno.
2. La questione del fondamento causale
dell’art. 1227, comma 1o, e la sua pretesa pre-giudizialità rispetto al problema della atipi-
cità delle omissioni rilevanti. Tra le poche pro-nunce di legittimità che hanno aderito alla tesi delladottrina classica per cui l’art. 1227, comma 1o, sa-rebbe espressione del principio di autoresponsabili-tà: Cass., 3.6.1959, n. 1650, in Foro it., 1959, I, 923ss. e in Resp. civ. e prev., 1960, 160 s. A favore delcarattere soggettivo della colpa della vittima: Cass.,17.10.1969, in Foro it., 1970, I, 1207 ss.
La giurisprudenza, anche passata, ha quasi sem-pre letto l’art. 1227, comma 1o, nella prospettivacausale. La sentenza in commento cita, a questoproposito, Cass., 26.4.1994, n. 3957, in Rep. Foroit., 1994, voce «Responsabilità civile», n. 130 eCass., 8.5.2003, n. 6988, ivi, 2003, voce cit., n. 247.
Cass., sez. un., 21.11.2011, n. 24406 - Commento Responsabilità civile
NGCC 2012 - Parte prima 441
Fra le altre, cfr. anche Cass., 5.2.1987, n. 1137, inMass. Giust. civ., 1987; Cass., 9.1.2001, n. 240, ivi,2001; Cass., 20.8.2009, ivi, 2009.
Quanto al carattere «tralatizio» della premessa sulfondamento dell’art. 1227, comma 1o (par. 2.3) e lapretesa conseguenza (par. 2.6), si può notare che lasentenza commentata riprende letteralmente i pas-saggi di Cass., 6.7.2006, n. 15384, in Foro it., 2006,I, 3358, par. 7.3 s. Analogamente Cass., 3.12.2002,n. 17152, in questa Rivista, 2003, I, 799, con nota diFusaro; in Foro it., 2003, I, 1802; in Danno e resp.,2003, 497, con nota di Malvasi e Violante; in Re-sp. civ. e prev, 2003, 60, con nota di Facci; in Corr.giur., 2003, 759, con nota di Molina.
Distingue tra prevedibilità in astratto, in applica-zione del principio della causalità adeguata, e preve-dibilità in concreto, con riferimento alla colpevolez-za: Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 576, par. 5.4. Avevaribadito la necessità di mantenere separati i due pro-fili anche Cass., 18.4.2005, n. 7997, in Corr. giur.,2006, 257, con nota di Rolfi.
Per la giurisprudenza maggioritaria, secondo cuiil comma 1o dell’art. 1227 cod. civ. «concerne il rap-porto tra causa ed effetto, regolando il concorso di col-pa del danneggiato nella produzione dell’evento»,mentre il comma 2o riguarda «il rapporto tra eventoe danno»: Cass., 16.6.2003, n. 9629, in Giust. civ.,2004, I, 2334; ma v. anche Cass., 17.5.2001, in que-sta Rivista, 2002, I, 365, con nota di Meoli e Cass.,9.1.2001, n. 240, in Giur. it., 2001, 2289.
IV. La dottrina
1. Solidarietà «verso se stessi» e correttez-za «extracontrattuale». Sulle modalità di accer-tamento del nesso causalistico omissivo: Capecchi,Il nesso di causalità. Da elemento della fattispecie«fatto illecito» a criterio di limitazione del risarcimen-to del danno, Cedam, 2005, 162 ss. e Belvedere, Ilnesso di causalità, nel Trattato di biodiritto, diretto daRodotà e Zatti, IV, La responsabilità in medicina, acura di Belvedere e Riondato, Giuffrè, 2011, 261.
Espone gli orientamenti favorevoli alla tipicità ov-vero all’atipicità dell’illecito omissivo Salvi, La re-sponsabilità civile, Giuffrè, 2005, 164 s. Fra la tipici-tà, evocante un numero chiuso di obblighi, e l’atipi-cità, che richiama tutti i possibili casi in cui «il sog-getto avrebbe potuto prendere misure e cautele perprevenire l’evento», Alpa, Il problema della atipicitàdell’illecito, Jovene, 1979, 141 ss., intravede una fasedi «passaggio» o di compromesso in Cass.,
4.1.1971, n. 66.Resta dell’opinione che il sistema degli illeciti
omissivi vada ricostruito nel segno della tipicità, tragli altri, Scognamiglio, voce «Responsabilità civi-le», nel Noviss. Digesto it., XV, Utet, 1968, 268 ss.;
Trimarchi, voce «Illecito (dir. priv.)», in Enc. deldir., XX, Giuffrè, 1970, 99; Visintini, Trattato bre-ve della responsabilità civile, Cedam, 1999, 67 e Id.,I fatti illeciti, II, Cedam, 1990, 44 s.; Franzoni, L’il-lecito, nel Trattato della responsabilità civile, direttoda Franzoni, Giuffrè, 2010, 218 ss.
A favore di una posizione intermedia, inclini a ri-correre al procedimento analogico per determinaregli obblighi di attivarsi: Cian, Antigiuridicità e colpe-volezza. Saggio per una teoria dell’illecito civile, Ce-dam, 1966, 262 s. e Salvi, La responsabilità civile,113 ss.
Caldeggiano un sistema atipico degli illeciti omis-sivi Alpa, Il problema dell’atipicità dell’illecito, 176,applicando le regole dell’art. 2 Cost. e dell’art. 2043cod. civ; Cricenti, Il problema della colpa omissiva,Cedam, 2002, 184; Salvi, voce «Responsabilità ex-tracontrattuale (dir. vig.)», in Enc. del dir., XXXIX,Giuffrè, 1988, 1256 ss. V. anche Monateri, La re-sponsabilità civile, nel Trattato dir. civ., diretto daSacco, Utet, 1998, 100.
Per indicare l’anomalia dell’atipicità delle omis-sioni, parla di «isola» di tipicità nel «mare» della ati-picità dell’illecito Alpa, Sulla responsabilità dellabanca per i danni risentiti dai clienti nel corso di unarapina, in Giur. it., 1981, I, 2, 159 ss. Sui rapporti traprincipio di neminem laedere e clausola generaledell’art. 2043 cfr. Id., Responsabilità civile e danno,Il Mulino, 1991, 39 ss. Vede nella solidarietà un«obbligo di operare in situazioni nelle quali il pros-simo è svantaggiato, come nel caso in cui sta per su-bire o subisce un danno» Id., L’arte di giudicare, La-terza, 1996, 103. Sulla possibilità di attribuire allenorme costituzionali il ruolo di «direttive interne delsistema civilistico»: Rodotà, Il principio di correttez-za e la vigenza dell’art. 1175, in Banca, borsa, tit.cred., 1965, I, 159. Più di un trentennio prima del-l’entrata in vigore della Costituzione richiama la so-lidarietà, come valore puramente sociale, Pacchio-ni, Elementi di diritto civile, Utet, 1916, 326.
Distinguono omissioni proprie e improprie Vi-sintini, I fatti illeciti, 20 ss. e Franzoni, L’illecito,215, ss., che parla, nello stesso senso, di colpa «insenso tecnico» e «in senso ampio». Salvi, La respon-sabilità civile, 113, per qualificare le omissioni insenso stretto, richiama la figura del buon samaritanodella parabola evangelica. Cricenti, 66, osserva che«la condotta attiva si riferisce ad un rischio ascrivi-bile al danneggiante», come effetto di una sua attivi-tà, mentre «l’omissione consiste nel mancato inter-vento del soggetto in ordine ad un rischio creato daaltri».
A proposito della solidarietà in riferimento alleomissioni «verso se stessi», Maiorca, I fondamentidella responsabilità, Giuffrè, 1990, 395 evoca il «ne-minem laedere» come un «principio di base accen-
Cass., sez. un., 21.11.2011, n. 24406 - Commento Responsabilità civile
442 NGCC 2012 - Parte prima
trato sull’idea dell’alterità (alterum)». Osserva che iltratto caratteristico della solidarietà sarebbe la «con-siderazione dell’interesse altrui», Uda, La buona fe-de nell’esecuzione del contratto, Giappichelli, 2004,57. Sulla configurabilità del concorso di colpa, me-diante condotte omissive, v. Monateri, 118 e Cat-taneo, Il concorso di colpa del danneggiato, in Riv.dir. civ., 1967, 493.
La proposta di attribuire alla buona fede valenzaintegrativa, alla luce dell’esperienza tedesca, è for-mulata da Rodotà, Le fonti di integrazione del con-tratto, Giuffrè, 1969 (rist. integr. 2004). Sulla espan-sione del principio di buona fede, v. Nanni, Laclausola generale della buona fede, in Clausole e prin-cipi generali nell’argomentazione giurisprudenzialedegli anni novanta, a cura di Cabella Pisu e Nan-ni, Cedam, 1998, 331 s. e le considerazioni di Livi,L’integrazione del contratto, in Diritto civile, direttoda Lipari e Rescigno, III, Obbligazioni, 2, Il con-tratto in generale, Giuffrè, 2009, 652. Sul rischio chela buona fede venga adoperata oltre i suoi «naturali»confini, mi permetto di rinviare al mio La domandaparcellizzata: i devastanti riflessi sul sistema, in Giur.it., 2010, 10, 2055.
È favorevole a ricostruire atipicamente gli illecitiomissivi nell’ambito dei rapporti obbligatori Capec-chi, Il nesso di causalità, 156 ss., «mediante il ricor-so agli obblighi di buona fede ex artt. 1175-1375c.c.». Dello stesso avviso è Visintini, I fatti illeciti,45, che reputa inopportuno un sistema extracontrat-tuale fondato su di un generalizzato dovere di coo-perazione.
Per la teoria degli obblighi di protezione senzaobbligo di prestazione, fondati sull’affidamento de-terminato dal contatto sociale, v. Castronovo, Lanuova responsabilità civile, Giuffrè, 2006, 443 ss.,che svolge anche una ricostruzione dell’evoluzionegiurisprudenziale.
2. La questione del fondamento causale
dell’art. 1227, comma 1o, e la sua pretesa pre-giudizialità rispetto al problema della atipi-
cità delle omissioni rilevanti. Ricostruisce il di-battito sul fondamento dell’art. 1227, comma 1o,Venchiarutti, Concorso del fatto colposo del credi-tore, nel Commentario del Codice Civile, diretto daCendon, Giuffrè, 2009, 1107 ss. Cfr. anche Fren-da, Tra causalità e colpa: il concorso del fatto del dan-neggiato nella produzione dell’evento lesivo, in que-sta Rivista, 2010, I, 812 e Senocrate, Il concorsodel fatto colposo del creditore ex art. 1227, 1o comma,c.c. tra vecchi e nuovi problemi, in Obbl. e contr.,2011, 612 ss.
In particolare, leggono l’art. 1227, comma 1o, inchiave di autoresponsabilitàDe Cupis, Sulla riduzio-ne del risarcimento per concorso del fatto colposo del
danneggiato incapace, in Foro it., 1958, I, 933 ss., an-che in altri scritti successivi; Cattaneo, 460 ss.;Trimarchi, Causalità e danno, Giuffrè, 1967, 129ss. Sul dovere del danneggiato di contribuire, insie-me al danneggiante, a prevenire il danno a sé: DeCupis, Il danno. Teoria generale della responsabilitàcivile, I, Giuffrè, 1979, 252 ss. Per una nozione dicolpa attenta anche agli stati soggettivi, Id., Il dan-no, 253 e Cattaneo, 501. Fa riferimento alla colpacome ad un «principio suscettibile di applicazioni il-limitate, al quale ricondurre tutte le ipotesi di re-sponsabilità del Code civil». Visintini, Trattato bre-ve della responsabilità civile, 8 ss. parla di un lungoperiodo «morale» (das Schuldmoment) che ha vistola colpa come unico fondamento della responsabili-tà, in ossequio al principio di ragion naturale «Nichtder Schaden verpflichtet zum Schadenersatz, sonderndie Schuld» Carbone, Nesso di causalità e criteri divalutazione del danno contrattuale, in Diritto civile,diretto da Lipari e Rescigno, III, Obbligazioni, 1,Il rapporto obbligatorio, Giuffrè, 2009, 696.
Avverte l’esigenza di guardare alla norma sul con-corso colposo in termini di causalità Bianca, Dirittocivile, 5, La responsabilità, Giuffrè, 1994, 137. Sulfondamento causalistico dell’art. 1227, comma 1o, v.anche Id., Dell’inadempimento delle obbligazioni,nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foroit., 1979, sub art. 1227, 404 ss. Contesta la teoria del-l’autoresponsabilità Salvi, voce «Responsabilità ex-tracontrattuale (dir. vig.)», 1255 ss.; Franzoni, Deifatti illeciti, nel Commentario Scialoja-Branca, Zani-chelli-Foro it., 1993, 772. Sembra oscillare tra pro-spettiva causalistica e quella dell’autoresponsabilitàMonateri, 114 ss. Sulla non vincolatività del requi-sito della colpa ex art. 1227, comma 1o, v. Salvi, vo-ce «Responsabilità extracontrattuale», 1256. Conce-pisce la colpa in chiave oggettiva, tra gli altri, Bian-ca, Dell’inadempimento delle obbligazioni, 415 ss. èambiguo, sul punto Monateri, 118, nt. 27.
Evidenzia, nell’ambito della condotte omissive,un continuum «tra ragionamento sul nesso causale eragionamento sulla colpa» Monateri, 119. Analo-gamente, in campo penale: Fiandaca-Musco, Di-ritto penale, parte generale, Zanichelli, 2008, 615,589. Avverte l’esigenza di mantenere distinti il pianocausale e quello della colpaGigliotti, Illeciti da in-formazione e responsabilità omissiva, in Riv. dir. civ.,2002, 920 s. V. anche Capecchi, Note in tema dicausalità omissiva, in Danno e resp., 2006, 273; Li-serre, Ancora sul concorso colposo del danneggiatoincapace, in Foro pad., 1962, 1267; Frenda, 808.Dello stesso avviso sembra Castelli, Dei fatti illeci-ti: art. 2043 e art. 96 c.p.c., nel Commentario al Codi-ce Civile, diretto da Gabrielli, Utet, 2010, 441 ss.L’esigenza di distinguere il profilo della diligenza daquello dei doveri di intervento è posta in luce da
Cass., sez. un., 21.11.2011, n. 24406 - Commento Responsabilità civile
NGCC 2012 - Parte prima 443
Maiorca, 389, che, in generale, è scettico (278 s.)sulla artificiale separazione fra elemento oggettivo esoggettivo dell’illecito caro alla «teoria analitica del-l’illecito», di cui si mostrano entusiasti, viceversa,Alpa-Bessone, I fatti illeciti, nel Trattato Rescigno,XIV, Utet, 1982, 90.
Sembra sovrapporre i piani della causalità con edella colpevolezza Salvi, La responsabilità civile,164 s., il quale, parla di un peculiare grado di colpe-volezza, fondato sulla sproporzione tra l’entità dellosforzo richiesto per evitare il danno e l’entità del pe-ricolo. Trattano il tema della tipicità dell’illecitoomissivo come un problema di latitudine della culpain omettendo Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Diritto civile, III, Obbligazioni e contratti,Utet, 1989, 788.
Per una concezione soggettiva della colpa extra-contrattuale Gazzoni, Manuale di diritto privato,Esi, 2007, 721, che, invece, propende per una con-cezione rigorosamente oggettiva della colpa contrat-tuale.
Quanto ai rapporti fra i due commi dell’art. 1227
cod. civ., la dottrina dominante (tra gli altri: Visin-tini, Trattato breve della responsabilità civile, 692;Cattaneo, 460) riferisce il comma 1o al caso in cuiil danneggiato intervenga nella fase produttiva del-l’evento lesivo (causalità di fatto) e il comma 2o al-l’ipotesi in cui il la sua condotta incida sulle conse-guenze dannose di un evento interamente addebita-bile al danneggiante (causalità giuridica).
Fornisce una lettura stravagante dei rapporti fra idue commi dell’art. 1227 cod. civ. Bianca, Dirittocivile, 4, L’obbligazione, Giuffrè, 1994, 138, seguitoda Sapone, Il concorso di colpa del danneggiato,Giuffrè, 2007, 7 ss., e Gabrielli, La condotta deldanneggiato, in La responsabilità civile, a cura diCendon, VIII, Utet, 1998, 573, i quali intendono ilcpv. dell’art. 1227 cod. civ. come una regola sullaprevenzione dello stesso evento di danno. Critica ilconcetto di «causalità» giuridica Belvedere, Causa-lità giuridica?, in Riv. dir. civ., 2006, 21.
Vittorio Bachelet
CORTE GIUST. UE, 21.12.2011, causaC-496/10
Responsabilità civile - Danno da pro-
dotto difettoso - Utilizzazione di
un prodotto in occasione di una pre-
stazione medica - Direttiva n. 85/374/CEE - Ambito di applicazione - Regi-me nazionale - Responsabilità delle
strutture sanitarie pubbliche anche
in assenza di colpa - Ammissibilità (di-rettiva n. 85/374/CEE, art. 13)
Posto che la responsabilità di un prestato-re di servizi il quale utilizzi, nell’ambito diuna prestazione di servizi quale l’eroga-zione di cure in ambiente ospedaliero, ap-parecchi o prodotti difettosi di cui non siail produttore ai sensi delle disposizionidell’art. 3 della direttiva del Consiglio25.7.1985, n. 85/374/CEE, e causi in talmodo danni al destinatario della presta-zione, non rientra nell’ambito di applica-zione di tale direttiva, quest’ultima non
osta a che uno Stato membro istituisca unregime che preveda la responsabilità di unsimile prestatore per i danni in tal modocagionati, anche in assenza di qualunquecolpa imputabile al medesimo, a condizio-ne, tuttavia, che sia fatta salva la facoltàper la vittima e/o per il suddetto prestato-re di invocare la responsabilità del produt-tore in base alla citata direttiva.
dal testo:
Il fatto. I motivi. 1. La domanda di pronun-cia pregiudiziale verte sull’interpretazione del-la direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle di-sposizioni legislative, regolamentari ed ammi-nistrative degli Stati membri in materia di re-sponsabilità per danno da prodotti difettosi(GU L 210, pag. 29), come modificata dalladirettiva del Parlamento europeo e del Consi-glio 10 maggio 1999, 1999/34/CE (GU L 141,
Corte giust. UE, 21.12.2011, causa C-496/10 Responsabilità civile
444 NGCC 2012 - Parte prima
c