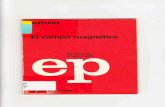RÔMULO ALMEIDA: Nas Dobraduras do Campo Econômico Com o Campo Político
Le regole dell’attenzione: teoria e pratiche dell’intellettuale in campo. Introduzione a...
Transcript of Le regole dell’attenzione: teoria e pratiche dell’intellettuale in campo. Introduzione a...
Sommario
IntroduzioneLe regole dell’attenzione. Teoria e pratichedell’intellettuale in campo 7
Un’idea del campo intellettuale 10Habitus e agency dell’intellettuale 17Località, abitudini e oggetti culturali 22
Avvertenza e ringraziamenti 31Versioni originali 32
Capitolo primoPrima della religione civile: sugli incontri dimenticatitra Robert N. Bellah e l’America, 1955-1965 33
Talcott Parsons e la sociologia americana 38Robert Bellah al Department of Social Relations di Harvard 42Una lettura parsonsiana della storia religiosadel popolo americano 45La teoria della modernizzazione e l’America 50Bellah teorico della modernizzazione 53Arriva la religione civile 58Emancipazioni intellettuali e organizzative 64
Capitolo secondoLa trappola del successo intellettuale.Robert N. Bellah e il dibattito sulla religione civile americana 73
Il successo intellettuale e la teoria dell’accumulazionedel vantaggio 75Il dibattito sulla religione civile americana (1967-1975) 80Il successo di Bellah negli studi americani (1967-presente) 86Attraverso lo specchio: la trappola del successointellettuale (1971-1980) 91Successo intellettuale e differenziali di status 99
Capitolo terzoL’“affaire Bellah” a Princeton: eccellenza intellettuale elibertà accademica in America negli anni Settanta 109
L’Institute for Advanced Study a Princeton 112Robert N. Bellah prima del 1973 113Lo scontro sulla nomina di Bellah allo IAS 115L’“affaire Bellah” 119La libertà accademica e i suoi nemici: due storie contrapposte 123Reazioni pubbliche e private 126Il superamento dell’affaire Bellah 133
7
Introduzione
Le regole dell’attenzione.Teoria e pratiche dell’intellettuale in campo
A guide is not a guide if he leads simultaneously in all directions at once.
John W. Burrow
Gli intellettuali sono persone che vivono di idee1. Creano idee. Manipolano idee. Le sostituiscono con altre idee, migliori o sem-plicemente diverse. Qualche volta riescono ad attirare l’attenzione dei loro pari o, addirittura, di pubblici più vasti. Se un tempo gli “uomini di idee” erano considerati, e si rappresentavano, come in-dividui eccentrici o straordinari – lo scienziato geniale e distratto, il brillante ma superfi ciale conversatore dei salotti, il poeta maudit votato all’autodistruzione, l’arcigno inquilino della torre d’avorio –, la sociologia della conoscenza li ha descritti come portatori di ruoli sociali radicati in strutture e processi collettivi – gruppi, comunità, organizzazioni, istituzioni.
1 Utilizzerò indifferentemente “idea” e “oggetto culturale” per indicare qualunque oggetto simbolico riconoscibile come tale. Come spiego nel secondo capitolo, questa decisione è giustificata dal fatto che idee e testi vengono usualmente compresi e uti-lizzati mediante formule semplificate che li compattano in oggetti facilmente ricono-scibili. In questo senso, non c’è alcuna differenza analitica tra la formula “E = mc2” e l’intero testo della Divina Commedia.
8
Complici le numerose svolte relazionali, culturaliste e pratiche degli ultimi trent’anni2, l’agenda dei sociologi del sapere è cambiata radicalmente e la concezione classica degli intellettuali si è dissolta in un nuovo vocabolario fatto di discorsi, interventi, capitali, allinea-menti e performance. I miei tre studi di caso su Robert N. Bellah – il sociologo americano allievo di Talcott Parsons noto per le sue tesi sulla religione civile americana e l’evoluzione della religione – in-tendono collocarsi nell’ambito di quella che è stata defi nita nuova sociologia delle idee3. Questa introduzione elabora e presenta bre-vemente i concetti utili a costruire una sociologia di tipo narrativo capace di spiegare singole evenienze storiche utilizzando concetti e teorie sociologiche – soprattutto al livello dei meccanismi – senza perdere di vista l’unicità dei fenomeni sotto esame; nonché, vice-versa, una sociologia capace di cogliere analiticamente le vicende biografi che e le carriere di intellettuali, gruppi e scuole di pensiero come esempi e studi di caso per chiarire questioni teoriche più am-pie4. La mia trattazione si concentrerà soprattutto sui due concetti, campo e habitus, che occupano una posizione centrale nelle due te-orie egemoni nella nuova sociologia delle idee – quelle di Pierre Bourdieu e Randall Collins5. Muovendomi nello spazio marcato da
2 Per una articolazione delle varie svolte si possono vedere l’introduzione di Marco Santoro e Roberta Sassatelli a Studiare la cultura (Il Mulino, Bologna, 2009) e T.R. Schatzki, K. Knorr Cetina e E. von Savigny (eds.), The Practice Turn in Contemporary Theory, Routledge, London-New-York, 2001, dove le pratiche sono definite come «in-siemi incorporati e materialmente mediati di attività umane organizzati da comprensio-ni pratiche condivise» (p. 11).
3 L’espressione si trova in C. Camic e N. Gross, The New Sociology of Ideas, in J.R. Blau (ed.), Blackwell Companion to Sociology, Blackwell, Oxford, pp. 236-249.
4 Sul concetto di meccanismo sociale si possono vedere, innanzitutto, F. Barbera, Meccanismi sociali, Il Mulino, Bologna, 2004, e N. Gross, A Pragmatist Theory of Social Mechanisms, in «American Sociological Review», 74, 2009, pp. 358-379.
5 Questa introduzione esclude il terzo dei pilastri della nuova sociologia delle idee, la ANT di Bruno Latour e John Law ma anche, più in generale, gli approcci di tipo mi-crosociologico ed etnografico – di cui abbiamo esempi anche nell’analisi delle scienze sociali e delle humanities, per esempio in How Professors Think di Michèle Lamont (Harvard University Press, Cambridge, MA, 2009) e in alcuni saggi del recente Social Knowledge in the Making, curato dalla stessa Lamont con C. Camic e N. Gross (The University of Chicago Press, Chicago-London, 2012). Tale esclusione è dovuta unica-
9
queste impostazioni teoriche mi servirò del lavoro di sociologi come Bernard Lahire, Howard Becker, e Michèle Lamont per aprire e ren-dere più ricco e fl essibile il mio toolkit teorico.
Ognuno dei capitoli in cui si articola il volume presenta un episo-dio della biografi a intellettuale di Bellah alla luce di un tema di più ampio respiro teorico – i processi con cui i creatori di oggetti cul-turali si autonomizzano dai propri maestri; i meccanismi di stereo-tipizzazione e i paradossi della teoria dell’accumulazione del van-taggio; la circolazione delle reputazioni nell’ambito delle istituzioni che defi niscono e difendono l’autonomia del campo intellettuale. I tre capitoli possono dunque essere letti come studi su quelle reti di relazioni in cui il campo si concretizza e diventa operativo attraverso le pratiche che attori individuali e collettivi portano avanti nel conte-sto di organizzazioni più o meno formalizzate.
Tre avvertenze. In primo luogo, essendo convinto che i concetti vadano messi a confronto con le necessità della ricerca, più che con altri concetti, ho volutamente evitato la modalità scolastica della dis-sertazione teorica per presentare un apparato analitico che combina alcune delle intuizioni migliori della nuova sociologia delle idee. Il fi ne ultimo è quello di mettere in luce e spiegare alcuni dei mecca-nismi del campo intellettuale, modifi cando i concetti quando ciò si dimostra necessario per comprendere appieno fenomeni e processi. In secondo luogo, poiché parto dalla premessa che lo schema gene-rale sia applicabile al di là delle differenze tra i diversi ambiti del campo intellettuale, ho disseminato questa introduzione di esempi che puntano a mostrare icasticamente le omologie tra un ambito e l’altro. Con ciò non intendo affermare che arte, letteratura e scienza funzionino esattamente nello stesso modo. Sono però convinto che le analogie con le arti e le humanities siano cruciali quanto le analo-gie con le scienze dure per introdurre una serie di studi di caso che si
mente a una insufficiente elaborazione teorica da parte di chi scrive. Un altro riferimen-to importante, anch’esso non sufficientemente integrato in questa introduzione, è M.S. Archer, La morfogenesi della società, Franco Angeli, Milano, 1997.
10
concentrano sulle vicende di un intellettuale posizionato all’incrocio di una serie di campi accademici diversi.
Infi ne, nonostante Bourdieu sia una presenza fi n troppo evidente, la sociologia delle idee che propongo in questo volume non coincide con quella del sociologo francese. Oltre alla rielaborazione dell’ha-bitus, assai più in linea con il lavoro di Lahire, mancano nei miei studi i paralleli tra posizioni interne ed esterne al campo intellet-tuale che costituiscono il punto decisivo di molte delle analisi di Bourdieu, da Homo Academicus all’Ontologie politique de Martin Heidegger, da Les règles de l’art alla Distinction. Pur riconoscen-do e prendendo in esame l’infl uenza indiretta dei processi esterni al campo della produzione culturale, gli studi di caso presentati di seguito privilegiano le pratiche degli intellettuali e le dinamiche che operano all’interno di campi intellettuali specializzati, tanto da poter rientrare nel cosiddetto “nuovo internalismo sociologico”6. Nono-stante esistano ragioni di carattere storico per limitare l’analisi alle dinamiche interne, sono convinto che il limite si giustifi chi anche dal punto di vista epistemico. Come scriveva Niklas Luhmann, la teoria vede tutto il mondo, ma da un solo punto di vista. L’ambizio-ne è che da lì si veda qualcosa di cui altri, situati altrove, possano fare buon uso.
Un’idea del campo intellettuale
Seguendo la defi nizione di Charles Camic e Neil Gross, intendo per intellettuali coloro che «sono relativamente specializzati nel-la produzione di idee scientifi che, interpretative, morali, politiche o estetiche»7. Sebbene sia sociologicamente impossibile che una
6 Camic ha elaborato la nozione di “nuovo internalismo sociologico” (new so-ciological internalism) in riferimento ai lavori di Randall Collins e Andrew Abbott. Vedi “Bourdieu’s Two Sociologies of Knowledge”, in P. Gorski (ed.), Bourdieu and Historical Analysis, Duke University Press, Durham-London, 2013.
7 C. Camic e N. Gross, The New Sociology of Ideas, cit., p. 237.
11
collettività o un ceto sociale riescano a monopolizzare i processi di creazione e diffusione delle idee, la defi nizione include innanzitutto scienziati e artisti, critici e scholar8, ideologi e scrittori. Creando oggetti culturali – concetti, fatti scientifi ci, teorie, paradigmi, pro-grammi di ricerca, metodi, romanzi, fi lm, stili di recitazione, dipinti, sculture, canzoni o poesie – che vorrebbero convincenti e deconte-stualizzati, cioè capaci di circolare al di là delle condizioni immedia-te della loro produzione, gli intellettuali ambiscono a dare una forma al mondo – aspirano a chiarire come stanno, e come dovrebbero sta-re, le cose9.
Possiamo chiamare campo intellettuale la sfera sociale – diver-samente differenziata e articolata nelle diverse formazioni storico-sociali – in cui avviene la produzione, circolazione e discussione delle idee. Prendere le mosse dal concetto di campo signifi ca pen-sare gli intellettuali come attori che occupano posizioni intrinseca-mente relazionali. In altre parole, per comprendere cosa sta facendo un intellettuale nel momento in cui propone un oggetto culturale è necessario situarlo nello spazio delle posizioni oggettive occupa-te da altri intellettuali: «Le posizioni espresse in un dato contesto sono a tal punto defi nite per relazione che possiamo caratterizzarle adeguatamente solo per riferimento alla loro opposizione o comple-mentarietà reciproca»10. Più dei concetti relazionali di “fi gurazione” o “mondo”, la nozione di campo richiama l’attenzione sul caratte-
8 In italiano le parole che traducono “scholar” – studioso, colto, erudito, istruito – faticano a restituire il complesso di significati intessuti nella parola inglese, quindi userò quest’ultima.
9 La definizione è una sintesi delle definizioni di Bourdieu (The intellectual field: a world apart, in Id., In Other Words, Stanford University Press, Stanford, 1990, p. 146) e Collins (Sociologia, Zanichelli, Bologna, 1980, ultimo capitolo, e The Sociology of Philosophies, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA, 1998, p. 19).
10 Fritz Ringer, The Intellectual Field, Intellectual History, and the Sociology of Knowledge, in «Theory & Society», 19, 1990, p. 270. Un esempio a contrario è l’arte naïf che, esterna al campo artistico, non ne comprende le forme né la storia: vedi H.S. Becker, I mondi dell’arte, Il Mulino, Bologna, 2004, capitolo 8. Vedi anche P. Bourdieu, Risposte, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, p. 60.
12
re intrinsecamente competitivo dei rapporti tra gli attori sociali11. Il campo intellettuale è infatti defi nito tanto dalla mappatura delle posizioni quanto dai processi di allocazione dello specifi co capitale a cui puntano, e di cui si servono, gli attori nell’ambito della “rivalità strutturata” che li oppone legandoli.
Possiamo defi nire il capitale intellettuale come un nesso di atten-zione e reputazione: le posizioni del campo intellettuale si defi nisco-no per la dotazione di specifi che forme di infl uenza – essere ascoltati, convincere senza argomentare, trasformare idee in scatole nere – che possono essere investite nel perseguimento di profi tti “interni” – at-tenzione, infl uenza e reputazione – o “esterni” – capitale economico, politico, educativo. Per ragioni metodologiche, la nuova sociologia delle idee tende a presupporre, spesso con qualche forzatura, che i campi intellettuali funzionino come spazi d’azione autonomi, in cui la competizione riguarda risorse che altrove non circolano: «Nelle competizioni tra fi losofi », scrive Collins, «si può conquistare l’at-tenzione degli altri solo grazie a risorse specifi camente intellettua-li, cioè risorse sociali specifi che delle reti intellettuali»12. In realtà, le condizioni materiali e organizzative del lavoro intellettuale, così come il gioco reciproco delle transazioni dei capitali esterni e interni, dipendono dalla condizione di autonomizzazione e differenziazione del campo intellettuale dalle altre sfere sociali, un problema storico e non teorico o astratto.
Data la natura relazionale del campo della produzione culturale, le idee prodotte al suo interno sono sempre interpretabili come prese di posizione – rifl essi di relazioni, somiglianze, allontanamenti a loro volta leggibili come attacchi, difese o rinunce – anche a prescindere dall’intenzionalità degli attori. Il gioco del posizionamento è con-
11 Mi riferisco ovviamente a Norbert Elias e Howard Becker. Il linguaggio delle “comunità” (scientifica, artistica, letteraria) era invece tipico della sociologia struttural-funzionalista. Vedi H.S. Becker e A. Pessin, A Dialogue on the Ideas of World and Field, in «Sociological Forum», 21, 2006, pp. 275-286; P. Baulle et al., Elias and Bourdieu, in «Journal of Classical Sociology», 12, 2012, pp. 69-93.
12 R. Collins, The Sociology of Philosophies, cit., p. 13.
13
sentito dall’esistenza di un ordine simbolico di distinzioni, categorie e signifi cati articolato in generi, correnti di pensiero, tradizioni di ricerca e stili artistico-intellettuali13. Il processo di categorizzazione, necessario per ridurre la complessità del campo, tipizza gli oggetti culturali con atti di identifi cazione che li situano all’intersezione tra opposizioni e confi ni simbolici pre-strutturati. Ecco un buon esem-pio di posizionamento:
Il trio britannico Muse è tanto punk quanto prog rock […] Il loro debutto, Showbiz, raggiunge la maestosa agonia di un Thom Yorke […], ma con un piglio più vezzoso e straccione.
Lo stesso accade nella recensione di Anarchy, State, and Utopia di Brian Barry:
Politicamente il libro non fa che portare il meschino senso comune dell’America profonda alle sue logiche conseguenze […] Se avete amato [il senatore Barry] Goldwater amerete Nozick […] Nozick è il Gerald Ford dei colti o, se preferite, il John Rawls dei ricchi (visto che difficilmente potrebbe essere il John Rawls dei poveri)14.
Al di là della funzione cognitiva, l’ordine simbolico consen-te l’attivarsi di pratiche valutative che producono e riproducono il campo come spazio stratifi cato di oggetti e produttori15. Il giudizio sull’oggetto culturale combina due atti logicamente indipendenti. In
13 Riprendo per tutto il paragrafo senza citarli volta per volta P. Baert, Positioning Theory and Intellectual Interventions, in «Journal for the Theory of Social Behaviour», 42, 2012, pp. 304-324; P. Di Maggio, Organizzare la cultura, Il Mulino, Bologna, 2009; E. Zerubavel, Social Mindscapes, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1997; M. Lamont e V. Molnar, The Study of Boundaries in Social Science, in «Annual Review of Sociology», 28, 2002, pp. 167-195.
14 Vedi N. Chonin, Review: Muse, Showbiz, in «Rolling Stone», 14 ottobre 1999; B. Barry, Review of Anarchy, State, and Utopia, in «Political Theory», 3, 1975, pp. 331-336.
15 H.S. Becker, I mondi dell’arte, cit., p. 376.
14
prima battuta, i generi, le scuole e i movimenti intellettuali sono già stratifi cati, così che una idea acquisisce lo status della regione del campo a cui viene assegnata. Situare un oggetto ambiguo come la Low Symphony, per esempio, richiede particolare attenzione:
Esatto, Philip Glass ha costruito la sua nuova sinfonia su alcuni temi tratti dall’album di David Bowie del 1977, Low, ma ciò non signifi-ca che il suo nuovo lavoro sia rock & roll16.
Ogni oggetto culturale ha inoltre un impatto individuale: eser-cita cioè un’infl uenza sul campo e la sua struttura, spinge alla cre-azione di nuovi oggetti culturali – come imitazioni, elaborazioni, estensioni o critiche – e contribuisce a tracciare, ridefi nire o can-cellare distinzioni. Al vertice della gerarchia delle idee si trovano le pietre miliari da cui dipende la leggibilità stessa di una porzione del campo o il tracciato di un confi ne simbolico17. Si pensi, giusto per citare alcuni oggetti culturali che hanno assunto una posizione di preminenza all’interno dei propri campi, alla teoria generale della relatività, Madame Bovary, il metodo Stanislawskij, la conscience collective, il dogma centrale della biologia molecolare, Les demoi-selles d’Avignon, Philosophische Untersuchungen, Fallingwater o Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band. La storiografi a delle idee più eminenti diventa a sua volta un oggetto culturale, poiché tutto ciò che le riguarda diventa necessario per comprendere anche il campo o la porzione del campo che hanno contribuito a delimitare. Ecco come Lawrence Scaff comincia la storia della ricezione di un libro assai noto:
16 G. Sandow, Review: Philip Glass, Low Symphony, in «Entertainment Weekly», 147, 4 dicembre 1992.
17 P. Bourdieu, The Field of Cultural Production, or: The Economic World Reversed, in «Poetics», 12, 1983, pp. 338-339; R. Collins, On the Acrimoniousness of Intellectual Disputes, in «Common Knowledge», 8, 2002, p. 51; R. Collins, Interaction Ritual Chains, Princeton University Press, Princeton, 2004, p. 357; H.S. Becker, I mondi dell’arte, cit., p. 384.
15
Tra tutti i testi di Max Weber, ce n’è uno dotato di un significa-to particolare come espressione della sua originalità e come base della sua reputazione: Die protestantische Ethik und der Geist der Kapitalismus […] La versione di Parsons ha regnato come auto-rità incontrastata sul mondo anglofono per settantadue anni. Solo la pubblicazione della nuova traduzione di Peter Baehr e Gordon Wells, basata sui saggi originali di Weber pubblicati nel 1904-1905 sull’Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik ha mutato la si-tuazione18.
La complessa citazione parla tanto della storia (e della trasfi gu-razione) di un oggetto culturale quanto del processo di tipizzazione che oggettivizza i creatori degli oggetti culturali. Anche gli intellet-tuali sono infatti sottoposti a una dinamica simile, che nel loro caso funziona come costruzione di una storia reputazionale19. La defi ni-zione pubblica di un intellettuale comincia a prendere forma quando le sue creazioni vengono confrontate e messe in relazione tra loro. Dal punto di vista valutativo che accompagna la defi nizione senza mai coincidere perfettamente con essa, la rilevanza di un intellettua-le come rappresentante, o meglio sarebbe dire incarnazione, di un genere, di uno stile o di una scuola di pensiero si costituisce nel tem-po: è solo quando il creatore di oggetti culturali è riuscito a mante-nersi visibile per un certo periodo e il suo lavoro è stato riconosciuto come degno di attenzione che il suo nome comincia ad assumere un signifi cato. All’inizio della sua carriera Jackson Pollock era diffi cil-mente categorizzabile, e ciò si ripercuoteva sulla circolazione delle sue opere; il sostegno di un gruppo di ricchi estimatori gli assicurò l’agio di coltivare la sua arte fi no a quando non emerse un voca-bolario critico – action painting e impressionismo astratto – adatto
18 L.A. Scaff, Max Weber in America, Princeton University Press, Princeton, 2011, p. 211.
19 Contro Becker (I mondi dell’arte, cit., p. 376) uso la parola “reputazione” solo per gli attori sociali, in quanto, come ha ben sottolineato Antonio Mutti (Reputazione, in «Rassegna italiana di sociologia», 48, 2007), la reputazione presuppone reiterazione.
16
a descriverla20. In breve, i processi con cui gli oggetti culturali si diffondono, con cui le diverse creazioni di un autore vengono cata-logate e situate, con cui i vari pubblici familiarizzano con un nome o un’etichetta, con cui tutti questi elementi vengono messi relazione al fi ne di costituire un giudizio complessivo – il quale, di rimando, può confermare o modifi care confi ni, vocabolari e identifi cazioni ca-tegoriali – sono centrali per la defi nizione e la categorizzazione degli intellettuali come creatori di cultura.
La categorizzazione delle idee e dei loro autori, così come la de-fi nizione del loro valore, è un processo interattivo a cui partecipano intellettuali, pubblici e oggetti materiali e culturali. Seguendo Bour-dieu e Gary A. Fine possiamo distinguere analiticamente tre tipi di pubblico: gli altri produttori, gli imprenditori reputazionali e il pub-blico dei non specialisti, a sua volta distinto in gruppi e segmenti21. Il processo funziona in modi diversi nei diversi ambiti del campo della produzione culturale per via delle diverse relazioni che lega-no produttori e consumatori di oggetti culturali. Nei campi caratte-rizzati da forte autonomia, come la fi sica quantistica o la fi losofi a analitica, le posizioni di produttore, consumatore e critico tendono a essere ricoperte dai medesimi individui empirici e l’impatto del pubblico non specialistico è limitato. Nei campi più aperti e porosi le varie posizioni vengono ricoperte da individui diversi, organizzati in collettività più o meno coese e orientate da sottoculture partico-lari. I pubblici gestiscono in relativa autonomia processi paralleli di attribuzione della reputazione che allocano diverse forme di capitale simbolico e costituiscono, a loro volta, una forma di competizione. Nel campo della produzione musicale, per esempio, i critici eserci-tano una forte infl uenza sulla defi nizione delle opere e degli artisti,
20 M. Mulkay ed E. Chaplin, Aesthetics and Artistic Career: A Study of Anomie in Fine-Art Painting, in «The Sociological Quarterly», 23, 1982, pp. 117-138.
21 P. Bourdieu, The Field of Cultural Production, cit., p. 313; G.E. Lang e K. Lang, Etched in Memory, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1990; G.A. Fine, Difficult Reputations, The University of Chicago Press, Chicago-London, 2001; A. Cossu, It Ain’t me Babe, Paradigm, Boulder, 2012.
17
fungendo da imprenditori reputazionali e stimolando la reazione dei produttori – il caso più eclatante è forse quello di Jon Landau, il cri-tico passato dall’altra parte della barricata come produttore e braccio destro di Bruce Springsteen22.
Habitus e agency dell’intellettuale
La sociologia delle idee più radicale attribuisce ai processi di po-sizionamento e categorizzazione che hanno luogo nel campo intel-lettuale una centralità epistemica tale da rendere inutile lo studio dell’intenzionalità degli attori. In Bourdieu il legame tra posizioni e prese di posizione appare spesso pre-determinato mentre Collins invita «a guardare attraverso le personalità» poiché è «la struttura interna delle reti intellettuali che dà forma alle idee»23. Nella sua teoria del posizionamento – una versione estrema della teoria del campo – Patrick Baert24 ha scritto che «la soluzione [metodologica] sta nell’abbandonare del tutto il vocabolario delle intenzioni per un vocabolario degli effetti». Teorizzando una “sociologia degli inter-venti” ispirata a Bourdieu e agli studi di Harry M. Collins sull’ex-pertise, Gil Eyal e Larissa Buchholz hanno sostenuto che non solo le personalità ma anche le caratteristiche sociologiche degli attori – i “ruoli” dei tempi che furono – vanno subordinate alle forme, agli al-lineamenti e agli assemblaggi che compongono la rete25. Dalla mol-tiplicazione di discorsi, strategie e arene in cui avviene la produzione di oggetti culturali emergerebbe infatti una generale redistribuzione
22 Vedi, tra i molti studi: R. von Appen e A. Doehring, Nevermind the Beatles, Here’s Exile 61 and Nico, e M.R. Watson e N. Anand, Award Ceremony as an Arbiter of Commerce and Canon in the Popular Music Industry, entrambi in «Popular Music», 25, 2006; M. Santoro, Effetto Tenco, Il Mulino, Bologna, 2010. Su Landau e Springsteen vedi D. Remnick, We are alive, in «The New Yorker», 30 luglio 2012.
23 R. Collins, The Sociology of Philosophies, cit., pp. 2-4.24 P. Baert, Intellectual Positioning and Intellectual Interventions, cit., p. 318.25 Vedi G. Eyal e L. Buchholz, From the Sociology of Intellectuals to the Sociology
of Interventions, in «Annual Review of Sociology», 36, 2010, pp. 117-137.
18
della facoltà di nominare il mondo, da specifi ci attori-in-posizione a network compositi e imprevedibili. In realtà, il superamento del pro-blema del ruolo dell’intellettuale26 riconfi gura il problema dell’agen-cy nei termini di una teoria delle pratiche. Bourdieu ha elaborato una versione di tale teoria nel concetto di habitus27, che prenderò come punto di partenza per una rapida ricognizione sull’agency degli in-tellettuali.
Possiamo pensare l’habitus intellettuale come il complesso delle disposizioni necessarie per agire all’interno del campo intellettuale – produrre idee e oggetti culturali, comprendere le dinamiche di al-locazione del capitale di attenzione e reputazione, affrontare la com-petizione che ha luogo al suo interno. L’editor che sostiene la “sua” rivista coltivando un’ampia rete di autori e fi nanziatori, il coreografo che crea un balletto in cui si fondono il suo stile personale, i punti di forza del primo ballerino e la tradizione della compagnia di danza, il fi losofo che scrivendo anticipa le possibili obiezioni al proprio argo-mento, il traduttore capace di rendere i signifi cati più complessi al di là di qualsivoglia norma grammaticale sono tutti portatori di habitus intellettuale ben formato, diverso a seconda della regione del campo in cui i singoli intellettuali si trovano ad agire28. Secondo una teoria disposizionale fondata sul concetto di pratica, l’habitus intellettuale si costituisce come una sorta di “matrice astratta, non contestuale e
26 Vedi per esempio i saggi in P. Rieff (ed.), On Intellectuals, Doubleday & Co., Garden City, 1969.
27 Riprendo qui in forma abbreviata alcuni degli spunti presentati con il titolo L’habitus e il suo individuo al workshop “Teorie in campo”, Università di Bologna, 22 febbraio 2013. Vedi C. Camic, The Matter of Habit, in «American Journal of Sociology», 91, 1986, pp. 1039-1087.
28 Vedi, a mo’ di esempio: S.P. Wainwright et al., Varieties of habitus and the em-bodiment of ballet, in «Qualitative Research», 6, 2006, pp. 535-558; M. Philpotts, The Role of the Periodical Editor, in «The Modern Language Review», 107, 2012, pp. 39-64; M. Watkins, Discipline, Consciousness and the Formation of a Scholarly Habitus, in «Continuum», 19, 2005, pp. 545-557; R.R. Faulkner e H.S. Becker, “Do you Know…?” The Jazz Repertoire in Action, The University of Chicago Press, Chicago-London, 2009; M. Santoro, Come si diventa scrittori, in «Polis», 17, 2003, pp. 453-481.
19
trasponibile”29 dell’azione che emerge dal consolidamento e dalla naturalizzazione di modi di fare appresi entro situazioni concrete – sperimentando in laboratorio, interagendo con registi e sceneggiato-ri, rispondendo alle domande dei discussant durante un seminario.
Chi possiede il giusto habitus è in grado di improvvisare corsi d’azione adeguati alla situazione utilizzando accortamente la rete delle distinzioni simboliche del campo come struttura percettiva di classifi cazione. Il naso per l’argomento che tira ovvero per l’editore, il gallerista o l’artista giusto dipende “senza alcuna necessità di un calcolo cinico”30 dalla capacità di cogliere e interpretare le posizio-ni, di leggere la gerarchia di pubblici e produttori, di fi gurarsi una mappa dettagliata e realistica del mondo in cui si opera – tutte facol-tà stratifi cate e legate sia alla dotazione di capitale culturale dell’at-tore sia all’energia emotiva che egli è in grado di investire nella sua pratica31. Mentre improvvisa con naturalezza un assolo, il pianista sa che ai partecipanti alla jam session non sfuggono gli accenni agli stili di Art Tatum, Bill Evans ed Herbie Hancock – e sa che la propria reputazione dipende, almeno in parte, dalla capacità di suggerire fra-seggi e stilemi senza riprodurli troppo banalmente.
Bourdieu defi nisce illusio il terzo elemento dell’habitus – l’inti-ma convinzione circa il valore di uno specifi co capitale e la rilevanza della propria partecipazione ai confronti che hanno luogo nel campo. L’illusio è la condizione di chi è preso da un gioco sociale e vuole parteciparvi pienamente. È costituita da due dimensioni inestricabil-mente legate, inclinazione a giocare e senso del gioco: «L’abilità di differenziare – il “gusto” – distingue chi, essendo capace di differen-
29 O. Lizardo, The Cognitive Origins of Bourdieu’s Habitus, in «Journal for the Theory of Social Behaviour», 34, 2004, p. 392.
30 P. Bourdieu, The Field of Cultural Production, cit., p. 95.31 Sulla relazione tra habitus e capitale culturale vedi almeno S. Lash, Pierre
Bourdieu: Cultural Economy and Social Change, in C. Calhoun et al. (eds.), Bourdieu: Critical Perspectives, Polity Press, Cambridge, 1993, pp. 193-211. Sull’energia emoti-va il testo di riferimento è R. Collins, Interaction Ritual Chains, cit.
20
ziare, non è indifferente»32. Gli studenti di sociologia che al bar si scannano su Luhmann e Habermas appaiono agli altri clienti simili a tifosi di calcio – e in un certo senso lo sono, perchè come accade per gli ultras del Palermo o del Cosenza, per chi vive di sociologia la contrapposizione tra teoria dei sistemi e teoria dell’agire comuni-cativo è qualcosa di terribilmente serio. Chi non è preda dell’illusio rimane invece indifferente: non vede l’urgenza del gioco, non coglie la rilevanza della posta, non è in grado di leggere le raffi nate distin-zioni tra le posizioni. E infatti, come ha scritto Marco Santoro, senza illusio «non ci sarebbero ragioni di agire, non ci sarebbero confl itti, non ci sarebbero coinvolgimenti né investimenti, non ci sarebbero quei microcosmi di vita collettiva che costituiscono dinamicamente la “società”»33.
Se Bourdieu ha gettato le basi di una teoria disposizionale dell’azione, è anche vero che nella sua opera la compattezza e la coerenza dell’habitus tendono a essere date per scontate. Al con-trario, l’eterogeneità delle traiettorie individuali, intese come storie dei transiti tra situazioni e campi diversi, rende necessario smontare e rimontare empiricamente la presunta coerenza dell’habitus, pren-dendo coscienza del fatto che, soprattutto quando parliamo di socie-tà moderne e contemporanee, gli attori posseggono «stock di sche-mi di azione o abitudini che sono non-omogenei, non-unifi cati e di conseguenza […] pratiche eterogenee (o addirittura contraddittorie), che variano a seconda del contesto sociale in cui si sviluppano»34. In una serie di ricerche empiriche approfondite, Bernard Lahire ha mostrato come le disposizioni si stratifi chino in antiche e recenti, superfi ciali e profonde, disponibili, attive o latenti, e, soprattutto, in disposizioni “ad agire” e disposizioni “a credere”35. Oltre che di
32 P. Bourdieu, The Peculiar History of Scientific Reason, in «Sociological Forum», 6, 1991, p. 8.
33 M. Santoro, L’onere della sociologia, in «Rassegna italiana di sociologia», 54, 2013.
34 B. Lahire, The Plural Actor, Polity Press, Cambridge, 2011, p. 26.35 Ivi, p. 32 e pp. 56 e ss.
21
pratiche sedimentate in agency, infatti, le traiettorie individuali sono fatte di convinzioni ideali, politiche e religiose, immagini morali e caratteriali. Si tratta di disposizioni che si attuano in processi di de-fi nizione e ridefi nizione rifl essiva dell’identità personale36 e che non si lasciano ridurre, né diacronicamente né sincronicamente, alla po-sizione occupata dall’attore in un campo.
I modelli dell’intellettuale in campo basati sull’habitus vanno al-lora ridisegnati e completati con una teoria del concetto di sé intel-lettuale (intellectual self-concept) – inteso come «comprensione che gli attori hanno di sé in quanto esseri umani caratterizzati da storie e identità uniche»37. Gli intellettuali
raccontano storie a proposito di sé e degli altri, storie che dicono chi sono in quanto intellettuali. Sono dunque fortemente motivati a impegnarsi in progetti intellettuali che li aiuteranno, tra le altre cose, a esprimere e a mettere insieme i disparati elementi di queste storie. Ceteris paribus, si orienteranno verso idee che rendono possibile tale tipo di sintesi38.
L’aspetto più interessante del recupero del tema dell’identità all’interno della nuova sociologia delle idee è l’intuizione sugli stru-menti che l’intellettuale utilizza per costruire le storie che formano il concetto che ha di sé. Neil Gross parla infatti di “storie tipologi-che”: gli attori raccontano a sé e agli altri narrazioni costruite con i materiali – le distinzioni, i confi ni, le tassonomie – che costituiscono l’ordine simbolico del campo39. L’autoposizionamento comprende inoltre la topologia degli atteggiamenti nei confronti di altri intel-
36 Vedi anche M.S. Archer (ed.), Conversations About Reflexivity, Routledge, London-New York, 2010.
37 N. Gross, Richard Rorty, The University of Chicago Press, Chicago-London, 2008, pp. 12-13 e p. 261.
38 Ivi, p. 272.39 S. Frickel e N. Gross, A General Theory of Scientific/Intellectual Movements, in
«American Sociological Review», 70, 2005, p. 222.
22
lettuali, comprese le relazioni immaginate con scuole o tradizioni di pensiero di lunga o lunghissima durata che sono tipiche degli intel-lettuali40 – dirsi “durkheimiano” o “weberiano” è cruciale per l’au-todefi nizione di un sociologo quanto fare i conti con lo stile di Scott LaFaro o Jaco Pastorius lo è per l’autodefi nizione di un bassista. Le narrazioni autobiografi che comprendono infi ne un’idea generale di cosa signifi ca essere e fare l’intellettuale che rimandano a dimensio-ni identitarie più astratte.
L’habitus intellettuale contiene dunque le immagini stratifi cate, complesse e spesso incoerenti che l’attore ha di sé – come Richard Rorty, soggetto alla tensione tra la posizione di star della fi losofi a analitica e una profonda identifi cazione, non limitata all’aspetto professionale, con il pragmatismo americano41. Distinguere dispo-sizioni a credere e disposizioni ad agire aiuta a descrivere e spie-gare l’illusione, la frustrazione o il senso di colpa – i casi cioè in cui credenze e capacità non sono allineate o in cui gli attori hanno incorporato «delle credenze senza avere i mezzi (materiali e/o atti-tudinali) per rispettarle, per concretizzarle, per raggiungerle o per realizzarle»42. Abbiamo dunque bisogno di una sociologia delle idee “di scala individuale”, l’espressione è di Lahire, che sia capace di spiegare fenomeni sociali e vicende personali dando conto dell’equi-librio tra la generalità intessuta nell’individuo e la sua singolarità di attore sociale.
Località, abitudini e oggetti culturali
In sintesi, l’idea è che campo e habitus siano entrambi necessari per comprendere la creazione, la circolazione e la trasformazione delle idee: posizionamenti e complessi disposizionali concorrono a
40 R. Collins, The Sociology of Philosophies, cit., p. 27.41 N. Gross, Richard Rorty, cit., passim.42 B. Lahire, Per una sociologia di scala individuale, in «Sociologia e politiche
sociali», 7, 2004, p. 57.
23
spiegare non solo il comportamento degli intellettuali, ma anche la condivisione di modelli d’azione e aspettative, le specifi che fi gu-razioni sociali-storiche che emergono dalle pratiche e si produco-no attraverso la riproduzione di queste ultime, nonché la rigidità, la resilienza o la malleabilità delle strutture a fronte delle inevitabili variazioni che introducono contingenza negli assetti istituzionali. Il fi ne è, da una parte, comprendere lo strutturarsi dell’habitus del singolo intellettuale come insieme stratifi cato di disposizioni a cre-dere e ad agire, e, dall’altra, vedere come l’attore individuale, una volta “in campo”, agisca e reagisca alle situazioni locali e situate in maniera più o meno stereotipata. Ciò è possibile solo prendendo le vicende di un intellettuale, o al massimo di uno specifi co gruppo di individui, come una sorta di lente attraverso la quale leggere e rileg-gere processi strutturali e storici di breve e medio periodo43.
Il punto di osservazione che ho scelto è la fi gura di Robert Neelly Bellah, sociologo e intellettuale pubblico americano nato nel 1927 e noto per i suoi lavori sulla religione civile, il Giappone e la cultura delle classi medie. Il suo ultimo libro, Religion in Human Evolution, pubblicato nel 2011, è un’opera imponente per scopo ed erudizione, il coronamento di una lunga carriera intellettuale e accademica44. Bellah è un caso interessante per la sociologia delle idee da molti punti di vista: allievo di Talcott Parsons, professore ad Harvard e, dal 1967 al 1997, a Berkeley, è oggi un intellettuale assai noto anche
43 Una concezione complessa e stratificata dell’habitus intellettuale può anche contribuire alla comprensione del processo di intellettualizzazione dei pubblici di cui parlano Eyal e Buchholz: la disponibilità di capitale culturale oggettivato e la moltipli-cazione delle tecniche e dei luoghi di comunicazione e partecipazione si rivelerebbero inutili se non si accompagnassero all’acquisizione, da parte dei “non specialisti”, di alcune delle disposizioni che un tempo distinguevano gli intellettuali di professione. Vedi due esempi assai diversi: R. Florida, L’ascesa della classe creativa, Mondadori, Milano, 2003; L. Pellizzoni, Conflitti ambientali, Il Mulino, Bologna, 2011.
44 Vedi R.N. Bellah, Religion in Human Evolution, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA, 2011. Sul volume si veda il dibattito ospitato dal sito The Immanent Frame all’url: http://blogs.ssrc.org/tif/bellah/. I saggi che seguono sono stati pensati e scritti come materiali per un volume dal titolo provvisorio Beyond Borders. A Sociology of Robert N. Bellah.
24
al di fuori del campo accademico, autore di uno dei libri più venduti e dibattuti – Habits of the Heart –, nonché di uno degli articoli più citati, e forse malcompresi, – “Civil Religion in America” – della storia della sociologia americana45. Al tempo stesso, la sua infl uenza in diversi campi scientifi ci e umanistici – oltre alla sociologia, gli studi orientali e americani, nonché la teologia e gli studi religiosi, – non raggiunge certo quella di Jürgen Habermas, Charles Taylor o Clifford Geertz – giusto per citare tre studiosi con cui Bellah ha in-trattenuto lunghe relazioni di amicizia e collaborazione. Questa po-sizione trasversale, centrale ma non “stellare”46, unita alla ricchezza e alla complessità delle vicende personali e alla disponibilità di una gran mole di rifl essioni autobiografi che edite e inedite, fa di Bellah un oggetto di studio perfetto per una sociologia delle idee che am-bisce a cogliere sia l’individualità degli eventi e degli attori sia la loro tipicità all’interno di una sistemazione sociologica di forme e categorie.
Non potendo ripercorrere i tre studi di caso, cercherò di fornire una chiave di lettura complessiva partendo dall’individuo e dal pro-cesso di strutturazione delle sue disposizioni a credere e ad agire. Come qualunque attore sociale, Bellah si forma all’interno di una specifi ca regione del campo intellettuale, e in particolare all’interno di una scuola di pensiero dotata di leader, dimensioni organizzative e schemi concettuali condivisi. Studente e dottorando al Department of Social Relations di Harvard nel decennio 1945-1955, Bellah entra nel campo sociologico sotto l’ala di Talcott Parsons, fi gura centrale della sociologia postbellica e instancabile animatore di una serie di movimenti fi nalizzati al consolidamento e alla professionalizzazione delle behavioral sciences. La socializzazione disciplinare e profes-sionale di Bellah avviene dunque nel contesto di una particolare co-stellazione epistemica e teorica – concezione interdisciplinare della
45 Edizioni italiane di entrambi i testi sono state pubblicate da Armando nei volumi Le abitudini del cuore (1996) e La religione civile in Italia e in America (2009).
46 R. Collins, The Sociology of Philosophies, cit., pp. 42 e ss.
25
ricerca sociale, funzionalismo, teoria della modernizzazione, area studies – che infl uisce profondamente sul rafforzamento di alcune disposizioni di fondo e sul costituirsi di un habitus intellettuale in cui idee e pratiche del lavoro intellettuale, dell’essere un accademico e delle scienze umane e sociali si intrecciano senza soluzione di con-tinuità con idee politiche e religiose relativamente mutevoli47.
Al cuore del complesso disposizionale sviluppato da Bellah nella sua relazione con Parsons e altri maestri – tra cui Paul Tillich, Edwin O. Reischauer e Wilfred Cantwell Smith – sta quello che, in man-canza di espressioni migliori48, chiamerò habitus “dello studioso” (scholarly habit): una sintesi tra la capacità di creare, manipolare e presentare idee idonee ad attirare l’attenzione di pubblici eterogenei per orientamento, expertise e disponibilità al confronto; la spinta ad accrescere costantemente il proprio capitale culturale e la discipli-na necessaria per farlo; la propensione a discutere pubblicamente le proprie idee; la disponibilità a tornare sulle proprie posizioni nel caso le critiche colgano nel segno. Si tratta di una costellazione di di-sposizioni astratte e rifl essive che non è legata a particolari orienta-menti teorici, metodologici o ideali – come tratto di base, in altre pa-role, essa trascende sia le appartenenze di scuola sia quelle politiche, religiose o civili. Accoppiate a una forte identifi cazione con Parsons – il quale, dal canto suo, proietta sull’allievo altissime aspettative – le disposizioni a pensarsi, e ad agire, come uno scholar destinato all’eccellenza intellettuale costituiscono la leva principale di Bellah come “intellettuale in campo”, cioè come attore sociale che agisce, e reagisce, nel contesto di confi gurazioni via via differenti di relazioni, gruppi, reti e strutture simboliche. Ciò è evidente in almeno due mo-menti della vicenda di Bellah: nel modo in cui il sociologo america-no vive e affronta il “dilemma dell’allievo dotato” (primo capitolo)
47 Sebbene nel testo si trovino pochi accenni alle sue vicende personali, durante il suo primo decennio harvardiano Bellah si iscrive al Partito comunista e ne viene espulso, perde e ritrova la fede cristiana, viene costretto dal Maccartismo a riparare in Canada e si interessa a diversi oggetti di studio.
48 Vedi nota 8.
26
e nel suo modo di porsi all’interno del dibattito sulla religione civile americana (secondo capitolo). Vediamoli brevemente.
La logica del campo intellettuale come luogo della competizione per l’attenzione porta gli attori a sperimentare, prima o poi, una par-ticolare alternativa: seguire le orme del proprio mentore o sforzarsi per creare una posizione originale, dalla quale sviluppare una voce autonoma? Secondo Randall Collins il posizionamento del maestro e dell’allievo all’interno del campo determina non solo il modo, e l’intensità, in cui il secondo sperimenta il dilemma, ma anche la ra-dicalità della rottura che gli è necessaria per ricavare una posizio-ne originale: i migliori studenti dei migliori maestri sono quelli che vivono più acutamente la frustrazione di trovarsi in una posizione secondaria e quelli che hanno più da guadagnare da una rottura forte ed esplicita con il mentore, avendone ereditato, almeno in parte, il capitale culturale e simbolico.
Intorno ai quarant’anni Bellah è spinto dalla logica del campo ad autonomizzarsi rispetto a Parsons e all’intero milieu intellettua-le e organizzativo in cui ha mosso i suoi primi passi di sociologo. Durante il suo secondo decennio harvardiano (1957-1967) Bel-lah occupa una posizione invidiabile – professore associato e poi ordinario, fi gura di spicco del funzionalismo e degli area studies sull’Estremo Oriente. Dopo il 1967 tutto cambia: temi (dal Giap-pone all’America), stili (dalla sociologia parsonsiana a un discorso umanistico di ampio respiro), luoghi (da Harvard a Berkeley). Al contrario di quanto previsto da Collins, però, non troviamo espliciti atti di rottura nei confronti di Parsons, quanto piuttosto un lento ma irresistibile allontanamento. L’idea è che la concezione di sé come scholar destinato all’eccellenza intellettuale e la forte iden-tifi cazione di Bellah con Parsons su cui essa si è costruita siano il tratto disposizionale più profondo e duraturo che impedisce a Bel-lah di contrapporsi esplicitamente al suo vecchio maestro, il tratto che mette in secondo piano le necessità della logica del campo in favore di un formale mantenimento della continuità – ripetutamente
27
di/mostrata in pubblico e in privato – e di una modifi cazione degli strati più superfi ciali del complesso disposizionale, quelli legati ad appartenenze di paradigma e scuola di pensiero, che non intacca gli strati più profondi e duraturi del suo concetto di sé e delle sue capa-cità pratico-intellettuali.
La persistenza del nucleo profondo dello scholarly habit spiega, almeno in parte, il comportamento di Bellah durante il dibattito sulla religione civile. Come racconto nel secondo capitolo, Bellah debut-ta nel campo degli studi americani quasi per caso, grazie all’inatteso successo di un saggio scritto obtorto collo su richiesta di Parsons. Il dibattito sulla religione civile può essere pensato come una sorta di rete discorsiva complessa e multidisciplinare all’interno della quale circolano capitali culturali e simbolici diversi da quelli posseduti da Bellah – questo anche per sottolineare come cambiare “ogget-to, stile e luogo” non sia un’operazione indolore e automatica, ma una decisione che necessita, prima o poi, di uno sforzo di ridefi -nizione e adeguamento il cui esito non è scontato. Bellah si trova privo di autorevolezza e di expertise; è la comprensione che ha di sé come scholar di eccellenza che lo porta ad ampliare a dismisura il suo capitale culturale incorporato per eccellere anche nella nuo-va situazione. Date la sua formazione e la posizione che ricopre all’inizio degli anni Settanta, la decisione di impegnarsi in lunghe ore di studio e rifl essione sul nuovo oggetto, secondo nuove regole e nuovi vocabolari, è una “scelta” perfettamente iscritta nel patri-monio disposizionale di Bellah e inconsapevolmente giustifi cata da una logica pratica. Un intellettuale con un diverso habitus di fondo avrebbe potuto agire diversamente: avrebbe potuto snobbare le ri-chieste del pubblico dei non specialisti, avrebbe potuto considerare le domande dei suoi colleghi come attacchi ad personam, avrebbe potuto decidere di abbandonare la discussione alle prime diffi col-tà (“Questo non fa per me, dopotutto mi occupo di Giappone”). Un altro intellettuale, poi, avrebbe potuto utilizzare il suo capitale extra-scientifi co per zittire gli interlocutori – una strategia spesso
28
utilizzata nei campi intellettuali nostrani con “ottimi” risultati. È il nucleo profondo del suo scholarly habit, dunque, che spiega il com-portamento di Bellah di fronte alle sollecitazioni del campo – così come spiega, almeno in parte, la sua decisione di abbandonare il di-battito, e l’espressione “religione civile”, nel momento in cui le sue idee non ottengono l’attenzione desiderata. Piuttosto che adagiarsi in una posizione comoda ma in qualche modo lontana dalle sue convinzioni, e quindi inautentica, Bellah preferisce abbandonare la discussione.
Vorrei concludere indicando tre punti metodologici che ritengo irrinunciabili. In primo luogo, se vogliamo comprendere a fondo le dinamiche della produzione, diffusione e circolazione degli oggetti culturali e dei loro creatori non possiamo fare a meno di prendere sul serio il fatto che gli ambienti e i campi sociali in cui si svolgono le pratiche intellettuali sono località complesse e plurali, situate su livelli diversi di generalità e astrazione. Negli studi di caso l’atten-zione si è concentrata soprattutto su gruppi di collaboratori (i circoli harvardiani e le relazioni tra Parsons, Bellah e Geertz), istituzioni accademiche (il Department of Social Relations e l’Institute for Ad-vanced Study), regimi di discorso fl uidi ma organizzati (il dibattito sulla religione civile americana e il movimento per la professionaliz-zazione delle scienze sociali, nonché il movimento, opposto, per la loro ri-politicizzazione), norme astratte e scarsamente tangibili circa i confi ni e la vita delle comunità scientifi che (le discipline e la libertà accademica). Ma le località e le reti in cui si addensa il campo sono molteplici, e qualunque identifi cazione dell’intellettuale con un solo campo, o la porzione di un campo, rischia di aprire più problemi di quanti ne risolve. Dopo brevi premesse, come quella contenuta in questa introduzione, è necessario abbandonare il discorso astratto, che rischia di essere vuoto o tautologico, per calarsi nelle modalità in cui le diverse regioni del campo si articolano in località caratte-rizzate da relazioni strette e coagulate intorno a particolari gruppi, pratiche, saperi impliciti – in poche parole, nelle reti in cui il campo
29
si manifesta tangibilmente49, così che qualsivoglia spiegazione ge-nerale viene, di per sé, esclusa di principio.
Ciò implica anche, secondo punto, che la ricostruzione dei cam-pi e delle traiettorie individuali sia orientata dai canoni più rigorosi della ricerca storica. Il sociologo delle idee dovrà dunque rinunciare a fonti di seconda mano, alle interpretazioni e alle distinzioni tipi-che del folklore accademico e, spesso, anche alle storie dei campi intellettuali scritte dagli appartenenti ai campi stessi – le quali vanno considerate per quello che sono: “auto-narrazioni” idiosincratiche, connotate da un certo grado di auto-celebrazione e di acredine verso gli antagonisti. Le biografi e degli attori individuali e collettivi van-no ricostruite al massimo livello di precisione e completezza storica possibile, in modo da rendere conto delle molteplici appartenenze, del trascorrere del tempo, del mutamento delle condizioni e degli attaccamenti di fondo. Proprio perché comprende la complessità dei patrimoni disposizionali, il sociologo delle idee dovrà inoltre utiliz-zare gli account autobiografi ci come punti di partenza per ulteriori verifi che. In particolare, come afferma Gross50, l’analisi di docu-menti privati – corrispondenza, appunti, minute, bozze e diari – è cruciale per distillare l’idea di sé che guida, almeno in parte, le scelte dell’intellettuale, e non può essere eliminata in favore della storia delle idee condotta su testi pubblici. Lo stesso vale per le idee: i so-ciologi della conoscenza devono prestare più attenzione al contenuto degli oggetti culturali. Come mostra il secondo capitolo, prendere in considerazione le idee può modifi care profondamente la compren-sione che abbiamo di una vicenda o di un episodio. Il sociologo deve allora rinunciare a quella pratica di categorizzazione e stereotipiz-zazione su cui si fonda il funzionamento dei campi della produzio-ne culturale, e sforzarsi di ricostruire minuziosamente il processo di creazione degli oggetti culturali, le versioni, i ripensamenti, le
49 P. Bourdieu, Risposte, cit., pp. 82-83.50 N. Gross, Richard Rorty, cit., pp. 274 e ss.
30
variazioni – senza per questo convincersi che si possa giungere a interpretazioni autentiche o defi nitive.
In terzo e ultimo luogo, quando scriviamo di persone in carne e ossa dobbiamo seguire l’avvertimento di Pierre Bourdieu e non lasciarci affascinare dai nostri soggetti umani. Ciò è necessario per sfuggire alla fallacia biografi ca51, la tentazione di raccontare le vite individuali come se fossero storie logicamente coerenti, prive di so-luzione di continuità. Bourdieu ha ragione. Le vite dei nostri sog-getti, così come le nostre, sono un caos di eventi diversi, abitudini e novità, decisioni strategiche e momenti di distrazione, possibili-tà e rimpianti. Allo stesso tempo, come ci ricorda lo stesso Bellah all’inizio di Religion in Human Evolution, gli uomini non possono non raccontare storie, e le storie si organizzano simbolicamente – la loro verità «non nasce dalla corrispondenza tra le singole parole o proposizioni e la “realtà”, ma dalla coerenza della storia presa nel suo complesso. Come una poesia non può essere parafrasata con-cettualmente senza che il suo signifi cato si perda irreparabilmente», così la narrazione deve mantenere una sua unità di fondo52. Al di là degli apparati concettuali e della prudenza scientifi ca, l’equilibrio tra spiegazioni strutturali e libertà individuale, apertura alla contin-genza e senso complessivo delle storie che raccontiamo non può che rimanere precario e provvisorio.
51 P. Bourdieu, Ragioni pratiche, Il Mulino, Bologna, 1995, pp. 71 e ss.52 R.N. Bellah, Religion in Human Evolution, cit., p. 33.
31
Avvertenza e ringraziamenti
Fatta salva l’introduzione, scritta ex novo, il volume raccoglie articoli apparsi su riviste internazionali che escono per la prima vol-ta in italiano. Pur prendendomi parecchie libertà come traduttore di me stesso, ho rispettato le versioni originali anche dove avrei voluto inserire modifi che più consistenti.
Ringrazio le riviste e le case editrici che mi hanno consentito di pubblicare le versioni italiane dei saggi che seguono. Vorrei ringra-ziare Jeffrey C. Alexander, Peter Bearman, Matteo Bianchin, René Capovin, Harry M. Collins, Paolo Costa, Stefano Crabu, Daniele De Pretto, Vanina Ferreccio, Gary A. Fine, Renée C. Fox, Marcel Fournier, Nils Gilman, Neil Gross, Donald G. Jones, Clive Kessler, Samuel Z. Klausner, Victor M. Lidz, Andrea M. Maccarini, Neil McLaughlin, Alessandro Mongili, Tatiana Motterle, Larry T. Ni-chols, Jennifer Platt, Gianfranco Poggi, Riccardo Prandini, Massimo Rosati, Giuseppe Sciortino, Edward Tiryakian, John Torpey, Isacco Turina, Aristide e Vera Zolberg e Harriet Zuckerman, e ricordare Ir-ving L. Horowitz, Carl Kaysen e Melanie Bellah. Un ringraziamento particolare va a Marco Santoro e Andrea Cossu, compagni di ricerca e amici dai quali ho avuto più di quanto non sia riuscito a dare, e a Bob Bellah, che mi ha accolto. Elisa Nutria Scalabrin e Riccardo Bortolini sono qui con me.
Dedico questo libro a Pierpaolo Donati, per tutto quello che mi ha obbligato a fare da solo.
Tra Bologna e Padova, febbraio 2013
32
Versioni originali
Capitolo primo: Before Civil Religion. On Robert N. Bellah’s Forgotten Encounters with America, 1955-1965, in «Sociologica», 4, 2010, 33 pp.
Capitolo secondo: The Trap of Intellectual Success. Robert N. Bellah, the American Civil Religion Debate, and the Sociology of Knowledge, in «Theory & Society», 41, 2012, pp. 187-210.
Capitolo terzo: The ‘Bellah Affair’ at Princeton. Scholarly Ex-cellence and Academic Freedom in America in the 1970s, in «The American Sociologist», 42, 2011, pp. 3-33.