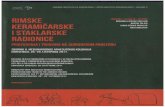La metafora morale e le questioni emergenti in bioetica. Il caso della biologia di sintesi (trad....
Transcript of La metafora morale e le questioni emergenti in bioetica. Il caso della biologia di sintesi (trad....
Quadernidella ricerca
Studi dei dottoratiin Discipline filosofiche e Storia della scienza
della Scuola di dottorato in Discipline umanistichedell’Università di Pisa
e del dottorato in Filosofia del Dipartimento di Filosofiadell’Università di Firenze
a cura diLuca Bellotti
Edizioni ETS
00pped_indice_prefaz:Layout 1 20-09-2012 9:42 Pagina 3
© Copyright 2012EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 [email protected]
DistribuzionePDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]
ISBN 978-884673377-1
Pubblicato con un contributo dai fondidel Dipartimento di Filosofia dell’Università di Pisa
www.edizioniets.com
00pped_indice_prefaz:Layout 1 20-09-2012 9:42 Pagina 4
Indice
Prefazione 7
Davide PesaresiTra Aristotele e lo scettico. Note su una ricostruzione formale dell’elenchos 9
Mariagrazia GranatellaAristotele e la retorica del persuasivo. Spunti di riflessione 27
Federico M. PetrucciTracce di teoria musicale aristotelica nell’esegesi di Teone di Smirne 53
Caterina AgostiniL’uso della metafora in Plinio il Vecchio: «si descrive la natura, in altre parole, la vita»(Plinio, Naturalis Historia, I.13) 69
Dario FerrariIn regione dissimilitudinis.La struttura delle Confessioni agostiniane alla luce della concezione dell’io 89
Andrea RabassiniMetafore e analogie nel platonismo di Marsilio Ficino 109
Angelo MarinucciOsservazioni su determinismo e prevedibilità tra Settecento e Ottocento 121
Chiara BisignanoMente, mondo, fenomenicità. Linee per un confronto tra l’intuizione concettualedi McDowell e la sintesi trascendentale kantiana 129
Leonard MazzoneIl marxismo, tra realismo e “liberalism” 155
Francesco PetruzzelliVisioni teogoniche e metafore politiche nei Dialoghi filosofici di Ernest Renan 173
Linda BertelliDall’intuizione alla figura. Il Discorso sul metodo bergsoniano 199
Marco SaracenoLa parabola dell’ergologia nell’opera di Angelo Mosso 217
Francesco LanzillottiLa nozione husserliana di formalità 239
00pped_indice_prefaz:Layout 1 20-09-2012 9:42 Pagina 5
Emanuele DettoriTra Husserl e Heidegger. Jean-Luc Marion e le trasformazioni della fenomenologia 261
Maurizio CandiottoPredicazione e necessità 275
Joseph A. RahoLa metafora morale e le questioni emergenti in bioetica.Il caso della biologia di sintesi 287
Abstracts 309
Gli autori 317
6 QUADERNI DELLA RICERCA
00pped_indice_prefaz:Layout 1 20-09-2012 9:42 Pagina 6
* Traduzione italiana a cura di Francesco Petruzzelli. Ringrazio la Professoressa Lucia Galvagni e il Pro-fessor Sergio Bartolommei per i loro preziosi suggerimenti e la loro cordiale disponibilità.
1 Childress (1997) e Childress (20033). Questo tema è riemerso più recentemente in campagne per la salu-te pubblica contro il cancro e l’AIDS.
2 Cfr. Casarett, Pickard, Fishman et al. (2010). La speranza è che la metafora possa risultare utile ai pa-zienti, consentendo loro una decisione libera e pienamente informata. Cfr. Kirklin (2007).
JOSEPH A. RAHO*
LA METAFORA MORALE E LE QUESTIONI EMERGENTIIN BIOETICA.
IL CASO DELLA BIOLOGIA DI SINTESI
Quando di un dolore dico che è «lancinante», di una decisioneche è «irremovibile» o di un pensiero che è «confuso», non rilevoalcun particolare divario tra l’oggetto e le parole. L’oggetto non è«qualcosa di completamente diverso» di cui le parole ci parlano soloindirettamente, esprimendosi per enigmi come la Sibilla di Delfi.
Murdoch (1951-1952; trad. it. 2006, p. 80)
Senza dubbio le metafore sono pericolose – e forse soprattutto infilosofia. Ma un veto posto al loro uso costituirebbe una restrizioneostinata e dannosa delle nostre capacità di indagine.
Black (1954-1955; trad. it. 1983, pp. 65-66)
1. Introduzione
Gran parte del linguaggio quotidiano è metaforico; come una lente di ingran-dimento esso ci consente una più agevole lettura del nostro mondo. Il nostro pa-norama linguistico e concettuale si forma grazie all’ausilio di metafore, che ciconsentono di articolare ed esporre informazioni complesse, idee, sentimenti,esperienze personali e ci coadiuvano nell’espressione di giudizi etici. La metaforaè inoltre utile per descrivere i fenomeni scientifici e gli sviluppi tecnologici.
Nel 1880, anno in cui furono per la prima volta identificati i batteri, in campomedico si faceva largo impiego di metafore militari: la medicina muoveva guerraalle malattie1. I medici cominciarono a ricorrere al linguaggio figurativo al fine dicolmare le lacune comunicative nel dialogo con i pazienti gravamente malati2,utilizzando metafore belliche (ad es., «combattere una coraggiosa battaglia con-tro il cancro»), sportive (ad es., i risultati possono essere «una vittoria o unasconfitta», il paziente e la malattia si affrontano «come fossero avversari»), o
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 287
3 Periyakoil (2008). Poiché un’enfasi eccessiva sulle metafore belliche in alcuni casi potrebbe risultareproblematica – ad es., incoraggiando un trattamento eccessivo indesiderato (per cui viene dispiegato l’intero ar-senale medico) e favorendo quei «pazienti buoni» che combattono con vigore fino alla fine – un importantecontrappeso potrebbe essere la metafora della comunità come cura, identificata da Wurzbach, che implichereb-be un approccio più olistico alla cura del singolo paziente. Cfr. Wurzbach (1999, p. 97).
4 Cfr., ad esempio, Scully (2001).5 Cfr., ad esempio, Cserer e Seiringer (2009). Anche nella percezione da parte del pubblico della biologia
di sintesi si ricorre al linguaggio metaforico. Cfr. Pauwels (2009).6 Alcuni sostengono la possibilità di eludere l’impiego di metafore. Secondo Lakoff e Johnson (2003, p.
244) sono errori costanti ritenere che: (1) la metafora sia una questione di parole piuttosto che di concetti; (2)
quelle di un corpo-macchina (ad es., il corpo umano ha «parti difettose che pos-sono [essere] rimosse e sostituite»)3.
Nel dibattito bioetico, la metafora viene impiegata nel tentativo di ponderareopzioni e di tracciare linee e confini morali4. Un recente esempio di analisi me-taforica in ambito morale concerne il campo della biologia di sintesi. Parlando diquesto settore, gli scienziati, gli esperti e i media ricorrono al linguaggio metafo-rico5, e molte critiche sono state sollevate da chi sostiene che interferire nella na-tura scateni spesso conseguenze imprevedibili. Le accuse agli scienziati di giocarea far la parte Dio e di voler scoperchiare un vaso di Pandora sono le due principa-li obiezioni alla biologia di sintesi, metafore morali o normative che corrispondo-no alla tradizionale distinzione etica tra errori intrinseci e conseguenze.
In questo lavoro saranno tracciate le linee principali della riflessione filosoficacontemporanea sulla metafora al fine di prendere in considerazione le implicazio-ni che il suo impiego comporta in ambito bioetico, in particolare, nel campo dellabiologia di sintesi. Saranno presentate quattro diverse concezioni metaforiche – apartire dalla riflessione di Max Black, di George Lakoff e Mark Johnson – e siprenderanno in considerazione le metafore descrittive e normative nella biologiadi sintesi. Dato che parte del nostro linguaggio quotidiano è metaforico, ci trove-remmo in serie difficoltà se pretendessimo di descrivere gli sviluppi scientifici –come quelli della biologia di sintesi – senza ricorrere all’ausilio di metafore. Nonsolo, come vedremo, ciò vale anche spostandoci dal piano descrittivo a quellonormativo – cioè, nella valutazione di ciò che sta accadendo e di ciò che dovreb-be accadere. Per questo motivo tenteremo di far emergere quelle che sono leistanze specifiche della metafora nel suo farsi un mezzo – forse ancor più efficacedell’equivalente letterario – di comprensione del nostro mondo fisico e di quellomorale. Sarà inoltre illustrato il funzionamento delle metafore – evidenziando co-me possano far risaltare, oppure celare, fatti e valori – e sarà messo in evidenzacome esse, al di là di una loro funzione descrittiva, forniscano sempre degli spuntinormativi. Nella biologia di sintesi in particolare, la metafora non ha una funzio-ne meramente descrittiva (in termini scientifico-letterari), ma esprime anche ap-provazione o biasimo dal punto di vista etico. Non forniremo un’analisi esaustivadell’impiego della metafora nella biologia di sintesi, ma cercheremo di dimostrarecome alcuni suoi impieghi descrittivi abbiano effettive ricadute normative6. Da
288 QUADERNI DELLA RICERCA
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 288
che la metafora si basi sulla somiglianza; (3) che tutti i concetti siano letterali e che nessuno possa essere me-taforico. Il problema però, come spiega Davidson (1978; trad. it. 1994, p. 357), è «di sapere quale sia la relazio-ne tra la metafora e ciò che ci fa vedere». Secondo la sua posizione, «le metafore non significano niente di piùdi ciò che significano le parole nella loro interpretazione più letterale» (p. 338). Di conseguenza: «Occore ab-bandonare l’idea che una metafora sia portatrice di un messaggio, che abbia un contenuto o un significato (al dilà, ovviamente, del suo significato letterale)» (p. 357). In quest’articolo, per motivi di spazio, la posizione di Da-vidson non sarà affrontata. Per una sua critica, cfr. Black (1979b). Cfr. inoltre Lakoff e Johnson (2003).
7 Turbayne (1970, p. 3) fornisce ulteriori esempi: «Hobbes sostiene che lo Stato sia un mostro a più testeo un leviatano; Shakespeare che si tratti di un alveare di api», e aggiunge, «Cartesio sostiene che la mente nelsuo corpo sia il pilota di una nave; Locke che si tratti di una stanza, vuota all’inizio, ma successivamente pienadi mobili; e Hume che si tratti di un teatro».
8 Aristotele Poet., 1457b. «Questo trasferimento» scrive Aristotele (ibid.), «avviene o dal genere alla spe-cie, o dalla specie al genere, o da specie a specie, o per analogia».
9 Questo non vuol dire che le teorie importanti sulla metafora non siano state sviluppate precedentemen-te. Per un’eccellente disamina della questione, si veda Leezenberg (2001, pp. 15-67) che discute le radici dellametafora nelle società preistoriche e analfabete, come la Mesopotamia, così come il suo sviluppo in Aristotele,Abd al-Qahir al-Jurjani, e Giambattista Vico.
10 Cfr. Davidson (1978; trad. it. 1994).11 Ad esempio, su base interazionale: è la posizione di Black (1954-1955; trad. it. 1983).
questo punto di vista, l’impiego dell’espressione metaforica ha una funzione con-cettuale, tant’è che la validità della nostra analisi morale dipende in modo crucia-le dalla metafora scelta nella descrizione dei fenomeni morali. Per tale ragione, ènecessario porre estrema attenzione all’uso che facciamo del linguaggio; seppursia impossibile epurarlo da ogni metafora, potremmo almeno valutare quanto es-se siano adatte a descrivere ciò che sta accadendo e ciò che dovrebbe accadere. Èquesto, d’altra parte, il lavoro della filosofia.
2.Che cos’è la metafora? Riflessioni filosofiche
Generalmente, la metafora viene considerata come uno strumento dell’imma-ginazione poetica, dell’arte retorica: se ne fa una questione di stile. La storia delpensiero occidentale offre notevoli esempi di un ricorso costante all’espressionemetaforica. Si è detto di Socrate che era una levatrice e un tafano e Nietzsche haparlato di morale del gregge. Più recentemente, con la rinascita dell’etica dellavirtù, Alasdair MacIntyre ha definito la vita morale una narrazione incarnata7.Gran parte delle discussioni filosofiche sulla metafora prende il via dalla celebredefinizione aristotelica contenuta nella Poetica: «La metafora consiste nel trasfe-rire a un oggetto il nome che è proprio di un altro»8. Nonostante ciò, solo a par-tire dalla metà del XX secolo, si è aperta una discussione sistematica sulla me-tafora, che prescinde dai suoi impieghi esclusivamente poetici o retorici9. Le di-scussioni teoretiche si sono concentrate sul linguaggio metaforico come rivelato-re, in misura maggiore o minore, dei fatti veri nel mondo. Se alcuni ritengonoche il significato di una metafora si riduca soltanto al suo equivalente letterale10,altri ritengono che le metafore siano foriere di nuovi significati11 spesso rilevanti
LA METAFORA MORALE E LE QUESTIONI EMERGENTI IN BIOETICA - J.A. RAHO 289
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 289
12 Cfr. Ricoeur (1978). Per una recente indagine monografica in lingua italiana, cfr. Bazzanella (a cura di,2009).
13 Black (1954-1955; trad. it. 1983).14 Ibid., p. 51.15 Ibid., p. 49.16 Ibid., p. 51.17 Ibid., p. 53.18 Ibid., p. 54. Per Black, la concezione comparativa è un caso speciale della concezione sostitutiva. Il proble-
ma della concezione comparativa è che, secondo Black, essa «presenta una tale indeterminatezza da rasentare lavacuità» (ibid.).
19 Nel suo More About Metaphor (Ancora sulla metafora), Black afferma che sia le concezioni sostitutiveche comparative «trattano la metafora come non enfatica, secondo la mia terminologia, e quindi superflua in li-nea di principio, se si trascura il probabile piacere di affermare figurativamente quello che si potrebbe afferma-re ugualmente bene in modo letterale». Black (1979; trad. it. 1983b, p. 112).
20 Citando Richards (1936; trad. it. 1967, p. 89), Black (1954-1955; trad. it. 1983, p. 55) scrive: «Per dirlonei termini più semplici, quando adoperiamo una metafora abbiamo due pensieri di cose differenti contempo-raneamente attivi e sorretti da una singola parola o frase, il cui significato risulta dalla loro interazione».
21 Black (1954-1955; trad. it. 1983, p. 57).22 Cfr. Black (1979a; trad. it. 1983, p. 113). I due soggetti distinti vengono identificati come il soggetto
«primario» e quello «secondario».
dal punto di vista cognitivo12. Max Black, in un saggio che è ormai un classico,ha offerto un’analisi dei tre principali tipi di metafore13.
(a) I tre principali tipi di metafore
Si consideri l’esempio di Black: «Richard è un leone»14. Stando a una concezio-ne sostitutiva della metafora (substitution view of metaphor) – «l’espressione me-taforica è usata al posto di una equivalente espressione letterale»15. In questo caso«Richard è un leone» significa che «Richard è coraggioso»16. Secondo una conce-zione comparativa (comparison view of metaphor) – l’espressione metaforica è «unasimilitudine condensata o ellittica» che può «essere sostituita da un’equivalentecomparazione letterale»17. In questo caso l’espressione metaforica significa «Ri-chard è come un leone (in quanto coraggioso)»18. La visione comparativa, però,non aggiunge alcun contenuto a quello di una equivalente metafora letterale19.
Date queste limitazioni, Black propone una terza maniera di concepire la me-tafora chiamata interattiva (interaction view of metaphor)20. Nell’esempio «L’uo-mo è un lupo»21, i due soggetti – l’uomo (il soggetto principale) ed il lupo (il sog-getto sussidiario)22 – sono correlati in maniera non letterale. Secondo Black,
Ciò che occorre non è tanto che il lettore conosca il significato di «lupo» di un comu-ne dizionario – o sia in grado di usare quella parola nei suoi sensi letterali – quanto cheegli conosca ciò che io definisco il sistema dei luoghi comuni associati. […] L’effetto, allo-ra, che si ha chiamando (metaforicamente) un uomo «lupo» è quello di evocare un siste-ma-lupo di relativi luoghi comuni. Se l’uomo è un lupo, preda gli altri animali, è feroce,affamato, impegnato in una lotta costante, è un animale che si nutre di carogne e via di
290 QUADERNI DELLA RICERCA
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 290
23 Black (1954-1955; trad. it. 1983, pp. 57-58). Con ciò egli intende dire che «gli usi letterali della parolalupo sono governati da regole sintattiche e semantiche, la violazione delle quali produce non-senso e autocon-traddizione» (p. 58).
24 Ibid., p. 63. Cfr. inoltre Black (1979; trad. it. 1983b, p. 114): «Nel contesto di una particolare asserzionemetaforica, i due soggetti “interagiscono” nel modo seguente: (i) la presenza del soggetto primario incita l’a-scoltatore a selezionare alcune delle qualità proprie del soggetto secondario; e (ii) lo invita a costruire un “com-plesso di implicazioni” parallelo che possa andar bene per il soggetto primario; e (iii) reciprocamente inducedei cambiamenti paralleli nel soggetto secondario».
25 Lakoff e Johnson (1980a [20032]; trad. it. 1982). Per una breve panoramica della loro posizione, cfr.Lakoff e Johnson (1980b).
26 Lakoff e Johnson (1980a [20032]; trad. it. 1982, p. 21).27 Ibid., p. 19.28 Ibid., p. 20.
seguito. Ciascuna di queste asserzioni implicate deve essere ora adattata al soggetto prin-cipale (l’uomo) o nel senso normale o in quello non-normale23.
Si noti che la metafora «l’uomo è un lupo» nel mentre che pone in risalto alcu-ne caratteristiche sia dei lupi che degli uomini, ne de-enfatizza delle altre. A talproposito, come vedremo, le metafore funzionano secondo quelle che sono le in-tenzioni dell’oratore. In altre parole, esse selezionano, enfatizzano, sopprimono edorganizzano alcune caratteristiche del soggetto principale alla luce del sistema di re-lazioni inerenti al soggetto sussidiario24. È il fatto che le nostre metafore servano amettere in risalto o a de-enfatizzare le caratteristiche della realtà ad indurci aprendere in considerazione le differenze tra metafore descrittive e metafore nor-mative in campo bioetico. Prima di farlo, tuttavia, dovremo parlare di una quartaaccezione metaforica, – quella della metafora convenzionale (conventional me-taphor) – per capire in che modo il nostro pensiero quotidiano tenda strutturarsimetaforicamente e quali implicazioni di rilievo ciò comporti nelle modalità diconcettualizzazione dei fenomeni morali.
(b) Una teoria “empirista” della metafora: le metafore di cui viviamo
L’opera di George Lakoff e Mark Johnson, Metaphors We Live By25, segnaun’importante rottura con i precedenti studi sulla metafora. La tesi principale diquest’opera è che «L’essenza della metafora [consista nel] comprendere e vivere untipo di cosa nei termini di un altro»26 e che «il nostro comune sistema concettua-le, in base al quale pensiamo ed agiamo, sia essenzialmente di naturametaforica»27. In altre parole, secondo i due autori, il ricorso a concetti metafori-ci serve a strutturare le attività quotidiane, e questa strutturazione non soltanto èuna questione di linguaggio, ma riflette i processi del pensiero umano. Si prendauno dei loro esempi, la discussione è una guerra, che dà luogo a frasi come: le tuerichieste sono indifendibili; egli ha attaccato ogni punto debole della mia argomen-tazione; le sue critiche sono andate a segno; ho demolito la sua argomentazione28.Lakoff e Johnson mettono in luce come, tramite l’impiego di queste metafore,
LA METAFORA MORALE E LE QUESTIONI EMERGENTI IN BIOETICA - J.A. RAHO 291
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 291
29 Ibid., pp. 20-21. Come nel caso della metafora di Black, «l’uomo è un lupo», anche il considerare la di-scussione come una “guerra”, ovviamente, non struttura completamente il concetto. Secondo questi autori, po-tremmo immaginare un’altra cultura in cui «una discussione è vista come una danza, i partecipanti come artisti,e lo scopo come quello di una rappresentazione equilibrata ed esteticamente piacevole» (ibid., p. 21). In questacultura, le discussioni sarebbero intese in maniera diversa, vissute in modo diverso, e portate avanti diversa-mente. Potremmo dire che mentre noi abbiamo una forma di discorso strutturata in termini di combattimento,la loro si struttura nei termini di una danza. Proseguono: «Questo è un esempio di ciò che significa dire che unconcetto metaforico, e precisamente la discussione è una guerra, struttura (almeno in parte) ciò che facciamo ecome comprendiamo ciò che stiamo facendo nel corso di una discussione» (ibid.).
30 Lakoff e Johnson (1980a [20032]; trad. it. 1982, p. 75).31 Ibid., p. 137. Tra gli esempi che gli autori forniscono vi è il concetto di amore: l’amore è una forza fisica
(«[Sentivo] dell’elettricità fra noi»); l’amore è un malato («Questa relazione è malata»); l’amore è follia («Sonopazzo di lei»); ed infine, l’amore è guerra («Lei è assediata dai corteggiatori. Egli deve schivarli. Lui ha ottenutol’appoggio degli amici di lei») (ibid., p. 67).
32 Lakoff e Johnson (2003, p. 243). Proseguono: «Il vostro matrimonio è una partnership, un viaggio insie-me attraverso la vita, un rifugio dal mondo esterno, un mezzo per la crescita, o l’unione di due persone in unaterza entità? Scegliere tra questi modi comuni di concettualizzare il matrimonio consente di stabilire cosa di-venterà il vostro matrimonio» (ibid.).
non ci si limiti a parlare di una discussione in termini di guerra. La discussionepuò davvero essere vinta o persa:
Vediamo la persona con cui stiamo discutendo come un nemico. Attacchiamo le sueposizioni e difendiamo le nostre. Guadagnamo e perdiamo terreno. Pianifichiamo e usia-mo strategie. Se troviamo una posizione indifendibile possiamo abbandonarla e scegliereuna nuova linea di attacco. Molte delle cose che facciamo durante una discussione sonoparzialmente strutturate dal concetto di guerra. Benché non vi sia un combattimento fisi-co, c’è un combattimento verbale, che si riflette nella struttura della discussione (attacco,difesa, contrattacco ecc.)29.
Come spiegano i due autori, le nostre esperienze quotidiane sono strutturate,in parte, in chiave metaforica. In altre parole, siamo soliti far ricorso a metaforeche esprimono modi di pensare «parzialmente compresi nei termini di altri con-cetti»30. Secondo gli autori, le metafore funzionano nel seguente modo:
[…] dal momento che moltissimi dei concetti che sono importanti per noi sono astrat-ti o non sono chiaramente delineati nella nostra esperienza (emozioni, idee, tempo ecc.),abbiamo bisogno di coglierli per mezzo di altri concetti che possiamo comprendere intermini più chiari (orientamenti spaziali, oggetti ecc.)31.
Per chiarire ulteriormente questa concezione, si consideri quanto Lakoff eJohnson osservano a venti anni di distanza dal loro celebre lavoro:
Il modo in cui pensiamo metaforicamente ha un certo numero di implicazioni, poichéè in grado di determinare questioni di guerra e pace, la politica economica, e le decisionilegali, come anche le scelte banali della vita quotidiana. Un attacco militare è uno «stu-pro», «una minaccia alla nostra sicurezza», o «la difesa di un popolo dal terrorismo»?L’attacco stesso può essere concettualizzato in uno di questi modi con conseguenze mili-tari molto differenti32.
292 QUADERNI DELLA RICERCA
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 292
33 Childress (20033, p. 1834).
Le implicazioni di questa concezione sono di notevole importanza per la bioeti-ca e per la biologia di sintesi. Poiché le metafore ci consentono di dotare di sensoil nostro mondo, di articolare e riportare informazioni complesse, idee, sentimentied esperienze personali, esse stanno a fondamento delle nostre interpretazioni diquanto sta accadendo e di quanto dovrebbe accadere. A tal proposito, nelle pros-sime sezioni di questo lavoro, si applicheranno alla bioetica, e successivamente al-la biologia di sintesi, le due principali teorie discusse, la concezione interattiva del-la metafora, formulata da Black, e quella empirista di Lakoff e Johnson. Vedremorisultare dall’analisi che le metafore morali non possono essere sostituite da un’e-quivalente espressione o comparazione letterale (come nei primi due casi presi inconsiderazione da Black). Ciò perché le teorie bioetiche (ed anche la biologia disintesi) ricorrono a metafore che svolgono anche la funzione di modelli pratico-concettuali. Come vedremo, le metafore forniscono interpretazioni della realtà, in-dirizzando i nostri comportamenti, le nostre azioni e le nostre scelte. Esse, infine,hanno profonde ricadute sul nostro modo di “vedere” il mondo, di “interpretare”i fatti, e di formulare valutazioni etiche.
(c)Metafore in bioetica
Generalmente, si ritiene la metafora uno strumento dell’immaginazione poetica,dell’arte retorica e quindi un semplice artificio stilistico. Spesso si pretende inoltreche il linguaggio scientifico (ma anche il lessico filosofico), in quanto preciso e rigo-roso, sia privo di qualsiasi elemento figurativo. Quest’idea è stata messa in discus-sione da teorie come quelle di Black, Lakoff e Johnson. Ciò perché le descrizionidei fenomeni e degli sviluppi scientifici, che sono le fonti dei dibattiti bioetici, nondi rado sono intrise di un linguaggio metaforico. Come ha osservato un esperto,
Molte delle nostre pratiche e gran parte del nostro discorso sul servizio sanitario si in-centrano sulla metafora e sull’analogia, il cui significato è talvolta trascurato perché le siconsidera esclusivamente come elementi decorativi o tuttalpiù come espedienti. Nono-stante la generale distrazione nei loro riguardi, esse modellano significativamente le no-stre interpretazioni di ciò che sta accadendo e di quello che dovrebbe accadere33.
Ad esempio, in accese discussioni sulla concessione di incentivi finanziari peril trapianto di organi, ci si riferisce ad essi come a dei doni piuttosto che a dellemerci. Allo stesso modo, nei dibattiti sulla riproduzione assistita si fa una distin-zione tra la generazione di figli in modo naturale e la possibilità di una loro fab-bricazione, possibilità che genera una notevole inquietudine.
Nelle discussioni bioetiche, la metafora è inoltre associata a dei modelli. Peresempio, nei dibattiti sulla riforma dell’assistenza sanitaria negli Stati Uniti, il si-stema assistenziale è stato paragonato a un business o a un modello di mercato, in
LA METAFORA MORALE E LE QUESTIONI EMERGENTI IN BIOETICA - J.A. RAHO 293
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 293
34 Cfr., ad es., Malone (1999, p. 20).35 Childress (20033, p. 1835). In questa direzione, Childress e Siegler hanno analizzato cinque metafore
principali e come modelli di queste relazioni nel campo della sanità: il rapporto medico-paziente come rapportopaterno o parentale, rapporto societario, rapporto tra contraenti ragionevoli, rapporto amichevole e il personalemedico come tecnico. Cfr. Childress e Siegler (1997, pp. 45-48).
36 Black (1954-5; trad. it. 1983, p. 63). Cfr. inoltre Black (1979a; trad. it. 1983b, p. 114).37 Lakoff e Johnson (1980a [20032]; trad. it. 1982, p. 177).38 Childress e Siegler (1997, p. 44).39 Childress (20033, p. 1838).
cui i pazienti sono consumatori ed i medici fornitori di cure mediche. Intendere ilsistema sanitario in senso esclusivamente economico, o interpretarlo come unaditta, comporta tuttavia la messa in ombra di altri significativi aspetti della que-stione34, come la dimensione morale dell’accesso alle cure sanitarie. La metaforafa il suo implicito ingresso nelle discussioni bioetiche tramite la concettualizza-zione del rapporto medico-paziente. Ad esempio, nel caso in cui essa ci presenti imedici come genitori ed i pazienti come dei bambini, la loro relazione è colta at-traverso un modello paternalistico35. Possiamo ricollegare questo discorso a quel-lo di Black, Lakoff e Johnson: secondo la concezione interattiva della metafora(interactive view of metaphor) nel descrivere i medici come genitori e i pazienticome bambini, tali metafore individuano il sistema dei luoghi comuni associati.In altre parole, esse selezionano, enfatizzano, sopprimono e organizzano alcunecaratteristiche del soggetto principale applicandole al sistema di relazioni ineren-te al soggetto sussidiario36 ponendo enfasi su alcune importanti questioni peruna filosofia della medicina. Nel linguaggio di Lakoff e Johnson, «le metaforehanno implicazioni attraverso le quali mettono in luce e rendono coerenti certiaspetti della nostra esperienza»37. In questo senso, esse possono rilevare quelliche riteniamo essere i doveri e gli obbligi dei medici. È possibile, tuttavia, imma-ginare metafore diverse per ciascuno degli esempi sopra riportati. Di solito, chi ècontrario all’impiego di una particolare metafora nel rapporto medico-pazientenon rifiuta l’uso della metafora in quanto tale; piuttosto, la sostituisce con unametafora diversa – ad es., chi non vuole ricorrere alla metafora degli imprenditorirazionali può utilizzare la metafora della partnership38. Infine, l’impiego quotidia-no delle metafore non implica che ogni loro interpretazione sia valida. Comescrive Childress, va ricordato che
Quando si usano per descrivere, interpretare e spiegare relazioni, tali metafore vengo-no criticate se falsano piuttosto che delucidare. E quando si ricorre ad esse per regolarerelazioni e azioni, esse vengono criticate se evidenziano solo un elemento morale, come ildovere del medico di recare beneficio al paziente o di rispettarne l’autonomia, nascon-dendo o mettendo in secondo piano altre importanti considerazioni morali39.
Date queste due posizioni – il terzo tipo di metafora discusso da Black, e lateoria di Lakoff e Johnson –, vedremo adesso come esse si applichino alla biolo-gia di sintesi.
294 QUADERNI DELLA RICERCA
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 294
40 Gibson, Glass, Lartigue et al. (2010).41 Questo genoma sintetico ha 1.080.000 coppie di basi, ed è la struttura più grande sinora sintetizzata in
laboratorio e chimicamente definita. Cfr. J. Craig Venter Institute (2011).42 Gibson et al. (2010, p. 55).43 Per un panoramica sui più esperti in materia e sugli obiettivi della biologia di sintesi, cfr.What’s in a name?
(2009).44 Capurro, Kinderlerer, da Silva, e Rosell (2009, p. 10).45 La filosofia della biologia è particolarmente interessata al concetto di organismo. Per uno sguardo rile-
vante sul possibile uso di simili metafore in questo campo, cfr. Gagliasso Luoni (2009).46 Oltre a questi esempi, i due tipi dominanti di approccio al settore vengono articolati metaforicamente:
nel modello Top-down, o modello di Chassis, il genoma di un’organismo esistente è ridotto in maniera tale che,
3.Metafore e biologia di sintesi
Il 20 maggio 2010, Daniel Gibson e altri 23 ricercatori del J. Craig Venter In-stitute (Stati Uniti) hanno pubblicato i risultati40 delle loro ricerche sulla sintesi,il montaggio, la clonazione, e il trapianto con esito positivo della prima cellulasintetica auto-replicante, il genoma sintetico Mycoplasma mycoides41. Questi ri-sultati forniscono «una prova di principio per produrre cellule basate su sequen-ze di genomi disegnate al computer»42, sinora inesistenti in natura. La biologia disintesi è un settore di ricerca nuovo, che unisce elementi di biologia molecolare(ingegneria genetica), chimica, informatica e ingegneria. Benché non esista unadefinizione unanimamente accettata43, si tratta di un campo che promette di svi-luppare i fondamenti della conoscenza scientifica, di creare bio-fuel (bio-combu-stibili) rinnovabili e di sviluppare farmaci più efficaci. Due sono gli obiettiviprincipali: in primo luogo, sul piano teorico, quello di migliorare la nostra com-prensione degli attuali sistemi biologici nella loro complessità, in secondo luogo,sul piano applicativo, quello di impiegare gli organismi come fabbriche, in mododa ricavarne prodotti di uso immediato (ad es., prodotti farmaceutici, vaccini,bio-fuel, e agenti di bio-difesa)44.
(a) Le metafore descrittive nella biologia di sintesi
Gli obiettivi e lo scopo della biologia di sintesi potrebbero essere ben compre-si anche solo ricorrendo quasi esclusivamente alla metafora descrittiva:– I biologi di sintesi hanno l’obiettivo di disegnare e assemblare organismi45 a
partire da zero.– Nel farlo, essi adoperano parti diverse chiamate mattoni (o BioBricks).– Tali mattoni sono costituiti dal DNA e da altre molecole.– I BioBricks possono essere paragonati a bio-parti (che interromperebbero o av-
vierebbero correttamente la produzione di geni), o a bio-tools (che misuranoin modo affidabile la concentrazione di un particolare gene prodotto).
– In questo modo gli scienziati impiegano il DNA come una cianografia, permettere insieme un puzzle e creare macchine sintetiche viventi46.
LA METAFORA MORALE E LE QUESTIONI EMERGENTI IN BIOETICA - J.A. RAHO 295
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 295
in condizioni di laboratorio, al modello restino solo determinati componenti assolutamente necessari per soste-nere la vita del sistema e preservare il metabolismo di base. Stando al secondo tipo di approccio, chiamato Bot-tom-up o “modello Lego”, gli essere viventi (o forme di vita) sono assemblati da componenti che non sono pro-priamente vivi. Cfr. Swiss Confederation (2010, pp. 8 e 10).
47 Il giorno stesso dell’annuncio di Venter, negli Stati Uniti il Presidente Barack Obama ha chiesto al nuo-vo Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues di studiare le implicazioni etiche della biologia disintesi. Cfr. Letter to Dr. Amy Gutmann (2010). Cfr. inoltre il loro rapporto ufficiale: Presidential Commissionfor the Study of Bioethical Issues (2010).
48 Dabrock (2009, p. 47).49 Childress (20033, p. 1838).50 Douglas e Savulescu (2010, p. 688). Per una discussione intorno alla sovrapposizione dell’argomento
giocare a fare la parte di Dio ai riferimenti a Frankenstein di Mary Shelley, cfr. Van den Belt (2009).51 De S. Cameron e Caplan (2009, p. 1103).52 Per una discussione su come la biologia di sintesi si potrebbe applicare ai concetti teologici di creazione,
di peccato e di Imago Dei, cfr. Dabrock (2009, pp. 49-52).
(b) Le metafore morali nella biologia di sintesi
L’annuncio di Venter ha spostato l’attenzione sugli aspetti etici di questo nuo-vo punto di riferimento scientifico47. In questa sezione prenderemo in considera-zione le argomentazioni contrarie alla biologia di sintesi, basate su metafore nor-mative. Le obiezioni principali che le sono mosse derivano, a grandi linee, da unodei seguenti motivi: dalla sua presunta intrinseca erroneità (ad esempio il fattoche la nuova tecnologia sia sbagliata in sé) o dalla preoccupazione per le eventua-li conseguenze che possono derivare dalla sua applicazione (ad esempio in merito aquestioni legate alla sicurezza e ai possibili rischi dell’impiego di una tecnologia).Sebbene la letteratura si sia concentrata principalmente su queste ultime, pren-deremo in considerazione entrambe le prospettive alla luce delle varie metaforecui danno origine; in altre parole, vedremo come, a partire dai timori per un’in-trinseca erroneità della biologia di sintesi e per le sue conseguenze nefaste, sianovenute alla luce considerazioni metaforiche normative o morali.
«Giocare a fare la parte di Dio»
La metafora giocare a fare la parte di Dio «significa che l’uomo in generale o isingoli individui, gli individui specifici, hanno trasgredito i limiti stabiliti che costi-tuivano un certo ordine»48. In bioetica, gli scienziati, i medici ed altri professionistidel settore «sono stati accusati di usurpare il potere di Dio – ad esempio il poteresulla vita e sulla morte – lasciando morire i pazienti o impiegando nuove tecnolo-gie per la riproduzione»49. Nel contesto della biologia di sintesi, in molti stannoavanzando preoccupazioni nei confronti della possibilità di progettare e creare50,oltre che ritoccare e modificare, il DNA. «Nonostante si sia sempre pensato, dal-l’avvento dell’epoca nucleare, alla possibilità di autodistruggerci», scrive Nigel Ca-meron, «mai prima d’ora le specie hanno avuto a che fare con l’opzione di rein-venzione dell’ordine»51. La prospettiva di poter “reinventare” gli elementi fonda-mentali della vita suscita molta perplessità e non soltanto in ambito teologico52. Il
296 QUADERNI DELLA RICERCA
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 296
53 Cfr. Buchanan e Powell (2010).54 Coady (2009, pp. 155-156).55 Kaebnick (2009a, p. 1106).56 Buchanan e Powell (2010, p. 4).57 Coady (2009, p. 157).58 Buchanan e Powell (2010, p. 5).59 Coady (2009, p. 163).60 Cfr. inoltre Caplan (2010, p. 6).
senso intuitivo che qualcosa potrebbe andare storto porta i detrattori della biolo-gia di sintesi – anche quelli che appartengono al contesto secolare – a vedere in es-sa un affronto alla natura in varie forme. Esistono diverse maniere di formulare ilproblema.
Un certo tipo di obiezione espressa dalla metafora giocare a far la parte di Dio,deriva da una preoccupazione metafisica o teologica53. La biologia di sintesi, datale punto di vista, rappresenta l’intrusione in una sfera creativa tradizionalmenteriservata a un essere divino. Come ha notato C.A.J. Coady, secondo la posizioneteologica «l’idea è che vi siano certe cose troppo pretenziose per l’essere umanopoiché sono questioni da lasciarsi nelle mani di Dio» il quale, tradizionalmente, èsempre stato inteso «in controllo della creazione. Non solo Dio ha creato il mon-do, ma ne conserva le forme e si prende cura di ciò che succede in quel mon-do»54. Inoltre, con la creazione di forme di vita primitive, la biologia di sintesirappresenterebbe, secondo alcuni critici, un’inutile manomissione della natura.Gli scienziati starebbero «andando in modo inopportuno oltre il proprio ruolonel cosmo – cioè essi [starebbero] commettendo uno sbaglio rispetto alla catego-ria cui appartengono gli esseri umani nell’ordine delle cose, compiendo in talmodo un errore morale»55. Ciò equivale ad «asserire che gli esseri umani nondebbano intervenire in alcuni ambiti del mondo naturale indipendentemente dal-le possibili conseguenze di un tale intervento»56. Sono in molti, ad esempio, a ri-tenere che l’estinzione di una specie, o un danno causato all’ambiente, sianoeventi moralmente indesiderabili anche quando non ne consegua un danno im-mediato per gli esseri umani57.
La metafora del giocare a fare la parte di Dio può esprimere inoltre una preoc-cupazione epistemologica. Essa si incentra sulla «preoccupazione che, avendo ache fare con sistemi complessi, potremmo fallire nel riconoscere i limiti della no-stra conoscenza»58. Ciò perché «gli esseri umani sono eminentemente fallibili,hanno un potere limitato e sono soltanto in parte buoni»59. I biologi di sintesipotrebbero essere considerati “arroganti” nel loro tentativo di padroneggiarecompletamente la natura ma, in questo caso, centrale non è tanto l’usurpazionedel ruolo del divino quanto l’imprudenza nel giocare60.
L’ultima maniera di formulare la metafora giocare a fare la parte di Dio riguar-da il rapporto tra uomo e natura. In questo caso, il problema sorge in merito allaconfusione che si viene a creare nella distinzione tradizionalmente ammessa traartefatto e organismo, o tra vivente e non vivente. Douglas e Savulescu hanno
LA METAFORA MORALE E LE QUESTIONI EMERGENTI IN BIOETICA - J.A. RAHO 297
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 297
61 Douglas e Savulescu (2010, pp. 688-689).62 Kaebnick (2009a, p. 1107).63 Cho, Magnus, Caplan et al. (1999). Cfr. inoltre Swiss Confederation (2010, p. 19).64 Cho et al. (1999).65 Ad es., ha notato Caplan che «[M]olti al di fuori delle scienze biologiche ancora ritengono che la vita sia
un mistero che va oltre la comprensione umana e che è legato alla volontà di Dio. Tutti questi punti di vistaprofondamente radicati nella metafisica sono messi in discussione dalla dimostrazione che la vita può esserecreata a partire da parti non-viventi. Il raggiungimento della creazione della vita artificiale porrà fine alla teoriache la vita richiede una forza speciale o una potenza per esistere. In maniera per molti forse più preoccupante,tale conclusione suggerisce che né la vita microbica, né quella umana siano alimentate da una forza vitale tra-scendente». Caplan (2010, pp. 7-8).
66 Boldt e Müller (2008, p. 387).
rimarcato, ad esempio, come uno degli obiettivi principali della biologia di sinte-si, quello di creare una bio-fabbrica di batteri, rischi di generare confusione tra ledistinzioni tradizionali:
Queste bio-fabbriche potrebbero possedere molte delle caratteristiche della vita chenormalmente consideriamo irrevocabili: per esempio, meccanismi fisiologici omeostatici,un genoma acido nucleico e una struttura a base proteica, la capacità di riprodursi. Maesse possiedono anche molte caratteristiche delle macchine: ad es., la costruzione modula-re, basata su principi di progettazione razionale, e con specifiche applicazioni in mente61.
Un’ulteriore obiezione alla biologia di sintesi è mossa da chi la ritiene intrinse-camente sbagliata, poiché metterebbe a repentaglio alcuni concetti moralmenterilevanti62. «Il tentativo di modellare e creare un genoma minimo», scrivono Choet al., «rappresenta l’apice di un’agenda di ricerca riduzionista sul significato el’origine della vita che ha attraversato il 20° secolo»63. «Lo status speciale degliesseri viventi e il valore che attribuiamo alla vita», continuano, «possono quindiessere minati dal riduzionismo»64. Da questo punto di vista, il problema non è ilriduzionismo di per sé, ma la possibilità che la vita finisca per non essere più mi-steriosa65. Detto in altri termini, se la biologia di sintesi ci permettesse di costrui-re la vita a partire da zero, ciò non soltanto implicherebbe il venir meno della«forza speciale» di un essere trascendente, ma «creerebbe nuove forme di vitadai tratti fondamentali in gran parte progettati dagli esseri umani»66.
«Il Vaso di Pandora»
Secondo la mitologia greca, Pandora fu la prima donna al mondo creata perordine di Zeus da Efesto, dio della tecnologia. Le venne affidato un vaso con l’in-giunzione di non aprirlo per nessun motivo. Ciò non bastò a frenarne la curiositàe, dopo che l’ebbe aperto, tutti i mali in esso contenuti si riversarono nel mondo.Quando infine Pandora ne ebbe sostituito il coperchio, nel vaso rimase soltantola speranza. Interpretato in chiave moderna, il mito antico allude a un’azione re-sponsabile di un male irrimediabile. La biologia di sintesi non potrebbe ritenersi
298 QUADERNI DELLA RICERCA
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 298
67 Per una discussione su questo, cfr. Rejeski (2010).68 Swiss Confederation (2010, p. 22).69 De S. Cameron e Caplan (2009, p. 1105).70 Ibid.71 Ibid.72 Ibid.73 Swiss Confederation (2010, p. 24).
una sorta di invito ad aprire il vaso di Pandora? Possiamo davvero essere certiche gli organismi creati in laboratorio rimarranno al suo interno e non sarannoaccidentalmente rilasciati?
Questa grande inquietudine per le conseguenze della biologia di sintesi assu-me diverse espressioni67. Alcuni impiegano la formula «Oops!», esclamazioneche sta a significare il rilascio accidentale di sostanze pericolose nell’ambiente acausa di un errore umano o tecnologico. Legittima potrebbe essere la preoccupa-zione di chi ritiene che la biologia di sintesi, applicandosi ad organismi viventi, e“armeggiando” «con una quantità sconosciuta (essenzialmente sconosciuta otroppo complessa per essere conosciuta)», rappresenti «un significativo potenzia-le di rischio per gli esseri umani e per l’ambiente»68. È possibile esprimere una si-mile preoccupazione anche ricorrendo alla metafora del cavallo di Troia, stante asignificare che alcune tecnologie che la società ha accettato sono un errore. «Sap-piamo molto poco della storia delle attività umane che coinvolgono organismi vi-venti», sostiene Caplan, «la qual cosa ci rende fiduciosi sul fatto di poter rilascia-re al loro posto le nuove forme di vita»69. Su queste basi egli prosegue: «Per cen-tinaia di anni, la gente ha introdotto nuove forme di vita in luoghi dove generanoproblemi enormi»70, tra queste, i conigli, i kudzu, gli storni, gli scarabei giappo-nesi, i pesci channoidei, il vaiolo, la rabbia, i moscerini della frutta. Secondo Ca-plan si tratta soltanto di «un piccolo campione di esseri viventi che hanno causa-to distruzioni per l’umanità semplicemente venendo dispersi in posti che non vo-gliamo»71. L’errore umano potrebbe indurci a considerare la (non remota) possi-bilità che «Coloro che sono implicati nella creazione di nuove forme di vita per-dano accidentalmente traccia degli animali, degli insetti o delle piante con cuistavano lavorando, come è accaduto con l’introduzione delle “vespe killer” nelSud, nel Centro e nel Nord America»72.
Esiste infine un ulteriore tipo di metafora, detta del Dott. Stranamore, che dàvoce all’inquietudine per le conseguenze delle ricerche: cosa accadrebbe se labiologia di sintesi dovesse cadere in mani sbagliate? Poiché essa ci consente diprodurre virus o batteri potenzialmente pericolosi in modo relativamente sempli-ce, deve necessariamente aprirsi un dibattito sulla quantità di rischio che una so-cietà è disposta ad accollarsi. Una valutazione in questo senso dovrebbe tenerpresente sia il rischio per la biosicurezza (risultante dal trattamento improprio diorganismi), sia quello dovuto al bioterrorismo (nei casi in cui una tecnologia po-trebbe essere impiegata per scopi civili, militari o terroristici)73.
LA METAFORA MORALE E LE QUESTIONI EMERGENTI IN BIOETICA - J.A. RAHO 299
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 299
74 Lego (2011) (corsivo mio).75 Cfr. Midgley (2000).
4.Analisi delle metafore morali della biologia sintetica
Numerose metafore descrittive nel campo della biologia di sintesi (ad esem-pio, quella della progettazione e dell’assemblamento di organismi a partire dazero) danno adito a considerazioni di ordine morale o normativo. Si faccia caso,ad esempio, a come il “modello Lego” della biologia di sintesi – una mera descri-zione di cosa fa un biologo –, generi questioni di carattere normativo:– I biologi di sintesi hanno lo scopo di progettare e assemblare gli organismi apartire da zero; lo fanno impiegando diverse parti, chiamate mattoni (o Bio-Bricks), da cui ottenere un organismo nuovo.
– I BioBricks della biologia di sintesi sono paragonati, metaforicamente, ai mat-toncini a incastro della Lego con cui giocano i bambini.
– Stando al sito internet della Lego, il meccanismo a incastro con i suoi tubetti larende unica, poiché offre «illimitate possibilità di costruzione. Si tratta soltantodi lasciar correre l’immaginazione – e far sì che tutta la ricchezza creativa siesprima attraverso il gioco»74.In questo modo, la metafora descrittiva dà luogo a implicazioni normative in
domande di questo tipo: È giusto che gli scienziati giochino con gli organismi co-me fanno i bambini con la Lego? Quali sono i limiti da porre alle illimitate possi-bilità di gioco e di assemblaggio? Cosa significa “progettare” e “assemblare” de-gli organismi? Dovremmo essere proprio noi a farlo? È sempre vantaggioso “ma-nipolare” o “armeggiare” l’ordine naturale delle cose? Quali rischi si potrebberocorrere? Ciascuna di queste domande comporta riferimenti alle considerazionimorali o normative – nel caso specifico, ai giudizi sulla legittimità o meno di cer-te azioni nel campo della biologia sintetica. La visione del mondo come materiainerte da manipolare a piacimento si ripercuote sulla comprensione del nostrorapporto con la natura e del nostro concetto di specie75. La metafora del giocarea fare la parte di Dio e quella del vaso di Pandora implicano entrambe considera-zioni normative. È facile capire come i biologi di sintesi stiano confondendo indiversi modi molte delle nostre distinzioni culturalmente portanti.
Nella restante parte di questo articolo, vedremo come le metafore normativeimpiegate da chi si oppone alla biologia di sintesi, non siano meramente acciden-tali, bensì costitutive di un particolare modo di intendere la realtà e i nuovi pro-gressi scientifici. Tuttavia, non si tratta delle sole interpretazioni possibili dei pro-gressi biotecnologici. Le espressioni giocare a far la parte di Dio e aprire il vaso diPandora non dovrebbero essere liquidate come fossero semplice retorica. Nono-stante la vaghezza – e dunque la limitatezza – di tali concetti, sarebbe un errorenon prendere sul serio simili preoccupazioni da parte dell’opinione pubblica.Sembrano esserci, infatti, motivi piuttosto validi per invitare a procedere, nel
300 QUADERNI DELLA RICERCA
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 300
76 Ad es., «Per dire che un’azione è “contronatura”», scrive Kaebnick, «è necessario che uno abbia una cono-scenza chiara di cosa è “naturale” e di come e quando l’azione umana vi si oppone […]». Kaebnick (2009b, p. 24).
77 Ibid.78 Kaebnick (2009a, p. 1107).79 Nella sua critica all’uso della metafora del giocare a fare la parte di Dio nel contesto biomedico, ad es.,
Edmund Erde suggerisce che, diversamente dalle prescrizioni dirette di astenersi dal fare certe azioni (ad es., «Imedici non dovrebbero uccidere persone»), la frase «non è una vera e propria direttiva con un contenuto de-scrittivo». Cfr. Erde (1989, p. 596).
campo della biologia di sintesi, con estrema cautela e solo dopo adeguati control-li. Pertanto amplieremo adesso lo spettro metaforico al fine di mostrare tutta lasua importanza e il suo significato all’interno del nostro attuale dibattito politico.
(a) La critica a chi vuol giocare a far la parte di Dio e a chi vuol scoperchiareil vaso di Pandora
Entrambe le metafore normative sono state criticate in quanto troppo sempli-cistiche, vaghe o inutili. Dalla formulazione metafisica o teologica dell’argomen-tazione giocare a far la parte di Dio, non risulta immediatamente chiaro come sipossano distinguere i casi in cui gli esseri umani si sarebbero sostituiti a Dio o sa-rebbero intervenuti a modificare la natura: la stessa parola “natura” è ambigua76.Da un lato, abbiamo alterato per secoli il mondo naturale allevando animali,creando dighe, distruggendo foreste. Dall’altro lato, anche se potessimo tentaredi manipolare e modificare la vita, non potremmo mai farlo a partire dal nulla,dato che anche il nostro lavoro in laboratorio è sottoposto alle leggi della fisica.Pensare di poter tracciare una linea di demarcazione tra ciò che è naturale e ciòche non è naturale è un’operazione molto discutibile77. Per tale motivo, potrem-mo dire che, nella migliore delle ipotesi, la biologia di sintesi riuscirà soltanto adapprossimarsi ad una vera creazione. Mentre a Dio o ad un essere divino è in ge-nerale associato il concetto di creazione ex nihilo, nella sua “creazione”, la biolo-gia di sintesi non potrà che partire da materiali preesistenti78. Anche la sua for-mulazione epistemologica, che pone l’attenzione sul gioco incauto degli scienzia-ti, è da molti ritenuta poco credibile. La vera intenzione dei ricercatori è quelladi promuovere una gestione “responsabile” dei prodotti della biologia di sintesi.Inoltre, la preoccupazione epistemologica, espressa nella metafora giocare a farela parte di Dio, non sembra facilmente riducibile ad un principio morale o politi-co unitario che consenta di sanzionare o vietare determinate azioni79.
Quanto alle preoccupazioni per l’apertura del vaso di Pandora, in molti hannoespresso riserve, ma, anche secondo quanto dichiarato dalla Confederazione sviz-zera, sembra probabile che sia i sostenitori che i detrattori delle ricerche nel cam-po della biologia di sintesi, stiano esagerando nelle loro posizioni:
La mera speranza che tutto andrà bene non dovrebbe essere il principio guida per lamanipolazione di sostanze potenzialmente pericolose e organismi, non più di quanto lepaure debbano indurre a evitare qualsiasi azione. È evidente che, anche se ogni sviluppo
LA METAFORA MORALE E LE QUESTIONI EMERGENTI IN BIOETICA - J.A. RAHO 301
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 301
80 Swiss Confederation (2010, p. 23).81 Cfr. Van den Belt (2009).82 Cfr. Cho et al. (1999). Cfr. inoltre De S. Cameron e Caplan (2009, p. 1105): «Nessuna religione princi-
pale è contraria in linea di principio a che l’umanità cerchi di alterare l’ambiente naturale. Sono soprattutto icritici secolari della biologia di sintesi che invocano il divino per esprimere la loro inquietudine etica sulla bio-logia di sintesi». Cfr. Wolpe (2010).
83 Kaebnick (2000, p. 17).
tecnologico si basa su quanto avvenuto in passato, ciò che viene creato è in parte nuovo.[…] Le incertezze rimangono, e si è quindi di fronte ad una situzione di rischio tipico80.
Se è pur vero che la biologia di sintesi apre nuovi dibattiti sui rischi, è altret-tanto vero che questi rischi sono di difficile valutazione e quantificazione, poichérichiedono una previsione dettagliata di possibili situazioni future “scarsamenteprobabili” ma di “grande impatto”. Inoltre, qualsiasi valutazione dei rischi devetenere in considerazione i benefici attesi o soltanto possibili. La soluzione piùplausibile sarebbe quella di individuare una forma di controllo adeguata da partedei governi a livello nazionale e internazionale: a meno che la biologia di sintesinon comporti rischi estremi per l’umanità, dovrebbe essere consentito di proce-dere, con cautela, nella ricerche.
(b) Una riformulazione delle metafore del giocare a fare la parte di Dioe del vaso di Pandora
Nelle discussioni politiche, soprattutto in società pluralistiche, si ritiene spessoche l’unico tipo di discorso ammissibile sia quello traducibile in un linguaggio al-la portata dell’opinione pubblica. Per questo motivo, l’argomentazione del gioca-re a fare la parte di Dio è stata criticata, sebbene essa, come è stato fatto spessonotare, non presenti specifiche ingiunzioni teologiche81. Inoltre, in linea di prin-cipio, molte delle grandi religioni organizzate non sono contrarie alla biologiasintetica82. In quest’ultima sezione, estenderemo il concetto di giocare a fare laparte di Dio in modo da comprendervi l’idea laica del sacro. Così, sarà possibilevalutare la misura in cui esso può applicarsi al contesto della biologia di sintesi,tenendo presenti, al contempo, tutte le riserve sull’apertura del vaso di Pandora.
In un ambito puramente laico, l’espressione giocare a fare la parte di Dio puòritenersi un’affermazione religiosa senza riferimento ad uno speciale status on-tologico. La si potrebbe considerare una digressione sul sacro: «Qualcosa che èsacro ha un valore che trascende le cose umane nel senso che se ne fa esperien-za come avesse un valore indipendente da decisioni umane e da preferenze»83.Ad esempio, riteniamo spesso che i reperti storici, le culture e i capolavori arti-stici siano connotati da un valore innato o intrinseco. Così facciamo anche nellediscussioni di etica ambientale quando ci muoviamo per salvare una specie par-ticolare o una foresta nazionale. Conferire “sacralità” ad una cultura umana, adun manufatto storico, ad un’opera d’arte – ed anche alla “natura” – equivale ad
302 QUADERNI DELLA RICERCA
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 302
84 Ibid., p. 22.85 Wolpe (2010).86 Childress (20033, p. 1839).87 Kaebnick (2010).88 Kaebnick (2000, p. 22). L’autore continua, «Anche se è spesso assunto che il sacro solleva ingiunzioni
assolute […] non c’è nulla a proposito della nozione di sacro per come descritto qui che implica queste assolu-tezze. L’idea di un’ingiunzione assoluta è forse un residuo della versione religiosa del sacro, in cui il valore diqualcosa trascende i valori umani in virtù della sua relazione con ciò che trascende le vite umane».
ammetterne un valore intrinseco e si tratta di un giudizio che può ritenersi coe-rente anche nell’ambito di una morale meramente secolare84.
Muovendo da questa idea di sacro, possiamo affrontare le incertezze etichedella biologia di sintesi adottando un atteggiamento di stupore. Per dirla conWolpe: «Cominciamo col premettere che la vita è rara e preziosa, che la nostrabiosfera è fragile e singolare e di un valore inestimabile, e che ci siamo evolutiper essere i custodi del pianeta, e suoi custodi molto potenti»85. Su tali basi si po-trebbe sostenere che determinati interventi sulla natura potrebbero, se orientatiin maniera impropria, farci “giocare” la parte di Dio – non usurpando letteral-mente il ruolo del divino, ma oltrepassando determinate soglie, confini certi diun comportamento appropriato.
Un’ulteriore versione della metafora del giocare a fare la parte di Dio mostra l’im-portanza di porre domande intimamente connesse al fine – non in sensoteleologico, ma cercando di fare chiarezza sugli scopi, sui benefici e sui danni. Un’a-nalisi etica di tale questione non muove esclusivamente da considerazioni di carat-tere intrinseco (ad es., la biologia di sintesi è sbagliata in sé) o da preoccupazioniper eventuali conseguenze delle sue applicazioni. L’etica in questo senso non è ungioco a somma zero: non è questione di una metodologia etica vincente che laspunti sulle altre. Piuttosto, la metafora del giocare a fare la parte di Dio – intesa co-me ammonizione a non oltrepassare una certa soglia – può abbracciare una gammadi possibili interventi e risultati valutandone la desiderabilità o l’indesiderabilità.Questo, naturalmente, consente di anticipare le probabili conseguenze di un’aper-tura del vaso di Pandora. È possibile che debbano essere i biologi di sintesi ad averel’onere di fornire la prova dell’evidenza di una diminuzione del rischio. Potremmoinoltre aggiungere che, allo stato attuale delle cose, la biologia di sintesi non costi-tuisce una grave minaccia sebbene meriti una particolare attenzione per le sue futu-re applicazioni. In altre parole, una sospensione della ricerca per paura di cammi-nare su un terreno scivoloso (anche in questo caso si tratta di una metafora suilimiti86), non sembra giustificabile. Anche se i ricercatori del J. Craig Venter Institu-te non avessero “creato” la vita in senso stretto («hanno preso una cellula naturale evi hanno inserito la versione sintetica di un genoma naturale»87), ci sentiremmo au-torizzati a richiedere di procedere con cautela, effettuando accertamenti adeguati.
Naturalmente, una simile prospettiva sul “sacro” è limitata per molteplici ra-gioni. In primo luogo, non disponendo di alcuna ingiunzione assoluta, non èesattamente chiaro che cosa venga richiesto88. Inoltre, la genericità del concetto
LA METAFORA MORALE E LE QUESTIONI EMERGENTI IN BIOETICA - J.A. RAHO 303
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 303
89 Ibid.90 Ibid.
di sacro rappresenta un problema. Come ha osservato Kaebnick, «non è ovvioche le cose siano sacre, né ovvi sono i divieti o le condizioni che generano il sa-cro»89. Per questo motivo, dovremmo attenerci al modello ambientalistico90: an-che se possono darsi le condizioni per l’abbattimento di una foresta o per inter-venire sulla natura – con interventi ritenuti da alcuni indesiderabili – ciò nonesclude la possibilità che si possa giocare in maniera responsabile.
5.Conclusioni
Gran parte del nostro linguaggio quotidiano è un linguaggio metaforico. Lemetafore ci permettono di dare un senso al nostro mondo, di articolare e riferireinformazioni complesse, idee, sentimenti ed esperienze personali. In questo arti-colo si è discussa la metafora all’interno della riflessione filosofica contempora-nea, con particolare attenzione alle metafore nel campo della biologia di sintesi.Come si è visto, è molto difficile esprimersi senza far uso di metafore, soprattuttoquando parliamo di complesse teorie scientifiche. Non sono soltanto i poeti e gliscrittori a servirsene, come si è spesso ritenuto, ma esse sono impiegate anche dascienziati, da filosofi, e dagli esperti di bioetica.
Uno degli scopi di questo lavoro è stato quello di dimostrare come le metaforenon abbiano una mera funzione descrittiva, ma anche valutativa rispetto a ciò chesta accadendo e a ciò che dovrebbe accadere. Tra le quattro concezioni metafori-che prese in esame, si è sostenuto che la terza (quella di Black), assieme alla posi-zione di Lakoff e Johnson, dovrebbero far da guide nell’analisi della biologia disintesi. Ciò significa che le metafore del giocare a fare la parte di Dio e del vaso diPandora dipendono, almeno in parte, dal sistema dei luoghi comuni associati(Black) e dalle implicazioni attraverso cui esse mettono in luce e rendono coerenticerti aspetti della nostra esperienza (Lakoff e Johnson). L’impiego principale dellametafora del giocare a fare la parte di Dio è nel senso di una trasgressione dei limi-ti stabiliti in natura e, pertanto, può essere riferito ai luoghi comuni associati di unessere divino. La preoccupazione di trasgredire un certo ordine, o di interferire inuna certa sfera “creazionista”, è alla base di un sentimento comune nella nostraesperienza – l’inquietudine per un eventuale misconoscimento dei limiti del no-stro sapere. È questa preoccupazione a dar luogo alle inquietudini espresse nellametafora del vaso di Pandora. Essa, come abbiamo visto, dà inoltre luogo alle me-tafore del cavallo di Troia e del Dott. Stranamore. Tutto sommato, entrambe lemetafore devono farci porre delle domande. La biologia di sintesi è un invito adaprire il vaso di Pandora? Cosa vuol dire “progettare” e “assemblare” degli orga-nismi? Siamo noi a doverlo fare? È sempre vantaggioso “manipolare” o “armeg-giare” con l’ordine naturale delle cose? Che tipo di rischi si possono correre?
304 QUADERNI DELLA RICERCA
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 304
91 Scrivono: «[N]ella costruzione dei sistemi biologici dall’inizio alla fine», i biologi di sintesi sperano di«creare sistemi biologici che funzionino come computer o fattorie, producendo i prodotti che vogliamo, quandolo vogliamo e nella misura in cui vogliamo». Parens, Johnston, e Moses (2009, p. 6) (corsivo mio).
92 Cfr., ad es., De Lorenzo (2011).
Quali sono le condizioni di impiego delle metafore? In primo luogo, la forza diuna metafora dipende dalla sua capacità di far chiarezza su una questione. Si po-trebbe pensare pertanto di rinunciare all’impiego di una determinata metafora nelcaso in cui essa risultasse eccessiva o non rappresentasse la realtà in maniera ade-guata. Secondo alcune descrizioni della biologia di sintesi, come quella data daParens e colleghi91, dobbiamo stare attenti a ciò che la metafora implica. Forse,quando il linguaggio scientifico è espresso in questi termini, non dovrebbe sor-prendere che l’opinione pubblica avanzi profonde riserve sugli scienziati che ma-nipolano i microrganismi e che “giocano” con essi. Non dovrebbe stupire, inoltre,che lo stesso pubblico ricorra spesso alla metafora morale. Per chi lavora in cam-po scientifico ed è frustrato dall’adozione di metafore fuorvianti – da parte sia del-l’opinione pubblica che della stampa92 – sarebbe a mio avviso auspicabile un mu-tamento nelle metafore descrittive. Poiché, infine, la metafora del giocare a fare laparte di Dio si fonda su una concezione della natura che è, nella migliore delle ipo-tesi, discutibile, dovrebbe essere la metafora del vaso di Pandora a guidare le no-stre riflessioni etiche sulla biologia di sintesi. I compiti saranno, d’ora in avanti,quello di tentare di comprendere meglio le implicazioni e le conseguenze dellamanipolazione dei fondamenti della “natura” e, inoltre, quello di vedere se i fruttidella nuova scienza, metaforicamente parlando, giungeranno a maturazione.
Bibliografia
Almansi A., Paradisi E. (a cura di) (1983), Modelli Archetipi Metafore, Pratiche Editrice,Parma.
Bazzanella C. (a cura di) (2009), La forza cognitiva della metafora, «Paradigmi. Rivista dicritica filosofica», XXVII, 1, pp. 1-208.
Black M. (1954-1955), Metaphor, «Proceedings of the Aristotelian Society», New Series,55, pp. 273-294; trad. it. A. Almansi, E. Paradisi (a cura di), Metafora, in Modelli Ar-chetipi Metafore, Pratiche Editrice, Parma 1983, pp. 41-66.
Black M. (1979a), More About Metaphor, in A. Ortony, (a cura di), Metaphor & Thought,Cambridge University Press, Cambridge, pp. 19-43; trad. it. Id. (a cura di), Ancora sul-la metafora, inModelli Archetipi Metafore, Pratiche Editrice, Parma 1983, pp. 97-135.
Black M. (1979b), How Metaphors Work: A Reply to Donald Davidson, «Critical In-quiry», 6, 1, pp. 131-143.
Boldt J., Müller O. (2008), Newtons of the leaves of grass, «Nature Biotechnology», 26, 4,pp. 387-389.
LA METAFORA MORALE E LE QUESTIONI EMERGENTI IN BIOETICA - J.A. RAHO 305
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 305
Buchanan A., Powell R. (2010), The Ethics of Synthetic Biology: Suggestions for a Com-prehensive Approach, disponibile in rete al sito: http://www.bioethics.gov/docu-ments/synthetic-biology/The-Ethics-of-Synthetic-Biology-Suggestions-for-a-Com-prehensive-Approach.pdf
Caplan A.L. (2010), Testimony of Arthur L. Caplan to the Presidential Commission for theStudy of Bioethical Issues, disponibile in rete al sito: http://www.bioethics.gov/docu-ments/synthetic-biology/Testimony-of-Arthur-L-Caplan.pdf
Capurro R., Kinderlerer J., Martinho da Silva P., Rosell P.P. (2009), Ethics of SyntheticBiology, Opinion n. 25 del European Group on Ethics in Science and New Technolo-gies to the European Commission, disponibile in rete al sito: http://ec.europa.eu/be-pa/european-group-ethics/docs/opinion25_en.pdf
Casarett D., Pickard A., Fishman J.M. et al. (2010), Can Metaphors and Analogies Impro-ve Communication with Seriously Ill Patients?, «Journal of Palliative Medicine», 13, 3,pp. 255-260.
Childress J.F. (1997), Metaphor and Analogy in Bioethics, in J.F. Childress (a cura di),Practical Reasoning in Bioethics, Indiana University Press, Bloomington, pp. 3-24.
Childress J.F. (20033) Metaphor and Analogy, in S.G. Post (a cura di), Encyclopedia ofBioethics, Macmillan Reference USA, New York, pp. 1834-1843.
Childress J.F., Siegler M. (1997), Metaphors and Models of Doctor-Patient Relationships:Their Implications for Autonomy, in Id., Practical Reasoning in Bioethics, Indiana Uni-versity Press, Bloomington, pp. 44-55.
Cho M.K., Magnus D., Caplan A.L., McGee D., the Ethics of Genomics Group (1999),Ethical Considerations in Synthesizing a Minimal Genome, «Science», 286, 5447, pp.2087-2090.
Coady C.A.J. (2009), Playing God, in J. Savulescu, N. Bostrum, (a cura di), HumanEnhancement, Oxford University Press, New York, pp. 155-180.
Cserer A., Seiringer, A. (2009), Pictures of Synthetic Biology: A reflective discussion of therepresentation of Synthetic Biology (SB) in the German-language media and by SB ex-perts, «Systems and Synthetic Biology», 3, 1-4, pp. 27-35.
Dabrock P. (2009), Playing God? Synthetic biology as a theological and ethical challenge,«Systems and Synthetic Biology», 3, 1-4, pp. 47-54.
Davidson D. (1978), What Metaphors Mean, «Critical Inquiry» (Special Issue on Me-taphor), 5, 1, pp. 31-47; trad. it. R. Brigati (a cura di), Che cosa significano le metafore,in Verità e interpretazione, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 337-360.
De Lorenzo V. (2011), Beware of metaphors: Chasses and orthogonality in synthetic bio-logy, «Bioengineered Bugs», 2, 1, pp. 3-7.
De S. Cameron N.M., Caplan A. (2009), Our synthetic future: Two prominent ethicistsprovide their views on the ethical debates surrounding synthetic biology, «Nature Biote-chnology», 27, 12, pp. 1103-1105.
Douglas T., Savulescu J. (2010), Synthetic biology and the ethics of knowledge, «Journal ofMedical Ethics», 36, 11, pp. 687-693.
306 QUADERNI DELLA RICERCA
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 306
Erde E.L. (1989), Studies in the Explanation of Issues in Biomedical Ethics: (II) On ‘OnPlay[ing] God’, etc., «Journal of Medicine and Philosophy», 14, 6, pp. 593-615.
Gagliasso Luoni E.G. (2009), La metafora di individuo in biologia, in Id., La forza cogniti-va della metafora, «Paradigmi. Rivista di critica filosofica», XXVII, 1, pp. 137-146.
Gibson D.G., Glass J.I., Lartigue C. et al. (2010), Creation of a Bacterial Cell Controlledby a Chemically Synthesized Genome, «Science», 329, 5987, pp. 52-56, disponibile inrete al sito: http://www.sciencemag.org/content/329/5987/52.full.pdf
J. Craig Venter Institute (2011), disponibile in rete al sito: http://www.jcvi.org/cms/re-search/projects/first-self-replicating-synthetic-bacterial-cell/overview/
Kaebnick G.E. (2000), On the Sanctity of Nature, «Hastings Center Report», 30, 5, pp.16-23.
Kaebnick G.E. (2009a), Should moral objections to synthetic biology affect public policy?,«Nature Biotechnology», 27, 12, pp. 1106-1108.
Kaebnick G.E. (2009b) ‘It’s Against Nature’, «Hastings Center Report», 39, 1, pp. 24-26.Kaebnick G.E. (2010) Synthetic Biology, Analytic Ethics, «Hastings Center Report», 40,
4, p. 49.Kirklin D. (2007), Truth Telling, Autonomy and the Role of Metaphor, «Journal of Medi-
cal Ethics», 33, 1, pp. 11-14.Lakoff G., Johnson M. (1980a [20032]) Metaphors We Live By, University of Chicago
Press, Chicago; trad. it. P. Violi (a cura di), Metafora e Vita Quotidiana, Espresso Stru-menti, Milano 1982.
Lakoff G., Johnson M. (1980b), Conceptual Metaphor in Everyday Language, «Journal ofPhilosophy», 77, 8, pp. 453-486.
Lakoff G., Johnson M. (2003) Afterward 2003, in Id., Metaphors We Live By, Universityof Chicago Press, Chicago 20032, pp. 243-276.
Leezenberg M. (2001), Contexts of Metaphor, Elsevier, Amsterdam.Lego (2011), disponibile in rete al sito: http://aboutus.lego.com/en-us/group/legobrick.
aspxLetter to Dr. Amy Gutmann (2010), disponibile in rete al sito: http://bioethics.gov/cms/
sites/default/files/news/Letter-from-President-Obama-05.20.10.pdfMalone R.E. (1999), Policy as Product: Morality and Metaphor in Health Policy Discourse,
«Hastings Center Report», 29, 3, pp. 16-22.Midgley M. (2000), Biotechnology and Monstrosity: Why We Should Pay Attention to the‘Yuk Factor’, «Hastings Center Report», 30, 5, pp. 7-15.
Murdoch I. (1951-1952), Nostalgia for the Particular, «Proceedings of the Aristotelian So-ciety», New Series, 52, pp. 243-260; trad. it. P. Conradi (a cura di), Nostalgia del parti-colare, in Esistenzialisti e Mistici: Scritti di filosofia e letteratura, il Saggiatore, Milano2006, pp. 74-87.
Parens E., Johnston J., Moses J. (2009), Ethical Issues in Synthetic Biology: An overviewof the debates, Woodrow Wilson International Center for Scholars, disponibile in reteal sito: http://www.synbioproject.org/process/assets/files/6334/synbio3.pdf
LA METAFORA MORALE E LE QUESTIONI EMERGENTI IN BIOETICA - J.A. RAHO 307
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 307
Pauwels E. (2009), Review of quantitative and qualitative studies on U.S. public percep-tions of synthetic biology, «Systems and Synthetic Biology», 3, 1-4, pp. 37-46.
Periyakoil V.S. (2008), Using Metaphors in Medicine, «Journal of Palliative Medicine»,11, 6, pp. 842-844.
Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues (2010), New Directions: TheEthics of Synthetic Biology and Emerging Technologies, Government Printing Office,Washington, D.C., disponibile in rete al sito: http://bioethics.gov/cms/sites/default/fi-les/PCSBI-Synthetic-Biology-Report-12.16.10.pdf
Rejeski D. (2010), Testimony before the Presidential Commission for the Study of Bioethi-cal Issues, disponibile in rete al sito: http://bioethics.gov/cms/node/169
Richards I.A. (1936), The Philosophy of Rhetoric, Oxford University Press, Oxford; trad.it. B. Placido (a cura di), La filosofia della retorica, Feltrinelli, Milano 1967.
Ricoeur P. (1978), The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and Feeling, «Cri-tical Inquiry» (Special Issue on Metaphor), 5, 1, pp. 143-159.
Scully J.L. (2001), Drawing a Line: Situating Moral Boundaries in Genetic Medicine,«Bioethics», 15, 3, pp. 189-204.
Swiss Confederation (2010), Synthetic Biology - Ethical considerations. Report of the Fe-deral Ethics Committee on Non-Human Biotechnology ECNH, disponibile in rete alsito: http://www.ekah.admin.ch/fileadmin/ekah-dateien/dokumentation/publikatio-nen/e-Synthetische_Bio_Broschuere.pdf
Turbayne C.M. (1970), The Myth of Metaphor, Revised Edition, University of SouthCarolina Press, Columbia.
Van den Belt H. (2009), Playing God in Frankenstein’s Footsteps: Synthetic Biology andthe Meaning of Life, «Nanoethics», 3, 3, pp. 257-268.
What’s in a name? (senza autore) (2009), «Nature Biotechnology», 27, 12, pp. 1071-1073.
Wolpe P.R. (2010), Testimony before the President’s Commission for the Study of Bioethi-cal Issues, disponibile in rete al sito: http://bioethics.gov/cms/node/169
Wurzbach M.E. (1999), The moral metaphors of nursing, «Journal of Advanced Nur-sing», 30, 1, pp. 94-99.
308 QUADERNI DELLA RICERCA
16Raho 287:Layout 1 20-09-2012 9:49 Pagina 308
Edizioni ETSPiazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
[email protected] - www.edizioniets.comFinito di stampare nel mese di settembre 2012
18Autori 317:Layout 1 20-09-2012 9:48 Pagina 322