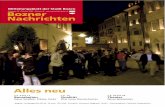Sintesi italiana del volume Selinus II. Die punische Stadt auf der Akropolis (2011).
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Sintesi italiana del volume Selinus II. Die punische Stadt auf der Akropolis (2011).
Sinrtesi italiana �75
1 Osservazionipreliminari
La ricerca sulle case di Selinunte intende contribuire alla fruizione di un aspetto centrale del mondo punico, la cultura domestica. Primo fine è un’accurata descrizione dell’archi-tettura domestica e dell’urbanistica. L’esposizione dell’archi-tettura domestica in forma di catalogo, discussione sintetica e classificazione comparativa delle abitazioni dal punto di vista dell’edilizia, della forma e dell’arredamento costituisce il fondamento per l’interpretazione delle case.
Al centro della ricerca è la descrizione della cultura del-l’abitare a Selinunte nel periodo dall’inoltrato IV alla prima metà del III sec. a. C. Una cultura non è mai un sistema sta-tico, in sé conchiuso, ma prevede sempre molti cambiamenti radicali, che possono essere causati da fattori differenti. In relazione all’edilizia domestica di Selinunte un fattore par-ticolarmente forte fu il contatto con l’ambiente greco, che a
Selinunte raggiunse grande intensità, poiché la città punica si trovava sul sito della fondazione greca e vicino alla Sicilia orientale, dominata dai Greci. L’abitato punico deve essere inquadrato nel campo dei rapporti tra la cultura punica e quella greca, nel quale verrà trattato in specie l’aspetto del-l’ellenizzazione dell’architettura domestica punica.
Le abitazioni che verranno esaminate sono state scavate da archeologi italiani alla fine del XIX e nel XX secolo, nel corso della direzione della Soprintendenza da parte di Francesco S. Cavalleri, Ettore Gàbrici, Jole Bovio Marconi, Giuseppe Cultrera e Vincenzo Tusa. Nel �996 Dieter Mertens ha iniziato la compilazione di un atlante delle strutture murarie conser-vate, che doveva coprire l’area sud-orientale dell’acropoli. L’atlante dei resti di Selinunte è stato ultimato nel �004 e costituisce l’essenziale fondamento per lo studio, l’analisi e l’interpretazione delle murature puniche, come d’altronde di quelle di epoca greca e medievale. Le conclusioni si basano in parte sulla valutazione dei diari di scavo. In primo luogo sono
VII Sintesi italiana
Abb. VII 1 L’acropoli di Selinunte
Teil VII�76
però il frutto di reiterate ricognizioni dei resti archeologici, durante le quali sono stati notati ulteriori dettagli e sono state definite le planimetrie delle abitazioni.
2 Lacornicecronologica
I sondaggi diretti da Dieter Mertens ed effettuati da chi scri-ve nelle campagne �996, �998 e �000, tesi in primo luogo a chiarire la cronologia dell’abitato punico di Selinunte nel IV sec. a. C., hanno afffrontato tre interrogativi:Quando fu rioccupato il sito dopo la distruzione di Selinunte nel 409?Nel IV secolo Selinunte fu abitata in modo continuativo o fasi di vita si alternarono a periodi di abbandono?La città venne effettivamente abbandonata alla metà del III secolo?
Il materiale ceramico dei sondaggi e della cisterna offre uno scarno riferimento. L’insieme dei singoli risultati compone però un quadro conclusivo che permette una valutazione preliminare:
Dopo la distruzione di Selinunte la città fu abitata per poco tempo. Poco dopo il sito venne abbandonato e nei decenni successivi fu frequentato appena o affatto. Solo nell’ultimo quarto del IV sec. a. C. la città venne di nuovo popolata da molti abitanti e fiorì per poco tempo. Nel corso della prima metà del III sec. a. C. si osserva una nuova cesura: alla metà del III sec. a. C. la città venne di nuovo abbandonata. Man-cano del tutto resti di epoca romana; la ceramica medievale attesta un’occupazione in periodo svevo. I dati archeologici si confrontano bene con la tradizione scritta, in particolare con l’opera storica di Diodoro.
3 L’assettoplanimetricodelleabitazioni
La suddivisione delle abitazioni in pochi gruppi, che in qual-che caso forza i resti antichi, è finalizzata a metterne in luce aspetti comuni e differenze nell’assetto. Occorre chiarire un possibile equivoco: non si deve credere che con l’espressione »tipo edilizio« (Haustyp) si pensi che nell’antichità esistesse un catalogo esemplare di tipi. Per i motivi, che verranno spe-cificati oltre, è impensabile che la spesso differente edilizia domestica di Selinunte venisse realizzata secondo una serie fissa di modelli. La definizione di tipi comporta spesso il pe-ricolo della formazione dei raggruppamenti. A seconda della valutazione dei criteri si possono formare differenti gruppi, in modo da limitare spesso la possibilità di comparare tra loro i tipi edilizi. È quindi opportuno definire in ordine di importanza i criteri rilevanti per la formazione dei gruppi, che si basano su determinati aspetti delle planimetrie:
�. Posizione e accesso del cortile�. Connessione dei singoli ambienti�. Estensione dell’abitazione4. Numero degli ambienti (piano superiore?)5. Allestimento (funzionale e decorativo)6. Qualità della muratura
Queste caratteristiche permettono di riconoscere quattro tipi planimetrici, che si possono suddividere in varianti. Il principale risultato è la conclusione che nelle abitazioni le stanze sono ordinate intorno a un ambiente a cielo aperto. Il cortile� è stato sicuramente l’elemento principale e carat-teristico delle abitazioni puniche. La posizione, l’estensione e la forma del cortile rappresentano infatti i criteri principali per ulteriori suddivisioni. All’interno dei quattro gruppi le planimetrie variano in modo evidente.
Tipo � – Casa con cortile centrale allungato (�5 esempi) Variante a – con ambienti laterali anteriori (�/�–�/�0) Variante b – senza ambienti laterali anteriori (�/��–�/��) Variante c – ridotta a una fila di ambienti longitudinale
(�/�4–�/�5)
Tipo � – Casa con cortile centrale e corridoio (Korridorho-fhaus) (�8 esempi)
Variante a – con corridoio lungo (�/�6–�/�6) Variante b – con corridoio corto (�/�7–�/��)
Tipo � – Casa con cortile nell’angolo (�� esempi) Variante a – con muri del cortile (�/�4–�/4�) Variante b – senza muri del cortile? (�/4�–�/46)
Tipo 4 – Casa con cortile centrale quadrato (7 esempi) Variante a – con ambienti laterali anteriori (�/47–�/50) Variante b – senza ambienti laterali anteriori (�/5�–�/5�)
Fuori tipologia – alcune abitazioni (6 esempi) non possono essere incluse in questi gruppi (�/54–�/59)
Elemento comune a tutte le abitazioni è l’ambiente a cielo aperto, che non si apriva sulla strada, ma che era accessibile tramite una porta o anche un corridoio.
Gli ambienti della casa non erano accessibili dalla strada, altrimenti avrebbero avuto la funzione di negozi. Le abita-zioni erano edifici chiusi verso l’esterno, nei quali il cortile assumeva la funzione di divisione. Direttamente dal cortile erano accessibili tutti gli ambienti. In molte abitazioni erano previsti anche alcuni ambienti, che si potevano raggiungere da un vano coperto. Le stanze accessibili tramite un ambiente di passaggio avevano spesso il carattere di stanza secondaria. Le case erano quindi dal punto di vista planimetrico case
� Un ambiente a cielo aperto è indiziato da numerosi elemen-ti: il lastricato, i solchi sulle pareti per l’acqua piovana, i canali di scolo presenti qui e quelli diretti da questo ambiente verso la strada indicano che l’ambiente era esposto agli agenti atmosfe-rici. In questo senso può essere valutata spesso anche la tecnica muraria. Le parti murarie rivolte verso i cortili interni sono infatti realizzate con pietre di grandi dimensioni come quelle affacciate sulla strada. Inoltre la rifinitura delle soglie lascia capire che le porte affacciate sul cortile battevano regolarmente verso l’am-biente interno. Anche la forma irregolare della superficie indica un ambiente a cielo aperto, che si sarebbe potuto a stento coprire con un soffitto.
Sinrtesi italiana �77
corte, poiché le stanze non erano disposte in profondità. La mancanza di ambienti disposti in serie e la posizione delle stanze vicino al cortile, dal quale tramite le porte riceveva-no aria e luce, rendevano d’altro canto le abitazioni simili a edifici aperti al loro interno. Le abitazioni erano così allo stesso tempo chiuse all’esterno e aperte all’interno. Tutte le case con cortile, con una sola eccezione (Kat.-Nr. �/45), non erano mai isolate sulle quattro pareti, ma erano piuttosto appoggiate l’una all’altra.
4 L’allestimentodelleabitazioni
a I pavimenti
Nei cortili e nei corridoi delle abitazioni selinuntine di pe-riodo punico il rivestimento pavimentale è costituito da un lastricato di pietre irregolari e/o di frammenti di laterizi. Nelle stanze interne venivano di solito usati pavimenti battuti di terra, argilla e marna di calce. I pavimenti di cocciopesto venivano impiegati nelle stanze adibite all’uso di acqua, in locali previsti per la vendita, in ambienti sacri e abitativi di particolare pregio. I pavimenti con gettate di malta, pur privi di una decorazione figurata o ornamentale, venivano tuttavia in molti casi ornati con file di tessere calcaree.
Sono stati classificati e ordinati in una tipologia tutti i pavimenti di Selinunte a me noti (Katalog Nr. �). I criteri di differenziazione sono stati il numero degli strati di malta sovrapposti e la cura nell’assetto della superficie.
Tipo �: Semplice pavimento a gettata di malta: 5–6 esempi, il migliore dei quali è Kat.-Nr. �/�.
Tipo �: Doppio pavimento a gettata di malta: preparazione e strato superiore più sottile: �� esempi, il migliore dei quali è Kat.-Nr. �/�4.
Tipo �: Semplice pavimento a gettata di malta, con fram-menti o piccole pietre.
a) mescolati nell’impasto: �–6 esempi, il migliore dei quali è Kat.-Nr. �/��
b) premuti dall’alto: 5 esempi, il migliore dei quali è Kat.-Nr. �/�9
Tipo 4: Doppio pavimento a gettata di malta con fram-menti o piccole pietre premuti dall’alto:
5 esempi, il migliore dei quali è Kat.-Nr. �/�4. Tipo 5: Semplice pavimento a gettata di malta con piccole
pietre poste l’una vicino all’altra: � esempio Kat.-Nr. �/�6.
Questi tipi di pavimenti, sviluppati nel corso del IV sec. a. C., sono considerati di origine punica. Viene proposta l’ipotesi che pone lo sviluppo del pavimentum signinum in pavimentum tessellatum al più tardi nella seconda metà del III sec. a. C.
b La decorazione architettonica
Elementi edilizi in assetto architettonico ricorrono solo di rado nelle abitazioni di Selinunte. Le poche parti architet-
toniche si trovano nel cosiddetto giardino dell’architettura nel settore meridionale dell’acropoli o giacciono lungo l’asse nord-sud, in ogni caso prive di luogo di ritrovamento e di contesto edilizio. Soltanto nei resti di un’abitazione situata a ovest del tempio A sono tuttora conservati frammenti ar-chitettonici, che si possono attribuire a un ordine. Inoltre si può ricostruire una facciata di rappresentanza nel cortile di un’abitazione presso l’asse nord-sud grazie a una parte edilizia profilata e ai resti della muratura conservati in situ. Nel Kat.-Nr. 4 sono inoltre incluse altre parti edilizie caratteristiche, quali architravi e basi, la cui posizione si può dedurre nel contesto edilizio.
Solo in poche abitazioni del settore indagato si può documentare un allestimento con elementi edilizi parti-colarmente curati. Caratteristico è l’uso della decorazione a stucco, simile a quelle attestate a Cartagine, nella Sicilia occidentale, a Pompei e nell’Oriente greco. L’impiego su larga scala di intonaco e stucco nell’architettura domestica divenne comune a Selinunte già alla fine del IV sec. a. C. I reperti da Kerkuan documentano che anche nel territorio circostante Cartagine l’uso dello stucco era diffuso nello stesso periodo. Dal punto di vista formale e stilistico gli elementi architet-tonici in stucco di Selinunte si inseriscono nella temperie culturale tipica del repertorio formale greco. Il profilo atipico delle basi costituisce forse una componente dell’architettura domestica punica.
c Le cisterne
In alcune case della città si trovano sui pavimenti aperture circolari o rettangolari, che rimandano a riserve idriche naturali quali pozzi o artificiali quali cisterne. Poiché queste non sono state sinora indagate in modo sistematico, nel Kat.-Nr. 5 sono state inserite in modo preliminare soltanto quelle imboccature tra le �0 note, che sono state illustrate con indicazione più dettagliate. In tutti i dieci casi classificati si tratta di cisterne e non di pozzi.
Caratteristica del tipo � è la forma allungata e con i lati brevi arrotondati, che in letteratura viene spesso definita ci-sterna a bagnarola. I quattro esempi documentati a Selinunte (Kat.-Nr. 5/�, 5/�, 5/4 e 5/5) contano una lunghezza compresa tra � e 5 m e una larghezza tra 0,8 e �,� m.
La cisterna del tipo � è simile in lunghezza (�, 7 e �,� m) e larghezza (� m), ma presenta una pianta a L senza angoli arrotondati (Kat.-Nr. 5/7).
Nel tipo � sono state inserite le riserve idriche a forma di sacco, che sotto l’imboccatura si allargano come una caraffa, spesso definite cisterne a bottiglia (Kat.-Nr. 5/8 e 5/9).
Come tipo 4 è stata classificata in modo provvisorio la cisterna a due navate Kat.-Nr. �, nonostante non sia chiaro, se si tratta di un gruppo o di un unico esemplare. Questa cisterna è larga più del doppio rispetto alle cisterne allunga-te dei tipi � e �. Le pareti ben connesse del serbatoio idrico, unitamente alla diversa forma del contenitore, indicano che si tratta di una cisterna greca, che fu nuovamente utilizzata in periodo punico.
Le planimetrie delle abitazioni inducono a concludere che le cisterne, indipendentemente dalla propria tipologia, si trovano in specie nelle abitazioni di grande estensione,
Teil VII�78
meglio dotate anche di pavimenti in cocciopesto e intonaco parietale.
Le cisterne a bagnarola del tipo � presentano grandezza e caratteristiche costruttive del tutto simili agli esempi trovati a Cartagine. Nei siti punici in Sardegna accanto alle cisterne a bagnarola si trovano anche cisterne a L (tipo �). Gli esempi sardi sono molto simili a quelli di Cartagine e di Selinunte per quanto riguarda grandezza e caratteristiche costruttive. Nelle abitazioni a Byrsa accanto a cisterne a bagnarola di varia lunghezza vennero scavati nel terreno anche serbatoi per l’acqua a forma di bottiglia. Le cisterne selinuntine del tipo � non devono perciò necessariamente risalire alla fase greca, anche se contenitori idrici di questa forma furono di uso corrente nel mondo greco.
Nei siti punici in Sardegna, Sicilia e a Cartagine cisterne si trovano regolarmente nelle abitazioni. Con una buona manu-tenzione delle cisterne vi si poteva conservare acqua pulita, anche se per il gusto era preferita l’acqua fresca ottenuta dalle sorgenti. La presenza di una cisterna in un’abitazione costi-tuiva per gli abitanti un notevole alleggerimento di lavoro, poiché evitava la fatica del trasporto dell’acqua necessaria alla cura del corpo e alle attività domestiche. L’acqua, che era sempre disponibile e presumibilmente specie in estate serviva a raffreddare le stanze e ai lavaggi corporei, potreb-be aver elevato la qualità della vita e la considerazione degli abitanti della casa.
5 Allestimentofunzionaleeusodellestanze
Attrezzature immobili quali vasche da bagno, trogoli, mor-tai, doli, presse olearie, Viertelkreise� e forni lasciano capire l’uso delle case. Senza dubbio il ritrovamento in situ di una vasca da bagno indica che l’ambiente era usato come stanza da bagno. In questo caso e anche in presenza delle altre at-trezzature occorre però tenere presente che l’ambiente non deve essere stato utilizzato per forza soltanto in questo modo. Le indicazioni devono essere intese soltanto come indizi per una destinazione, che non ne esclude una seconda (stanza da bagno e cucina), che in qualche caso è poco probabile (stanza da bagno e stalla). Focolari e forni per il pane permettono una destinazione a cucina. I trogoli costituiscono indizi per un uso come stalla. I mortai, necessari per la preparazione del cibo, corroborano l’interpretazione come ambienti fun-zionali. I doli٩ alludono a magazzini. Il Viertelkreis allestito nell’angolo di una stanza indica un ambiente funzionale, forse un magazzino o una cucina.
Le diverse planimetrie delle case e le differenti suddivisioni degli ambienti ostacolano ulteriormente l’interpretazione della funzione per stanze prive di attrezzature, di installazio-ni e di un allestimento soltanto in base alla posizione e alle dimensioni. Dal confronto con la dislocazione degli apparati funzionali e decorativi si ricavano tuttavia caratteri costanti, che permettono di determinare la destinazione delle singole stanze in base alla posizione, alla forma e alle dimensioni.
� Strutture in forma di quarto di cerchio (cfr. catalogo 7).
A Selinunte sono conservate otto stanze da bagno, adia-centi al cortile e in media di appena tre metri quadrati l’una. In due abitazioni (Kat.-Nr. �/�0 e �/44) due vasche da bagno sono conservate in una stanza chiaramente più grande. Possiamo quindi concludere che il bagno non aveva sempre luogo in un ambiente specifico.
Nei resti conservati dell’intera area urbana sono stati contati appena cinque focolari, che indicano come le stanze fossero adibite alla cottura del cibo. Tutti i focolari si trovano in un ambiente coperto sul cortile. La cucina nella casa �/4 (k) è la meglio conservata: accanto a pietre dritte davanti alla parete meridionale furono allestiti anche un alto Viertelkreis e un basso bacile rivestito di cocciopesto. Nella seconda fase costruttiva dell’abitazione l’ambiente divenne accessibile dal cortile e ebbe un’estensione di circa �5 metri quadrati. La forma e la grandezza della stanza non sono tuttavia così specifiche, per identificare ulteriori cucine in ambienti di analoghe tipologie.
Lo stesso si verifica per gli ambienti adibiti a forni. Soltanto pochi forni per il pane (cinque esempi) permettono di identi-ficare le stanze, nelle quali veniva cotto il pane, tutte coperte da un tetto. I tannur non erano al centro della stanze, ma in tre casi sono negli angoli e si appoggiano alle pareti.
Circa 5 metri quadrati costituivano forse l’estensione minima di una stalla, destinata a un animale. In stalle più grandi, estese anche più di �0 metri quadrati, potevano es-sere ospitati più animali. Una stalla era prevista in una casa su tre (�9 su 59).
Nelle abitazioni di Selinunte molti ambienti del piano terra e del cortile erano destinati a scopi funzionali, come indicano alcuni Viertelkreise e i numerosi mortai, che si trovavano non solo nella stanza adiacente al cortile, ma anche nel cortile. Attività grossolane come la cottura del cibo venivano forse espletate di frequente nel settore a cielo aperto della casa. Anche altre attività domestiche quotidiane venivano spesso effettuate all’aperto. Il cortile offriva infatti spazio e luce, le sue mura proteggevano dagli sguardi dei passanti e dei vicini.
Accanto agli ambienti, la cui destinazione si può definire in base a determinate installazioni, compare regolarmente nelle case con cortile un ambiente, che per la decorazione e la forma si può interpretare come stanza di ricevimento. Si tratta di un ambiente allungato e vasto, accessibile tramite una porta posta a metà della larghezza. Spesso la soglia era ben definita e lievemente più larga, in modo tale da presumere in corrispondenza una porta di migliore qualità. La stanza di ricevimento (c) della casa Kat.-Nr. �/�7 sulla strada principale è quella meglio conservata. La stanza dotata di pavimento a gettata di malta e intonaco parietale si trova proprio di fronte all’ingresso della casa sul lato del cortile. Un’ampia porta in-vitava l’ospite ad accedervi. In �4 su 59 delle case con cortile che sono state catalogate si riscontra la presenza di questo ambiente di ricevimento.
Malgrado sia stato possibile definire singoli ambienti funzionali in relazione alla forma, alla grandezza e alla posi-zione (stanza da bagno, stalla, stanza di ricevimento), occorre comunque ribadire che nello gruppo funzionale esistono ambienti differenti. Il carattere irregolare delle planimetrie domestiche e l’ampia variabilità in grandezza e nella forma per quanto riguarda la destinazione delle stanze rivelano che nella disposizione delle stanze non erano previsti né un siste-
Sinrtesi italiana �79
ma fisso né una rigida standardizzazione. Le necessità degli abitanti determinavano verosimilmente la disposizione delle stanze di un’abitazione. Tra tutte le case con cortile quella con cortile a corridoio (tipo �) è forse l’unica, i cui ambienti fossero chiaramente differenziati nelle proprie funzioni pri-marie. Nella maggioranza delle piccole case non si riesce a distinguere una costante suddivisione interna dei singoli am-bienti secondo la destinazione specifica. In queste abitazioni gli ambienti erano utilizzati in modo polifunzionale.
6 Lafunzionedelleabitazioni
Oltre alla propria funzione di difesa dagli agenti atmosferici e dai pericoli della natura, la casa assume un ruolo impor-tante nella definizione della vita sociale di una comunità. Gli edifici non definiscono soltanto gli ambienti della famiglia, ma forniscono anche sicurezza e controllo dagli altri membri della comunità. La casa permette inoltre di definire lo status sociale nella comunità e lo rende riconoscibile nello spazio. La casa è stata luogo della famiglia, luogo della rappresentanza e infine della produzione, come indicano gli oggetti previsti regolarmente nell’arrredamento.
Per adattarsi al clima torrido la casa venne dotata di un cortile interno, che di giorno offriva ombra, di notte freddo e al mattino conservava per qualche tempo la fresca aria notturna. Inoltre la circolazione dell’aria e l’illuminazione erano garantite per le stanze adiacenti al cortile. Per le abi-tazioni di Selinunte non si dispone della concreta evidenza, che un gruppo familiare vivesse in un’unità domestica. La grandezza delle abitazioni lascia però presumere che la casa fosse il punto centrale di un unico nucleo familiare (da sei a otto persone) e non di numerose famiglie o di una tribù. Abitazioni di maggiore grandezza non devono essere state abitate necessariamente da un più elevato numero di persone, ma l’estensione dell’abitazione poteva dipendere da motivi di prestigio.
Per quanto riguarda il mestiere esercitato e i rapporti la-vorativi interni, la forma delle case non permette di definire né il raggruppamento sociale né l’attività degli abitanti. Tutte le 59 case con cortile sono unitarie nella sintassi spaziale e nell’allestimento funzionale. Le installazioni previste in tutti i tipi di abitazioni indicano che veniva praticata una spiccata economia domestica. In casa venivano macinati i cereali, si cuoceva il pane, si preparavano i pasti e veniva pestato il cibo per gli animali. La casa era sicuramente il luogo di produzione per l’alimentazione e l’abbigliamento, come indicano i pesi da telaio. Le merci che non si riusciva a produrre nell’am-bito dell’economia domestica venivano forse acquisite per scambio o per acquisto. Non è dato sapere quanto le famiglie riuscissero a funzionare come unità produttive, in quale misura fosse progredita la specializzazione nella divisione dei compiti e quanti oggetti fossero necessari allo scambio. Anche se sinora non sono state identificate abitazioni di arti-giani, frammenti isolati di scorie di vetro e di metallo nonché gusci di conchiglia per la porpora documentano l’esistenza di botteghe specializzate. Il vasellame non veniva sicuramente prodotto in casa propria, ma in una fornace ceramica. Per i pericoli di incendio e per il fastidio provocato dal fumo
queste officine si trovavano presumibilmente alla periferia dell’insediamento.
Le stalle proprio piccole, che sono state identificate in molte abitazioni, indicano che un asino, un mulo o un cavallo erano usati nelle case come animali da trasporto. Nelle rimes-se più grandi potevano trovare posto anche tre animali, ma un numero maggiore di capi di bestiame non veniva custodito entro l’abitato. Insieme alle mandrie che vivevano nei pascoli fuori città, il lavoro nei campi costituiva la principale fonte di sostentamento per gli abitanti. Le differenze nel rango non si possono determinare soltanto in base all’allestimento delle case a cortile. Le case a cortile simili tra loro possono indicare che molti abitanti della città erano allo stesso tempo contadini, artigiani e allevatori.
Tra i fattori sociali che determinano la forma domestica soltanto la situazione patrimoniale permette allo stato attuale della ricerca una valutazione preliminare. Verosimilmente c’erano casate più ricche e più povere. Nelle case del tipo planimetrico �, per lo più piccole e con poche stanze, man-cano cisterne e specifiche stanze da bagno. Gli abitanti di rado possedevano un proprio animale da soma, poiché stalle non sono documentate se non in un caso. Anche decorazioni particolari come intonaco parietale e pavimento di malta costituiscono un’eccezione in queste case con cortile. Queste osservazioni sono corroborate anche dalla planimetria, che non rivela una particolare concezione del cortile, se non una spiccata funzionalità.
L’arredamento delle case lascia riconoscere le persone ricche e possidenti all’interno della cittadinanza. In estensione soltanto poche case tra quelle sinora esplorate superano la media. Cinque abitazioni (Haus Kat.-Nr. �/48 (seconda fase). �/7, �/54, �/58 e �/59) sono più vaste di �00 metri quadrati e quattro sono dotate di una propria cisterna. I proprietari erano verosimilmente benestanti e potevano permettersi un elevato tenore di vita. Tra queste abitazioni spicca in specie la casa �/54, che al piano terreno occupa una superficie di quasi �00 metri quadrati e possiede anche una scala in pie-tra. L’edificio si distingue dalle altre abitazioni non solo per l’arredamento eccezionale, ma probabilmente imita nell’in-tera costruzione una casa greca del tipo a pastas. Soltanto l’esplorazione dell’intera area urbana di Selinunte potrebbe chiarire se nella fase punica le case piccole o quelle grandi come questa costituivano l’eccezione.
La funzione della casa come luogo di rappresentanza è determinata dagli ambienti di ricevimento e dal decoro architettonico nelle grandi abitazioni con cortile interno. Le poche file di colonne residue non si trovano significativamen-te sulla facciata esterna della casa, ma decorano un lato del cortile interno. Le porte profilate non sono rivolte sul fronte stradale, ma verso il lato del cortile. L’auto-rappresentazione degli abitanti aveva perciò luogo non all’esterno ma all’inter-no della casa. Le abitazioni non dovevano colpire i passanti, che lungo le strade camminavano accanto agli edifici. Una ristretta cerchia, ossia gli ospiti che venivano invitati nella propria casa, doveva piuttosto essere impressionata dal contesto decorativo. L’interno dell’abitazione come luogo di esibizione sottolinea la caratteristica principale, che si evince dalla concezione planimetrica: le abitazioni erano chiuse all’esterno e il cortile interno era invece considerato il centro comunitario della casa. Questa osservazione potrebbe
Teil VII�80
indicare che anche la società, dotata di un elevato controllo sociale, non era aperta, ma era piuttosto composta da singoli nuclei comunitari, le famiglie, ritirate all’interno e riparate all’esterno.
7 Ilcontestourbano
La parte sud-orientale dell’acropoli costituiva in periodo punico il centro della città, poiché a parte le abitazioni e gli edifici sacri vi si trovavano due piazze libere e molti negozi. La definizione di agorà ellenistica di Gàbrici è giusta nel senso che si tratta di un’area libera a est del tempio C, che riuniva in sé differenti funzioni. Questa piazza si distingue però nettamente da quello che sappiamo sulle agorai ellenistiche del mondo greco. Non si tratta infatti di una piazza realizzata secondo una concezione urbanistica con edifici di diverse funzioni, ma si presenta piuttosto come una superficie libera dai contorni irregolari, che venne risparmiata dagli edifici.
a L’acropoli come centro commerciale
L’affollamento dei negozi che si allineavano lungo le strade principali e circondavano a sud ovest il tempio C è molto evidente. Oltre agli edifici, anche i ritrovamenti effettuati durante gli scavi attorno al tempio C indicano un’intensa utilizzazione commerciale del quartiere.
a � I ritrovamenti
Nel corso dello scavo del tempio C sono state trovate molte anse di anfore con lettere puniche impresse. Le anfore sono contenitori tipici per il trasporto e la conservazione. I grandi contenitori fittili, trovati sulle strade e sulle piazze dell’acro-
poli, sono serviti per lo più come recipienti per trasporti commerciali e solo in pochi casi per la conservazione di derrate alimentari private. Nelle anfore commerciali venivano conservati sia liquidi come olio e vino, sia merci secche come cereali e legumi. Gli stampi presentano evidenti indicazioni sulla provenienza. La massa di anfore con lettere puniche impresse indica da un lato che gli abitanti di Selinunte, che scrivevano e parlavano in lingua punica, trattavano merci locali, dall’altro che esistevano contatti con altre località del mondo punico.
Un quadro simile si ricava dalle informazioni fornite da un altro cospicuo gruppo di materiali quali le monete. Soltanto negli anni �876 e �877 vennero raccolte oltre ��50 monete, per lo più emesse da zecche puniche. Anche nel corso dello scavo della stoa commerciale sul lato nord della piazza del mercato punica sono state recuperate numerose monete. Le coniazioni puniche costituirono quindi il mezzo di pagamen-to predominante nel IV e III sec. a. C., sebbene nel quadro del commercio anche alcune monete greche giunsero a Seli-nunte. Le monete, che verosimilmente furono smarrite nelle strade e nei vicoli, costituiscono una testimonianza eloquente dell’intenso scambio commerciale, che doveva avvenire nei pressi del tempio C.
Alcuni strumenti di misurazione, utilizzati per verificare volume e peso, indicano che il commercio era comunemente praticato sull’acropoli di Selinunte. In un ambiente situato immediatamente a est dell’altare greco D vennero identificati nel �88�–�88� due tavoli per campioni, sui quali cliente e venditore potevano valutare diverse misure di capacità. Un terzo tavolo per misurare è stato trovato nel �9��. I tre tavoli per campioni documentano che in questo luogo si potevano esaminare e misurare determinati volumi. I pesi di piombo, che furono trovati nel �877 in un ambiente vicino all’angolo sud-occidentale del tempio C, avevano sicuramente una fun-zione simile, ossia una valutazione affidabile del peso. Pure Gàbrici notò anche pesi, enumerando i reperti. Non abbiamo
Abb. VII 2 Il quartiere ad ovest del Tempio C.
Sinrtesi italiana �8�
alcuna cognizione sulle caratteristiche di tutti i pesi menzio-nati, che comunque costituiscono indizi sulle operazioni di commercio e di vendita, che venivano qui effettuate.
a � La stoa commerciale
La vivace immagine del commercio fornita dai piccoli reperti viene integrata in modo ideale dall’edificio commerciale, che si trova a nord della piazza. L’edifico allungato è la più evidente nuova costruzione del periodo punico, realizzata nell’avanzata prima metà del III sec. a. C.
La stoa commerciale consisteva nella sua concezione base in dodici unità costruttive allineate l’una all’altra sul lato longitudinale. Questi dodici assi spaziali componevano a loro volta tre ambienti disposti uno dopo l’altro: una stanza anteriore (a), una stanza centrale pressappoco della stessa grandezza (b) e un piccolo ambiente posteriore (c). Le dodici unità base possedevano pareti in comune ed erano unite da un portico anteriore sul lato rivolto sulla piazza. Spesso sono conservate porte doppie, che rendevano le stanze anteriori comodamente accessibili dal corridoio coperto. Una porta molto più stretta, posta di lato, introduceva nell’ambiente centrale. Nell’ambiente posteriore (c) si trovava la scala o l’accesso alla scala. Questo ambiente era accessibile dalla stanza centrale e dalla parte posteriore dell’edificio tramite un ingresso posteriore. La superficie costruita di tale unità costruttiva occupava appena di più di �� metri quadrati, ai quali entrambe le stanze anteriori, pressappoco quadrate, sottraevano ognuna circa 9 metri quadrati di superfice utiliz-zabile. Le stanze anteriori potevano essere dotate di intonaco parietale dipinto e pavimento a gettata di malta. Davanti si apre l’atrio. Listelli decorativi erano previsti almeno sulla fronte occidentale dell’edificio e sulla tettoia. L’edificio a due piani era dotato di un tetto piatto, mentre il lungo portico era coperto da un tetto a una falda.
Dalla concezione e dalla posizione delle stanze si evince che nel settore occidentale il piano inferiore era accessibi-le alle persone. L’ipotesi è corroborata dalla destinazione commerciale degli ambienti, che permette la definizione qui adottata di stoa commerciale. La limitata grandezza delle stanze indica che si potevano ricevere ristretti gruppi di persone. La stanza centrale si può invece interpretare in un altro modo, ossia come stanza da lavoro, ripostiglio o separée. Meno agevole è la definizione della stanza del piano superiore, per la quale si possono prospettare due possibilità: la destinazione a magazzino (a) o a stanza di abitazione (b). Non si può scegliere una delle due varianti.
La stoa commerciale era un edificio caratterizzato da numerosi vani della stessa grandezza. I muri in comune e il portico la qualificano come edificio costruito insieme da un gruppo di persone con interessi simili, che però come singoli individui miravano ad avere vani separati. Le stanze estremamente aperte, allestite in modo prezioso e individuale, indicano che erano destinate al pubblico.
La particolare qualità dell’edificio è indice di una certa esigenza e di un commercio di elevato livello. In mancanza di riferimenti a laboratori e in considerazione dell’accurato allestimento delle stanze, che depone contro la vendita di prodotti alimentari, preferisco intendere la stoa commerciale come sede di mercanti, che forse agivano come intermediari
per il commercio sovrarregionale, con annessi magazzini e/o stanze da letto. Oltre alla vendita di merci si può pensare an-che ad attività di servizio come agenti commerciali, armatori, mediatori o cambiavaluta.
a � I negozi
La stoa commerciale delimita l’area libera a nord. Dal con-fronto con la posizione degli altri negozi nel tessuto urbano si ricava una serie di osservazioni. Da un lato i locali commer-ciali si trovano per lo più lungo le strade maggiori, dall’altro coronano ad arco il lato occidentale del tempio C. I negozi non sono distribuiti allo stesso modo lungo ogni strada, ma soltanto determinati segmenti stradali vennero adibiti a iti-nerari commerciali. Molti negozi si trovavano per esempio lungo l’asse nord-sud e non proseguono a sud della strada est-ovest. In questo settore è evidente una suddivisione degli spazi, poiché i negozi sono concentrati in specie a nord della strada est-ovest, mentre a sud di questa strada se ne trova un numero di gran lunga inferiore.
La posizione dei negozi lungo le strade e sulle piazze è la preferita in assoluto, poiché qui si concentravano i flussi del traffico e c’era la possibilità di paragonare la merce con quella venduta nelle strade attigue. Spesso i locali com-merciali erano allineati lungo entrambi i lati di una strada, con una disposizione che ricorda le file dei bazar delle città orientali. Raramente i negozi sono connessi ad abitazioni e sono lontani dalle strade che avevano finalità commerciali. Il nesso tra spazio commerciale e quartiere residenziale non è un elemento base delle abitazioni puniche.
Le strade, nelle quali si svolgeva il commercio, costituivano dunque la posizione preferita per i negozi. Evidente espres-sione di questo fenomeno è la stoa commerciale, presso cui questo concetto venne applicato a un edificio, nel quale il lungo corridoio costituisce una strada coperta. Le attività commerciali inoltre si svolgevano presumibilmente sulla piazza libera a nord e a est del tempio C, ai margini di questa piazza del mercato e nelle strade colà dirette. Il tempio costi-tuiva il centro e il punto di riferimento della piazza.
b I santuari
Nel tessuto urbano dell’acropoli di Selinunte la destinazione sacra di un certo numero di edifici e di vani è definita dal-l’evidenza degli oggetti deposti o dagli emblemi degli dei. La loro forma architettonica e il comportamento religioso dei Punici si distinguono nettamente dai templi e dai costumi religiosi dell’abitato greco.
Quando si considera il destino riservato agli edifici sacri greci, si verifica che per le vecchie costruzioni erano possibili due soluzioni. Gli edifici potevano essere integrati nel tes-suto residenziale, come si è verificato presumibilmente per il cosiddetto tempio delle piccole metope nella zona nord-orientale (Haus Kat.-Nr. �/��). Questo destino venne riservato in specie agli altari, come illustra con evidenza l’altare con triglifi (Häuser Kat.-Nr. �/9 e �/4�). Altrimenti si poteva con-tinuare a utilizzare gli edifici anche in periodo punico, come avvenne per il tempio C, il tempio A e il cosiddetto Megaron (tempio R). Fu possibile frequentare ancora in forma mutata i
Teil VII�8�
tre grandi templi dell’acropoli – A, C e D –, forse limitandone la frequentazione successiva agli ambienti interni.
b � Le costruzioni greche
b �.� Il tempio CSi può presumere che molto probabilmente il tempio greco C, risalente al periodo arcaico, sia stato utilizzato in periodo punico non solo per la posizione centrale. A favore di questa interpretazione militano gli eloquenti ritrovamenti di sigilli sui gradini della larga scalinata e le già menzionate costruzioni nel pronao. Le ripetute apposizioni di sigilli sui documenti indicano che gli accordi conclusi tra due parti venivano sanciti da una terza parte ufficiale. Presumibilmente qui funzionari o sacerdoti sigillavano i contratti commerciali, che venivano conservati negli archivi del tempio.
b �.� Il tempio AIl tempio A, risalente al periodo classico e poco più piccolo, si eleva in una posizione urbanistica simile. La zona a est del podio a gradini fu lasciata libera da costruzioni per accen-tuare l’accesso all’edificio. Con la chiusura dell’intercolumnio centrale e la realizzazione di un muro interno nell’atrio greco del tempio periptero venne anche ricavato un ambiente qua-drangolare, che molto probabilmente serviva da vestibolo alla stanza cultuale vera e propria.
L’allestimento del vestibolo con una banchina, i simboli degli dei sul pavimento e il piccolo altare cubico a est del podio a gradini non lascia dubbi sull’uso cultuale della cella greca. Si può anche immaginare che l’originario passaggio sul lato settentrionale della cella sia divenuto in età punica una stanza. Al posto dell’adyton greco a ovest della grande cella longitudinale anche in periodo punico si poteva trovare la costruzione cultuale più sacra, dove veniva probabilmente venerata la dea Tanit, da sola o insieme a Baal.
b �.� Il tempio RIl tempio R, o megaron, risalente al periodo arcaico, venne forse utilizzato anche in periodo punico come ambiente di culto, poiché venne certo aggiunta una banchina perimetrale, di cui si conservano soprattutto le fondamenta. La banchina potrebbe essere stata utilizzata come sedile o come superficie per deporre offerte; poiché banchine votive ricorrono con frequenza nei contesti sacri punici, si può presumere anche in questo caso tale destinazione. Le due basi quadrangolari nella stanza anteriore (a) potrebbero essere riferite a betili, Nella seconda stanza (b) si trovava forse un podio per sacrifici.
b � Le nuove costruzioni puniche
Oltre ai tempi greci menzionati, la cui utilizzazione proseguì in modo differente, c’erano in periodo punico alcuni edifici sacri, che riflettono una concezione chiaramente diversa. Gli edifici cultuali si inseriscono nel tessuto urbano e a differenza delle costruzioni greche non erano corpi di fabbrica liberi e plastici nello spazio. Piuttosto gli edifici cultuali erano simili alle abitazioni o in secondo tempo sono stati realizzati en-tro queste. In due casi si riconoscono con evidenza, poiché vennero deposti vasi di grandi dimensioni, riempiti di ossi carbonizzate.
b �.� Il santuario a cortile a sud dell’acropoli e il piccolo santuario a sud-est dell’acropoli
Il più vasto dei due santuari si trova sul bordo della città pu-nica a sud dell’acropoli. I resti meridionali dell’edificio sono purtroppo molto radi. Nell’ala settentrionale dell’edificio cultuale Vincenzo Tusa riuscì nel �965 a identificare alcune deposizioni, effettuate in grandi contenitori fittili, che, riem-piti con cenere e ossi di mammiferi incinerati, erano stati deposti su un podio per sacrifici.
Un altro santuario di ridotte dimensioni, nel quale fu deposto vasellame, è stato scoperto negli scavi effettuati nell’autunno �966 da Vincenzo Tusa. Per la stanza al centro (b) delle tre sono di nuovo menzionate deposizioni, proba-bilmente simili a quelle del santuario maggiore.
b �.� La stanza di TanitOltre ai santuari con le deposizioni, un altro luogo di culto è stato identificato nel settore della città punica. La stanza di Tanit presso la strada est-ovest è evidente grazie alla riprodu-zione dell’emblema della dea Tanit, in origine fiancheggiato da due caducei. Le similitudini dal punto di vista architettonico con un vano cultuale a Cartagine e il simbolo di Tanit, che a Selinunte ricorre una seconda volta per di più in un am-biente sacro quale il vestibolo del tempio A, lo qualificano come piccolo luogo cultuale, che è stato allestito tra i locali commerciali della strada est-ovest.
b � Riassunto
La diversa impostazione nella planimetria e nell’arredamento degli impianti cultuali esaminati in questa sede ne ostacola la comprensione immediata e non lascia comporre un quadro unitario. Alcuni elementi ricorrono tuttavia diverse volte e contraddistinguono le mutate credenze religiose della nuova popolazione. Sono riflessi riti che si possono ricondurre alle pratiche religiose del mondo culturale fenicio-punico.
L’usanza di raccogliere in un vaso i resti di un rogo sacrifi-cale e di seppellirli nel terreno è particolarmente caratteristi-ca. Questo rito è strettamente connesso alla regione punica e documentato nei tofet di questo ambito culturale. Inoltre a Selinunte ricorrono anche banchine votive, che possono essere state utilizzate per deporre offerte. Queste banchine deposizionali sono una caratteristica particolare dei santuari dell’area siro-palestinese e sono forse di tradizione orientale. Anche il vasto podio, conservato in due dei nostri edifici di culto (grande santuario a cortile, piccolo santuario), trova confronto nei podi per sacrifici. degli edifici cultuali dell’età del Bronzo e del Ferro sulla costa levantina e a Cipro. L’eviden-za di betili a Selinunte è invece ardua da dimostrare, poiché questi elementi, lontani dal proprio contesto originario, sono riconoscibili come tali solo con grandi difficoltà. L’ambiente cultuale di Cartagine rende probabile riconoscere nel pavi-mento su due livelli un caratteristico elemento punico.
In generale i complessi sacri punici di Selinunte presen-tano un carattere tradizionale. Sia i templi greci modificati con aggiunte sia i santuari punici di nuova costruzione si possono connettere ai luoghi di culto, che erano stati costruiti nel mondo culturale fenicio-punico. A questi rimandano soprattutto le usanze religiose, in specie il rito di deporre il rogo sacrificale in vasellame e la collocazione di offerte vo-
Sinrtesi italiana �8�
tive su banchine deposizionali, che sono caratteristiche per la pratiche religiose puniche. Le concezioni architettoniche non sono direttamente paragonabili, poiché la forma degli ambienti non era soggetta a norme rigorose e quindi non permette confronti diretti.
c L’impianto da bagno
A sud della cosiddetta acropoli si è conservato un complesso di vani, che per la planimetria e l’allestimento si distacca net-tamente dalle case di abitazione. Interpretato come impianto da bagno, è sinora privo di ogni confronto. Elementi caratteri-stici sono il bacile per immersioni e le due ali appartenenti al bagno, una delle quali si poteva riscaldare. L’intero complesso di vani si può interpretare come bagno per un numero ridotto di persone. Si può immaginare che il visitatore all’inizio si lavasse in uno dei bagni, per poi raggiungere tramite gradini il bacile e qui immergersi interamente. Un simile bagno per immersione ricorda nella sua funzione principale gli antichi
bagni rituali (Mikwen) del mondo ebraico, che ugualmente si possono connettere alle stanze da bagno. Oltre alla analo-gie costruttive anche una piccola pietra con nicchia allude a una destinazione cultuale. La stanza da bagno di Selinunte non rappresenta alcun bagno rituale per immersione in senso ebraico, ma la destinazione dell’impianto da bagno è strettamente affine, come si evince dall’assetto planimetrico e dall’allestimento dell’edificio, poiché simili ideali di purezza potrebbero avere avuto una certa importanza.
8 L’urbanistica
La Selinunte punica venne fondata ex novo sul sito dell’abitato greco. Nella definizione dei fondamenti caratteristici dell’as-setto urbano punico da un lato lo schema base urbanistico della città greca Selinunte confonde lo sguardo e complica l’analisi, dall’altro si notano a colpo d’occhio differenze evi-denti. Come quella greca la città punica si presenta come un
Abb. I 2 Selinunt in einem Luftbild von 1968, Ansicht der Akropolis von Süden.
Teil VII�84
insediamento urbano con un fitto tessuto, i cui giardini, campi e pascoli erano al di fuori delle mura urbane. Si riscontrano differenze nella struttura urbana interna. Si può presumere che il rapporto tra spazi destinati al traffico, aree libere e zone abitate sia cambiato in maniera considerevole.
a Le zone abitate
I coloni si insediarono nelle macerie della città e assun-sero le essenziali caratteristiche della città greca. La vecchia rete stradale venne mantenuta completamente e le insulae furono proseguite. Nel settore del temenos arcaico-classico i nuovi abitanti seguirono tuttavia altri schemi base. Le zone edificate a maglia larga, che in periodo greco non erano state occupate da abitazioni e la cui edificazione sarebbe stata un sacrilegio, non vennero più considerate ambito sacro, ma nell’intero terreno dell’ex temenos vennero ora costruite case. Le costruzioni di epoca precedente vennero in seguito regolarmente inglobate nell’edilizia e si appoggiavano agli edifici preesistenti, fossero questi portici colonnati, altari, tempi o abitazioni. Altri edifici come il portico colonnato a est dell’acropoli e il presunto propylon proprio a sud del tempio D furono ristrutturati e vennero utilizzati a scopi abitativi.
Gli edifici per abitazioni non si ergevano isolati, ma si appoggiavano l’uno all’altro, concentrandosi e ammassandosi tra loro in blocchi irregolari (cosiddetta edilizia agglutinante). Le murature seguivano allineamenti spesso divergenti, po-tevano formare angoli obliqui e racchiudere stanze di forma irregolare. La superficie edificata non era ispirata ad alcun criterio fisso. In nessun punto del tessuto urbano sinora scavato sono state trovate case costruite secondo le stesse norme. Nessuna casa è completamente simile all’altra, pur se vennero adottate soluzioni simili.
b Gli spazi destinati al traffico
Tra le abitazioni si formò una rete viaria e risultarono aree libere di modesta estensione. Le nuove strade del periodo punico ebbero il carattere di arterie di traffico, che dovevano servire soltanto a raggiungere le abitazioni e vennero rispar-miate dall’edificazione. Le strade strette non vennero orien-tate ad alcun schema, ma percorrevano in obliquo e talora ad arco il sito. La larghezza delle strade e dei vicoli variava, ma in generale era più ridotta di quella della città arcaica-classica, cosicchè anche durante il giorno si poteva usufuire dell’om-bra. Le strade dritte e larghe, che in periodo greco avevano indirizzato lo sguardo lungo le facciate delle case verso il territorio o sul mare, vennero dotate di costruzioni sui lati e risultarono così sensibilmente ristrette e suddivise.
Nel quartiere sud-est le nuove strade si orientarono sul terreno in declivio, irradiandosi quindi lungo il pendio. Nel settore del temenos arcaico sorsero due nuove strade, ognuna tesa grosso modo in senso est-ovest. Una strada proseguiva proprio a sud del tempio C, l’altra nasceva sulla strada prin-cipale poco a nord del tempio D. Nel quartiere nord-est si notano stretti vicoli, che si restringevano sino a �,� m e talora erano senza uscita.
c Le aree libere
Le piazze della città punica sono irregolari come la rete via-ria. Presumibilmente a est dei templi A e C una vasta area venne risparmiata dalle costruzioni residenziali. Il tempio greco periptero A e forse la sede di un ufficio incorniciavano il lato occidentale della piazza meridionale. A nord i locali commerciali, che erano stati allestiti sul lato settentrionale della principale strada est-ovest, rappresentavano una quinta architettonica. A est l’altare greco a colonne costituiva un limite, mentre a sud la piazza era chiusa da edifici di abita-zione, tra i quali due strade erano dirette a sud. In modo del tutto simile si può immaginare l’allestimento della piazza settentrionale, che si apriva di fronte al tempio C. Di nuovo il vecchio altare diveniva il limite a est, a sud è presumibile la presenza di edifici di abitazione, mentre sia a nord-est sia a sud-ovest due strette strade si diramavano dalla piazza verso i quartieri di abitazione. Anche la stoa commerciale, che era stata costruita a nord del tempio C, costituiva forse una cornice costruita della piazza, senza chiuderla affatto, ma anzi prolungandola chiaramente a est.
d La posizione di luoghi di culto
Gli abitanti punici di Selinunte avevano chiaramente un altro rapporto con gli edifici sacri greci e lo spazio che circondava questi edifici. Spesso gli altari greci non erano più accessibili. A causa della chiusura dei passaggi e dell’occupazione del podio a gradino è poco affidabile parlare tout court di una sconsacrazione del tempio greco, ma è preferibile pensare a un’altra concezione religiosa. L’unità greca formata da tem-pio, altare e temenos venne palesemente infranta, anche se secondo alcuni indizi continuò la frequentazione di almeno due templi per scopi religiosi. In periodo punico il tempio C, che probabilmente venne dedicato a Melqart e utilizzato come archivio templare, costituiva il punto urbanistico cen-trale. Il tempio con la piazza non edificata a est formava in periodo punico il centro urbano.
Dalla dislocazione di locali commerciali presso le grandi strade nonché a nord e a est del tempio C si può desumere che la piazza davanti e intorno al tempio greco avesse ac-quisito un carattere del tutto commerciale. I luoghi di culto e i santuari non pretendevano una propria area urbana, ma erano piuttosto dispersi nel contesto urbano e in parte integrati negli isolati residenziali. Future ricerche potranno chiarire se la lieve maggioranza di edifici cultuali nella zona meridionale dell’acropoli rimanda a una zonizzazione o se la concentrazione di santuari presso la cuspide meridionale del promontorio dipende dallo stato attuale degli scavi e delle conoscenze. Una suddivisione della città in zone dedicata alla vita pubblica-politica, pubblica-religiosa e privata, come si riscontra di solito nelle città greche, non risulta possibile nella Selinunte punica. Questa mancanza avrebbe recato un grave danno all’utilizzazione di una città greca. Come caratteristica strutturale si deve osservare che la città punica si distingue dalla fondazione greca per una più ristretta regolamentazione dello spazio urbano tramite strutture edificate. Le differenze menzionate nell’assetto degli spazi e degli edifici urbani si possono attribuire con sicurezza a un’altra concezione della città come spazio di vita.
Sinrtesi italiana �85
9 Lamatriceculturaledell’architetturadomesticadiSelinunte
Poiché le abitazioni di Selinunte sono state interpretate come testimonianza culturale specifica, occorre ricercarne la matrice culturale. Quali elementi dell’architettura domestica si pongono nella tradizione punica e in quali settori si può invece riconoscere un influsso greco? Scopo delle conside-razioni è la verifica della tesi dell’ellenizzazione, che è stata più volte formulata nella ricerca e con la quale si intende l’adozione di planimetrie tipiche greche e di allestimenti greci nell’architettura domestica punica.
a Gli elementi punici
a � Le tecniche edilizie
Come già specificato, la tecnica edilizia a telaio è caratteri-stica per il mondo culturale punico. In una casa di Selinunte è stato osservato il modo di costruire le fondamenta usuale a Cartagine con una cornice di fondazione e un riempimento di terra negli interstizi. Le costruzioni delle porte e delle scale non sono invece specifiche e non sono risultate significative in relazione all’interrogativo di partenza. I pavimenti in coccio-pesto si possono considerare tipicamente punici. I pavimenti in signino sono molto probabilmente un’elaborazione punica, poiché si sono diffusi nell’Africa settentrionale prima che il caratteristico rivestimento pavimentale venisse adottato dal mondo ellenistico occidentale.
Forse anche il modo di rivestire con stucco le parti archi-tettoniche è tipicamente punico. Parti costruttive sono state regolarmente rivestite a Cartagine con uno spesso strato di intonaco, sul quale veniva steso un sottile strato di stucco. Lo spesso strato inferiore e il libero modellato degli ornamenti potrebbero avere costituito una tecnica specificamente puni-ca. Occorre ancora indagare quanto specificamente occiden-tale sia la tecnica della stuccatura. Un elemento certamente punico sono le riserve d’acqua per l’approvigionamento idrico delle abitazioni. Cisterne allungate con estremità arrotondate (cosiddette cisterne a bagnarola) sono documentate sia a Cartagine sia a Nora e Tharros in Sardegna. Altri allesti-menti funzionali, come i Viertelkreise e i forni da pane, sono verosimilmente di tradizione orientale e si possono quindi considerare un elemento tradizionale punico.
a � L’assetto planimetrico delle case puniche
Secondo le attuali conoscenze tutte le case puniche possede-vano sempre un cortile. Inoltre si distinguono tre tipi base, che si possono intendere come punici:
A Casa a stanze concatenate, la casa lunga con ambienti sca-glionati (attestata a Kerkuan, Cartagine?, Tharros, Monte Sirai)
B Casa con cortile a corridoio (attestata a Kerkuan, Carta-gine, Monte Sirai?, Tharros, Utica, Mozia)
C Casa con cortile a portico (attestata a Kerkuan, Cartagi-ne)
La casa a stanze concatenate (tipo A) è semplice e veramente poco specifica nella sua disposizione, cosicchè motivi meto-dologici impediscono di tirare delle conclusioni in merito a una matrice tipicamente punica.
Le case con cortile a corridoio (tipo B) sono attestate in tutte le località menzionate e sono con sicurezza tipicamente puniche. Evidente è la somiglianza con la casa greca a prostas, che secondo Heinrich Drerup era diffusa specie nell’Asia Minore. Entrambe le case con cortile possiedono un corri-doio laterale, però nella casa punica con cortile a corridoio mancano le colonne nel cortile, che contraddistinguono la casa a prostas.
La casa con cortile a portico (tipo C), il cui cortile è circondato da portici, sta forse nella tradizione sud-fenicia della cosiddetta casa a quattro stanze o a quattro zone, nella quale il lato lungo del cortile è regolarmente delimitato da una fila di pilastri. Le forme di case adottate nell’età del Ferro rimangono a lungo in uso. La casa a tre o quattro zone viene anche chiamata »casa tipica israelitica«.
a � Classificazione delle case di Selinunte
La casa a stanze concatenate tipo A non è attestata a Seli-nunte. La caratteristica concatenazione si trova solo nei vani della stoa commerciale. L’assetto base delle singole unità abitative ricorda il tipo di casa punica A, dal quale tuttavia le case commerciali si distinguono per la presenza di un secondo ingresso.Ottimi riscontri sono invece emersi nella verifica delle pla-nimetrie domestiche di Selinunte per i tipi B e C. Per il tipo di casa punica B si trova a Selinunte una serie di confronti calzanti, raccolti in questa sede come tipo di casa �, che con �8 esempi catalogati rappresenta circa un terzo di tutte le abitazioni.
Tra gli edifici di abitazione selinuntini inoltre si possono inoltre collocare le case del tipo � variante a delle cosiddette case a quattro zone (tipo C), che con dieci esempi catalogati costituiscono il secondo gruppo. Gli abituali sostegni, che separavano le stanze laterali dal cortile, sono tuttavia rim-piazzati a Selinunte sempre da muri chiusi. Questa tendenza si può osservare regolarmente già nelle abitazioni dell’età del Ferro della costa levantina nel corso dell’VIII sec. a. C. Tra le abitazioni a Cartagine e a Kerkuan si trovano sia case con pilastri sui bordi del cortile sia case prive di pilastri. In questa serie si possono forse inserire anche entrambe le abitazioni di Mozia, contrassegnate dal cortile anteriore centrale e dalle stanze laterali, che circondano il cortile su tre lati.
La chiusura dei muri laterali del cortile rappresenta un successivo ulteriore sviluppo di questo tipo planimetrico, ma non cambia la costruzione strutturale della casa, poiché le stanze laterali continuavano a essere accessibili dal cortile. Il nuovo assetto delle pareti laterali del cortile permetteva di includere con questa posizione negli edifici di abitazione altre stanze chiuse oltre agli ambienti funzionali, di solito piccoli e per lo più adibiti a stalle aperte. I vani nelle abita-zioni potevano essere suddivisi in modo indipendente, dal momento che ora tutte le pareti del cortile erano chiuse. La flessibilità degli ambienti domestici si riflette di conseguenza anche sull’estensione della casa a quattro zone. La casa non
Teil VII�86
era sempre allungata, ma poteva anche assumere una forma tozza, qualora il cortile fosse delimitato da stanze con mag-giore profondità anziché dai ridotti vani stretti. Il settore con le stanze in fondo potevano anche essere abolite, come è probabilmente avvenuto nelle case del tipo � nella variante b. Verosimilmente le case del tipo 4 sono alla fine di questo sviluppo, poiché il loro cortile non è più allungato, ma ha assunto una forma quadrata.
Queste considerazioni permettono ora una successione ideale di cronologia relativa dei tipi di case selinuntini di età punica: la variante a del tipo planimetrico � costituisce il tipo più antico di casa. Dal tipo � si sviluppò la variante � b. Le abitazioni del tipo 4, variante a potrebbero rappresentare uno stadio successivo della variante del tipo � a, poiché il cor-tile allungato è ora scomparso. Dal tipo � b potrebbe essere derivato il corrispondente 4 b.
Una versione ridotta della cosiddetta four room house israelitica è costituita dalla casa a tre ambienti, che su uno dei due lati del cortile è ridotta di un’ala, cosicchè il cortile si veniva a trovare in un angolo della casa. Le stanze circonda-vano il cortile soltanto su due lati e coprivano una superficie a forma di L. In questo caso si può forse ipotizzare un processo simile a quello che è stato presunto per la casa a quattro zone. Il lato del cortile aperto e sorretto dai pilastri venne chiuso da un muro, cosicchè la suddivisione delle stanze poteva es-sere intrapresa più liberamente. In seguito furono soppressi l’allungamento dell’edificio e infine il cortile allungato. Pur se il tipo planimetrico � di Selinunte appare così poco specifico, tuttavia con gli stessi argomenti si può far ben derivare dalla tradizionale casa a tre zone e potrebbe essere ugualmente legato a tradizioni orientali.
La casa con il cortile a corridoio, il tipo planimetrico � di Selinunte, potrebbe essere uno sviluppo particolare delle case con cortile, nelle quali il vano a cielo aperto veniva raggiunto direttamente dopo aver varcato la soglia del cortile. L’aggiunta di un corridoio presentava forse numerosi vantaggi. Da un lato un passante, che camminava di fronte alla porta di casa aperta, riusciva a stento a guardare nel cortile; dall’altro il passaggio dalla strada pubblica all’ambiente domestico pri-vato divenne anche più tangibile per il visitatore tramite la larghezza del corridoio, che di norma era soltanto di poco più largo della porta d’ingresso. Lo stretto passaggio, forse coperto e quindi più scuro e più freddo, venne utilizzato per l’allestimento del cortile, in modo che l’aspettativa dell’ospite fosse incrementata prima dell’accesso al cortile. Forse questo tipo di casa costituisce il tipo planimetrico più innovativo e moderno.
In complesso le abitazioni selinuntine del periodo punico mostrano un’evidente connessione con le planimetrie dome-stiche tradizionali del mondo punico. I coloni punici avevano forse la necessità di costruire abitazioni, che corrispondessero alle loro tradizioni specifiche.
b Gli elementi greci
b � L’assetto planimetrico delle abitazioni greche
Si può considerare la casa a pastas come l’abitazione greca tipica. Il suo atrio colonnato, che è disposto trasversalmente
e forma un corridoio, non è conosciuto nel mondo fenicio e punico. Le case greche a prostas assomigliano per il loro assetto planimetrico allungato alla case puniche con cortile a corridoio, ma nelle abitazioni puniche non si trova il portico (prostas) prima della stanza di ricevimento. Nella madrepa-tria la casa a pastas è stata molto diffusa. In Sicilia l’edilizia domestica greca è ancora priva di una ricerca esaustiva. A Se-linunte in periodo greco le case a pastas erano verosimilmente comuni, come indicano le unità abitative quasi quadrate.
Case con cortile a peristilio vennero introdotte nel mondo greco dal IV sec. a. C. Il tipo edilizio del cortile circondato da colonne venne utilizzato nell’architettura pubblica già nel V sec. a. C. e fu adottato dall’edilizia domestica nel corso del IV sec. a. C. Ulteriori novità del IV sec. a. C. sono l’alle-stimento delle stanze principali con decorazioni parietali, mosaici di ciottoli e sculture, che permettono di rivalutare l’architettura privata del periodo tardo-classico. Cortile co-lonnato, portico colonnato, sala da banchetto e gruppi di tre stanze si possono considerare ambienti tipicamente greci di periodo tardo-classico.
La casa Kat.-Nr. �/54 a Selinunte mostra una planimetria strettamente connessa a quella della casa greca a pastas e costituisce sinora un’eccezione tra le case selinuntine del periodo punico. L’imitazione di una pastas venne forse perse-guita anche nella casa Kat.-Nr. �/�7, nella quale due colonne furono collocate sulle lastre di copertura di una cisterna, per aggiungere un portico colonnato alla stanza centrale di ricevimento. La giacitura delle colonne sulle lastre della cisterna indica una successiva ristrutturazione del cortile: è infatti improbabile che la posizione del portico colonnato, infelice dal punto di vista statico, sia stata concepita sin dalla costruzione della casa.
A parte queste due case, non è stato possibile riconoscere a Selinunte alcuna disposizione spaziale tipicamente greca. I pavimenti in cocciopesto conservati non mostrano mai una fascia rialzata, che nelle sale da banchetto greche era riservata alle klinai. Non sono stati trovati mosaici a ciottoli. I cortili a peristilio in voga specie dal III sec. a. C. non sono documentati a Selinunte.
b � La decorazione architettonica
Mentre elementi greci si possono rintracciare nell’assetto planimetrico delle case puniche solo in casi eccezionali, le forme di decorazione architettonica mostrano al contrario l’inconfondibile impronta del repertorio formale greco-el-lenistico. Sono infatti documentati kymatia di tipo lesbio e ionico, cornici dentellate, astragali e ovoli. Nel recente studio dedicato ai frammenti di stucco rinvenuti a Cartagine, Anne Laidlaw ha ribadito l’affinità con le decorazioni in stucco pompeiane di primo stile. L’adozione della decorazione archi-tettonica greca si può seguire a Selinunte grazie alle cornici degli architravi delle porte e ai frammenti di stucco dipinti con kymatia ionico e lesbio. Le basi non sono invece ispirate ai prototipi greci, ma rappresentano piuttosto formulazioni nuove poco abituali. Il trattamento libero degli elementi architettonici greci è evidente anche nell’adozione delle colonne prive di scanalature, che sono poste in opera senza base direttamente sul pavimento (Haus Kat.-Nr. �/�7).
Sinrtesi italiana �87
c Riassunto
Da un lato elementi specifici quali cisterne, vasche da bagno e Viertelkreise, e caratteristiche nella costruzione dei muri e dell’esecuzione dei pavimenti connettono le case di Selinunte al mondo culturale punico. Anche le planimetrie sono di tradizione punica. Si può presumere un forte nesso con le forme domestiche tradizionali. Il carattere punico delle abitazioni è particolarmente evidente nella tecnica edilizia e nella forma domestica.
D’altro canto si può percepire un influsso greco nell’archi-tettura domestica. In due abitazioni il lato di un cortile ven-ne sottolineato con la messa in opera di colonne. L’assetto rappresentativo delle abitazioni era verosimilmente ispirato al modello greco, come traspare dall’allestimento in stile ellenistico della facciata di un cortile. Le cornici degli archi-travi delle porte e la trabeazione della casa �/54 sono ispirate direttamente a prototipi greci. L’ellenizzazione dell’architet-tura domestica punica ha riguardato proprio quegli elementi che servivano agli abitanti delle case per la rappresentanza, come la messa in opera delle colonne nel cortile interno e il loro assetto nel dettaglio. Altri elementi connessi dal punto di vista funzionale alla cultura domestica punica vennero invece conservati.
10 Osservazioniconclusive.L’ellenizzazionedellaculturadomesticapunica
La case puniche di Selinunte sono da un lato connesse al mondo punico e dall’altro mostrano elementi greci. Non si può però parlare di una forte ellenizzazione dell’architettura domestica di Selinunte. La ricezione dell’architettura greca si ferma all’ambito decorativo, riguardando solo in un caso eccezionale anche la planimetria domestica. Verosimilmente le forme greche vennero incontro alla necessità di rappre-sentanza della popolazione punica. In primo piano si pose verosimilmente la ricerca di un assetto appariscente delle case, per il cui ornato architettonico si fece ricorso alla de-corazione architettonica standard del mondo mediterraneo, quella del mondo greco.
L’incremento qualitativo delle forme domestiche in pe-riodo ellenistico viene spesso definito tout court a Cartagine come ellenizzazione, anche se elementi punici come l’appro-vigionamento idrico delle cisterne domestiche e i pavimenti decorativi in cocciopesto furono mantenuti. A causa dell’im-pronta greca della decorazione architettonica viene per lo più ipotizzato, che l’elevato allestimento delle abitazioni si debba al determinante influsso del mondo greco. L’adozio-ne della decorazione architettonica greca si inserisce bene nel generale processo di ellenizzazione nel campo artistico, che si verifica dal IV sec. a. C. L’influsso greco sulla cultura materiale punica è stato più volte ribadito. Si riscontrano piuttosto delle differenze nella valutazione di questo influsso. L’ellenizzazione si deve intendere come un’assimilazione, una profonda compenetrazione e adattamento della cultura e del modo di vita punici o gli elementi greci sono stati recepiti come involucri, da riempire con contenuti propri, specifica-mente punici?
In relazione alla case di Selinunte è stato constatato che l’influsso greco ha riguardato in prima linea elementi de-corativi. È difficile giudicare il carattere dell’ellenizzazione, senza sapere quali valori contenutistici venissero attribuiti al repertorio decorativo greco. L’esibizione di decorazioni greche non deve in nessun caso significare, che si è trattato di abitanti greci. Anche l’adozione da parte degli abitanti punici non significa necessariamente che ci si volesse com-portarecome tipicamente greci. Il linguaggio ornamentale greco può essere servito al gusto punico a incrementare il lusso abitativo, senza che si volesse trasferire un bagaglio culturale specifico. Non si può quindi optare per una delle due alternative ora proposte.
La grecizzazione rilevata nel settore dell’architettura do-mestica può avere differenti cause. Generalmente vengono distinti fattori esterni e interni, che provocano uno scambio culturale. Il fattore esterno di maggior rilievo è costituito dal contatto culturale, che può avere causato uno scambio di beni culturali. Tra i fattori sociali interni si annoverano l’adattamento all’ambiente e ai cambiamenti di questo nonchè l’azione innovativa di singoli individui e di elites. La pluralità dei processi spesso in contrasto tra loro dei differenti settori fa si, che nessuna cultura o società costituisca un sistema statico in sè chiuso.
Si deve alla più alta valutazione attribuita tradizional-mente nella storia della ricerca alla cultura greca rispetto a quella punica che il fattore di una assimilazione ampiamente passiva in seguito al contatto con la cultura greca sia stato sottolineato. Il livello superiore della cultura greca non la-sciava alternative all’assimilazione. Con questa concezione scivolano in secondo piano l’agire innovativo come fattore culturale interno e il fertile confronto attivo con elementi innovativi, due aspetti che vengono incrementati dalla ridotta conoscenza del mondo punico. La valutazione dell’ellenizza-zione della cultura punica non dovrebbe escludere a priori questi aspetti, che implicano un confronto consapevole con gli elementi estranei. La cultura che riceve non è soltanto costretta a reagire, ma i suoi membri possono anche agire at-tivamente, cercando modi per soddisfare le proprie necessità culturali. Il predominio delle forme greche nell’architettura domestica a Selinunte e a Cartagine indica a mio avviso una scelta selezionata e un confronto consapevole con diversi stili decorativi e quindi un’attiva compartecipazione della società punica allo scambio culturale.
Naturalmente è molto complesso il gioco alterno tra una scelta attiva e un influsso passivo, tra le proprie necessità nuove e quelle generate dall’influsso esterno, tra concezione teorica e trasformazione formale figurata. Per portare mag-giore chiarezza nella discussione relativa all’influsso greco sulla cultura punica, bisognerebbe valutare a parte per ogni singolo aspetto, quanto l’influsso greco sulla cultura punica fu profondo e quanto penetrò nella vita. Alcuni processi di trasformazione rimangono marginali e non hanno alcun ef-fetto visibile sull’intera cultura, altri invece non si limitano a cambiare comparti della società, ma la struttura stessa della cultura. Specie il mantenimento della religione tradizionale rivela però che non è lecito equiparare automaticamente la ricezione del repertorio formale greco a una profonda penetrazione. Sia i templi greci modificati con aggiunte sia i
santuari punici edificati ex novo si possono infatti connettere ai luoghi di culto costruiti nel mondo fenicio-punico.
Rispondere alla domanda sull’effettiva dimensione dell’ac-culturazione della cultura e della vita cartaginese richiede ulteriori ricerche sistematiche sul contatto culturale del mondo greco con quello punico, per ottenere un quadro differenziato anche dei fattori della trasformazione culturale. La ricerca sulle abitazioni puniche di Selinunte si intende come un passo sul cammino verso una nuova immagine della cultura punica.