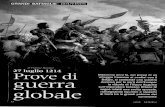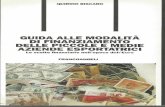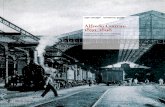Non solo Roma. Piccole e grandi questioni
Transcript of Non solo Roma. Piccole e grandi questioni
LA CAPITALE A ROMA• CITTA' E ARREDO URBANO• 1945-1990 ROMA - PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 2 ottobre - 28 novembre 1991
COMUNE DI ROMA ASSESSORATO PER GLI INTERVENTI SUL CENTRO STORICO
Assessore Paolo Battistuzzi
Direttore Bruno Cussino
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Direttore Maria Elisa Tittoni
Vice Direttore Maria Grazia Tolomeo Speranza
Organizzazione Nicoletta Bufacchi, Beatrice Galasso, Mara Pitorri
Allestimento
Progetto: Anna Di Noto, Pier Luigi Eroli
Realizzazione: lntersistema
Coordinamento: Antonio Simbolotti
Assistenza all'allestimento: Mauro Marini
Ricerche e materiali video e cinematografici Officina Film Club
Fotografi Pietro Olivieri, Carlos Vallejos
Segreteria amministrativa Elisabetta Bemabei
Referenze fotografiche Archivio Fotografico della Triennale di Milano, Gabriele Basilico, Roberto Cavallini, Bianca Corazziari, Pino Dell'Aquila, Maurizio Di !anni, Fondazione Michelucci, Fotocielo, Luigi Ghirri, Guido Guidi, Mimmo Jodice, Silvia Massotti, Paolo Pellion, Sergio Rossi, Grazia Sgrilli, Anna Maria Temperanza, Stefano Topuntoli
Assicurazioni Ascoroma
Ufficio Stampa Bianca Lami Cimiotta
ORGANIZZAZIONE E CURA DELLA MOSTRA
Daniela Fuina, Francesca Margo11i, Maria Carla Meloni, Antonio Simbolotti
COMITATO D'ONORE
Ettore Bemabei - ITALSTAT, Gastone Bollino - INTERMETRO, Renato Cecilia - lNASA, Umberto Colombo - ENEA, Tullio De Felice - ACOTRAL, Teodoro De La Grange - ASCOROMA, Antonio Delle Fratte - AMNU, Mario De Sena - CONDOTIE D'ACQUA, Bruno Gabrielli - ANCSA, Adriano La Regina - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI ROMA, Enrico Manca - RAI, Luigi Pallottini - ATAC, Ernesto Pascale -SlP, Leone Piccioni - BONCFICA, Alfredo Provvidera - METROROMA, Pier Paolo Saleri - ACEA, Francesco Zurli - SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONJCJ E AMBIENTALI
DI ROMA
COMITATO SCIENTIFICO
Massimo Casavola, Renato Cecilia, Bruno Cussino, Daniela Fuina, Achille Maria Ippolito, Francesco Moschini, Roberto Perris, Luigi Prestinenza, Antonio Simbolotti, Antonino Terranova, Corrado Terzi
COMITATO DEI CURATORI
Roberto Perris, Achille Maria Ippolito, Corrado Terzi, Francesco Moschini, Antonio Simbolotti , Daniela Fuina, Antonio Terranova, Maria Cristina Tullio, Massimo Casavola
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATORE
Ripartizione X: Luisa Cardilli, !NASA: Renato Cecilia, us1cs: Bruno Cussino, Luigi Prestinenza, ANCSA: Antonino Terranova
CURA DEL VOLUME
Daniela Fuina, Francesca Margotti, Antonio Simbolotti
Il coordinamento tra le due se~(o11i della mostra è stato curato da: Anna Cambedda Napolitano, Luisa Cardilli, Daniela Fuina, Antonio Simbolotti
Edizioni CARTE SEGRETE
Direzione Artistica Massimo Riposati
Coordinamento Lia Maria Viscuso
Grafica Manuela Sodani, Mauro Fanti
ANNI'50
ANNI '60
ANNl '70
ANNI '80
INDICE
Alcuni aspeui dell'emergenza degli "spazi urbani" ........................................... .......................... .............................................. ...... ......... ............ .. 23 Comitato scientifico
Il progetto di allestimento della mostra ...... .......... ...... ............................................................................... ....... ......... .... ......................................... 35 Arma Di Nora, Pierluigi Ero/i
Disgregazione urbana e rimozione dello spazio pubblico .................................................. ... .......... ...................................................................... 4 l Roberto Perris
Monumento ai caduti delle Fosse Ardeatine • Piazza Capecelatro a Primavalle • Quartiere IN A-Casa Tuscolano • Quartiere INA-Casa Tiburtino• Case a Torre in Viale Etiopia • Parchi e giardini dell'Eur: sistemazioni realizzate negli anni '50: Area centrale dei laghi all'Eur -Parchi della Valfiorita del Ninfeo e del Turismo - Altre sistemazioni minori • Concorso per l'edificio di testa della stazione Termini• Concorso per la città giudiziaria a Piazzate Clodio • Concorso per la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele Il • Aerostazione dell'Aeroporto Leonardo Da Vinci a Fiumicino• Palazzina detta "Il Girasole" in Viale Bruno Buozzi • Autorimessa e mercato in Via Magna Grecia • Casa Baldi al Km. 12 della Via Flaminia • Grandi Magazzini "La Rinascente" a Piazza Fiume
La progettazione dello spazio pubblico tra utopia e realtà ................................... ............. ........................................................................ ............. 75 Achille M.lppo/ito
Piano di zona n° 46 di Spinaceto • Quartiere A.L.P.l. • Quartiere INCIS a Decima • Villaggio Olimpico • Palazzetto dello Sport• Viadouo in Corso Francia • Stadio del Nuoto• Stadio Olimpico• Complesso Sportivo dell'Acqua Acetosa• Massenzio Caracalla • Velodromo Olimpico• Via Olimpica • Viadouo dell'autostrada di Fiumicino • Parcheggio sotterraneo a Villa Borghese • Proposta di ristrutturazione dei Lungotevere a Roma• Concorso per i nuovi uffici della Camera dei Deputati • Uffici Giudiziari • La Biblioteca Nazionale • Episodi che caratterizzano l'ambiente urbano
La riscoperta dello spazio pubblico ............................................................................................................................................................... ...... 105 Corrado Terzi
Vigna Murata• Laurentino • Tor Sapienza • Corviale • Vigne Nuove • Parco dell'Appia Antica • Parcheggio Villa Borghese• Tangenziale Est • La Metropolitana • Progetto di segnaletica • L'effimero anni '70-'80
Architetture per la città ............................................................ .................... ....................... ........................................ ......................................... 139 Amonio Simbo/01ti
Non solo Roma. Piccole e grandi questioni ................... ....................... ........................................................................................... .................... J 43 Francesco Moschini
CENTRO STORICO E ARCHEOLOGIA ....... .............. ............. ................................. .......................................................................... ............................. 149 Colosso • Area Archeologica Centrale e Bando di Concorso delle aree di bordo • Sistemazione della zona archeologica centrale di Roma • Sistemazione dell'area archeologica di Largo Argentina• Museo Archeologico e Archivio al Tempio delle Ninfe Campo Marzio• Sistemazione degli scavi archeologici al porto fluviale di Testaccio
LE PIAZZE ...... ............................. ............................................................................... ...................................................... ....................................... 156 Piazza del Pantheon • Piazza Beniamino Gigi i • Piazza Colonna • Piazza Madonna ai Monti • Piazza del Popolo • Piazza della Repubblica• Via del Teatro Marcello• Piazza Zama • Ponte di Nona • Renovatio Urbis • Piano parcheggi: sistemazione degli spazi del verde e degli arredi • Piazza Risorgimento • Piazzale Cl odio • Piazza Mazzini • Piazzale delle Provincie • Piazza Finocchiaro Aprile • Piazza Annibaliano
LA STRADA .. ........ ....... ...... .............. ....... ....................... ... ... ........... .......................... .............. ...................................................... ................. .......... 167 Via Veneto• Avanguardia e Transavanguardia • Mura Aureliane • Via Margutta • Piazza S.Salvat0re in Lauro • Piazza dei Coronari • Tor di Nona • Ghetto • Lungomare di Ostia • Concorso fontane
PARCI-U E GIARDINI .................. ...................................................................................................................... ............. .... .............. .......................... l 78 l progetti del Servizio Giardini • Giardino per il Cenrro Anziani Palazzo Pizzicaria • Ex Acquario in Piazza M.Fanti • Piano di riqualificazione del Colle del Gianicolo e Piazza Garibaldi • Orto Botanico• Concorso 48 aree • Parco Fluviale Archeologico • Sistemazione paesaggistica dell'area archeologica • Colosseo • Palatino
INFRASTRUTTURE .... .... .............. .................................................................................................... ......................................... ................................ 187 Ristrutturazione area di Porta S.Paoto • Stazioni della Metropolitana di Roma- Linea D • Grande Raccordo Anulare di Roma· Itinerario attrezzato di scorrimento interno al Grande Raccordo Anulare• Cavalcavia sull'Appia Antica • Centrale urbana sotterranea SlP • Torre del Centro-Roma Laurentino • Centro polivalente delle acque
AREE STRATEGICHE .................... ......... ........ .............................................................................................................. ............................................. 193 Piano particolareggiato dell'area di Piazza Vittorio • ll ripristino detta cancellata storica di Piazza Vittorio • Giardino di Piazza Vittorio• Piano quadro Testaccio
GRANDI PROGETft .. ......................... ....................... ................................................................................................................................................. 199 Moschea e Centro culturale islamico • Dipartimento di informatica - Università La Sapienza • Progetto di ristrutturazione della Stazione Termini • Progello di sistemazione di Piazza dei Cinquecento e delle Terme di Diocleziano • Piano di Zona 03 Tor Vergata • Piano di Zona 04 Casale di Gregna • Laboratorio di Progettazione indetto dalla A.A.M. • Progetto del gruppo romano alla XVU Triennale di Milano
PAESAGGIO URBANO
ITALIA
EUROPA
VIDEO CITIA'
Il paesaggio della città ....... .................................................................................................................................................................... ............... 217 Daniela Fuina
Finiture del plateatico stradale• illuminazione pubblica • Finiture esterne degli edifici • Edicole e chioschi• Parchi e verde d'arredo• Sculture e monumenti commemorativi• Trasporti pubblici urbani • Elementi per la raccolta dei rifiuti • Esercizi commerciali • Indagine sui negozi storici ed alcuni negozi d'autore presenti a Roma
Paesaggi metropolitani ........................................................................................................................................................ ................................. 25 1 Antonino Terranova
Panorami italiani ................................. ... .............................................................................................................................................................. 257 Carmen Andriani
ANNI '50 ....................................................... ........................... ................................. ............................................................................................. ............... 260 TRASFORMAZIONI URBANE -GRANDI PROGETTI: Matera, Villaggio La Martella. Mìlano, Quartiere QT8. Milano, La Torre Velasca STRADA: Torino, Bottega d'Erasmo • Venezia, Casa d'abitazione aUe Zattere • Milano, Complesso per abitazioni cd uffici in Corso Italia PADIGLIONI: Torino, Padiglione San Valentino• Milano, Padiglione Breda
ANNI '60 ................... ............................................................................ .............................................................................................................................. .. 264 TRASFORMAZIONI URBANE: Genova, Quartiere Residenziale Forte dei Quezzi • Mestre, CEP alle Barene di S.Giuliano • Torino, Concorso Centro Direzionale INFRASTRUTTURE: Firenze, Chiesa di San Giovanni Battista• Genova, Viadotto sul Polcevera • Milano, Metropolitana SPAZI MONUMENTALI - ALLESTIMENTI MUSEAU: Milano, Piazza Meda • Temi, Case Franconi e Pallotta in Largo Spada • Castelveccbio, Restauro e allestimento del Museo di Castelvecchio
ANNI 70 ........................................................................................................ ............................................................................................. .......................... 267 TRASFORMAZIO!'ll URBANI!: Milano, Complesso residenziale Monte Amiala • Palermo, Quartiere Zen • Ivrea, Unità residenziale per dipendenti Olivetti SPAZI MONUMENTALI: Modena, Cimitero di San Ca1aldo • Parabila, Cimitero • Pieve Emanuele, Cenrro Civico con Municipio • Al1ivole, Tomba monumen1ale Brion • Erto e Casso, Nuovo cimilero STAZIONI DI SERVZIO, PIAZZE ED ARREDO URBANO: Aulostrada del Brennero, Stazioni di servizio AGfP . Sislema Briona . Milano, Arcangeli Metropoli1ani
ANNI '80 ................................ ......... ................................................................................................................................................................ ...................... 272 TRASFORMAZIONI URBANE: Milano, Concorso per il Polo Tecnologico della Bicocca• Venezia, Isola della Giudecca, abitazioni popolari • Torino, Isolato in Via S.Agostino SPAZI MONUMENTAU: Temi, Nuovo palazzo degli Uffici Comunali • Genova, Nuovo Teatro Carlo Felice • Mìlano, Piazza del Duomo• Perugia, Centro Direzionale Pomivegge SPAZI PUBBLICI: $.Severina, Sis1emazione della piazza e giardino comunale• Cefalù, Fronte a mare -La Corte delle S1eJJe • Gibellina, Nuova piazza • Polizzi Generosa, Pavimentazione e fontana • Lecce, Piazza del Mercato • Palazzuolo sul Senio, Piazza e Nuova fonre INFRASTRUTTURE: Milano -Stazione MM di Piw.a Croce Rossa • Cultura balneare • Bologna, Tangeniiale
Dalla città funziona.le alla ricerca di identità dei "luoghi" urbani ...... ......... ................................................. ........................................................ 279 M.Cristina Tullio
Piano di ricostruzione di Le Havre • Piano per il Nedre Norrrnalm • Karl Marx Allee • Barbican Cenrer • Stevenage • lnterventi a Firminy Vert • Défense • Robin Hood Gardens • Marne la Vallée • Parco dell'Arlequin • Peine de Los Vienros • Centro Civico Derby • Museo di Monchengladbacb • Villaggio Olimpico del Poble Nou • Parco della Estaciòn Norte • Parco della Villene • Parco di Sausse1 • Piazza della Stazione di Sants
Immagini della città in movimenro ............................................................................................... .......................... ............................................. 299 Massimo Casavola
Passeggiate romane .............................. ...................................................................................................... ....... ...................... ............................. 308 Officina Film Club ·
Cali me Ismael ................... ..................................................... ........................................ ..................................................................................... 309 Gianni Menon
NON SOLO ROMA. PICCOLE E GRA1\1DI QUESTIONI
Francesco Moschini
La situazione attuale delle città italiane è tale da imporre come prioritari gli interventi pi restauro e conservazione, sia per quanto riguarda i singoli manufatti che per intere parti della città moderna. Quando parlo cli città moderna mi riferisco in particolare a quella costruita a partire dalla prima rivoluzione industriale. Anche se è dal '900, che si andranno configurando parti di città più complete e riconoscibili da un punto di vista architettonico e urbanistico. In questo senso una città come Roma è caratterizzata da tre situazioni profondamente emblematiche: l 'EUR, il Foro Italico e la Città Universitaria, che rappresentano momenti particolarmente importanti di progettazione unitaria di parti urbane, con da un lato un impianto di estremo interesse urbanistico e dall 'altro episodi architettonici che rappresentano alcuni fra i momenti più alti della dialettica tra la tradizione classica e il razionalismo. Pertanto diviene importante estendere il concetto di salvaguardia agli stessi tessuti urbani. Assistiamo invece al più generale disinteresse sia verso il singolo edificio che verso l'impianto urbano compiuto. L'EUR rappresenta un fatto molto importante per la sua collocazione storica di momento cli passaggio tra un ordine classico reinterpretato come modello anziché come tipo e la sua possibile continuazione in una tradizione del moderno, proprio per la sua volontà di porsi come modello di astrazione in quanto destinato a rischiarare su di sè un ruolo di immagine progettata per dar enfasi all'Esposizione Universale che avrebbe dovuto svolgersi nel 1942. Come già era successo nella città Universitaria, anche qui Piacentini chiama a raccolta la cultura architettonica di quegli anni anche se si porrà in maniera vincolante l'idea del ritorno ali' ordine cui tutti dovranno sottostare. Saranno le personalità più accorte a fuoriuscire dai ferrei vincoli piacentiniani per proporre alcune tra le opere più straordinarie dell'architettura moderna a Roma, come A. Libero nel Palazzo dei Congressi, i BBPR con il Palazzo delle Poste e E. La Padula con il più contraddittorio palazzo della Civiltà del Lavoro. Tutti comunque dovranno sottostare a quell'aurea monumentale cui aspirava e a cui condizionava l'impianto urbanistico. Il rinvio dell'Esposizione Universale e le vicende belliche determineranno la perdita di parte del progetto originario e l'urbanizzazione delle zone limitrofe con criteri più spesso opportunistici piuttosto che in armonia con l'impianto preesistente. L'attuale più distaccata lettura storico-critica rivela e riscopre l'importanza sia urbanistica che architettonica di tutto l'EUR, per il quale il mantenimento e il controllo della forma urbana da un lato, e il restauro del palazzo dei Congressi e la riqualificazione interna del palazzo della Civiltà del Lavoro dovrebbero costituire obiettivi prioritari, così come il restauro ed il riordinamento, secondo il progetto originario, dell'ufficio postale dei "BBPR". Importante sarebbe a questo proposito che gli interventi di ripristino e di riorganizzazione funzionale fossero affidati a personalità affini e sensibili alla cultura architettonica di quegli anni, anziché, come si va ventilando, vedi il caso del Palazzo dei Congressi il cui restauro era stato offerto a una
143
personalità come R. Piano certo non affine a questo tipo di cultura sempre oscillante tra classicità e mediterraneità a nomi di puro richiamo spettacolare all'interno delle grandi firme dell'architettura. Per quanto riguarda la Città Universitaria il discorso è ancora più delicato perché da una parte la manomissione è stata portata a livelli irreversibili, come nel caso dell'Istituto di Fisica, con l'avvenuta sopraelevazione dell'edificio di Pagano, dall'altra si è procequto all'inserimento di nuove costruzioni che hanno stravolto completamente il disegno urbano piacentiniano, soprattutto nella parte esterna all'impianto "basilieale", su cui sono attestati gli esempi più significativi dell'architettura degli anni '30. Le nuove esigenze funzionali non possono ignorare i valori storici ed architettonici espressi da questo complesso, nè è più comprensibile il perdurare di un atteggiamento che continua a tenere separati cultura e nuove esigenze funzionali. E' necessario allora trovare un momento di sintesi e una prassi operativa all'interno della quale stabilire corrette metodologie d'intervento. Il Foro Italico presenta i problemi più urgenti proprio per la sua vocazione a Parco urbano attrezzato che è andata man mano scemando, compromettenti sia le singole presenze architettoniche che la possibile continuità con le pendici di Monte Mario. Si pensi al disastro compiuto con la manomissione ~ella Palazzina della Scherma di Moretti, destinata ora a ospitare processi caratterizzati da grandi necessità di sicurezza e completamente stravolta, ora, nelle sue magiche qualità spaziali interne. Questo atteggiamento cinico e distratto caratterizza tutta la politica degli interventi su architetture storiche. E se da un lato si circoscrive il "centro storico" all'interno di normative capaci solo di limitazioni e divieti senza per altro imporre mai prescrizioni capaci di salvaguardare gli edifici, i tessuti e lo stesso carattere dei luoghi letteralmente degradati dagli assalti consumistici, dall'altro ciò che si colloca all'esterno di questa ideale e niente affatto protettiva linea delimitante il centro storico, diviene oggetto su cui è lecito qualunque intervento. Così demolizioni, costruzioni, ricostruzioni si susseguono nel tempo ad onta degli appelli sempre più insistenti, che la cultura ufficiale e non, rivolge al fine di proteggere e tutelare edifièi il cui valore è riconosciuto e apprezzato non solo in Italia. Anziché dunque pensare ad interventi molto mirati di microchirurgia architettonica, come quella necessaria per intervenire su parti di città circoscritte e riconoscibili nella loro unicità, a distanza di quasi trent'anni si continua a puntare su un disegno totalizzante della città, ingombrante cultura delle macrostrutture, tipica del boom degli anni '60. Lo SDO, su cui tutte le forze sono ormai allertate, infatti non è altro che una riconversione della ormai lontana idea di L. Piccinato dell'asse attrezzato, che per quegli anni, poteva apparire come l'unica possibilità per risolvere i problemi ùrbanistici di Roma, ipotesi per altro viziata da problemi di pura configurazione formale data la disponibilità allora delle aree. Riproporre oggi un'operazione di questo tipo sembra assumere caratteristici demagogici volti a soddisfare le ambizioni del-
la cultura architettonica desiderosa di lasciare segni nella città e appettiti economici di cui è indicativa la passività dell'amministrazione Comunale. Roma è una città tonnentata da situazioni irrisolte ormai da anni, dove le cose più urgenti sarebbero la soluzione di problemi puntuali e ben definiti come la annosa questione dell 'Auditorium, destinato ancora a raccogliere, al massimo, tanti bei primi premi in inutili concorsi di architettura, o il problema di riqualificare l'attuale Centro Fieristico, peggiore di qualsiasi fiera di provincia, adeguandolo alle esigenze di una città moderna o ancora l'assenza di un idoneo centro Congressi, oggi interamente sostituito da strutture private. In tale contesto si preferisce, invece di elaborare un piano di crescita e di sviluppo complessivo, rimettendo in discussione le scelte urbanistiche, tipiche degli anni '60, del Piano Regolatore Generale, sovrapporre ad una città considerata come un tutto omogeneo e indifferenziato un intervento spettacolare che ne dovrebbe, miracolosamente, risolvere le contraddizioni. E' forse lecito chiedersi se realmente Roma ha bisogno di un Sistema Direzionale e se invece questo non sia già compreso nel disegno della città e vada solo rievocato attraverso più mirati interventi di ricucitura, per esempio nelle stesse aree dello SDO, degradate in modo irreversibile ed formalizzazione urbanistica di situazioni chiave. Ancora è opportuno chiedersi quale città si voglia costruire e se l'immagine evocata sia compatibile con la storia e la memoria di Roma, per la quale ancora una volta si ricorre all'intervento taumaturgico di "estranei protagonisti" della cultura internazionale, con le incomprensioni e la superficialità che questo comporta. Si può per Roma, in armonia con la politica e le smanie di protagonismo, pensare ancora in termini di megalopoli sul modello di città come Tokyo o New York? li quartiere di Testaccio ha assunto un ruolo centrale nello sviluppo urbanistico, ma anche architettonico, romano a partire dall'unità d'Italia, definendosi, in contrasto con il progetto post-unitario che lo proponeva come polo industriale e di servizi, come quartiere operaio e popolare, alla realizzazione del quale hanno contribuito alcuni fra i più interessanti architetti del '900, come Q. Pirani, L. Magni e I. Sabbatini e, nel periodo compreso fra le due guerre, A. Libera e De Renzi, che proprio ai limiti del quartiere hanno realizzato l'edificio delle Poste che resta a tutt'oggi uno degli esempi più straordinari dell'architettura moderna. Se consideriamo inoltre la presenza del Mattatoio progettato da G. Ersoch e di alcune significative emergenze quali il Monte dei Cocci, e il Campo Boario ed il Cimitero Acattolico insieme alle aree archeologiche di particolare rilievo, è evidente l' importanza "storica" che assume il quartiere nel suo complesso. Su questo coacervo di presenze e di memorie si evidenzia in modo esemplare, per la sua sistematicità, il "Pianoquadro" di Testaccio, elaborato dall'architetto L. Caruso in quella stagione di "euforia" pregettuale durante la gestione Aymoniana dell'assessorato al centro storico. E' innanzitutto riconosciuto al quartiere il carattere di parte di città formalmente compiuta, così come negli anni '70 era stata teorizzata da C. Aymonino, mentre se ne rispettano i valori onnai consolidati rafforzandone il carattere residenziale e integrandolo con attrezzature culturali e sportive. Il "piano-quadro", nato per sopperire alle inevitabili limitazioni che caratterizzano uno strumento come il Piano Regolatore, parte dal presupposto che "i patrimoni storici e artistici i grandi complessi immobiliari costituiti dalla stessa realtà urbana e la semplice concentrazione di persone nelle metropoli sono già, per loro natura fattori di 'ricchezza, segni dell'evoluzione sociale"', si tratta dunque d'impostare un processo di trasfonnazione degli elementi architettonici e urbanistici già disponibili. Nell'ambito del Piano-quadro che ripropone anche nel disegno di una piazza ellittica e di adeguate attrezzature la memoria della vocazione "sportiva" di quel quartiere in cui si insidiò la "Roma" ai suoi esordi calcistici, sono stati individuati tre elementi emergenti: la residenza (con tessuto ottocentesco integro e qualificato), l'artigianato (con una forte presenza di lavoratori e botteghe che sfruttano anche situazioni precarie e costituiscono per l'area un fattore di identità da conservare) e infine i beni culturali. Intorno a questi elementi si è sviluppato il
144
piano programma che ha coinvolto nell'iniziativa anche il Dipartimento di Architettura e Analisi della Città della Facoltà di Architettura di Roma con una ricerca coordinata da C. Dardi e F. Purini e da E. Guidoni. Quindi completamento attraverso la funzione residenziale secondo l'originaria maglia ottocentesca integrazione dell'artigianato e del commercio, infine individuazione delle aree e progettazione di attrezzature culturali sociali e sportive ora utilizzando la preesistenza come contenitore, ora attraverso nuovi progetti. E' nel rispetto delle preesistenze e delle caratteristiche del luogo che si collocano sia l'asilo nido che i laboratori progettati da L. Caruso nell'area dei prati del popolo romano. L'asilo nido a pianta centrale e l'edificio in linea dei laboratori fronteggiantisi ai lati del campo sportivo che ripropone quale elemento a grande scala urbana il circo agonale romano, svolgono il ruolo di ricucitura e riqualificazione urbanistica della breccia esistente tra la piramide e la Porta S. Paolo mentre enfatizzano le dissonanze linguistiche, nell'ambiguo rovesciamento delle falde della copertura, e nella muratura in blocchetti di tufo interrotta dei ricorsii in mattoni pieni e dal.la d.iscreta contaminazione con elementi metallici. L'area dei prati del popolo romano è completata, nell'ambito della ricerca affidata all'Università, da alcuni interventi progettuali, che esaltano caratteri peculiari del quartiere e della città: l'ossessiva spazialità romana, alla ricerca di quel vuoto senza qualità fatto vibrare dalla selva dei pi.lastri, del mercato di D. Passi, la rievocazione dell 'architettura di pietra tra Venezia, Genova e Roma delle residenze di F. Prati e, sul limite del monte dei cocci, il museo di G. D'Ardia e A. Zattera, con le sue composte reminiscenze classiche appena temperate dall'ordine del moderno, e che ben si adattano al parallelo lavoro di rilievo filologico e di recupero delle Grotte del Monte. In composta analogia con il preesistente edificio residenziale si colloca invece il progetto di un edificio a corte aperta di A. Lambertucci, che mina, nel prospetto interno, lo stesso ritmo delle bucature della preesistenza e si propone integralmente come riflessione e rielaborazione delle forme dell'abitare definitesi negli anni '50 con la tipologia, tutta romana, della palazzina. L'estrema elaboratine del tema urbano è costituita però dal progetto per residenze speciali di A. Anselmi, nel quale si innestano elementi altamente simbolici quali il sistema ascendente della rampa fiancheggiata da quinte svuotate dietro le quali corrono i ballatoi. L'orizzontalità sottolineata da correnti, i modesti aggetti delle logge così come le astratte emergenze del prospetto sul retro, evidenziano un processo compositivo per parti giustapposte e violentemente ricomposte in un intervento che si presenta comunque fortemente unitario. Ed è proprio in questo esasperato ritorno al "Moderno" che A. Anselmi raggiunge una straordinaria unitarietà dei diversi piani del suo usuale ricorso al simbolismo, quello della fonna astorico, quello archetipico e quello urbano della città come organismo di parti diverse in cui pare ritrovarsi la verifica di quel "salto qualitativo" hegeliano. Più accattivante è il progetto per la città della scienza e della tecnica di P. Portoghesi, il cui ricorso al simbolismo si fonda su di una ben individuata iconografia romana. I terni dell'obelisco, della piazza chiusa della torre e del muro cieco introducono nel composto e ordinato tessuto ottocentesco elementi di discontinuità figurativa ma rivendicano nel loro carattere di emergenze, il ruolo di mediazione tra centro storico e periferia che caratterizza il quartiere di Testaccio. Il progetto di F. Purini e L. Thennes che segue un precedente progetto localizzato nel Campo Boario e che esaltava il carattere misto di residenza e artigianato dell'area nell'elaborazione di tradizionali modelli tipologici e che resta ancor oggi una delle più avvincenti sperimentazioni sulla idea di abitare, si attesta nella zona archeologica del porto fluviale. La riflessione sull'architettura romana, con l'immediato richiamo ali' emporium preesistente, elabora un elemento architettonico fortificato, presente anche nel progetto per l'isola tiberina, che limita il rapporto tra la città e il fiume e racchiude dentro di sè i resti archeologici. La tutela è affidata a questo elemento-diga, reso più incisivo dal ritmo necessario, dalla misura come generatrice di fonna. Il quartiere di Testaccio per la complessità storica, architettonica e ur-
banistica che lo caratterizza può porsi allora come vero e proprio laboratorio tra i più avanzati per le nuove strategie di intervento urbano complessivo. Solo nell 'unitarietà della concezione progettuale sarà possibile allora intervenire sulla città nella logica della salvaguardia e rifunzionalizzazione della città per "parti" e per "fasi" successive.Ecco perché mi sembra malposto il problema "parziale" di attrezzare degli spazi sopratutto nel caso del.le "piazze di periferia", perché ciò sembra essere nella sua "separatezza" di partenza più una sorta di risposta volta ad acquietare le cattive coscienze soprattutto colpevoli delle attuali condizioni della periferia piuttosto che una volontà di risolvere il degrado complessivo di queste aree di "margine". Possiamo in qualche modo considerare definitivamente risolto il problema della progettazione delle piazze proprio con le teorizzazioni di C. Sitte. Per quanto questo possa apparire paradossale, l'opera, del 1889 (L'arte di costruire la città), mette a fuoco una tematica di estrema attualità, non per quanto riguarda l'enunciazione di una tecnica capace di consentire la progettazione di questi particolari luoghi urbani, quanto per il sottolineare e poi ridurre a tecnica un problema legato più in generale ai modi d.i crescita stessi della città, al suo "pensiero". Dopo le esperienze del dopoguerra, a proposito delle quali si veda per esempio il fallimento del Tiburtino, partito da un 'ipotesi di crescita della città per nuclei e finito per trasformarsi in "Paese di Barocchi", assistiamo alla concreta applicazione dei modelli di zoning di tradizione anglosassone, di cui un episodio come Corviale rappresenta l'ultimo momento, che ancora, come il Tiburtino per L. Quaroni, sfocerà in progetti autocritici redatti da M. Fiorentino. Ora il problema non sembra essere quello di decidere con quale "trucco" intervenire in periferia, se siano migliori le piazze medievali di C. Sitte, o le ipotesi neorealiste del dopoguerra, o ancora gli intensivi degli ultimi anni, per finire ad ipotizzare il ridisegno di piazza del Popolo, come propone P. Portoghesi, nella convinzione che la forma di un luogo possa in qualche modo porsi come garanzia di qualità della vita. Allora il problema va posto, prima ancora che in termini di maquellage, in termini di crescita della città, la quale fino ad ora si è sviluppata in totale assenza di piani, secondo mentalità speculative non estranee agli stessi enti pubblici. Cioè la città cresce, occupa spazi liberi, quasi in modo autonomo, poi necessità fiscali, prima ancora che di igiene pubblica condonano, infine il coro di lamenti sulla periferia senza qualità, sulla necessità di porre rimedi, e il rimedio rischia di essere peggiore della malattia: non si cambia la qualità della vita arredando piazze, o peggio ancora, disegnandole attraverso l'arredo. Tuttavia continuiamo a muoverci senza pensare. Che cosa va pensato innanzitutto? Dobbiamo riflettere sulla città moderna, sui contenuti, sui valori prima ancora che sulla sua forma, poi pensarne la forma, e non l'arredo. Penso a tutte quelle proposte d'interventi che ritengono i poter caratterizzare un luogo con elementi estranei come una statua una scultura, magari una fontana scultorea, con cippi marmorei, decontestualizzati se non addirittura ridotti a caratterizzare rotatorie per la circolazione veicolare. Infine c'è ancora un altro problema come possiamo pensare alle piazze di periferia quando questo, nello stesso centro storico sembrano essersi ridotte a una pura questione toponomastica se non sono sostenute da una alta concentrazione di servizi, (che comporta altri problemi) senza citare la fin troppo nota piazza Venezia, che dire di quei luoghi informi come per esempio piazza bocca della Verità o piazzale Flaminio? Mi sembra inoltre opportuno riflettere anche sul carattere eterogeneo della periferia, e sulla labilità stessa del concetto. Esistono infatti periferie di straordinaria bellezza, e non mi riferisco solo ai luoghi immortalati da L. Visconti in Rocco e i suoi fratelli o da P.P. Pasolini in "Accatto", oppure che si sono caricate nel tempo di notevoli valori storici, culturali, ambientali. Ritengo di estrema importanza calibrare le scelte, e mi spiego. Da un lato c'è un atteggiamen-
to intellettuale, che romanticamente vorrebbe lasciare le cose così come sono, evitando qualsiasi tipo di intervento, dall'altro, nella prassi quotidiana assistiamo alla più totale ignoranza nei confronti della preesistenza, che, con estrema leggerezza, viene regolarmente manomessa a fino ad una condizione di degrado. Ora una delle caratteristiche di questi luoghi è la loro vitalità espressa, attraverso le nuove costruzioni di volta in volta necessarie al funzionamento di quella parte di città, non ancora satura com'è il centro storico. E' opportuno che queste tengano conto oltre che della propria necessità e funzione del tessuto urbano, delle qualità e caratteristiche architettoniche, all'interno delle quali si pongono. Noi, cioè non possiamo intervenire in modo analogo a Testaccia e a Spioaceto, io entrambi i casi dovremo sapere dove interveniamo, decidere come, ecc. nella salvaguardia di valori presenti anche in situazioni "moderne". Ed infine per poter riflettere anche sugli atteggiamenti corretti di fronte ad imprese meno eclatanti ma non meno condizionanti il volto della città, vorrei sottolineare il senso e la portata di un'operazione come quella del "colore" io una città come Roma. Premetto che fare un discorso sul "colore" ed i problemi delle facciate del Moderno in una città come Roma che si presenta carente di infrastrutture ed "abbandonata"per quanto riguarda la qualificazione del tessuto urbano di quello residenziale in particolare, riveste un aspetto demagogico che sembrerebbe rivolto più alla propaganda se non all'autocelebrazione dei vari sponsor o istituti preposti alla salvaguardia oltreché un carattere antistorico proprio per il ruolo dell 'architettura moderna che tanto ha fatto per essere antiprospettica e, fruibile nella sua compless_ità a tutto tondo. La situazione roman1-poi non si presenta con le caratteristiche di omogeneità,ad esempip. di Torino, per cui sia possibile parlare di piano del colore e rich"iedç. invece interventi differenziati che tengano conto del suo essere pura successione di stratificazioni storiche. E' inoltre praticamente trascurata la manutenzione dell'architettura sul versante dell'edilizia residenziale come appare, con grande chiarezza, allontanandosi dall 'arbitrario perimetro del centro storico verso una periferia che ormai è caratterizzata contrariamente a quanto si continua a credere, a sproposito, da un'alta qualità architettonica e urbanistica, si pensi al quartiere tuscolano con le torri di S. Muratori e l'unità di abitazione di A. Libera (luoghi emblematici della periferia pasoliniana) o a edifici come la splendida casa a gradoni di I. Sabbatini a Via della Lega Lombarda o il prospiciente cinema Jolly, notevolissimi esempi del novecento romano la cui pura ridipintura è ormai indifferibile e sarebbe sufficiente per farli uscire dal loro attuale stato di degrado. Mentre infatti edifici a carattere pubblico, quelli postali di M. Ridolfi a Piazza Bologna, G. Samonà a Via Taranto o di A. Libera all'Aventino o le stazioni sono soggetti a manutenzioni che seppure spesso intervengono senza particolare cura nella rifunzionalizzazione degli interni, ne garantiscono però la continuità di immagine all'esterno, il privato, non soggetto ad alcuna normativa, è troppo spesso degradato o malamente reinterpretato. Fondamentalmente allora è innanzitutto riconoscere la qualità architettonica sia del singolo edificio che dell'intero tessuto urbano, per esempio l'edificio moderno di A. Libera a Via di San Basilio, in un contesto tutto più antico o l'intero tessuto urbano di Prati dove i singoli edifici avrebbero da soli scarse qualità architettoniche mentre l'unità di immagine, attraverso una appropriata manutenzione, ne ha rivelato insospettate bellezze. Da ciò è necessario partire per definire ogni singolo intervento che può avere necessità di interventi filologici, come nel caso della Palazzina di P. Aschieri a Piazza della Libertà o quella Furmanik di M. De Renzi al Lgt. Flaminio, oppure interventi più liberi, in altri contesti, dove ad esempio diventa inutile recuperare infissi io legno che devono essere più adeguatamente sostituiti da quelli io alluminio o in plastica, questo sì, meglio disegnati, progettati ed eseguiti.
Alla sezione "Anni '80", hanno collaborato : Maurizio Di /anni, Andrea Marte/lotta, Luigi Salustri, Ida Siniscalchi.
145