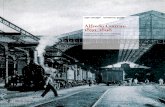Le grandi tappe della preistoria europea, dalla fine del Paleolitico al Ferro, e i loro riflessi...
Transcript of Le grandi tappe della preistoria europea, dalla fine del Paleolitico al Ferro, e i loro riflessi...
II. LE GRANDI TAPPE DELLA PREISTORIA EUROPEADALLA FINE DEL PALEOLITICO AL FERRO
E I LORO RIFLESSI LINGUISTICI1
1 Dal Pleistocene all'Olocene: la catastrofe climaticaIl Mesolitico -l'ultimo periodo preistorico prima
dell'introduzione dell'agropastorizia in Europa, con cui il continente ha acquisito la tipica configurazione territoriale e culturale ancora oggi osservabile- è caratterizzato, oltre che da importanti innovazioni concernenti il modo di produzione, anche da un grandioso fenomeno climatico ed ecologico, le cui conseguenze sono ancora attuali: la fine del Pleistocene e l'inizio dell'Olocene, che è il periodo geologico nel quale viviamo.
2 La deglaciazione e l'inizio dell'Europa climatica moderna
Fu infatti nel corso del Mesolitico, a partire da circa 13.500 anni fa, che l'Europa glaciale pleistocenica si trasformò nell'Europa temperata olocenica dei nostri tempi (detta anche postglaciale), attraverso giganteschi mutamenti, che purtroppo non hanno ancora trovato un divulgatore che abbia saputo rievocarli adeguatamente, nonostante la loro importanza per la cultura generale.
Per centinaia di migliaia di anni, durante tutto il Paleolitico, il clima dell'Europa e di altre parti del mondo era stato caratterizzato da temperature glaciali, che avevano enormemente limitato le possibilità di sopravvivenza degli uomini.Gli intervalli detti 'interglaciali' non furono mai sufficienti a cambiare il carattere generale di questo immenso periodo. I primi sforzi dell'umanità paleolitica furono quindi rivolti a combatterequesto clima glaciale, e solo dopo centinaia di migliaia di anni ottennero i primi successi, con il controllo del fuoco, l'inizio dell'uso della pelle animale come indumento, e di altre tecniche di difesa dal freddo, che aumentavano le possibilità di sopravvivenza umana in tali condizioni. Quando, giunti al Paleolitico Superiore, constatiamo che Homo sapiens sapiens aveva raggiunto livelli intellettuali e spirituali che si possono già definire 'moderni', perché si esprimeva in altissime forme d'arte,
1. Testo (senza illustrazioni e con alcune omissioni) del cap. II del secondo volume di Origini delle lingue d'Europa, in stampa.
conosceva già la sepoltura, il rito e la religione, e quindi parlava certamente forme di linguaggio moderno, dobbiamo renderci conto che ciò è stato possibile solo perché aveva vinto la sua battaglia per la sopravvivenza in un clima glaciale.
Tuttavia, ciò che il clima glaciale gli impediva assolutamente di fare era di vivere là dove il ghiaccio aveva coperto la crosta terrestre. E questa crosta di ghiaccio non solo sommergeva tutte le valli alpine e montane dell'Europa meridionale, oggi sedi di fiorenti comunità montane e pedemontane e meta di villeggiatura, ma anche tutta l'Europa settentrionale e parte di quella mediana, tanto da ridurre di quasi un terzo la superficie abitabile dell'Europa, rispetto a quella attuale. E' quindi importante rendersi conto non solo di com'era l'Europa glaciale, ma anche del fatto che essa è durata fino a pochi millenni fa, fino a quando, cioè, i nostri antenati, pescatori e cacciatori del Mesolitico, poterono insediarsi stabilmente, per laprima volta, nelle aree deglaciate.
L'Europa glaciale di alcuni millenni fa era straordinariamente diversa da quella che conosciamo: non esistevano -sommerse come erano da un'enorme calotta di ghiaccio- l'Islanda, quasi integralmente l'Irlanda e l'Inghilterra, parte della Danimarca, tutta la la Norvegia, la Svezia, la Finlandia e la Carelia, parte della Germania del Nord e della Polonia, i tre paesi baltici, vaste aree della Russia del Nord. Non solo, ma per l'abbassamento dei mari dovuto al congelamento e ai suoi effetti, la parte non ghiacciata dell'Irlanda e dell'Inghilterra erano unite alla Francia a sud e alla Danimarca a ovest, e formavano l'estremo Nord-Ovest del continente. Per cui, le popolazioni dell'Europa settentrionale di quel periodo -corrispondente all'Europa mediana odierna, trasformata però in un'immensa tundra-non guardavano al mare come al loro limite settentrionale, così come fanno adesso, ma ad una sterminata linea di ghiacciai.
Inoltre, i ghiacciai del Nord e dei rilievi montuosi, uniti ai bacini proglaciali posti fra essi, avevano di fatto bloccato loscambio culturale e genetico fra l'Europa occidentale e l'Europa orientale da un lato, e fra queste due regioni e l'Europa mediterranea dall'altro (Kozlowski e Otte 1994, Nuñez 1997).
Il primo corollario di questo quadro è quindi che in questa Europa glaciale le comunità preistoriche del Mesolitico dovevano necessariamente abitare a sud della calotta glaciale. Il secondo èche per un'interpretazione realistica delle isoglosse che legano idiversi gruppi linguistici IE fra loro occorre rendersi conto che per tutta la durata del Glaciale i contatti e gli scambi, sia
2
culturali che genetici, ebbero luogo quasi esclusivamente all'interno di ciascuna delle tre provincie dell'Europa glaciale (occidentale, orientale e mediterranea), e che questo quadro finì solo dopo la deglaciazione, nel Mesolitico. Le isoglosse che legano gruppi occidentali a gruppi orientali (come per es. quelle germano-balto-slave) sono quindi necessariamente mesolitiche o neolitiche. Solo le altre possono essere più antiche.
Che cosa fu, esattamente, a cambiare l'Europa da quella glaciale in quella attuale? E che conseguenze ebbe questo cambiamento sulle popolazioni mesolitiche d'Europa?
Ca 13.500 fa, un' enorme mutazione climatica causò il graduale scioglimento delle masse di ghiaccio che prima ricoprivano le regioni sopra descritte, oltre alle vallate alpine e montane, con un catastrofico aumento del livello dei mari. Il mare penetrò nelle valli meno profonde, separando dal continente l'Inghilterra, l'Irlanda, la Sicilia e l'isola d'Elba. Intere pianure vennero inondate, come quella che prendeva il posto dell'attuale alto Adriatico, che prima collegava l'Italia del norde parte di quella centrale alla Dalmazia. In molti suoi tratti la linea della costa europea venne radicalmente modificata. A nord, ighiacci che prima continuavano fino al Polo Nord lasciarono ora posto al Mare del Nord. Nacque ora il Mar Baltico, che prima di diventare tale passò attraverso quattro diversi stadi: il Lago Glaciale Baltico, il mare a Yoldia, il mare ad Ancylus e il mare aLitorina (v. cap. III).
3 Importanza dell'area nord-europea per lo studio della continuità
Poiché la deglaciazione comincia ca. 11.500 a.C. e dura 5 millenni, finendo quindi ca. 6.500 a.C. (Nygaard 1989, 75), il popolamento definitivo dell'Europa settentrionale quale noi la conosciamo è avvenuto soltanto in questi cinque millenni. Messo da parte il dogma dell'invasione indoeuropea, si deve necessariamente accettare lo scenario che i gruppi di pescatori e cacciatori che nel Mesolitico si avventurarono nelle aree del Nord man mano che esse si liberavano dai ghiacci, e che si rivelarono eccezionalmente ricche di pesca e di fauna, erano gliantenati degli Irlandesi di lingua celtica, degli Scandinavi di lingua germanica, dei Balti di lingua baltica, degli Uralici di lingua uralica. E' dunque fra questi gruppi che vanno cercati i creatori e a diffusori di quelle culture di pesca e caccia specializzata, di straordinaria ricchezza ed importanza, che
3
l'archeologia ha potuto ricostruire con grande precisione, grazie all'abilità dei ricercatori e alle circostanze che hanno permesso la conservazione di molti manufatti normalmente deperibili.
In un primo momento, questo popolamento dell'Europa settentrionale dovette essere, oltre che graduale e pacifico perché senza ostacoli, anche senza problemi di adattamento, dato che i cacciatori e pescatori che vivevano a sud dei ghiacci in etàglaciale conoscevano già molto bene i metodi di caccia e pesca adatti a sopravvivere nei nuovi territori nordici. A differenza delle catastrofi immaginarie della linguistica invasionista, la vera catastrofe che diede inizio all'Olocene moderno non comportò mutamenti nelle popolazioni che ormai da diecine e diecine di millenni popolavano l'Europa. Il primo impatto della deglaciazione-oltre a quello della sommersione degli abitati costieri, che provocò lo spostamento dei nuovi insediamenti verso l'interno, lungo la nuova costa che si andava formando- fu di spingere tutte le popolazioni che abitavano sotto la calotta glaciale, nell'attuale Europa mediana, a salire al nord, da una parte per seguire le mandrie che ora avevano trovato nuovi pascoli, dall'altra per sfruttare le vastissime aree e i nuovi mari che si rivelavano ricchissimi di cacciagione e di pesca. L'archeologia è oggi in grado di seguire e di studiare i movimenti dei gruppi di popolazioni che si spostavano verso nord man mano che i nuovi promettenti territori si liberavano dal ghiaccio. Sono questi movimenti di popolazioni, le cui prime traccie sono state datate dall'archeologia al X/IX millennio a.C. (Harbison 1988, 19, Barbaza 1994), a fornire le informazioni più importanti, nell'ambito della TC, per la ricostruzione dell'etnogenesi dei popoli europei del nord. Questo è in effetti il capitolo più evidente e più facile della nuova storia linguistica europea.
Il secondo impatto della deglaciazione fu più complesso, ed èstato apprezzato pienamente solo dalla ricerca archeologica moderna, a partire da Graham Clark (1932, 1936). Fino al secolo scorso, infatti, si pensava che l'Europa postglaciale, "abbandonata dai cacciatori di renne e mammut, fu un campo aperto per gli immigranti del Neolitico che la trasformarono in pascoli eterreno coltivabile" (Childe 1972, 1). Le conclusioni della ricerca sono invece: (I) Dopo la deglaciazione, l'economia di caccia e di pesca che si sviluppò nelle aree liberate dai ghiacci acquistò gradualmente caratteri estremamente specializzati e profondamente adattati, anche sul piano sociale, al nuovo sistema ecologico (Nygaard 1989,
4
71).(II) Essa diventò talmente produttiva da poter competere perfino con l'agricoltura, quando questa si era da tempo affermata nell'Europa mediana e meridionale, e quando apparve, nella fase climatica detta Atlantico -che è ancora quella attuale- la prima cultura neolitica dell'Europa settentrionale. La vecchia cultura mesolitica continuò sul Mare del Nord e sul Baltico, in area uralica, in gran parte della penisola scandinava, in Polonia, nei paesi baltici orientali, nello Schleswig-Holstein in Germania, in Inghilterra e in Scozia (Childe 1972, 16, 235). (III) Dopo la deglaciazione, i mutamenti climatici furono tali da cambiare radicalmente il quadro botanico d'Europa, non solo settentrionale ma anche mediana, con ulteriori, profondi mutamentisulle comunità mesolitiche di quelle aree. Se prima la caccia collettiva nelle steppe e nelle tundre di quella che era allora l'Europa settentrionale (cioè dalla Francia alla Russia meridionale) produceva quantità talmente grandi e sicure di carne di mammut, di renna, di bisonte e di cavallo, che i cacciatori potevano installare campi quasi permanenti (semisedentarismo) e permettersi il lusso di coltivare l'arte nel loro 'tempo libero' (Childe 1972, 1), con la scomparsa del ghiaccio scomparvero anche le vecchie mandrie, la foresta invase i campi aperti, e rese obsoleta la tecnica della caccia collettiva. La caccia si adattò ora alla foresta, e parallelamente alle innovazioni nelle tecnichedi caccia e di pesca si svilupparono anche un' elaboratissima lavorazione del legno e dell'osso, dando vita a un complesso che Childe chiamò 'culture della Foresta' (Childe 1972). Recentemente,un archeologo non ha esitato a definire "rivoluzione verde" lo straordinario fenomeno della crescita della foresta, sia nell'attuale Europa settentrionale che in quella mediana, in quelle pianure che durante il glaciale erano solo tundra, e a cui si accompagnò un'altrettanto grande crescita della fauna (Barbaza 1994). In effetti, il nuovo ecosistema ebbe una tale importanza inrapporto ai meccanismi della sussistenza dell'uomo e al cambiamento della sua percezione del mondo, da poter parlare di una "totale diversità dell'universo mentale mesolitico", che consiste nell'integrazione del vegetale nella vita quotidiana, in una concezione del mondo che ha chiamato "vegetalismo", in contrasto all'"animalismo" del Paleolitico (Barbaza 1994, 112). Vedremo, in effetti, come la terminologia della lavorazione del legname, e certi rapporti semantici connessi ai nomi degli alberi,non siano spiegabili se non in questo nuovo contesto mesolitico dell'Europa delle foreste.
5
(IV) Infine, se prima della deglaciazione le condizioni ecoclimatiche avevano consentito processi di simbiosi solo all'interno delle tre grandi provincie europee (generando isoglosse come quelle italo-celtiche, italo-celto-germaniche, balto-uraliche simili), con lo scioglimento dei ghiacci la pianuramedio-europea divenne il corridoio preferito per gli scambi fra occidente e oriente.
In questo quadro appare quindi chiaramente la straordinaria importanza dell'area nord-europea per lo studio del problema delleorigini linguistiche europee. Rispetto al resto dell'Europa, infatti, la preistoria dell'Europa settentrionale e della fascia settentrionale dell'Europa mediana mostra una differenza enorme, perché conta poco più di dieci millenni, contro le centinaia di millenni del resto d'Europa. L'area nordica (e in minor misura le aree alpine e insulari) è ideale per la TC proprio perché a causa della glaciazione essa era sicuramente 'disabitata' fino alla deglaciazione (e se fosse mai stata abitata negli intervalli qualunque traccia se ne sarebbe persa), e quindi la storia del suopopolamento e del suo sfruttamento economico si lascia ricostruirein modo del tutto certo, in contrasto al quadro più speculativo valido per il resto d'Europa.
Si noti che in questo scenario, determinato rigorosamente dalla deglaciazione, i movimenti migratorii della teoria tradizionale non sono più 'invasioni' che si sovrappongono alle popolazioni autoctone acculturandole, ma costituiscono un vero e proprio 'primo popolamento' del territorio, che non richiede quindi alcuna sostituzione di popoli, di culture e di lingue, e nessuna delle variabili introdotte obbligatoriamente dalla teoria invasionista. La verità è più semplice: come dice il proverbio, "chi primo arriva meglio alloggia". Nel Mesolitico, in effetti, un'alloggio' nelle proibitive coste nordiche deglaciate poteva essere realmente desiderabile per le popolazioni che si trovavano a sud della calotta glaciale, dato che nell'ultimo periodo dell'età glaciale erano state già sviluppate nuove tecniche di caccia e di pesca, che non solo permettevano la sopravvivenza, ma garantivano anche una relativa abbondanza: si pensi al nuovo tipo di pesca che nasce dalla scoperta delle abitudini di pesci come ilsalmone, alla facilità della pesca alla foca, alla produttività della caccia alla balena, all'importanza della tecnica dell'essiccamento del pesce per l'alimentazione e così via dicendo. Per i Mesolitici dell'Europa glaciale che si trovavano a sud dei ghiacci si trattava quindi di un'imprevista possibilità diespandere a nord il loro territorio di caccia e pesca, di
6
insediarsi nelle nuove aree, inseguendo la linea del ghiaccio in ritirata, e di mantenere così, o di aumentare, le proprie risorse,senza per questo cambiare le proprie abitudini di vita. E' quindi evidente che i primi che poterono profittare di questa nuova, ricchissima nicchia ecologica, furono le popolazioni che si trovavano a sud della calotta glaciale, e che nello scenario dellaTC sono già Celti, Germani, Balti e Uralici.
Nel quadro della teoria tradizionale, invece, in cui la colonizzazione IE del Nord Europa dovrebbe avvenire nell'Età dei Metalli, o addirittura nel Bronzo, nessuno si è mai preoccupato dispiegare perché Celti, Germani e Balti già neolitizzati -anzi addirittura in possesso della metallurgia e del cavallo come cavalcatura- avrebbero volontariamente 'scelto' aree proibitive come le coste settentrionali dell'Irlanda, della Scozia, della Scandinavia, per finirvi la vita come pescatori! E' davvero uno strano modo di conciliare i dati della linguistica con le realtà acquisite dalle altre scienze (per non parlare del buon senso), e a mio avviso l'unica spiegazione che si può dare di un simile absurdum sta nell'enorme peso psicologico della tradizione scientifica. Anche quando questa risale, come nel nostro caso, all'Ottocento pre-scientifico.
Nell'ottica della TC, il nuovo scenario corrisponde invece esattamente, anche nel dettaglio, alle conclusioni dell'archeologia. Anzitutto, gli archeologi hanno molto insitito sul fatto che le culture di pescatori, cacciatori e boscaioli specializzati del Mesolitico nord-eureopeo si continuano in parte fino ad oggi in molti aspetti fondamentali, talvolta fino nei dettagli degli utensili e delle tecniche usate, rimasti identici dopo ottomila anni. Lo abbiamo già visto in OR1, ma conviene tornarvi qui. Già Childe, sulla scorta delle fondamentali ricerchedi Clark, notava che a queste culture "si possono [...] attribuirecontributi positivi a culture più tarde che dovevano adattarsi ad un ambiente analogo. I popoli delle foreste avevano, evidentissamente, perfenzioanto un'attrezzatura atta a safruttare le risorse naturali del loro habitat; attrezzatura ancora oggi esistente in quei luoghi in cui perdurano le medesime condizioni ambientali: reti-trappola per pesi e arpioni, strutturalmente identici a quelli inventati nei tempi boreali, sono tuttora usati dai pescatori del Baltico: esempio notevole di una tradizione artigianale che sussiste localmente perfino ottomila anni! Così quei popoli avevano scoperto il modo di fare la pece con la betulla, un materiale artificiale ancor oggi usato dai conmtadini delle stesse regioni; inoltre i popoli delle foreste avevano
7
perfezionato una serie di utili strumenti per lavorare il legno e,in particolare, la ingegnosa tecnica a trincetto per affilare gli utensili da taglio di selce" (Childe 1972, 17, cfr. 10-14). E Childe aggiungeva ancora: la pesca della balena e della foca in particolare, con la particolare tecnica che richiede, l'essiccamento del pesce (ancora oggi una delle risorse fondamentali nell'area), certi tipi di strumenti da pesca e per rompere il ghiaccio (arpioni, piccozze da ghiaccio, asce per grasso di balena (idem, 12-14, 235-236), la domesticazione del cane per la caccia e per il trasporto su slitta, battelli di pelle, per non parlare della slitta e degli sci (idem, 14, 239-240), e così via. In secondo luogo, Childe notava acutamente il rapporto fra sopravvivenza del'equipaggiamento e continuità della popolazione: "il sopravviverte di un equipaggiamento implica ancvhe la continuità delle tradizioni che costringono a fabbricarlo e e asurlo; e la continuità della tradizione significa, a sua volta, una certa continuità nel tipo di popolazione" (Childe 1972, 235). Infine, Childe osservava che l'unità culturale ed economica che caratterizza l'Europa mesolitica postglaciale del Nord non significa anche unità etnica e linguistica e insisteva sulla necessità di distinguere fra diverse facies o culture regionali: in Inghilterra, in Germania settentrionale, in Danimarca, in Scandinavia del Nord, nel Balticoorientale, in Finlandia (Childe 1972, 12, 235).
Sono dunque queste facies regionali, così precisamente identificabili sulla base della documentazione archeologica, che corrispondono ai quattro gruppi etnolinguistici -Celti, Germani, Balti e Uralici- che seguendo i ghiacci in ritirata durante la deglaciazione si divisero le nuove aree dell'Europa del Nord, dall'Atlantico agli Urali. Di fatto, le culture di pesca dell'Europa settentrionale del Mesolitico corrispondono sostanzialmente alle quattro grandi aree attuali di pescatori dell'Europa settentriomale: quella di lingua celtica dell'Irlanda e Scozia, quella di lingua germanica dell'Olanda, Frisia e Scandinavia, quella di lingua baltica del Baltico orientale, e quella di lingua uralica, che si estende dalla Finlandia e dall' Estonia fino ai Samoiedi ad Ovest e ad Est degli Urali. La futura ricerca potrà studiare, sulla base della terminologia tecnica dialettale di questi quattro gruppi linguistici, i contatti, le innovazioni, la direzione delle varie correnti innovatrici.
Per limitarci qui a Uralici e Germani (degli altri due parleremo più oltre), i gruppi uralici che iniziano la loro marciadietro il ghiaccio (come riconoscono ormai linguisti e archeologi
8
dell'area uralica), sono prima portati a continuare le loro abitudini nelle nuove terre deglaciate, con le prime culture di Askola e Suomusjärvi, poi a sviluppare nuovi modi di produzione e a nuove forme di civiltà (v. cap. III). Al centro, i gruppi germanici più settentrionali, che si trovano a fronteggiare la linea del ghiaccio in ritirata, sono quelli che avevano partecipato prima all'Ahrenburgiano e poi al Maglemosiano. Dopo avere gradatamente popolato la Scandinavia man mano che questa si liberava dai ghiacci, questi gruppi ormai 'scandinavi' creano le culture di Fomsa e Hensbacka, e continuano a svilupparsi nel Neolitico e nelle Età dei Metalli, ponendo così le fondamenta della futura civiltà e delle lingue scandinave (v. cap. VIII).
Nella visione della TC, dunque, gli enormi mutamenti climatici ed ecologici che seguirono la deglaciazione, pur avendo avuto una diretta e fondamentale influenza sulla distribuzione delle popolazioni preesistenti, non dovettero mutarne radicalmentei rapporti reciproci. Ciò che la documentazione archeologica mostra è soltanto che i gruppi epipaleolitici boreali sopravvissero ai mutamenti, adattandosi alle nuove condizioni ecoclimatiche e diventando così, da cacciatori di renne nella tundra, pescatori o abitanti e sfruttatori delle nuove foreste, che lentamente si svilupparono nel nuovo clima settentrionale.
Dal punto di visto distributivo, semmai, gli sconvolgimenti di quest'area trasformarono gruppi prima coesistenti con altri sullo stesso continente in popolazioni insulari o peninsulari, isolate da confini naturali ormai permanenti. Nello scenario dellaTC, questo è il destino comune ai quattro gruppi nord-europei: ai Celti, prima riuniti, poi divisi fra Celti insulari e Celti continentali (capp. XII-XIII); ai Germani, prima uniti sul continente con gli altri Germani, poi isolati nella penisola scandinava (e forse in Inghilterra dopo la separazione dell'isola,nel VII millennio: v. cap. X); ai Balti, ora isolati sulle coste del Mar Baltico, e forse per questo separati dai futuri sviluppi degli Slavi, loro strettissimi affini (cap. VII), e agli Uralici della Scandinavia e della Finlandia, prima uniti sul continente poi isolati nella penisola finlandese e di Kola (cap. III). Sul continente, riprendono i contatti fra Europa occidentale e orientale, prima impediti dai ghiacci e dai bacini proglaciali. Come vedremo, alle isoglosse italo-celtiche e italo-celto-germaniche del Paleolitico Superiore -tipicamente limitate all'Europa occidentale- seguono le isoglosse celto-germaniche -tipicamente mesolitiche e neolitiche. Le isoglosse parziali che l'indoeuropeistica ha così spesso studiato, senza mai veramente
9
riuscire a spiegarle, e che uniscono interi gruppi linguistici adiacenti senza coinvolgere gli altri, diventano molto più verosimili nel quadro del Paleolitico Superiore e delle mutate condizioni del Mesolitico e del Neolitico.
Nel quadro della TC, tutte le popolazioni che si sono insediate per prime nelle aree deglaciate sono quelle che vi sono rimaste fino ad oggi. Certamente l'inondazione delle pianure che una volta univano l'Inghilterra alla Danimarca avrà contribuito all'estinzione di un intero gruppo di linguemi germanici di transizione, e all'impoverimento di un ricco continuum geolinguistico, ma la documentazione linguistica e toponomastica non sembra suggerire la presenza di altri gruppi linguistici oltrea quelli IE a noi noti (v. cap. XII). La toponomastica, in particolare, presenta un quadro di straordinaria trasparenza: quella scandinava è germanica, e lo è per tutti gli aspetti territoriali (località, microponomi, fiumi, monti ecc.). Se questipopoli germanici si fossero sovrapposti a gruppi pre-IE, come continua a sostenere, senza alcun fondamento che non sia il dogma,la teoria tradizionale, dovrebbero esserci abbondanti traccie di una toponomastica non IE. Queste tracce non ci sono. La toponomastica dell'area uralica è uralica, come lo è anche in certe aree della Russia, dove archeologia e linguistica hanno potuto stabilire che gli Uralici erano gli autoctoni. Ed è di lingua baltica in un'area baltica più vasta di quella che oggi è occupata dai Lituani e dai Lettoni. Al massimo vi possono essere stati mutamenti di confini fra popolazioni 'da sempre' coesistentinegli stessi territori.
Lascio al lettore il compito di giudicare lo scenario tradizionale: secondo il quale popoli 'pre-IE' di pescatori nordici, in possesso di un'economia e di una tecnologia di tipo altamente specializzato, a un certo punto sarebbero stati acculturati da popoli IE superiori, in possesso dell'agropastorizia, della metallurgia e del cavallo. Questi ultimi arrivati, tuttavia, nonostante la loro superiorità culturale, tuttavia, avrebbero finito con dedicarsi anche alla pesca e alla caccia tradizionale degli autoctoni, acquisendone tutti gli elementi tecno-economici, e subendo, di fatto, una nuovaacculturazione da parte degli autoctoni. Ciò nonostante, ne avrebbero sostituito la lingua, e per di più sarebbero riusciti a cancellarne ogni traccia dalla toponomastica!
10
4 Il quadro distributivo delle culture del MesoliticoDopo l'impatto della deglaciazione, le culture che si sviluppano
nel corso del Mesolitico creano un quadro distribuzionale estremamente variegato, assai diverso da quello del Paleolitico Superiore, e che secondo gli archeologi "riflette la differenziazione delle popolazioni del Mesolitico di tutta Europa, in corso di evoluzione" (Neustupny 1976, 38).
Anche se è vero, come scrive Barbaza, che semplificando al massimo "è possibile individuare, sul territorio europeo, alcune grandi aree tecnologico-culturali", queste "si configurano come unmosaico di gruppi culturali, di estensione territoriale e durata estremamente variabili, spesso in rapporti di scambio durevoli e percorsi da correnti unificatrici assimilabili a fenomeni di moda o a "modi di fare" altamente apprezzati, attivamente assimilati e riprodotti" (Barbaza 1994, 118). E ancora: "A dispetto dei tentativi di semplificazione, la geografia culturale dell'Europa mesolitica è e rimane estremamente complessa e configura uno strano mosaico straordinariamente mutevole, nel tempo e nello spazio, in seguito ai contrasti e agli scambi che tesero a fonderee confondere in diversa misura le società tradizionali" (ibidem 127). Se quindi volessimo identificare l'appartenenza linguistica delle diverse culture dell'Europa mesolitica, "i cui elementi fondanti possono avere una validità limitata a poche decine di chilometri quadrati" (ibidem 120), dovemmo ipotizzare un quadro diavanzata frammentazione geovarazionale (dialettale).
Purtroppo, una ricerca delle convergenze fra microisoglosse emicroaree mesolitiche si rivela per il momento impensabile, non tanto per lo stato assai ineguale delle conoscenze e delle ricerche sul Mesolitico delle diverse aree europee (anche se negliultimi anni sono stati fatti passi da gigante); e neanche perché vi è ancora una notevole discordia sulla dinamica dei processi ricostruibili; ma perché una ricerca sistematica di convergenze fra microisoglosse dialettali e confini culturali (mai molto netti) richiederebbe la collaborazione di molti specialisti. Dobbiamo quindi accontentarci delle grandi aree individuate dagli archeologi, che tuttavia sono assai utili, in quanto sembrano rappresentare gli unici contesti, assieme a quelli del PaleoliticoSuperiore e del Neolitico, in cui possono essersi formate le isoglosse plurilingui già ricordate qui sopra, e di cui ho già parlato in OR1.
Vediamo, quindi, quali sono le più importanti ed evidenti aree dell'Europa mesolitica. Sulla base delle ricerche degli
11
specialisti, fra cui spiccano i polacchi Stefan e Janusz KozÂowski (Kozlowsly 1973, 1980, Kozlowski e Kozlowski 1979) si possono individuare per lo meno tre grandi "cerchie" culturali, che rientrano ancora nelle tre grandi 'provincie' dell'Europa del Paleolitico Superiore, sopra ricordate:
(1) cerchia nord-orientale (culture del Nemunas, Volga-Oka, Kunda,Kama e Jangel'ka), che si estende dal Nord-Ovest della Polonia agli Urali, e dal Nord dell'Ucraina al mare di Barents.
(2) cerchia nord-occidentale (culture del Maglemosiano, Duvensee, Kongemose, Ertebolle;JanisÂawice), attestata in Inghilterra, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia meridionale, Germania settentrionale, Polonia, con tendenza all'espansione verso l'oriente;
(3) cerchia sud- occidentale (Sauveterriano, Tardenoisiano e Castelnoviano), che dall'Italia e dalla Francia si espande poi anche all'Europa nord-occidentale.
Anche se questi raggruppamenti, allo stato attuale delle ricerche, devono essere considerati provvisori, per la TC essi si rivelano abbastanza produttivi: (1) la cerchia nord-orientale sembra corrispondere -tranne che per la cultura di Nemunas (per cui v. cap. VIII)- all'area di più antico insediamento degli Uralici in Europa, che illustrerò nel prossimo capitolo. Questa conclusione concorda con quella degli uralisti, e quindi può essere considerata fra le più sicure. (2) La cerchia nord-occidentale sembra riflettere il gruppo germanico, la cui successiva espansione verso oriente spiegherebbe le importanti isoglosse germano-balto-slave, che come vedremo riguardano proprionozioni mesolitiche (v. cap. VIII). (3) La cerchia sud-occidentale, infine, si lascia leggere come un'area tipicamente italica che tuttavia, come vedremo, nella TC va intesa diversamente rispetto alla tradizione, in quanto si estenderebbe dall'Iberia alla sponda orientale dell'Adriatico (come del resto anche nella teoria di Renfrew). Questo gruppo mostrerebbe una tendenza ad espandersi verso ovest e verso nord (v. cap. XIV).
Più frazionato risulterebbe il quadro mesolitico della rimanente area europea, cioè quella (sud-)orientale, dove possiamosupporre si trovino già gruppi slavi, caucasici e altaici. La continuità dal Mesolitico dei gruppi neolitici di quest'area è comunque riconosciuta dagli archeologi (e.g. Merpert 1994, 190, e v. capp. IV-V)).
12
Poichè, d'altra parte, come ho già detto un'alto grado di frazionamento culturale è caratteristico di tutta l'Europa mesolitica, e non solo della regione sud-orientale (le tre granbdicerchie risultando solo da alcuni tratti comuni), questo aspetto dimostrerebbe che nel Mesolitico i phyla e i gruppi linguistici erano già differenziati anche al loro interno (cfr. OR1).
Una tale interpretazione globale delle grandi aree del Mesolitico in tanto è legittima in quanto possiamo dare per certo:(A) che la neolitizzazione della maggior parte d'Europa è avvenutacol concorso delle popolazioni autoctone, e che anche là dove ci sono state correnti immigratorie di una certa portata queste sarebbero state poi riassorbite dagli autoctoni; (B) che in molte aree europee gli archeologi hanno accertato l'effettiva continuitàdal Mesolitico al Neolitico. Vi è quindi, sia teoricamente che empiricamente, una sostanziale continuità fra Mesolitico e Neolitico, che ci autorizza a leggere il Mesolitico in questa chiave.
5 La neolitizzazione dell'Europa: diffusione con un modesto apporto immigratorio
Per quanto riguarda le tappe fondamentali e la cronologia del processo di neolitizzazione d'Europa, la ricerca archeologica diquesti ultimi anni -in particolare la scuola archeologica inglese (Clarke 1976, Ashbee 1982, Dennell 1983, Price 1983, Barker 1985, Zvelebil 1986ab e molti altri) ha sgombrato il terreno dalla tesi di un'invasione di coltivatori con sostituzione etnolinguistica delle popolazioni mesolitiche, ipotizzata da Renfrew (cfr. fra gli altri Raetzel-Fabian 1986, 26), dimostrando che i Mesolitici europei vi hanno quasi sempre partecipato, in misura maggiore o minore a seconda delle aree. Di fatto, questa è la teoria che ho sostenuto in OR1, ricavandola dalle ricerche di Zvelebil: un processo che vede contributi immigratori importanti solo nelle prime aree neolitizzate, in primo luogo nei Balcani, e la partecipazione prevalente delle popolazioni del Mesolitico nella maggioranza del continente. Già Childe, del resto, aveva formulato l'ipotesiche i 'Danubiani' della cultura oggi detta Linear Bandkermik ('Ceramica Lineare') potessero essere dei Mesolitici acculturatidai coltivatori balcanici della cultura di StarÂevo: "il Danubiano I potrebbe essere stata una cultura "secondaria" del Neolitico, creata da gruppi di cacciatori-pescatori autoctoni che avrebbero appreso a coltivare i campi e a foggiare le
13
ceramiche dai popoli della cultura della cultura StarÂevo immigrati" (Childe 1972, 128). Nello scenario della TC, questi 'immigrati' furono sufficienti a insegnare agli autoctoni una nuova economia di produzione, e sul piano linguistico a introdurre elementi di superstrato, ma non costituirono in alcunmodo una invasione, né determinarono una sostituzione etnica e linguistica.
Il quadro successivo dello sviluppo del Neolitico europeo, nonostante i grandi mutamenti cronologici (le date oggi accettate sono ca. 6800-2550 a.C.) e quelli meno importanti di carattere interpretativo, è poi rimasto abbastanza simile a quello classico,tracciato da Gordon Childe (1972 (=1957), 1958). Il nuovo modo di produzione caratterizzato dall'agricoltura e dall'allevamento, destinato a rivoluzionare il mondo, a formare la base -ancora oggi- della sussistenza dell'umanità, e a dare all'Europa il suo assetto territoriale e culturale moderno, nasce nella 'mezzaluna fertile' del Medio Oriente. Di qui la nuova economia produttiva sidiffuse prima in tutta l'area egeo-anatolica e nella parte meridionale della penisola balcanica (verso la metà del VII millennio), poi raggiunse (nella seconda metà del V) l'Europa orientale e centrale e (alla fine del IV e inizio del III) le regioni baltiche.
Le prime culture agropastorali che emergono in Europa, dando inizio al Neolitico antico, sono fondamentalmente due: (1) La cultura neolitica più antica in assoluto (VII-VI millennio), che Childe chiamava 'danubiana' (dalla sua principale rotta di diffusione), e che oggi viene spesso chiamata 'balcanica'(dalla sua prima e principale area di diffusione), ha la sua manifestazione iniziale nella cultura greca detta, dalle sue due fasi, Proto-Sesklo e Sesklo. La cultura che apparve subito dopo nei Balcani interni, nel VI millennio, e che rappresenta un diretto sviluppo della prima, fu quella detta della Ceramica Dipinta (facies di StarÂevo/ Körös (CriÂ)/ Karanovo, rispettivamente in Jugoslavia, Ungheria, Romania e Bulgaria; e di Vashtemi-Podgornie e Kolsh in Albania). Da questo complesso si originò, sempre nel VI millennio, la cultura ucraina detta del Bug-Dnestr (dal nome dei due fiumi). Successivamente, lo stesso complesso si diffuse anche in Europa centrale, occidentale ed orientale, quasi ovunque con l'attiva partecipazione dei Mesolitici. (2) La seconda, che interessa anche l'Italia, è la cultura detta della Ceramica Impressa o Cardiale (a decorazione impressa, o ottenuta con il bordo della conchiglia detta Cardium) , anch'essa
14
del VI millennio, che proveniendo da imprecisati centri egeo-anatolici (Bagolini 1992, 277) apparve prima sulle due sponde dell'Adriatico, poi si diffuse lungo le coste e nelle isole del Mediterraneo centrale e occidentale, per giungere fino alle coste dell'Atlantico in Portogallo.
A partire dal V millennio (con cui si fa iniziare il Neolitico Medio) l'agropastorizia si estese gradatamente al resto dell'Europa. Mentre nei Balcani e sul Mediterraneo appariva ormai la 'seconda generazione' delle culture neolitiche (cioè VinÂa in Serbia, Dimini in Grecia settentrionale, Veselinovo in Bulgaria, Boian in Romania, Lengyel in Ungheria e in Europa centro-orientaleecc.; le varie facies della ceramica dipinta, Serra d'Alto e Diana in Italia meridionale, la corrente culturale di Chassey-Cortaillod-Lagozza, estesa dall'alta-Italia al Portogallo (Bagolini 1992, 277)), una nuova ondata di influenze balcaniche (cultura di StarÂevo), proveniente dalle pianure del bacino carpatico, in Ungheria settentrionale e Slovacchia sud-orientale, si estese ulteriormente a nord, lungo il Danubio, formando la più importante cultura neolitica dell'Europa centrale e mediana, dettadella Ceramica Lineare (in tedesco Linear Bandkeramik, da cui l'abbreviazione in uso LBK), e contribuendo ad est all'ulteriore sviluppo delle culture ucraine (Tripolje) e nord-pontiche. La sua area di diffusione si estese fino al bacino di Parigi, alla Bretagna e al medio corso dell'Elba e Weser a ovest, alla Boemia eMoravia e alla Polonia meridionale a est.
Nella prima metà del IV millennio (con cui si fa iniziare il Neolitico recente) inizia infine il processo di neolitizzazione delle regioni più settentrionali, con il graduale dissolvimento degli ultimi residui delle comunità mesolitiche. Nell'Europa mediana occidentale la nuova economia arriva da due direzioni: da sud, con l'influenza della Ceramica Impressa/Cardiale, e da est con quella della LBK. Nelle altre regioni le popolazioni mesolitiche vengono gradualmente acculturate dall'influenza di duediverse culture neolitiche, che si sono sviluppate da quelle precedenti: in area centrale dalla cultura del Vaso Imbutiforme (in tedesco Trichterbecher, da cui l'abbreviazione corrente TRB), erede della LBK; sul Mar Baltico dalle culture della Ceramica a Cordicella e delle Asce a Combattimento, ispirate dai gruppi neolitici pastorali delle steppe.
Per quanto riguarda i principali aspetti culturali del Neolitico, l'economia fu fin dall'inizio mista, agropastorale, e l'archeologia non fornisce prove di uno sviluppo spontaneo di pastorizia o di agricoltura separate. I vegetali domestici, e fra
15
gli animali domestici gli ovicaprini, furono introdotti dal VicinoOriente, mentre bovini e suini poterono svilupparsi dai corrispettivi selvatici esistenti localmente (Bagolini 1992, 275).Gli strumenti nuovi erano la zappa e il bastone da semina, le ascee le accette per la lavorazione del legno, macine e pestelli in pietra per la molitura, recipienti di ceramica. L'agricoltura era itinerante, con rioccupazione ciclica dei terreni per il riposo e la rigenerazione dei terreni (debbio, maggese) (ibidem, 276). Comevedremo, a tutte queste innovazioni tecniche corrispondono importanti innovazioni lessicali.
Nel Neolitico medio iniziano poi gli insediamenti in sedi collinari naturalmente protette, e nel tardo Neolitico le esigenzedifensive diventano prevalenti (ibidem). Nel tardo Neolitico compare anche l'aratro, si diffondono la ruota e il carro trainatoda bovini, inizia l'industria dei latticini e della lana. E' la cosiddetta 'rivoluzione dei prodotti secondari' (Sherratt 1981, 1983). Vengono effettuali estesi disboscamenti per favorire agricoltura e pastorizia; alle idrovie fluvio-lacustri e marittimesi aggiungono itinerari terrestri (con importanti lessicalizzazioni).
Alla fine del IV e nella prima metà del III millennio a.C. ilquadro delle culture tardo-neolitiche tende a frantumarsi ulteriormente in numerose entità regionali. L'Egeo e i Balcani sono le prime aree europee in cui si formano culture metallurgiche, del Rame. Nel corso del III millennio la metallurgia si diffonde nelle altre regioni europee, portando a disgregazione le tradizioni del Neolitico finale. La metallurgia ela pastorizia inducono forme di tesaurizzazione e di possesso privato gettando le basi per la diferenziazione sociale che caratterizzerà il Bronzo, il Ferro e la civiltà moderna (Bagolini 1992, 276-278).
Anche di queste innovazioni vedremo importanti riflessi lessicali.
6 Prime aree culturali del Neolitico e lingue europeeL'aspetto più saliente del Neolitico europeo è dunque che esso fin
dal suo inizio si presenta come un insieme di culture profondamente differenziate. Se ci fosse stata l'invasione IE ipotizzata da Renfrew, anche ammettendo una rapida reazione da parte dei vari sostrati autoctoni, dovremmo attenderci, almeno nella fase iniziale, un vasto complesso culturale indifferenziato. Solo in un secondo momento si sarebbero
16
manifestati i diversi sostrati. La ricerca archeologica non trova invece traccia di questa presunta cultura unitaria primordiale, se non nell'area balcanica, che fu appunto quella di maggiore impatto immigratorio.
Se invece -come oggi si dà per certo- l'immigrazione fosse stata più modesta, e presto riassorbita dalle popolazioni mesolitiche, dovremmo attenderci proprio il risultato che osserviamo, e cioè una cultura unitaria nell'area di maggiore impatto immigratorio, e nel resto dell'Europa tante culture neolitiche quanti erano i principali gruppi etnolinguistici mesolitici. L' immediata formazione di diversi focolai neolitici (Sesklo/StarÂevo, Impressa/Cardiale, Bug-Dnestr, LBK), dai quali sisono propagate ulteriori ondate di diffusione, con la formazione di altre numerose culture, non solo permette di escludere l'arrivodi un'unica ondata immigratoria che abbia sommerso il quadro culturale precedente, ma implica l'esistenza di circuiti comunicativi chiusi, linguisticamente predeterminati, entro i quali la grande ondata innovativa del Neolitico sarebbe stata costretta ad affermarsi in modi ogni volta diversi. Di conseguenza, le grandi corrispondenze che si lasciano individuare,soprattutto nel periodo iniziale e per le culture più marcatamentedistinte, sono queste:(1) nell'area balcanica e solo in questa, il grande complesso del Neolitico balcanico, proprio per il suo maggiore contributo immigratorio, avrebbe sommerso tutta l'area greca, illirica e slava meridionale, neutralizzando le precedenti differenze linguistiche. A livello linguistico, tuttavia, questa stretta unità si manifesterebbe proprio nella cosiddetta 'lega balcanica',un fenomeno ben noto ai linguisti, che collega la maggior parte delle lingue balcaniche (Greco, Albanese, Rumeno, Macedone, Bulgaro) mediante tratti distintivi specifici (v. cap. V). L'eterogeneità originaria si esprimerebbe invece nelle diverse facies regionali che ben caratterizzano il complesso balcanico;(2) nell'area nord-mediterranea centrale ed occidentale, dall' Atlantico all'Adriatico, sarebbe emerso il gruppo che chiamerò provvisoriamente 'para-italico' o 'ibero-adriatico' (termini che discuterò nel cap. XV), un gruppo già ipotizzato dallo studioso inglese sir John Ridgeway al principio del secolo, e ora postulatoanche da Renfrew;(3) nell'area centrale e mediana la cultura della LBK rifletterebbe un'area ormai tedesca, dato che nel Mesolitico i gruppi maglemosiani si sono già rivelati come proto-scandinavi. Ciò confermerebbe il grado di differenziazione linguistica già
17
raggiunto nel Mesolitico.Inoltre, partendo dall'assunto che i gruppi più o meno
importanti di coltivatori immigrati dall'Oriente furono sempre riassorbiti dalle popolazioni locali dopo l'adozione della nuova economia, dovremmo aspettarci effetti di superstrato nelle principali aree di antica diffusione. E infatti:(1) in Grecia, dove l'impatto dell'immigrazione orientale fu massimo, le tracce di influenze non-IE sono state da tempo segnalate, e attendono solo di essere rilette nella nuova ottica neolitica;(2) nell'area nord-mediterranea, e precisamente nelle aree di più antica neolitizzazione (sud Italia, Sicilia, Sardegna, Corsica), appaiono vistosi aspetti fonetici, di solito interpretati come 'sostrato', mentre nella TC apparirebbero come un adstrato o superstrato attribuibile agli immigrati orientali. (capp. XV-XX); (3) in Germania meridionale, dove la cultura della LBK, che secondo la maggior parte degli archeologi rappresenta il caso più sicuro di neolitizzazione intrusiva, anche se seguita dal riassorbimento delle popolazioni locali ("classically seen as the result of colonisation from the northern Balkans but possibly the result of indigenous transformation in connection with or in reaction to the emergence of the VinÂa culture" (Whittle 1985, 307), la cosiddetta seconda Lautverschiebung, che spirantizza le tre consonanti sorde occlusive, e separa l'Alto Tedesco da tutte le altre lingue germaniche, potrebbe essere messo in rapporto al fenomeno molto simile, caratteristico dell'area linguistica ungherese (territorio della cultura di Lengyel, da cui deriva direttamente la LBK), che distacca questa lingua dalle altre lingue uraliche, e a quello analogo del Bretone (nel territorio più occidentale della LBK), che stacca questa lingua dalle altre lingue celtiche. L'obiezione che questi tre fenomeni sono strutturalmente diversi non è sufficiente a escludere l'ipotesi, dato che differenze strutturali analoghe sono osservabili anche all'interno delle cosiddette 'leghe linguistiche', dove uno stessofenomeno assume funzioni e aspetti strutturali diversi a seconda del sistema in cui è penetrato.
7 Il modello di RenfrewGià Renfrew (159-161) aveva identificato nelle grandi culture
neolitiche d'Europa le 'proto-lingue' IE, con risultati in partesimili e in parte diversi da quelli sopra illustrati.
Se Renfrew è l'indubbio scopritore della generale identità
18
delle grandi aree neolitiche europee con le aree linguistiche (cfr. OR1), il suo problema è di conciliare tale corrispondenza con la tesi di un'invasione di coltivatori PIE, che naturalmente non possono arrivare già differenziati nel momento stesso in cui introdurrebbero l'agropastorizia. Di conseguenza, la sola soluzione a sua disposizione è di fare ibridare immediatamente i PIE ancora indifferenziati con le diverse popolazioni mesolitiche non IE, in modo da ottenere una altrettanto immediata differenziazione dei primi. Le aree delle culture neolitiche corrisponderebbero quindi a quelle dei diversi gruppi mesolitici pre-IE preesistenti, e queste agirebbero immediatamente come sostrato sui nuovi venuti PIE. A questo scopo egli ipotizza 9 'trasformazioni', non sempre chiare, ciascuna delle quali rappresenterebbe l'impatto di uno specifico sostrato mesolitico sulla comune lingua PIE in una determinata area. La trasformazione1 vedrebbe il Neolitico anatolico IE penetrare in Grecia, e a contatto con gli autoctoni produrre la variante greca. La trasformazione 2 vedrebbe altri PIE muoversi dalla Grecia del Nordverso StarÂevo/Körös/Karanovo, dove si incontrerebbero col sostratomesolitico locale, producendo l'Illirico, forse il Traco-Frigio e il Dacio. La trasformazione 3, con cui la cultura balcanica di Körös si trasforma in LBK, sarebbe quella che produce Celtico e Germanico in Europa Centrale (non è chiaro perché, e come, dalla stessa matrice possano nascere due gruppi linguistici diversi). Lapiù tarda trasformazione 4 rappresenterebbe il movimento di LBK (già IE) verso gli autoctoni locali di Cucuteni e Tripol'e, che produrrebbe lo Slavo. La trasformazione 5 rappresenterebbe l'influenza di LBK in Francia settentrionale e in Germania, con laformazione di TRB nell'area sud-scandinava e la genesi delle lingue scandinave (del tutto inverosimile). La trasformazione 6 rappresenterebbe il movimento dei Greci verso la costa adriatica orientale, che produrrebbe le lingue italiche (non l'Etrusco, considerata una lingua autoctona, con un rapporto inverso a quellodella TC, che postula la preesistenza delle lingue italiche, e l'intrusione dell'Etrusco). La trasformazione 7 vedrebbe la Ceramica Impressa/Cardiale muoversi verso l'Iberia, e produrre lingue 'iberiche' di ceppo IE. La trasformazione 8 rappresenterebbe le influenze della Ceramica Impressa/Cardiale in Francia Centrale e del Nord, che assieme a quella 5 sopra menzionata produrrebbe il Celtico in Francia. E la trasformazione 9 rappresenterebbe influenze della LBK in Inghilterra e in Irlanda, con produzione del Celtico insulare (non è chiaro come). Ricordo anche che Renfrew non tratta l'area uralica, nonostante
19
gli uralisti oggi concordino sulla teoria della continuità uralica, cioè sulla tesi che i primi insediamenti degli Uralici nel nord-est d'Europa avvennero nel Mesolitico, con conseguenze fondamentali anche per la teoria IE.
A parte le numerose contraddizioni implicite in alcune di queste trasformazioni (il Celtico, per esempio, risulterebbe prodotto dalla Ceramica Cardiale da una parte, dalla LBK dall'altra), e a parte quelle specifiche che il modello di Renfrewincontra nel nord d'Europa (perché qui le culture di epoca neolitica sono quelle dei pescatori e cacciatori mesolitici, presunti pre-IE, mentre i presunti IE, portatori dell'agropastorizia e dell'IE, arriverebbero nell'area solo con l'età del Bronzo!), il principale difetto del modello di Renfrew èdi non tener conto dei tempi necessariamente lunghi richiesti da qualunque trasformazione linguistica basata sul sostrato. Come ho già detto, dal modello di Renfrew ci si aspetterebbe prima l'emergere di una sola grande cultura neolitica, paneuropea, e solo in un secondo momento il suo frazionamento in tante culture quanti sono i sostrati etnolinguistici mesolitici. Lo scenario di Renfrew pecca quindi degli stessi difetti di irrealismo della teoria della Gimbutas.
8 Le sfere d'influenza del Neolitico e del post-Neolitico europeo rivelate dalla documentazione archeologica e la loro corrispondenza linguistica
Come il lettore avrà notato, la differenziazione culturale europea rivelata dalle prime fasi del processo di neolitizzazione non corrisponde ancora alla differenziazione linguistica europea nel suo insieme. Ciò si spiega facilmente: il Neolitico inizia nel Sud, e solo più tardi si espande all'Europa mediana, lasciando ancora fuori il Nord. Per ricercare le possibili convergenze fra aree culturali e aree linguistiche occorre valutare l'insieme del Neolitico, fino alle soglie del Bronzo. Per ottenere una visione sintetica del Neolitico europeo,
tuttavia, non bastano neanche i diagrammi topostratigrafici del Neolitico e del Calcolitico, pubblicati nei vari manuali di preistoria europea. Questi non sono mai veramente completi, perchéprivilegiano necessariamente le aree culturali più importanti. Se esaminiamo per esempio i due diagrammi pubblicati da Lichardus e Lichardus per il Neolitico e Calcolitico europeo, troviamo 13 sequenze areali, che corrispondono a Tessaglia, Adriatico, Balcani
20
centrali, bacino carpatico, Europa centro-orientale, Europa centro-occidentale, Europa settentrionale, Tracia, basso Danubio, Moldavia, Ucraina occidentale, steppe pontiche e Italia settentrionale (Lichardus e Lichardus 1985, 354, 514). Come si vede, mancano molte aree. fra le quali il lettore italiano noterà subito l'Italia centrale, quella meridionale e le isole; e la Francia (trattata in un capitolo a parte). Più completo, almeno per quanto riguarda l'Europa meridionale, è il diagramma, diviso in due parti, che accompagna l'ultima edizione di Dawn di Childe. Contiene infatti 14 sequenze areali: bacini superiori del Danubio e dell'Elba, bacino del medio Danubio, bacino dnepro-danubiano, Balcani orientali, Balcani occidentali, zona alpina, Saale-Vistola, penisola iberica, Italia settentrionale, Italia centrale e meridionale, Sicilia e isole Eolie, Grecia, Danimarca e nord, isole britanniche. Mancano però, anche qui, la Francia, la Sardegna, tutto il Nord-Est europeo, il Caucaso. In realtà, nessunmanuale di preistoria europea, anche del solo Neolitico e dei periodi successivi, può coprire in dettaglio tutte le aree culturali in cui risulta diviso il nostro continente (per la stessa ragione, anch'io ho dovuto limitare l'orizzonte di questo libro, fin troppo lungo!). Solo aggiungendo ai manuali generali europei anche le innumerevoli monografie che gli archeologi dedicano alla preistoria delle singole nazioni europee e delle loro regioni si riesce ad ottenere un quadro veramente completo delle sequenze culturali che ricoprono tutta l'Europa dal Neolitico all'età del Ferro, e che rappresentano le principali sfere d'influenza del continente. L'elenco che segue è il risultato di un primo studio di questo tipo, che salvo alcune lacune -che ho sempre cercato di segnalare- dovrebbe rappresentarelo stato delle conoscenze archeologiche negli anni Novanta. Inutile dire che un progetto di ricerca interdisciplinare affidatoa un gruppo di linguisti ed archeologi ben affiatato potrebbe raggiungere ben altri risultati.
Inizio l'elenco da nord-est, procedendo in senso orario e designando le aree nell'unico modo possibile, cioè con nomi geografici, e aggiungo l'attribuzione etnolinguistica e il capitolo n cui ne tratterò.(1) Una sequenza culturale nord-orientale, che non interessa quasiaffatto il resto dell'Europa, e che è principalmente attribuibile all'unità linguistica uralica (cap. III).(2) Una sequenza dell'area steppica, molto più interessata all'Asia che al'Europa, attribuibile alle lingue turciche (cap. IV).
21
(3) Una sequenza dell'area nord-caucasica, anh'essa esclusiva, attribuibile alle lingue nord-caucasiche (cap. IV).(4) Una sequenza greca, distinta da quella balcanica, che riflettela lingua greca (cap. V-VI).(5) Una sequenza balcanica e orientale, attribuibile all'unità slava, ma che comprende anche l'Illirico ed altre lingue estinte, come il Trace o Traco-Frigio (v. capp. V-VI). Solo per ragioni di spazio non ho distinto al suo interno un'area illirica, prendendo in esame le sequenze culturali che interessano soltanto l'Albania e i territori limitrofi.(6) Una sequenza mediterranea centro-occidentale, attribuibile al gruppo linguistico che ho chiamato provvisoriamente 'para-italico'o 'ibero-adriatico' (capp. XV-XXV), all'interno della quale si potrebbero distinguere una decina di sub-aree: adriatica, Italia nord-orientale e nord-occidentale, area alpina (anch'essa divisa in tre o quattro aree), Sicilia, Sardegna, Corsica, Francia meridionale, penisola iberica (anch'essa suddivisa in un numero per ora indeterminato di aree). (7) Una sequenza maltese, attribuibile al Maltese, lingua semitica, a cui si sovrappongono, nel corso dell'Età dei Metalli, linguemi 'neo-latini' (cap. XX).(8) Una sequenza nord- e medio-occidentale, attribuibile al Celtico (capp. XII-XIV).(9) Una sequenza nord- e medio- centrale, attribuibile al Germanico (Capp. VIII-XI). (10) Una sequenza baltica sud-orientale, nettamente diversa da quella uralica sua vicina, attribuibile al Baltico (cap. VII).
Come si vede, queste sequenze distintive corrispondono esattamente ai gruppi e ai phyla linguistici presenti in Europa (eccetto il basco, che come ho detto si lascia identificare solo in modo problematico).
9 La frammentazione culturale e linguistica durante e dopo il Neolitico
A partire dal IV millennio inizia il fenomeno che colpisce chiunque studi l'archeologia europea, e che deve essere esattamente interpretato dal linguista che si ponga nella nuova ottica della TC: il sempre più rapido frazionamento del quadro culturale (Raetzel-Fabian 1986, 225). A questo processo ha certamente contribuito un fattore come l'intensificazione dei contatti dovuta al progresso tecnologico (trasporto su veicoli, sistema viario ecc.) (ibidem), ma è evidente che le ragioni di
22
fondo del processo vanno cercate nella formazione e nella proliferazione di nuovi centri di potere territoriale, legati all'emergere di gruppi elitari (v. oltre), che nella loro espansione si sovrappongono al quadro culturale preesistente frazionandolo e allo stesso tempo ibridando le popolazioni rurali subordinate. E' quindi a partire da questo momento che sicrea, a livello linguistico, la dicotomia fra 'norma linguistica' o 'lingua' e 'dialetto', la prima associata ai gruppi elitari, la seconda ai coltivatori ormai subordinati. Alla frammentazione culturale con i suoi effetti ibridatorii si lega così non solo la frammentazione 'orizzontale', geolinguistica, che nasce dai fenomeni linguistici di adstrato, superstrato e sostrato, ma anche quella 'verticale', sociolinguistica, che diventerà poi dominante quando nasceranno,nel Bronzo/Ferro, i primi centri urbani.
Osservata nei diagrammi topostratigrafici degli archeologi, la frammentazione culturale delle singole aree europee a partire dal Neolitico appare ancora più chiaramente. Si torni ad osservare, per esempio, il diagramma riprodotto nel cap. I, validoper il Bronzo/Ferro dell'Italia settentrionale. Se si tiene conto che ad esso corrispondono due altri diagrammi, altrettanto frazionati, per l'Italia mediana e per l'Italia meridionale e insulare, e si considera che la radice dell'albero genealogico, cioè il punto di partenza per il mosaico di culture in cui si suddivide l''Italia del Bronzo e del Ferro, è una sola cultura neolitica, quella della Ceramica Impressa/Cardiale, ci si rende conto dell'enorme portata e complessità del processo di differenziazione culturale (e quindi linguistica) dell'area nord-mediterranea. Inoltre, la sinteticità inerente al diagramma rivelain modo immediato che si tratta di un processo accelerato, legato a circostanze storiche particolari. Non può trattarsi, insomma, diun processo naturale, quasi di 'fissione cellulare' delle singole culture, quanto del risultato dell'incrociarsi di correnti culturali provenienti da varie direzioni, e quindi, come già detto, da molteplici centri di potere, che di volta in volta irradiano la loro influenza o introducono il loro dominio nelle aree vicine. Naturalmente, neanche questo processo di frammentazione accelerata travalica mai quelle grandi 'sfere d'influenza' che si lasciano cogliere fin dal Mesolitico e si assestano con l'inizio del Neolitico.
E' poi interessante notare che la frammentazione culturale (elinguistica) di rado corrisponde alle unità 'nazionali' che a noi sono familiari (e che sono il risultato di processi politici di
23
epoca storica). Essa sembra piuttosto riflettere quella frammentazione di tipo regionale/dialettale, che appare quindi come la sola e autentica matrice etnolinguistica in cui affondano le radici delle nazioni europee. In altre parole, la preistoria europea sembra riflettersi molto di più nelle regioni dialettali d'Europa, che non nelle sue nazioni e relative 'lingue nazionali'.Non a caso, il folclore e i dialetti d'Europa conservano tante vestigia di concezioni e di costumi neolitici, legati soprattutto alla coltivazione e all'allevamento. Questa osservazione, che saràricorrente nei capitoli seguenti, conferma il ruolo primario dei 'dialetti' nella preistoria, come unici veri relitti dei gruppi preistorici respinti ai margini dai progetti di espansione dei gruppi più fortunati, tutti per definizione recenti. Sono dunque igruppi di dialettofoni che rappresentano le testimonianze parlantidella nostra preistoria, e non quelli 'linguofoni' -se posso coniare questo termine- che invece rappresentano una testimonianzadella sola storia recente.
Si nota infine un'altra corrispondenza, che è il corollario della precedente e conferma la validità dell'assunto e del metodo:là dove il processo di differenziazione regionale è molto accentuato, per cui il numero delle sequenze culturali aumenta (e il diagramma topostratigrafico ha bisogno di più colonne), la frammentazione dialettale è altrettanto spinta. In Europa vediamo questo fenomeno in modo evidente soprattutto in Italia e in Germania, che sono territori grandemente frazionati nella preistoria, e allo stesso tempo costituiscono i due 'paradisi' della dialettologia europea. Là dove il quadro culturale è più stabile, e la frammentazione è minore, come nell'Europa orientale,anche la frantumazione dialettale è minore. L'enorme differenza fra la differenziazione linguistica dell'area germanica e italica da un lato, e quella dell'area slava dall'altro (le differenze frale singole lingue slave sono molto minori delle differenze fra i dialetti di area germanica o italica), trova dunque in questa correlazione una spiegazione del tutto adeguata. Come vedremo, la grande uniformità delle lingue slave, che colpisce ancora di più se si riflette alla loro enorme estensione areale (quasi metà dell'Europa), si spiega con la straordinaria stabilità delle culture neolitiche slave, irrefutabilmente dimostrata dalla formazione dei tell (colline artificiali formate dai detriti dei villaggi neolitici nel corso di millenni di permanente stabilità).
24
10Età dei Metalli: società stratificate e gruppi elitari dominanti
Per quanto riguarda le Età dei Metalli, la ricerca archeologica moderna ha raggiunto due conclusioni fondamentali, che dovrebbero essere tali anche per la linguistica storica: (I) la prima è l'esclusione di qualunque immigrazione di massa che in questo periodo avrebbe potuto sostituire le popolazioni europee precedenti. (II) La seconda è che il principale tratto distintivo delle Età dei Metalli sta nel carattere stratificato delle loro società, cioè nella presenza di un ceto elitario dominante che gestisce a proprio vantaggio il surplus agricolo prodotto dai ceti subordinati.
Se la prima conclusione dovrebbe bastare a seppellire per sempre la tesi tradizionale di un'invasione IE all'inizio del Calcolitico, la seconda è fondamentale per capire che la diffusione di determinate culture protostoriche con una precisa identità linguistica (come quella celtica, o illirica, o etrusca, o scitica), non consegue necessariamente alla diffusione territoriale di un intero gruppo etnico, ma rappresenta quasi sempre l'effetto di campagne di conquista di gruppi elitari, i cuieffetti linguistici possono essere, al massimo, di ibridazione e quindi di superstrato. E' quindi del tutto chiaro che i sempre piùintensi movimenti di popolazioni che si possono seguire nelle Età dei Metalli non mutano che superficalmente il quadro etnolinguistico europeo, le cui radici affondano nelle prime grandi culture stabili del Neolitico e in quelle semisedentarie del Mesolitico.
Inoltre, proprio a causa del carattere inter- o infralinguistico dei movimenti di popolazione di questo periodo, la TC apre prospettive di ricerche specialistiche e interdisciplinari molto promettenti, che potrebbero mirare a identificare i superstrati linguistici determinati appunto da talimovimenti, visti come una delle principali cause della differenziazione linguistica e dialettale (v. OR1).
Mi soffermerò ora sui caratteri strutturali delle tre età deiMetalli, che come è noto, formano la sequenza Rame, Bronzo Ferro.
11CalcoliticoIn senso stretto, di età del Rame (detto anche Calcolitico o
Eneolitico) si dovrebbe parlare solo per quelle aree europee in cui la produzione di manufatti in rame fu importante, come per esempio nel bacino carpatico (Lichardus e Lichardus 1985, 503).
25
Là dove il rame non apparve se non sporadicamente, si dovrebbe parlare piuttosto di Neolitico Recente o Tardo, per poi passare,quando la produzione o l'importazione metallurgica comincia a diventare importante, all'Età del Bronzo. Se tuttavia l'uso del termine Calcolitico è rimasto corrente, ciò è dovuto anche a ragioni strutturali, illustrate soprattutto da Gordon Childe, come dirò nel cap. VIII. Quali sono i tratti strutturali di questo periodo? Per rispondere, mi valgo di una delle più recenti e migliori sintesi della preistoria europea del periodo in oggetto (Lichardus e Lichardus 1985, 503-505), che integro con altre fonti:
(A) Sul piano economico: inizio, nelle steppe pontiche, della domesticazione del cavallo, epiù tardi del suo uso come mezzo di trasporto veloce; specializzazione nell'allevamento (non solo del bestiame bovino e ovicaprino, ma anche del cavallo, allevato per la prima volta nelle steppe pontiche); apparizione del carro e dell'aratro (che trasforma l'agricoltura da femminile a maschile); prospezione ed estrazione dei minerali; artigianato specializzato, specialmente nella metallurgia; inizio della produzione di grossi manufatti in rame.(B) Sul piano sociale: stratificazione sociale (che nasce nel momento in cui, con l'evoluzione e l'intensificazione delle tecniche agricole (araturaecc.), si comincia a produrre più del necessario per il proprio mantenimento), con la formazione di un ceto dominante che gestiva il surplus, godeva di priviliegi ereditari e aveva spesso funzionimilitari; emblemi di prestigio; aumento del conflittualismo e quindi del numero degli insediamenti fortificati; aumento della specializzazione professionale. (C) Sul piano religioso e ideologico: probabile nascita di una casta sacerdotale, sottratta al lavoro per scopi rituali (Neustupny e Neustupny 1963, 80); apparizione dei primi edifici dedicati al culto (che tuttavia in un primo momento potevano essere gestiti anche da altri che non fossero preti); erezione dei primi sepolcri monumentali in pietra (megalitismo), per mezzo di lavoro collettivo; origine della concezione delle divinità antropomorfe (a seguito della nascita interra di individui dotati di potere di vita e di morte); passaggioda una società matrifocale a una patrifocale, e poi decisamente patriarcale e maschilista (la monta e riproduzione nell'allevamento, che ha ora un ruolo centrale nell'economia, è labase per una mitizzazione del ruolo maschile nell'universo),
26
rafforzato dal ruolo maschile nella guida degli aratri; mutamento anche all'interno dei rapporti sociali dell'agricoltura (è sempre più l'uomo che provvede ai bisogni vitali della produzione, mentrela donna viene relegata ai lavori 'domestici', nella cui sfera, oltre alla preparazione del cibo e alla cura dei figli, vengono sospinte anche la tessitura e la produzione delle ceramiche); passaggio dalla parità dei sessi nelle attività produttive e sociali (prima i compiti più faticosi erano spesso affidati alla donna), alla famiglia patriarcale, con ruoli secondari per la donna; comparsa del sacrificio cosiddetto sati o suttee, in cui ladonna e talvolta tutta la famiglia vengono immolate sulla tomba dell'uomo (Neustupny e Neustupny 1963, 78).
Anche senza la reale presenza di prodotti di rame, l'introduzione di un termine specifico, come Calcolitico o 'età del Rame', mira dunque ad inquadrare in modo più generale e strutturale queste innovazioni. Il termine, in questo senso, "ne correspond pas seulement à une période qui s'intercale entre le Néolithique et l'âge du Bronze, puisque avant tout elle inaugure de toute évidence une qualité de vie différente" (Lichardus e Lichardus 1985, 505).
Partendo da questa caratterizzazione del Calcolitico, i protagonisti europei di questo decisivo momento sono fondamentalmente quattro: (1) i rappresentanti della cultura dei kurgan (detta anche delle Tombe a Fossa o jamnaja, dal suo nome russo), nell'area delle steppe pontiche, e la loro continuazione in Asia, nel cui ambito appaiono per la prima volta riuniti i principali elementi della nuova società: l'allevamento di cavalli, l'uso dei cavalli come cavalcatura, i carri, la stratificazione sociale e l'emergere di 'guerrieri-principi' ereditari, con i grandi tumuli funerari (i kurgan) a loro riservati; (2) i rappresentanti delle culture pastorali dette della Ceramica a Cordicella e delle Asce da Combattimento, e quelle affini delle Sepolture Individuali (a tumulo), che da uno o più focolai ancora imprecisati, ma certamente ispirati, in ultima analisi, dai pastori guerrieri delle steppe eurasiatiche, si diffondono a macchia d'olio in tutta l'Europa orientale e centrale; (3) i costruttori dei monumenti megalitici, che partendo dalla loro culla sulle coste atlantiche diffondono in tutta Europa una religione nuova, di tipo uranico, legata all'agricoltura, all'osservazione del ciclo annuale del sole e all'idea della resurrezione dei morti; (4) i portatori del Vaso Campaniforme, che emergono nell'ambito
27
delle società megalitiche dell'Atlantico e si diffondono in Europaoccidentale e centrale, con un 'messaggio' ideologico guerriero e maschilista molto simile a quello dei loro cugini orientali delle Asce da Combattimento, e il cui 'bicchiere' era probabilmente usato per bevute di gruppo (di bevande inebrianti).
Queste quattro culture, infine, contribuiscono a formare due aree abbastanza omogenee e contrapposte in Europa: (I) quella dei tumuli e della Ceramica a Cordicella e Asce da Combattimento a oriente; (II) quella dei megaliti e del Vaso Campaniforme a occidente.
Delle due, la prima è leggermente più antica, ha il tempo di spingersi fino ad ovest, e non è escluso che abbia fornito lo stimolo per la formazione della prima. Come vedremo nei prossimi capitoli, nel quadro della TC sia i megaliti che i Vasi Campaniformi si lasciano attribuire senza problemi e con notevole sicurezza ai Celti. Un'attribuzione che fra l'altro non è nuova, enello scenario della TC si presenta con argomenti quanto mai solidi.
Per quanto riguarda la grande cultura dei kurgan, massima responsabile dei mutamenti economici ed ideologici in chiave pastorale e patriarcale, la TC permette di impostare il problema della sua interpretazione in modo nuovo, e del tutto diverso da quello tradizionale: cioè di attribuirla, anziché ai PIE, a gruppialtaici. Come vedremo, questa soluzione è particolarmente produttiva.
Per quanto riguarda infine la cultura della Ceramica a Cordicella e Asce da Combattimento, infine, anche se non si può accettare la teoria della Gimbutas, che attribuiva queste culture esclusivamente al gruppo baltico, si può tuttavia ammettere che ilgruppo baltico sia stato uno dei suoi principali rappresentanti.
12Età del Bronzo: la proiezione miceneaCon l'età del Bronzo, che corrisponde grosso modo al II millennio
a.C., raggiungiamo l'età micenea, con la quale abbiamo anche la prima manifestazione di una lingua IE in Europa. Una lingua scritta, per definizione elitaria, e quindi ricca di aspetti dialettali già identificati, che rinviano a una precedente differenziazione nello stesso territorio. Dal punto di vista metodologico, la TC impone a questo punto l'adozione di quello che ho chiamato il principio della 'proiezione micenea'. Secondoquesto principio la comparsa di una lingua scritta nella Grecia dell'Età del Bronzo è puramente casuale, essendo dovuta al
28
raggiungimento, in quell'area prima che nelle altre, delle condizioni necessarie e sufficienti per la formazione di una civiltà urbana, che a sua volta è il prerequisito per la nascitadi una lingua scritta. Di conseguenza, tutto fa pensare che nelle aree le cui popolazioni IE non avevano ancora raggiunto lafase critica per la formazione di ceti dominanti di tipo urbano si parlassero lingue dello stesso ceppo. Nel II millennio, insomma, la presenza dei Micenei ci dà il diritto di proiettare tutti i gruppi IE nelle loro sedi storiche, salvo modifiche non sostanziali nei loro confini, e di considerarli anche, come il Miceneo, dialettalmente differenziati.
Anche senza questo principio, comunque, l'archeologia ha per conto suo più volte sottolineato la inconfutabile continuità fra molti aspetti fondamentali dell'Età del Bronzo e l'epoca storica, ciò che rappresenta, in termini diversi, una conferma della 'proiezione micenea'.
Quali sono questi aspetti fondamentali del Bronzo? Come già detto, essa è anzitutto l'età che vede l'inizio delle società stratificate di tipo urbano: la prima civiltà urbana in Europa è infatti quella dell'area egea (Sherratt 1994, 244), seguita subitodopo dalla civiltà greco-micenea. Anche là dove la forma urbana non viene raggiunta, tuttavia, l'Europa del Bronzo è ormai dominata da gruppi di tipo elitario, di varia estrazione etnica, di solito impegnati in imprese di colonizzazione militare per lo sfruttamento in proprio delle risorse economiche delle aree vicine. Mentre gli archeologi sottolineano sempre l'aspetto elitario di questi gruppi, storici e linguisti spesso trascurano, o ignorano, le implicazione sociali e sociolinguistiche di questa nuova realtà. Nel quadro della TC, come vedremo, l'attribuzione diquesti gruppi elitari all'uno o all'altro ceppo etnolinguistico può essere effettuata di solito senza grossi problemi. Anche nei pochi casi in cui essa si rivela difficile, non è escluso che il problema sia nelle limitate conoscenze di chi scrive. Quello che importa sottolineare è che la colonizzazione economica e militare di territori vicini o lontani da parte di gruppi elitari non può mutare se non superficialmente la struttura etnolinguistica precedente, che dal Neolitico in poi è ormai indissolubilmente legata al territorio e alle masse dei coltivatori, destinate a essere sempre più sospinte verso la servitù e la ghettizzazione. Il processo di colonizzazione, tuttavia, ha una notevole importanza per la spiegazione corretta dei superstrati linguisticiche modificano le caratteristiche delle lingue originarie.
Come vedremo, nell'ambito della TC i gruppi etnici che si 29
lasciano riconoscere più facilmente come responsabili di vaste imprese di colonizzazione sono tre: (1) Celti ad occidente, (2) Balti a nord-est, (3) Turcichi alle porte dell'Asia e lungo le steppe europee. La partecipazione di altri gruppi a imprese dello stesso tipo, tuttavia, non è esclusa, e potrà essere accertata da future ricerche inerdisciplinari.
L'espansione di questi gruppi elitari non dev'essere dunque confusa con processi di diffusione etnica pura e semplice, come disolito tende a fare la ricerca tradizionale. I popoli di cui noi leggiamo nella documentazione storica, così come quelli che si lasciano postulare con sempre maggior sicurezza sulla base della documentazione del Bronzo e del Ferro, non si sostituiscono a quelli che essi dominano, ma vi portano, al massimo, degli elementi di superstrato. Questo vale dunque non solo per i Celti (che sono quelli che si spingono più lontano dalle loro terre di origine), per i Balti e per i Turcichi, ma anche per gli Illiri, gli Etruschi, gli Sciti, i Traci, i Medi, i Sarmati, i Cimmeri e così via, compresi, più tardi, i Romani stessi. Tutti questi popoli sono intrusivi rispetto a quelli che dominano. Anche i Romani, nella nuova lettura della preistoria del Mediterraneo settentrionale non sono più quelli che hanno portato la loro lingua in Dalmazia, nella Svizzera gallo-italiana, franco-provenzale e reto-romanza, in Sardegna e Corsica, in Francia e nella penisola iberica, ma sono soltanto quelli che hanno sovrapposto una o più varianti latine nate dalle ibridazioni dei millenni precedenti, su di un fondo linguistico che era già affineal Latino e alle altre lingue italiche fin dal Paleolitico, e che nel Neolitico si riflette chiaramente nell'unità culturale della Ceramica Impressa/Cardiale.
Tutti i gruppi elitari del Bronzo (e del Ferro) europeo, insomma, vanno considerati come gruppi potenzialmente coloniali, che là dove arrivano portano coloni, soldati, mercanti, prospettori minerari, funzionari e simili, e la cui presenza militare, commerciale e politica, più o meno forte, scompare con la fine delle condizioni che ne avevano permesso la instaurazione.Al massimo, questi gruppi possono aver diffuso alcuni tratti del loro linguaggio, grazie al prestigio di cui hanno goduto come dominatori. Ma non sono popolazioni etniche omogenee che si sostituiscono a quelle autoctone. Da questa confusione nascono spesso grossi equivoci, come nei riguardi dei Celti, per esempio, che sono tuttora visti come gli antenati degli abitanti della Svizzera. In realtà, la Svizzera fu abitata fin dal Mesolitico e certamente dal Neolitico da tre diversi gruppi Italici e da un
30
gruppo di Germani, sui quali una forte componente celtica si è sovrapposta solo più tardi, come gruppo coloniale. In questo e negli altri casi simili, il modello che dobbiamo seguire, mutatis mutandis, è quello del colonialismo europeo moderno, che in tutto il mondo ha portato gruppi elitari europei di diversa nazionalità,ma che in quasi nessuna parte del mondo è riuscito a cancellare leculture e le lingue precedenti, nonostante l'enorme disparità di potenza.
Come già detto nel cap. I, l'interpretazione in chiave etnicadegli eventi delle Età dei Metalli è dovuta all'errata applicazione del metodo 'retrospettivo', con la quale si attribuisce un'identità etnica a un'intera area, ignorando il carattere elitario e coloniale dei gruppi che noi vediamo all'opera in questa epoca.
31
Bibliografia
Alinei, Mario (1996a), Origini delle lingue d'Europa. Vol. I: La Teoria della Continuità, Il Mulino, Bologna
------- [in stampa], Origini delle lingue d'Europa. Vol. II: Continuità delle principali aree etnolinguistiche dal Mesolitico all'età del Ferro, Il Mulino, Bologna
Bagolini, Bernardino (1992), "Il Neolitico nell'Italia settentrionale", in Guidi-Piperno (cur.) (1992), 274-305.
Barbaza, Michel (1994), Il Mesolitico, in Guilaine e Settis (curr.), pp. 105-142.
Childe, V. Gordon (1972), L'alba della civilta europea, Einaudi, Torino (trad. di The Dawn of European Civilization, Routledge& Kegan Paul, London, 1957, 6th revised ed.).
Childe, V. Gordon (1958), The Prehistory of European Society, Penguin Books (trad. it. Preistoria della società europea, Sansoni, Firenze 1965).
Clark, Grahame (1932), The Mesolithic Age in Britain, London.Clark, Grahame (1936), The Mesolithic Settlement of Northern
Europe, Cambridge.Cunliffe, Barry (ed.) (1994), The Oxford Illustrated Prehistory of
Europe, Oxford New York, Oxford University PressGuidi, Alessandro, Marcello Piperno (cur.) (1992), Italia
preistorica, Editori Laterza, Bari. Guilaine, Jean, Salvatore Settis (curr.) (1994), Storia d'Europa,
vol. secondo, Preistoria e antichità, tomo primo, Einaudi, Torino.
Harbison, Peter (1988), Pre-Christian Ireland. From the First Settlers to the Early Celts, Thames and Hudson, London.
Kozlowsky, Stefan K. (ed.) (1973), The Mesolithic in Europe, Warszawa
Kozlowsky, Stefan K. (1980), Atlas of mesolithic in Europe, Warszawa
Kozlowsky, Janusz K. & Stefan K. Kozlowski (1979), Upper Palaeolithic and Mesolithic in Europe. Taxonomy and Palaeohistory, Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdansk.... PolskiejAkademii Nauk.
Kozlowsky, Janusz K. e Marcel Otte (1994), Il Paleolitico superiore in Europa, in Guilaine e Settis (curr.), 29-102
Lichardus Jan et Marion Lichardus-Itten (1985), La protohistoire de l'Europe. Le Néolithique et le Chalcolithique entre la merMéditerranéee et la mer Baltique, PUF, Paris.
32
Merpert, N.Ja (1994), Il Neolitico nell'Europa orientale, in Guilaine-Settis (curr.), 187-211.
Neustupny J. (1976), "Archaeological Comments to the Indo-EuropeanProblem", in Origini, X, pp. 7-18.
Neustupny E. e J. Neustupny (1963), La Cecoslovacchia prima degli Slavi, Il Saggiatore, Milano.
Nuñez, Milton G. (1997), Finland's settling model revisited, in Reports of the Early in the North Project, Helsinki Papers inArchaeology, No. 10, 93-102.
Nygaard, Signe E. (1989), "The Stone Age of Northern Scandinavia: A Review", in Journal of World Prehistory, vol. 3, pp. 71-116.
Raetzel-Fabian, Dirk (1986), Phasenkartierung des mitteleuropäischen Neolithicums. Chronologie und Chorologie (VAR Internagtional Series 316), Oxford.
Renfrew, Colin (1987), Archaeology and Language. The Puzzle of Indo-European Origins, London.
Sherratt, A. (1981), "Plough and pastoralism: Aspects of the Secondary Products Revolution". In Hodder, I., Isaac, G., andHammond, N. (eds.), Pattern of the Past, Cambridge universityPress, Cambridge, pp. 261-305
Sherratt, A. (1983), "The secondary exploitation of animals in theOld World", World Archaeology, 15, pp. 90-104
Sherratt, A. (1994b), The Emergence of Elites: Earlier Bronze Age Europe, 2500-1300 BC, in Cunliffe (ed.), 244-276.
Whittle, Alasdair (1985), Neolithic Europe. A Survey, Cambridge University Press, Cambridge New York New Rochelle Melbourne Sydney
33




































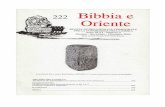




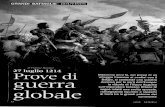


![Doppie lezioni e arcaismi linguistici pre-vulgata: la stratigrafia delle fonti nel manoscritto provenzale estense (D) ["Cultura neolatina", 55, 1995]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ccf61665120b3330c0992/doppie-lezioni-e-arcaismi-linguistici-pre-vulgata-la-stratigrafia-delle-fonti-nel.jpg)