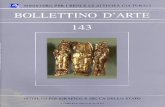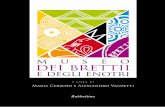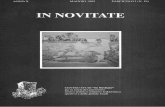Materiali lapidei di età romana nel Museo Archeologico di Cassino
Testimonianze del Paleolitico medio in località Folcara a Cassino (nota preliminare)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Testimonianze del Paleolitico medio in località Folcara a Cassino (nota preliminare)
Ministero per i Beni e le Attività CulturAli
soprintendenzA per i Beni ArCheologiCi del lAzio
Lazio e Sabina7
a cura digiuseppinA ghini
Atti del Convegno
Settimo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina
Roma9-11 marzo 2010
ESTRATTO
edizioni QuAsAr
493
1. Premessa
Nel corso di indagini archeologiche preventive alla costruzione di alloggi per studenti nel Campus Uni-versitario di Cassino (aprile 2008) sono stati esegui-ti saggi esplorativi, costituiti da 13 trincee paralle-le, che hanno permesso di individuare un’area con frammenti di fauna fossile (Elephas antiquus e Bos primigenius). Si è deciso, quindi, di avviare uno scavo sistematico, impostato in un settore circoscritto (mq 300 ca.), che dall’analisi degli affioramenti poteva es-sere più promettente; si è voluto inoltre intraprende-re uno studio geologico su tutta l’area del cantiere1. È stato, pertanto, avviato un lavoro interdisciplinare che ha consentito di ricostruire non solo gli aspetti paleoambientali e paleoclimatici, ma anche l’evolu-zione geomorfologica e di confermare la presenza di frequentazioni umane paleolitiche nel territorio.
Il sito è ubicato km 1,5 ca. a sud del moderno cen-tro abitato di Cassino, su un basso pianoro caratte-rizzato da depositi fluvio-lacustri (fra le quote m 40 e 50 s.l.m.), lambito dai torrenti Fontanelle e Pioppeto, affluenti di destra del fiume Gari, nel quale si immet-tono presso la località Ponte Marozzo (fig. 1) (I. C.).
2. Analisi geologica
L’area del Comune di Cassino è caratterizzata da una situazione articolata dal punto di vista geologico, ge-omorfologico e strutturale. Accanto ad estesi affio-ramenti di rocce calcaree (unità di piattaforma car-bonatica a comportamento prevalentemente fragile e contrassegnate da motivi tettonici principalmente orientati nord-ovest/sud-est) si rinvengono sia sedi-menti quaternari lacustri e fluviali, sia depositi vulca-nici e vulcanoclastici relativi al distretto del Vulcano di Roccamonfina2.
Per la comprensione degli aspetti geologici e pa-leoambientali dell’area lo studio si è svolto, inizial-mente, analizzando le sezioni esposte nelle trincee realizzate durante le indagini archeologiche preven-tive e, successivamente, analizzando tutte le sezioni aperte durante le fasi di scavo per la messa in ope-ra delle fondazioni degli edifici del Campus e delle strutture annesse. Le trincee preventive, profonde m 1 ca. e lunghe m 160 ca., erano posizionate parallele tra loro e con andamento circa N 70°. Tali trincee sono state indicate con un numero progressivo da
1 Le attività di scavo sono state dirette dal Funzionario respon-sabile per la preistoria, Dott.ssa A. Zarattini e dal Funzionario responsabile di zona, Dott. A. Betori, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, ai quali va un sentito ringraziamen-to per averci offerto la possibilità di presentare in questa sede i dati preliminari. Ringraziamo anche l’Arch. S. Tanzilli, Direttore del Museo Archeologico di Cassino, e il personale, in partico-
lare P. De Rosa (resp. magazzino), E. Evangelista e G. Butera (assistenza in cantiere), per la consueta disponibilità e la fattiva collaborazione. Allo scavo hanno partecipato anche gli studen-ti del corso di Paleontologia e Paleoecologia dell’Università di Cassino. I lavori sono stati eseguiti dalla Ditta Cominio S.r.l., che ha curato anche il recupero del testimone con resti faunistici.2 Angelucci et al. 1962-65; Giannetti 2001.
Testimonianze del Paleolitico medio in località Folcara a Cassino (nota preliminare)
Italo Biddittu – Ilenia Carnevale – Teresa Coppola – Margherita Malorgio – Eva Sacchi
Fig. 1. Stralcio della CTR sez. nrr. 403100 e 403110 (scala 1:10.000), con il posizionamento dell’area di scavo.
494
ITALo BIDDITTU – ILENIA CARNEVALE – TERESA CoPPoLA – MARGhERITA MALoRGIo – EVA SACChI
1 a 13, procedendo da nord verso sud. Gli scavi per la messa in posa delle fondazioni si sono spinti fino a m 6 nella porzione a nord e fino a m 4 ca. nella porzione a sud. Questi ultimi scavi, realizzati per lo più ortogonalmente alle trincee preventive, hanno consentito di intercettare in diversi punti le unità se-dimentarie riconosciute e di ottenere un’immagine tridimensionale delle strutture incontrate. Tali scavi hanno quindi permesso di correlare i sedimenti af-fioranti e determinare quelli che dovevano essere la morfologia e l’ambiente deposizionale al momento della messa in posto dei sedimenti stessi.
Per comprendere l’evoluzione sedimentaria dell’area esaminata sono stati adottati criteri di va-lutazione stratigrafica e metodologie di terreno che hanno permesso la caratterizzazione dei differenti corpi litologici. Tali corpi sono stati riconosciuti sia attraverso l’analisi delle caratteristiche composizio-nali, sia attraverso l’individuazione delle superfici di discontinuità. Data la complessità della situazione geologica si è resa quindi indispensabile un’analisi di estremo dettaglio di tutti i caratteri sedimentologici quali la granulometria (sabbia, argilla etc.), la natura dei componenti (cristalli, frammenti di cristalli, mi-croorganismi fossili etc.), la tessitura (percentuale e natura dello scheletro e della matrice, sfericità e smussamento dei componenti etc.) e gli spessori dei corpi. È stata investigata, inoltre, la natura (erosiva e non erosiva) e la geometria delle superfici di tetto e di letto di ciascun corpo individuato.
L’analisi di dettaglio dei sedimenti ha permesso di ricostruire un ambiente fluvio-lacustre estremamente variabile sia nel tempo che nello spazio, con caratte-ristiche complesse che hanno determinato variazioni laterali, anche marcate, durante la normale sedimen-tazione lacustre. La situazione studiata riflette in piccolo l’evoluzione tettono-sedimentaria, nel corso del plio-pleistocene, di una vasta area. Gli scavi sono stati condotti su una piccola porzione di tale area che nel suddetto periodo era ricoperta dalle acque di un antico e vasto lago di origine tettonica, il Lirino, che occupava la bassa valle del Liri tra Ceprano e il fiume Garigliano e si estendeva su una superficie di km² 350 ca.
L’analisi dei sedimenti, delle strutture e dei rap-porti stratigrafici fra i depositi ha permesso di rico-struire un primo ambiente lacustre testimoniato da depositi siltosi e argillosi. Le caratteristiche sedi-mentologiche hanno messo in luce una batimetria variabile nel tempo, oscillante da molto profonda a superficiale. All’interno di tali depositi sono stati re-gistrati inoltre alcuni eventi vulcanici rappresentati da livelli ricchi di pomici gialle e da livelli di cineriti grigie (fig. 2).
A questo primo ambiente lacustre seguono una o più fasi erosive, la cui testimonianza è data dalla presenza di tre canali, indicati come Canale I, Canale II e Canale III, e dalla presenza di un’ampia zona
depressa a nord dello scavo indicata come Canale IV (figg. 3-4); le elevate dimensioni di tale struttura rispetto all’area intercettata dalle trincee non ha per-messo di ricostruirne la corretta geometria.
I canali individuati mostrano direzioni differen-ti; si tratta molto probabilmente di canali divaganti meandriformi. Date le limitate dimensioni dell’area indagata non è stato possibile stabilire se i canali si siano approfonditi contemporaneamente o in tempi differenti.
Alla fase erosiva, che ha portato alla formazione delle strutture canaliformi, segue poi una nuova fase di invasione delle acque lacustri documentata dai primi sedimenti di riempimento dei canali. Succes-sivamente un’ulteriore fase erosiva fluviale interessa anche questi depositi lacustri, incidendoli. Una dimi-nuzione dell’energia di flusso determina una nuova fase deposizionale caratterizzata prima dall’accumu-lo della componente più pesante (ghiaie e alcuni resti ossei) e poi dall’accumulo di quella più leggera (sab-
Fig. 2. Particolare di alcuni livelli cineritici rilevati nei sedimenti di origine lacustre.
Fig. 3. Pianta dell’area di scavo con ubicazione delle trincee e con le quattro sezioni principali che hanno permesso la ricostruzione dell’ambiente e della morfologia al momento della messa in posto dei sedimenti. Le frecce indicano le ubicazioni dei canali e la dire-zione di scorrimento delle acque.
495
TESTIMoNIANZE DEL PALEoLITICo MEDIo IN LoCALITà FoLCARA A CASSINo (NoTA PRELIMINARE)
3 Devoto 1965.
l’intero territorio, riempiendo le depressioni in cui è ancora presente acqua, dove i granuli decantano e vengono rielaborati. La cinerite analizzata mostra, infatti, a luoghi, un sottile livello a laminazioni pia-no-parallele nella porzione basale. Sul paleosuolo e sulla cinerite si reimposta nuovamente un ambiente lacustre.
I depositi lacustri analizzati sono stati confrontati con quelli descritti in letteratura da Devoto3. L’Au-tore distingue tre facies lacustri, dal più antico al più recente: il “Limo lacustre inferiore”, la “Facies lacu-stre normale” e la “Facies lacustre tardiva”.
Non è stato possibile correlare direttamente i depositi in studio con una delle fasi deposizionali proposte dall’Autore. La difficoltà è in parte legata alla differente scala di rilevamento, l’Autore infatti descrive a livello regionale le caratteristiche delle dif-ferenti facies. Lo studio da noi effettuato si è invece incentrato su una piccola parte di territorio, è stato quindi possibile eseguire un’analisi e una descrizio-
bie grossolane fino al silt). I depositi di ghiaia gros-solana sono localizzati principalmente nella porzione ovest dell’area in esame; questo perché il flusso, pro-veniente da ovest, a mano a mano che si avvicinava al lago, a est, perdeva energia di trazione depositando i sedimenti dai più grossolani ai più fini.
Con la perdita di energia del mezzo traente, l’am-biente, da fluviale, lascia nuovamente il posto a un ambiente lacustre-palustre di acque basse. Nella fase successiva parte dell’area si interra e, in condizioni sub-aeree, subisce prima fenomeni di erosione su-perficiale, poi processi di pedogenizzazione che por-tano alla formazione di un paleosuolo. A conferma di ciò, in quest’ultima unità, sono stati ritrovati sia resti di gasteropodi terrestri (fig. 5) sia resti di muridi (fig. 6).
Parallelamente allo sviluppo del paleosuolo un nuovo evento vulcanico determina la deposizione di un corpo cineritico dello spessore di cm 70 ca. La cinerite, di composizione trachitica, ammanta
Fig. 4. Disegno schematico di una delle sezioni principali (SC4) con visi-bili i fianchi erosivi di due dei canali individuati nell’area e dei depositi di riempimento degli stessi.
Fig. 5. Esemplare di helix sp. ritrovato nel paleosuolo.
Fig. 6. Esemplare attuale di Apo-demus e uno dei molari ritrova-ti nei depositi, attribuibile alla specie Apodemus sylvaticus o a Apodemus flavicollis.
496
ITALo BIDDITTU – ILENIA CARNEVALE – TERESA CoPPoLA – MARGhERITA MALoRGIo – EVA SACChI
che aveva restituito la maggiore concentrazione di resti paleon-tologici, al fine di effettuare un calco che dovrà essere esposto nel Museo Archeologico di Cassino.
4 Dato il carattere di emergenza dell’intervento e la rilevanza del sito, che costituisce al momento l’unico scavo scientifico preisto-rico nel territorio di Cassino, si è deciso di asportare la porzione
3. Lo scavo
Lo scavo, che si è protratto da aprile a settembre del 2008, ha interessato una superficie di m 23,80 x 12,00, suddivisa in due saggi distinti (a e b), risultati dall’ampliamento e raccordo di parte di tre trincee esplorative (T5, T6 e T7) (fig. 8).
In particolare il saggio a e le trincee T5 e T6 han-no restituito la maggiore concentrazione di evidenze paleontologiche e archeologiche.
Il deposito preistorico, individuato a una profon-dità media di m 1,50-1,60 dal piano di campagna, è sottostante a una serie di limi argilloso-sabbiosi.
Più in dettaglio la successione stratigrafica evi-denziata nelle trincee di sondaggio e nell’area di sca-vo è costituita (dall’alto verso il basso) da: uno strato di humus (US1) di m 0,25-0,30, con rari resti di ce-ramica romana e medioevale, al di sotto del quale è presente un livello di limo sabbioso, con calcinelli di colore tendente al grigio (US2). Esso copre uno strato (US3) di sabbie color bruno-ocra, con fram-menti e “ciottoli” di travertino più grandi alla base, intercalato da diverse lenti di sabbia chiara, piutto-sto fine (US3b). Al suo interno sono stati individuati numerosi frammenti di fauna, in buona parte nell’in-terfaccia con il livello inferiore, costituito da argil-le e siltiti tendenti gradualmente dal grigio-avorio (US4) al verde (US5). Esse presentano una superfi-cie di erosione da acque correnti, testimonianza di una fase che ha modellato un’area con morfologia da paleo-alveo, caratterizzata da formazioni di canali di ruscellamento o scorrimento (Canali I-III), orien-tati est-ovest nell’area dello scavo. Al modellamento è seguita una fase di deposizione caratterizzata da sabbie grossolane, “ciottoli” di travertino e di argilla strappata dal fondo, minerali vulcanici prevalente-mente augitici, resti di fauna e rari manufatti litici in selce (US3 - US3b). Durante lo scavo è stata notata, in aree ristrette, una concentrazione di resti faunisti-ci4 con elementi anatomici non fluitati, appartenenti allo stesso individuo soprattutto di bovide, che in
Fig. 7. Gusci di ostracodi rinvenuti nei sedimenti lacustri analiz-zati.
ne estremamente dettagliata dei depositi sedimentari individuati.
Ulteriore difficoltà nella correlazione dei depo-siti individuati con le fasi deposizionali indicate da Devoto (1965) dipende dal fatto che l’area in studio occupava una zona marginale dell’ambiente lacustre lirino, area in cui variazioni di livello del lago, anche minime, hanno lasciato tracce marcate nei sedimenti. I depositi e le superfici di erosione osservate sono in-fatti tipici di ambiente instabili come i margini di un bacino. Per la presenza di esemplari di Candona sp. (ostracode dulcicolo) (fig. 7) il deposito in cui sono stati trovati i resti di grandi mammiferi potrebbe essere riferito, seguendo la suddivisione di Devoto (1965), alla “Facies lacustre normale” (facies inter-media), o alla “Facies lacustre tardiva” (facies più recente), anche se probabilmente dai dati ottenuti dalle analisi effettuate siamo portati a pensare che tale deposito appartenga a quest’ultima facies e che le fasi erosive abbiano rimaneggiato i depositi delle facies precedenti.
L’analisi dei reperti fossili (ostracodi, gasteropodi, bivalvi, denti di muride etc.), sebbene abbia fornito ottimi indizi paleoambientali per l’area studiata, non ha permesso di individuare, per i depositi in esame, un intervallo temporale definito. Sarà forse lo studio dei resti ossei di grandi e piccoli mammiferi a stabili-re, se possibile, l’intervallo temporale di deposizione dei depositi intercettati durante le operazioni di sca-vo (T. C. – E. S.).
Fig. 8. Veduta dell’area di scavo da sud-est.
497
TESTIMoNIANZE DEL PALEoLITICo MEDIo IN LoCALITà FoLCARA A CASSINo (NoTA PRELIMINARE)
qualche caso indicavano una probabile connessione (figg. 9-10). La rarità dell’industria litica suggerisce che queste concentrazioni non siano connesse ad at-tività di caccia e macellazione, ma possano derivare da fenomeni naturali in seguito a eventi alluvionali, che potrebbero aver interessato siti o accampamenti paleolitici presenti nelle aree carsificate del fronte di travertino sul versante sud-est del monte di Cassino, distante km 1,5 ca. dal sito, in cui si aprivano grotte con depositi a faune e industria del Paleolitico me-dio, come quella esplorata da o.G. Costa nel 18635 (I. B. – I. C. – M. M.).
4. L’industria litica
Nel sito è stata ritrovata rara industria litica su scheggia in selce. In questo lavoro viene presa in considerazione l’industria litica rinvenuta nell’area di scavo, saggi a e b, US3 e negli strati rimaneggiati delle trincee 2-3-5-7, posizionate nella restante area indagata dai saggi preventivi scavati nel 2008. L’indu-stria, attribuita al Paleolitico medio, è costituita nel complesso da 21 manufatti. 10 reperti provengono dal saggio a, US3 (quadrati B1- D3- C1- E3- A1-A2),
5 Costa 1864.
3 reperti provengono dal saggio b, US3 (quadrato B VI) e 8 reperti dagli strati rimaneggiati delle trincee 2-3-5-7 (fig. 11).
Dal saggio a:- scheggia non levallois con tallone non ricono-
scibile (saggio a, B1, nr. 8), l. mm 39; l. mm 19; sp. mm 17
Fig. 9. Particolare della planimetria del saggio a (ril. I. Carnevale).
Fig. 10. Particolare della fauna individuata nel saggio a, D2, D3, E2, C3, US3.
498
ITALo BIDDITTU – ILENIA CARNEVALE – TERESA CoPPoLA – MARGhERITA MALoRGIo – EVA SACChI
- scheggia non levallois con tallone liscio su di-stacco (frammento prossimale) (saggio a, D3)
l. mm 10; l. mm 19; sp. mm 14- scheggia non levallois con tallone puntiforme
e tracce di ossidazione. (saggio a, C1, US3)- scheggia non levallois, frammentaria nella par-
te distale e con tallone liscio (saggio a, D3)- scheggia levallois con tallone liscio su distacco
(saggio a, E3, nr. 1)- raschiatoio trasversale con tallone diedro (Sag-
gio a, D3)- raschiatoio semplice convesso su scheggia le-
vallois con ritocco semplice, profondo sub-pa-rallelo; tallone a faccette (saggio a, A1, US3)
- frammento mediano-distale di raschiatoio su faccia piana su scheggia Levallois con ritocco semplice profondo trasversale a distacchi pa-ralleli (saggio a, E3, 2)
l. mm 56; l. mm 48; sp. mm 13- grattatoio doppio su scheggia sub-triangolare
non orientabile con ritocco denticolato diretto erto profondo esteso su uno dei margini (sag-gio a, C1, 27)
l. mm 46; l. mm 39; sp. mm 12- nucleo discoidale (saggio a, A2, US3) l. mm 60; l. mm 56; sp. mm 45.
Dal saggio b:- raschiatoio semplice convesso con tallone li-
scio su distacco (ravvivamento di nucleo, in saggio b, B VI)
- scheggia, frammento (saggio b, B VI)- scheggia non levallois con tallone diedro, in
selce (saggio b, B VI)l. m 3; l. mm 25; sp. mm 6.
Dal rimaneggiato:- raschiatoio semplice diritto su scheggia con
ritocco semplice profondo diretto sinistro e ritocco parziale diretto distale denticolato. Presenza di cortice parziale e distalel mm 58; l. mm 32; sp. mm 14
- fammento di nucleol. mm 39; l. mm 22; sp. mm 10
- scheggia levallois, con tallone liscio su distacco (nello strato rimaneggiato, Facoltà di Lettere)l. mm 54; l. mm 47; sp. al tallone mm 10
- scheggia non levallois con tallone liscio su di-stacco (nello strato rimaneggiato, trincea 7)
- scheggia laminare (nello strato rimaneggiato, trincea 5)
- scheggia di lavorazione (nello strato rimaneg-giato, trincea 5)
- scheggia non levallois con tracce d’uso trasver-sali (nello strato rimaneggiato, trincea 2-3)
- scheggia non levallois con tallone liscio su distacco con distacchi a doppia patina (nello strato rimaneggiato, trincea 6).
Complessivamente i manufatti studiati sono:2 raschiatoi semplici convessi di cui uno su scheg-
gia levallois; 1 raschiatoio semplice diritto;2 raschiatoi trasversali, di cui uno su scheggia
levallois e l’altro su ravvivamento di nucleo; 1 grat-tatoio; nucleo discoidale; 1 frammento di nucleo; 3 schegge levallois; 10 schegge non levallois.
L’analisi preliminare della materia prima utiliz-zata per i manufatti provenienti dal settore di scavo (saggi a-b) ha rilevato un uso esclusivo della selce; i manufatti non presentano tracce di fluitazione e han-no una patina fresca, con qualche sporadica incro-stazione calcarea non indicativa per la comprensione delle dinamiche di formazione del deposito.
L’industria della Folcara mostra un aspetto leval-loisiano e può trovare confronti con le industrie già conosciute di Cassino e con quelle del giacimento di Valleradice a Sora6.
Fig. 11. 1. scheggia Levallois, strato rimaneggiato; 2. raschiatoio, saggio a, A1, US3; 3. raschiatoio, saggio a, B VI, US3; 4. nucleo discoidale, saggio a, A2, US3 (dis. M. Malorgio).
6 Biddittu et al. 1967.
499
TESTIMoNIANZE DEL PALEoLITICo MEDIo IN LoCALITà FoLCARA A CASSINo (NoTA PRELIMINARE)
saggio a-C3, saggio b, saggio b-A VI, T5, T6, T7, ri-maneggiato C-D
Stephanorhinus sp.: 1 molare superiore da trincea 5 rimaneggiato
Equus sp.: 1 premolare inferiore in saggio a-A1, 1 frammento di metapodiale in D4
Bos sp.: 1 emi-mandibola, 7 vertebre, 1 frammento di cranio, 1 omero, 5 molari, 1 frammento mandibo-la, 2 incisivi, 2 frammenti di dente, 3 astragali, 3 me-tapodiali, 1 frammento di corno, 1 falange, 1 cubo-scafoide, varie costole per un totale di 31 elementi. Per la provenienza: saggio a-C1: 8, saggio a-A1: 1, saggio a-C2: 2, saggio a-D1: 6, saggio a-D2: 1, saggio a-D3: 1, saggio a-D4: 1, saggio a-E4: 1, saggio b: 1, trincea 5: 2, trincee 2-3: 2
Capreolus sp.: 1 palco da saggio a-A4
Canis sp.: 1 dente da saggio a-D2
Lepus sp.: 1 Tibia da saggio b-DVI
Emys sp.: 6 frammenti di carapace da saggio a-A3: 1, saggio a-D1: 2, saggio a-C3: 1, saggio b-CVI: 1, trincea 7: 1
Aves sp.: 3 frammenti di diafisi.
Si ricordano anche 2 frammenti di valve di Unio sp.
La specie più rappresentata è il Bue primigenio anche con reperti in parziale connessione anatomica. Lo stato attuale dello studio non consente di affer-mare se sulle ossa siano presenti tracce di scarnifica-zione e la scarsità dell’industria litica suggerisce che la distribuzione spaziale dei resti sia conseguenza di fenomeni naturali, in attesa di esami più approfon-diti. Nel complesso alcuni elementi, insieme ai dati stratigrafici, suggeriscono un ambiente limitrofo a zone palustri o lacustri (I. B.).
6. Conclusioni
Il sito della Folcara conferma l’importanza del ter-ritorio compreso tra Cassino, Pignataro Interamna e S. Angelo in Theodice, nel quale sono spesso af-fiorate testimonianze di frequentazioni umane fin dal Paleolitico inferiore, associate a notevoli resti di fauna fossile. La marginalità dei siti con il “lago Li-
Testimonianze del Paleolitico medio sono note nell’area di Cassino7. La prima segnalazione è stata fatta nel 1863 da o.G. Costa che scavò una grotta nei travertini nella zona di Porta Paldi, in seguito di-strutta da lavori di cava (la nostra area di scavo dista km 1,5 da Porta Paldi); i manufatti rinvenuti erano associati a fauna fossile, determinata da Flores nel 1895, che riporta Elephas sp., Equus caballus, Rhino-ceros megarhinus, Sus scrofa, Ursus spelaeus, Hyaena crocuta var. spelaea.
Una revisione di De Lorenzo e D’Erasmo8 ha at-tribuito i resti di elefante alla specie E. antiquus e quelli di rinoceronte alla specie Rhinoceros Mercki. Nel complesso questa fauna è simile a quella rinve-nuta nel giacimento di Valleradice a Sora.
Il Mochi nel 1912 esaminò gli strumenti rinvenuti a Cassino dal Costa, conservati nel Museo di Antro-pologia di Napoli, e osservò una frequenza di punte e raschiatoi con tecnica levallois. Purtroppo i lavori per l’estrazione del travertino hanno successivamen-te distrutto il giacimento9. Analogamente a Sora10 la tecnica levallois è molto rappresentata.
Manufatti musteriani sono stati rinvenuti, inoltre, nelle terre rosse, che rappresentano i depositi di riem-pimento dei calcari modellati dal paleocarsismo, af-fioranti sulle pendici meridionali di Montecassino11. Un insieme di manufatti, rinvenuto da A. Giannetti e da G. Lena, proviene dall’area della necropoli volsca presso l’anfiteatro romano e nell’area compresa tra l’anfiteatro e S. Scolastica.
L’industria, tutta in selce, con raschiatoi déjeté, trasversali, su faccia piana associati a schegge di tecnica levallois, è nel complesso di piccole dimen-sioni e ricorda l’industria musteriana proveniente dai dintorni di Selva dei Muli a Frosinone12 (I. B. – M. M.).
5. I resti faunistici
Come accennato, molti resti della fauna sono stati inglobati in matrici di gesso o resina per il trasporto e l’eventuale esposizione nel Museo di Cassino. Non essendo ancora iniziate le operazioni di consolida-mento e restauro, non è stato effettuato uno studio definitivo. In questa sede, in via preliminare, viene riportato un elenco sommario delle specie ricono-sciute determinate in corso di scavo, nei laboratori di Cassino e del Museo di Pofi.
Sono stati determinati:Elephas sp.: 4 frammenti di difesa, 8 frammenti di molare, 1 frammento di diafisi per un totale di 13 elementi provenienti da saggio a-A1, saggio a-B1,
10 Biddittu 1984.11 Giannetti 1974; Lena 1980.12 Biddittu – Celletti 2003, 86-89.
7 Costa 1864; Mochi 1912.8 D’Erasmo – De Lorenzo 1932.9 Sacchetti 1920.
500
ITALo BIDDITTU – ILENIA CARNEVALE – TERESA CoPPoLA – MARGhERITA MALoRGIo – EVA SACChI
15 Radicati di Brozolo et al. 1988.13 Devoto 1965.14 Settepassi – Verdel 1965.
Italo BIddIttu
Istituto Italiano di Paleontologia UmanaUniversità degli Studi di Cassino
IlenIa Carnevale
teresa Coppola
Sapienza - Università di [email protected]
MargherIta MalorgIo
eva saCChI
Sapienza - Università di [email protected]
rino” e l’evoluzione delle facies lacustri riconosciute da studi di geologia13 e malacologia14 rappresentano una premessa importante per ricerche future. Lo studio geologico dell’area della Folcara ha eviden-ziato la presenza di un livello di cineriti di cm 70 ca. sopra il livello archeologico, riferibile probabilmente a un’eruzione dell’apparato vulcanico di Roccamon-fina, con attività perdurata fino a circa 50.000 anni15. Lo studio della fauna, che si spera possa essere effet-tuato al più presto, potrà fornire indizi più precisi sul significato e la cronologia del sito.
Bibliografia
angeluCCI I.A. – FranCIonI G. – sIrna G. – MeneChInI D. – devoto G. – ZalaFFI M. – BergoMI C. – MangarellI V. 1962-65: Carta Geologica d’Italia, Foglio 160 Cassino, scala 1:100.000, Servizio Geologico d’Italia, Roma.BIddIttu I. – CassolI p. – MalpIerI L. 1967: “Stazione musteria-na in Valle Radice nel comune di Sora, Frosinone”, Quaternaria, 9, 321-348.BIddIttu I. – CassolI p. – segre a.g. 1984: Il bacino paleolacu-stre di Sora (Frosinone) e i suoi giacimenti musteriani (Atti della XXIV Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria), Firenze, 149-154.BIddIttu I. – CellettI P. 2003: Età della Pietra. Uomini ed ele-fanti nella Preistoria del Lazio meridionale, Ceprano.Costa o.g. 1864: “Relazione intorno agli ossami fossili di Cassi-no e della Melfa”, RendAccSFNap, 3, 5, 155-161.d’erasMo G. – de lorenZo G. 1932: “L’uomo paleolitico e l’Elephas antiquus nell’Italia meridionale”, RendAccSFNap, 2, 19 (5), 1-106.devoto G. 1965: “Lacustrine Pleistocene in the Lower Liri Val-
ley (Southern Latium)”, GR, 4, 291-368.Flores E. 1895: Catalogo mammiferi fossili. Italia meridionale, Atti dell’Accademia Pontaniana, 25, 18, Napoli.gIannettI A. 1974: “Insediamento preistorico e luoghi di culto nel settore di Santa Scolastica (tenimento di Villa S. Lucia, Cas-sino)”, RAL, 29, 87-93.gIannettI B. 1994: “Comments on Cole et al., 1992. I. The ex-tracaldera-Galluccio Tuff, Roccamonfina volcano, Italy”, Rend-Fis AccLincei, 9 (5), 125-133.lena G. 1980: Scoperte archeologiche nel Cassinate. Note di topo-grafia antica, Cassino.MoChI A. 1912: La succession des industries paléolitique et les changements de la faune du Pléistocène en Italie, Firenze.radICatI dI BroZolo F. – dI gIrolaMo p. – turI B. – oddone M. 1988: “40Ar-39Ar and K-Ar dating of K-rich rocks from the Roccamonfina Volcano, Roman comagmatic Region, Italy”, Geochimica et Cosmochimica Acta, V. 52, Issue 6, 1435-1441.saCChettI G. 1920: Storia geologica di Monte Cassino, Cava dei Tirreni.settepassI F. – verdel U. 1965: “Continental quaternary mol-lusca of lower Liri Valley (Southern Latium)”, GR, 4, 369-452.









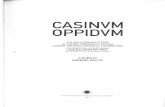






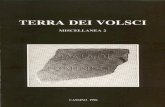


![[Quintiliano], Il ricco accusato di tradimento – Gli amici garanti (Declamazioni maggiori 11; 16), Cassino: Edizioni Università di Cassino 2014.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632670c2dff51a1950049504/quintiliano-il-ricco-accusato-di-tradimento-gli-amici-garanti-declamazioni.jpg)