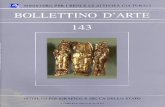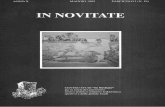A. La Marca, La tomba alla cappuccina di località Cannuzze, in A. Vanzetti, M. Cerzoso (a cura di),...
Transcript of A. La Marca, La tomba alla cappuccina di località Cannuzze, in A. Vanzetti, M. Cerzoso (a cura di),...
MU
SEO D
EI BR
ETT
II E DEG
LI ENO
TR
I
Ma c u r a d i
Maria Cerzoso e Alessandro Vanzetti
Rubbettino
Rubbettinoe 49,00
Museo civico dei Brettii e degli EnotriComplesso monumentale di S. AgostinoSalita S. Agostino - 87100 Cosenza - Tel. +39 (0984) 23303 - Fax +39 (0984) 22067www.museodeibrettiiedeglienotri.it - e-mail: [email protected]
Museo dei Brettii e degli EnotriCatalogo dell’esposizionea cura di Maria Cerzoso e Alessandro Vanzetti
Coordinamento redazionale, editing, impaginazione e progetto grafico a cura di Antonio VescioGrafica del logo a cura di Caterina Amendola
Stampato in Italia nel mese di giugno 2014 da Rubbettino print per conto di Rubbettino Editore srl 88049 Soveria Mannelli (Catanzaro) www.rubbettinoprint.it
ISBN 978-88-498-4233-3
© 2014 - Rubbettino Editore88049 Soveria Mannelli - Viale Rosario Rubbettino, 10 - Tel. +39 (0968) 6664201www. rubbettino.it
Progetto cofinanziato con fondi del POR Calabria FESR 2007/2013 L.I. 5.2.2.1
Unione
eUropea
repUbblica
italiana
regione
calabria
M U S E ODEI BRETTIIE DEGLI ENOTRI
C A T A L O G ODELL’ESPOSIZIONE
a c u r a d i
Maria Cerzoso e Alessandro Vanzetti
Rubbettino
V
CATALOGO DELL’ESPOSIZIONE
Indice
VII Presentazione, M. Occhiuto IX Premessa, S. Bonomi XI Nota dei curatori, M. Cerzoso, A. Vanzetti XV Autori delle schede e dei disegni XIX Referenze fotografiche XXI Abbreviazioni in catalogo e scala delle riproduzioni
Il Museo 1 Il Complesso monumentale di S. Agostino, C. Vulcano 5 La storia della collezione, M. Cerzoso, F. Quondam 17 L’allestimento per il Museo, A. Vanzetti, M. Cerzoso, A. Schiappelli 27 Il Museo dei Brettii e degli Enotri: valorizzazione di un territorio, valorizzazione di una città, S. Mancuso
Preistoria e protostoria 33 I reperti paleontologici, M.P. Bernasconi 35 Il Paleolitico antico e medio della Calabria, E. Spinapolice 41 La Calabria dal Neolitico all’età del ferro, V. Tiné, A. Vanzetti 45 L’età del ferro del Cosentino nelle collezioni del Museo, A. Vanzetti, F. Ferranti, F. Quondam 49 L’età del ferro nel territorio di Crotone, D. Marino
Torre del Mordillo 55 Torre del Mordillo: l’abitato, A. Schiappelli 61 Pregnanza archeologica della necropoli di Torre del Mordillo, A. Vanzetti 65 Caratteri della necropoli di Torre del Mordillo, A. Vanzetti con il contributo di F. Ferranti, F. Quondam 71 Le fibule, F. Quondam, F. Ferranti 77 L’armamento del guerriero in Calabria durante la prima età del ferro, nel quadro dell’Italia meridionale, S. Abbate 85 Il vasellame in ceramica depurata, F. Ferranti 91 Il vasellame in ceramica d’impasto, M.A. Castagna
97 Schede di catalogo 1-1104 287 Tavole 1-80
Età arcaica e classica 373 L’età arcaica, P.G. Guzzo 375 Francavilla Marittima, M.T. Granese 377 Cozzo Michelicchio, F. Quondam 381 Terrecotte architettoniche arcaiche da un santuario greco nel territorio di Sibari, G. Aversa 389 La necropoli in contrada Caccia di Favella, M. Cerzoso
395 Schede di catalogo 1105-1319 455 Tavole 81-88
VI
MUSEO DEI BRETTII E DEGLI ENOTRI
Età ellenistica e romana 469 I Brettii, P.G. Guzzo 471 Cosenza metropoli dei Brettii, S. Luppino, M. Cerzoso 473 Le necropoli brettie di Villanello e Moio, M. Cerzoso 479 I paesaggi dei Bruttii romani, A.B. Sangineto 483 Cosenza romana. Appunti per le ricerche future, A. D’Alessio 491 Le indagini archeologiche a Palazzo Pompeo Sersale, M. Cerzoso, A. Tosti 497 Le indagini archeologiche nell’ex Seminario Arcivescovile, A.B. Sangineto 503 Le indagini archeologiche a Piazzetta Toscano, S. Luppino, A. Tosti 509 Le indagini archeologiche a Via San Tommaso, A. Tosti 515 La tomba alla cappuccina di località Cannuzze, A. La Marca 519 Le lucerne di Cerchiara di Calabria, M. Cerzoso 527 Le iscrizioni in lingua latina, A. Zumbo
531 Schede di catalogo 1320-1668 603 Tavole 89-129
Le monete 649 Le monete, A. Polosa
651 Schede di catalogo M1-M300 669 Tavole 130-136
Bibliografia 681 Indice delle abbreviazioni bibliografiche 683 Bibliografia generale
XV
CATALOGO DELL’ESPOSIZIONE
Autori delle schede e dei disegni
Preistoria e protostoria
0001-0023 M.P. Bernasconi0024-0036 I. Fiore0037-0061 E. Spinapolice0062-0090 M.A. Castagna0091-0095 F. Ferranti0096-0163 F. Quondam0164-0166 M.A. Castagna0167-0168 F. Ferranti0169 M.A. Castagna0170-0202 F. Ferranti0203-0204 M.A. Castagna0205-0216 F. Ferranti0217-0255 M.A. Castagna0256-0274 F. Ferranti0275-0276 M.A. Castagna0277-0284 F. Ferranti0285-0286 M.A. Castagna0287-0308 F. Ferranti0309-0310 M.A. Castagna0311-0329 F. Quondam0330-0331 F. Ferranti0332 A. Vanzetti0333-0355 F. Ferranti0356-0419 M.A. Castagna0420-0422 F. Quondam0423 F. Ferranti0424-0443 F. Quondam0444 F. Ferranti0445-0449 F. Quondam0450 F. Ferranti0451-0453 F. Quondam0454-0455 M.A. Castagna
0456-0461 F. Quondam0462 F. Ferranti0463-0465 M. D’Andrea0466 F. Ferranti0467-0485 M. D’Andrea0486 F. Ferranti0487-0489 M. D’Andrea0490 F. Ferranti0491-0494 M. D’Andrea0495-0570 F. Ferranti0571-0830 M. D’Andrea0831-0832 F. Ferranti0833-0834 M. D’Andrea0835-0836 F. Ferranti0837-0846 M. D’Andrea0847 F. Ferranti0848-0854 M. D’Andrea0855-0856 F. Ferranti0857-0864 M. D’Andrea0865-0866 F. Ferranti0867-0872 M. D’Andrea0873-0875 F. Ferranti0876-0890 M. D’Andrea0891-0899 F. Ferranti0900-0948 M. D’Andrea0949-0950 F. Quondam0951-0985 F. Ferranti0986 F. Quondam0987-0989 F. Ferranti0990-1070 M.A. Castagna1071 A. Vanzetti1072-1079 M. D’Andrea1080-1104 M.A. Castagna
Età arcaica e classica
1105-1107 F. Quondam1108-1116 M.T. Granese1117-1131 F. Quondam1132-1176 M.T. Granese1177-1185 F. Quondam
1186-1201 M. Cerzoso1202-1270 F. Quondam1271-1286 M. Cerzoso1287-1300 G. Aversa1301-1302 A. D’Alessio1303-1318 M. Cerzoso1319 E. Spinapolice
Elenco degli autori per n. di scheda
XVI
MUSEO DEI BRETTII E DEGLI ENOTRI
Età ellenistica e romana
1320-1321 A. Tosti1322-1338 S. Mancuso1339-1358 A. Tosti1359-1364 A. Adamo1365-1396 S. Mancuso1397 A. D’Alessio1398 C. Loise1399-1410 C. Verrina1411 E. Spinapolice1412-1414 C. Loise1415-1445 C. Verrina1446-1450 C. Loise
1451-1468 C. Verrina1469-1475 C. Loise1476-1482 C. Verrina1483-1492 A. Tosti1493-1505 T. Cafaro1506 M. Cerzoso1507-1510 T. Cafaro1511 A. Adamo1512-1539 A. Tosti1540 A. Adamo1541-1543 A. La Marca1544-1565 T. Cafaro1566-1666 M. Cerzoso1667-1668 A. Zumbo
Le monete
M001-M300 A. Polosa
A. Adamo: 1359-1364, 1511, 1540.G. Aversa: 1287-1300.M.P. Bernasconi: 0001-0023.T. Cafaro: 1493-1505, 1507-1510, 1544-1565.M.A. Castagna: 0062-0090, 0164-0166, 0169, 0203-0204, 0217-0255, 0275-0276, 0285-0286, 0309-0310, 0356-0419, 0454-0455,
0990-1070, 1080-1104M. Cerzoso: 1186-1201, 1271-1286, 1303-1318, 1506, 1566-1666.A. D’Alessio: 1301-1302, 1397.M. D’Andrea: 0463-0465, 0467-0485, 0487-0489, 0491-0494, 0571-0830, 0833-0834, 0837-0846, 0848-0854, 0857-0864, 0867-
0872, 0876-0890, 0900-0948, 1072-1079.F. Ferranti: 0091-0095, 0167-0168, 0170-0202, 0205-0216, 0256-0274, 0277-0284, 0287-0308, 0330-0331, 0333-0355, 0423, 0444,
0450, 0462, 0466, 0486, 0490, 0495-0570, 0831-0832, 0835-0836, 0847, 0855-0856, 0865-0866, 0873-0875, 0891-0899, 0951-0985, 0987-0989.
I. Fiore: 0024-0036.M.T. Granese: 1108-1116, 1132-1176.A. La Marca: 1541-1543.C. Loise: 1398, 1412-1414, 1446-1450, 1469-1475.S. Mancuso: 1322-1338, 1365-1396.A. Polosa: M001-M300.F. Quondam: 0096-0163, 0311-0329, 0420-0422, 0424-0443, 0445-0449, 0451-0453, 0456-0461, 0949-0950, 0986, 1105-1107,
1117-1131, 1177-1185, 1202-1270.E. Spinapolice: 0037-0061, 1319, 1411.A. Tosti: 1320-1321, 1339-1358, 1483-1492, 1512-1539.A. Vanzetti: 0332, 1071.C. Verrina: 1399-1410, 1415-1445, 1451-1468, 1476-1482.A. Zumbo: 1667-1668.
Elenco alfabetico degli autori delle schede
515
ETÀ ELLENISTICA E ROMANA
La tomba alla cappuccina di località Cannuzze
A. La Marca
“Alle pendici del Colle Triglio – uno dei 7 che circondano Co-senza – sulla sponda destra del Crati, il contadino Arente Ro-sario nel marzo us. mise a luce accidentalmente una tomba
del periodo Ellenistico, giaceva alla profondità d’oltre un metro, formata dei soliti lastroni laterizi anepigrafi, foggiata alla cappuc-cina, simile alle altre moltissime scoperte lo scorso anno ai piedi delle colline Mojo sulla sinistra sponda del Crati, illustrate dal Prof. Scornajenchi. Il Colle Triglio e colline Mojo sono di fronte, e distano fra di loro qualche chilometro. Ciò avvalorerebbe l’ipotesi del Prof. Scornajenchi che cioè i 7 colli che circondano Cosenza fossero nei lontani evi, tutti abitati. La tomba – oltre a poche ossa umane andate disperse – conteneva: un’anfora diase alta cent. 17, di creta tendente al rosso, coverta di patina cinerea, di fattura as-sai scadente ma adorna di bassorilievi prodotti con stampi. Dalla base fino al collo si sviluppano tralci di vite con grappoli d’uva, fra i quali – da una parte – comparisce Bacco barbuto con capellatura
incolta, sostenente sulla destra un tirso, mentre l’antibraccio e la mano sinistra si adagiano sull’addome. Dal lato opposto è figu-rata una menade, nuda fino all’altezza delle ginocchia; la mano maestra è adagiata sul capo, e colla sinistra regge un lungo tirso. Conteneva ancora un grafeion o stilo bronzeo lungo cent. 16 della risaputa forma Greca e poi Romana. Conteneva infine un grosso vaso indistinto di fattura ancora più scadente, andato in frantu-mi. La tomba era orientata da Sud a Nord seguendo cioè il corso del fiume. Lo scopritore Arente portò i cimeli al posto delle GG Municipali, e fu così che venni a conoscenza del fatto. Ieri fui sul posto col proprietario del fondo: avv. Giacinto De Falco, Prof. Scornajenchi, Architetto Armentano e il Cav. Minicucci. Null’al-tro però mi fu dato constatare trovandosi la località in piena col-tura. I cimeli furono acquistati dal Comune e depositati nel Civico Museo. NB. Specillo auricolare, cilindretto eneo con coperchio, che forse conteneva un passito andato disperso”1.
1 Lettera del 17 giugno 1933, prot. n. 35, conservata presso l’Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria e in copia
presso l’Archivio del Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza. Sulla ne-cropoli di contrada Moio, vd. Galli, ScornajenGhi 1935, pp. 182-190.
Fig. 1. Carta Topografica d’Italia IGM, “Serie 25” (1:25.000), F. 559 sez. I (Rende). L’area in retino grigio indica la località Cannuzze.
516
MUSEO DEI BRETTII E DEGLI ENOTRI
È il testo di una lettera inviata al Soprintendente di Reggio Calabria il 17 giugno 1933 dall’Ispettore onorario, Cav. Giacinto d’Ippolito, Presidente della Commissione Provinciale Conservatrice dei Monumenti, dove appare chiaro il riferimento topografico di località Cannuzze, sita alle pendici settentrionali del colle Triglio, a nord-est di Cosenza, sulla destra idrografica del fiume Crati, presso la confluenza con il torrente Rovella (fig. 1), e dove il d’Ippolito descrive quanto venuto alla luce dalla scavo fortuito di una tomba del tipo alla cappuccina.
La sepoltura, parzialmente sconvolta, ha restituito solo una parte del corredo: un’anforetta di ceramica a matrice decorata a rilievo, un contenitore cilindrico e una sonda in bronzo, oltre ad un vaso frammentario in terracotta andato disperso. L’anforetta in terracotta – una pseudo-pelike (oinophóros)2 – presenta sulle due facce decorate a rilievo due figure stanti, attorniate da tralci di vite ricchi di grappoli d’uva. Da un lato troviamo Dioniso
nudo con un manto che scende lungo tutta la parte sinistra del corpo; nella mano sinistra regge un tirso, mentre il braccio de-stro è sollevato sul capo in atteggiamento di riposo e/o di eb-brezza (fig. 2). Sull’altra faccia vi è un Papposileno, reso di pro-filo verso sinistra, ammantato fino ai piedi, con timpano nella mano sinistra e tirso nella mano destra3 (fig. 3).
Il pezzo, benché decorato, non sembra particolarmente pre-giato sia per lo stampo irregolare che per la lavorazione affret-tata, che ha reso le giunzioni delle due valve del vaso molto evi-denti; infatti la lisciatura a stecca che nasconde i punti di sutura ha levigato in parte alcuni motivi floreali della decorazione. La forma sembra derivare da prototipi in vetro, bronzo e argen-to della prima età imperiale romana, ma trova precisi riscontri soprattutto negli esemplari in ceramica invetriata, prodotti in Asia Minore in epoca tardo ellenistica, che presentano anche analoghi motivi figurati a rilievo.
2 Cat. n. 1541.3 Dioniso e Papposileno sono raffigurati su un vaso di questo tipo con-
servato al museo di Atene (cfr. hauSmann 1954-1955, pp. 137-138, tav.
XLIV, 1) e su esemplari analoghi da Aquileia (BruSin 1960, p. 123, figg. 1a-1b). Sulla diffusione dell’iconografia dionisiaca nell’arte antica vd. Ve-neri, GaSparri 1986, pp. 414-514; GaSparri 1986, pp. 540-566.
Fig. 2. Pseudo-pelike (oinophóros) a matrice decorata a rilievo, lato A. Fig. 3. Pseudo-pelike (oinophóros) a matrice decorata a rilievo, lato B.
517
ETÀ ELLENISTICA E ROMANA
A causa della sua modesta diffusione, questa tipologia è stata poco studiata ed è poco conosciuta4. I tralci con le larghe foglie e i grappoli d’uva, che riempiono tutti gli spazi di risulta, costi-tuiscono il motivo più frequente nella produzione di Cnido5, ambito cui ci riportano tanto la tecnica di fabbricazione di questi manufatti, quanto le caratteristiche dell’impasto e della vernice, proprie dei vasi tipo oinophóros fabbricati in questo importante centro dell’Asia Minore, dove la decorazione con soggetti ed episodi del ciclo di Dioniso è una tematica che ricor-re assai frequentemente sulle ceramiche in età ellenistica6.
Tale iconografia, piuttosto nota, continua con poche varia-zioni in età romano-imperiale7. La Reliefkeramik, la serie di vasi a matrice fabbricati a Cnido, è stata in passato definita da alcu-ni studiosi col termine di Oinophorengruppe8. Si tratta di una produzione seriale, che privilegia la quantità più che la qualità dei manufatti9, e che viene generalmente datata tra la fine del I e il III secolo d.C. È tuttavia probabile che alcune forme siano leggermente più antiche10.
La diffusione di questi vasi a rilievo di Cnido, tra il II e il III secolo d.C.11, si concentra maggiormente nell’area del
Mediterraneo orientale e con più sporadiche presenze nelle re-gioni costiere nordafricane e del Mar Nero, lungo la frontiera danubiana e nel sud della Russia12. Pochissimi sono gli esempla-ri ritrovati in Italia. Abbiamo testimonianze di rinvenimenti ad Aquileia, Taranto, Siracusa, Roma e Pompei e appunto Cosenza; a queste rarissime attestazioni si può aggiungere l’oinophóros frammentario proveniente da uno scavo condotto all’interno dell’Università Cattolica a Milano13.
Anche se il vaso a rilievo di Cosenza resta un esempio raro della presenza di questa tipologia di manufatti in Italia meridio-nale14, il suo rinvenimento è un’ulteriore attestazione della cir-colazione ad ampio raggio di tali prodotti anche in Occidente, e rappresenta comunque un contributo alla conoscenza della vasta rete di scambi e di relazioni che dall’Asia Minore15 rag-giunsero in età romano-imperiale l’Italia meridionale.
Difficile rimane comunque la datazione di questo tipo di an-forette dato il loro ampio spazio temporale (fine I-III sec. d.C.); i criteri di datazione infatti, in mancanza di sicuri contesti di scavo, si basano su generici confronti stilistici riferibili alle prin-cipali opere della scultura romana anche ufficiale16.
4 hochuli-GySel 1977; heimBerG 1976, p. 252, C22, C23.5 Baldoni 2003, p. 20.6 La Mandel dedica un capitolo alle origini ellenistiche di questo parti-
colare tipo di ceramica (cfr. mandel 1988, p. 25); in questa fase si creano i modelli per l’età romana. Cfr. anche Baldoni 2003, p. 20.
7 KüBler 1928, p. 111, fig. 6. 8 Sulla tecnica di fabbricazione della Reliefkeramik si veda: Bailey
1972-1973, pp. 11-12 e Baldoni 2003, pp. 1-2. Si tratta di un gruppo ceramico prodotto a Cnido in Asia Minore, che comprende prevalente-mente una serie di forme chiuse. A parte l’edizione di esemplari isolati, una prima raccolta di forme appartenenti a questa produzione si deve a Silvio Ferri (Ferri 1933-1934, p. 30, tav. XIV, 8-9); fu tuttavia U. Hau-smann (hauSmann 1954-1955, pp. 125-144) che diede una prima siste-mazione e articolazione tipologica a questa classe ceramica. La decora-zione (con motivi vegetali, soggetti mitologici, erotici, ecc.) era esegui-ta mediante l’unione di due parti ottenute da matrici bivalve (probabil-mente in gesso), decorate a rilievo. Hayes (hayeS 1972, p. 411) così de-scrive le caratteristiche di questa produzione: “a hard fine-grained orange grey clay containing some lime and a little golden mica, with a thin metal-lic varnish-like slip”. Alcuni esemplari di forme chiuse presentano tracce di un’ingobbiatura giallastra: TorTorici 1981, pp. 233-235; KüBler 1928, p. 111, fig. 6.
9 Una solida base per la ricerca su questi aspetti particolari dell’artigia-nato microasiatico è rappresentata dal lavoro di Ursula Mandel, che ha pubblicato un gruppo di manufatti provenienti da Cnido. A questo cen-tro, a sud della costa egea dell’Asia Minore, la Mandel riferisce la produ-zione di vasi a rilievo tipo oinophóros (mandel 1988, p. 100 ss.), sulla ba-se delle osservazioni del Bailey (Bailey 1972-1973, pp. 11-25) che li col-legava alle officine delle lucerne tipo Romanesis attestate a Cnido (hereS 1968, pp. 185-211). Sulla forma del vaso, peculiare della produzione cni-dia, si veda Baldoni 2003, p. 7, fig. III, 2; heimBerG 1976, pp. 265, 287; TorTorici 1981, pp. 233-235. Sull’area di diffusione dei vasi a matrice di
Cnido: Baldoni 2003, p. 4, fig. 1; d’andria 1995, pp. 420-421.10 Sulla datazione della bottega cnidia: mandel 2000, pp. 57-68. Il lavo-
ro della Mandel rimane ancora oggi fondamentale per le ricerche su que-sti particolari manufatti dell’artigianato microasiatico.
11 Il vaso cosentino corrisponde alla forma presente in hauSmann 1954-1955, tav. XLIV, 1 ed in TorTorici 1981, pp. 233-235; d’andria 1995, p. 420: “[…] l’analisi di questi oggetti è prevalentemente storico-artistica, a volte con pletorici riferimenti alle principali opere della scultura romana an-che ufficiali: sui confronti stilistici con queste sculture si basano inoltre i cri-teri di datazione dei singoli vasi, mentre piuttosto in ombra resta lo studio archeologico di oggetti in cui i modelli iconografici e stilistici dell’arte aulica sono adattati dagli artigiani alle esigenze della produzione di serie e perfino di alcuni reperti significativi per lo studio delle officine, come i frammenti a matrice”. Per un inquadramento cronologico e tipologico della classe si veda hauSmann 1954-1955, pp. 125-144.
12 d’andria 1995, pp. 420-421: “[…] dal Mar Nero provengono 16 esem-plari, dall’Egitto 62 esemplari; altri 4 sono segnalati ad Aleppo. In Grecia abbiamo 27 esemplari; 9 esemplari nell’area nord africana […] un esempla-re a Malta”. Frammenti di oinophóroi di ceramica microasiatica medio-imperiale a stampo di fabbrica pergamena sono stati ritrovati nello scavo della terma romana a Kyme eolica (ScaTozza hörichT 2007, p. 110) e a Sagalassos (laFli 2004, pp. 125-135) in Turchia.
13 d’andria 1995, pp. 421-422. 14 L’oinophóros di Cosenza rimane ancora oggi l’unico esempio di que-
sto tipo di manufatto attestato in Calabria (paoleTTi 1994, p. 485). Si ve-da ancora: Guzzo 1979, p. 26, fig. 3 a-b-c; zumBini 1988, p. 63; Guida Museo 2009, p. 74.
15 La Turchia, per l’importanza dei suoi siti e per l’intensa attività inter-nazionale in campo archeologico, rappresenta sicuramente una fonte ine-sauribile di conoscenza sull’antichità, a partire dalle fasi più arcaiche per arrivare al periodo tardo antico e bizantino.
16 d’andria 1995, p. 418.
518
MUSEO DEI BRETTII E DEGLI ENOTRI
Assieme all’oinophóros, nella tomba di località Cannuzze, sono stati rinvenuti un vaso frammentario andato disperso e due oggetti in bronzo: una sonda a cucchiaio17 (cyathiscomela), e un astuccio-contenitore cilindrico18 (theca vulnerarea) a lamina sot-tile con coperchietto (figg. 4-5). La sonda, con corpo a sezione circolare e superficie liscia, è caratterizzata da un’estremità a nocciolo di oliva contrapposta all’altra estremità a forma di cuc-chiaino allungato19. Le sonde, prodotte in varie forme poiché innumerevoli erano le loro possibilità di impiego20, venivano custodite in astucci cilindrici metallici (specilloteche) adeguati alle loro dimensioni medie (17-20 cm)21.
L’astuccio-contenitore di Cannuzze, lungo solo 9,2 cm, pro-babilmente doveva servire come contenitore per aghi, che erano in osso e avorio, oltre che in bronzo e in acciaio22, e venivano utilizzati per le suture chirurgiche di ferite. L’astuccio trova un confronto preciso con quello proveniente dalla tomba detta “del chirurgo” scoperta in località San Vito di Luzzi23, dove è stato rinvenuto un completo corredo di strumenti medici24.
Il contesto di rinvenimento, purtroppo, non ci aiuta molto, anche perché gli altri oggetti trovati nella tomba non forniscono comunque una datazione più precisa, datandosi generalmente gli strumenti medici in un ampio arco temporale.
17 Cat. n. 1542.18 Cat. n. 1543.19 Sono veramente rari gli strumenti chirurgici provenienti da contesti
tombali. Per un elenco completo di distribuzione dei ritrovamenti di que-sto tipo di corredo in Italia cfr. paoleTTi 2002, p. 88 (con bibliografia sul-la medicina romana e gli strumenti chirurgici). Per la Calabria si segnala-no gli strumenti provenienti dalla necropoli di San Vito di Luzzi (Guzzo 1974, pp. 469-478, figg. 32, 35-36; Künzl 1996, p. 2574 s.v. Luzzi; pao-leTTi 2002, p. 88, fig. 29-31, 39), ai quali si può aggiungere il corredo ‘da Sibari’ (carBonelli 1904-1905, pp. 427-429 e tav.; di VaSTo 1983, p. 16; di VaSTo 1995, pp. 181-183) e il frammento di bisturi ageminato in ar-gento ritrovato assieme a due pinzette nel 1983 a Malvito (laTTanzi 1984, p. 13). Da segnalare ancora un cucchiaio e una spatola in bronzo, parte di un corredo funerario, forse da un contesto ellenistico rinvenuto a Cac-cia di Favella, nel comune di Corigliano Calabro (Quilici eT al. 1969, p. 139, n. 654, tav. XXXVII, b, c).
20 In genere le sonde, strumenti di uso più frequenti del medico chirur-go, potevano essere anche rivestite di oro o di argento. Il principio del-le sonde, o specilli, è fondamentalmente esplorativo, ma se si incontra un ostacolo estraneo non si disdegna il suo uso per pungere le cisti liquide o svuotare gli ascessi, far drenare gli umori aprendo le fistole. Possiamo di-
stinguere spatole a linguetta e spatole “a pala di remo”, in cui l’estremità opposta al nocciolo di oliva è costituita da una lamina lunga e piatta. Una volta praticato il taglio con il bisturi, la spatola veniva usata per divarica-re i bordi di una ferita, oppure isolare una vena dai tessuti senza danneg-giarla. Cfr. KruG 1980, p. 82, fig. 19, pp. 97, 99, fig. 37a.
21 KruG 1980, p. 83, fig. 19. Il materiale del chirurgo, in genere, era qua-si sempre in bronzo o in rame, quando non era necessario un materiale più duro come il ferro per gli strumenti che servivano per interventi su-gli arti e sul cranio.
22 VolTerrani 2002, p. 38.23 L’astuccio-contenitore di Luzzi, della stessa lunghezza di quello di
Cannuzze, riserva però all’inserzione del coperchio (di cui è privo) solo un terzo del cilindro. Cfr. Guzzo 1974, p. 469, fig. 32,89; 35; p. 480; KruG 1980, p. 82, fig. 19; p. 97; paoleTTi 2002, p. 88.
24 La necropoli di San Vito di Luzzi è stata datata dalla seconda metà del I alla metà del II secolo d.C. (Guzzo 1974, p. 483), ma per gli stru-menti chirurgici rinvenuti nella tomba 17 non possiamo indicare “un ter-mine post quem di fabbricazione nell’incapacità di fissare la lunghezza del periodo d’uso” (Guzzo 1974, p. 480). Per l’archeologia del territorio di Luzzi e della media valle del Crati si vedano da ultimi: la marca 2002a e 2011.
Fig. 4. Sonda a cucchiaio (cyathiscomela).
Fig. 5. Astuccio-contenitore cilindrico (theca vulnerarea).
574
MUSEO DEI BRETTII E DEGLI ENOTRI
Ago a sez. circolare, rastremato verso l’estremità sup.; testa ar-rotondata legg. oblunga con leggere rigature verticali. Lacuno-so in punta.II - VI d.C.Ampiamente attestato in contesti di età tardo-imperiale.Cfr.: Ostia 1978, p. 154, fig. 149.30 e p. 163, fig. 156.70; Arthur 1994, p. 365, fig. 157.20-21; MercAndo et Al. 1982, p. 222, fig. 93, T88, nn. 2-5; di MArio 2007, p. 142, fig. 50.
1539. Ago da cucito in ossoCosenza, via San Tommaso, scavi 2003Inv. 147028. Sala 9, vetrina 25Osso levigatoLacunoso. Lungh. 8,4; diam. max 0,6; diam. min. 0,4; diam. fori 0,15Cruna costituita da due fori circolari contigui; estremità sup. appuntita; sez. ovale. Lacunoso nella punta.Seconda metà del II - inizi del III sec. d.C.Ampiamente attestato in contesti di età tardo-imperiale.Cfr.: Ostia ii, p. 46, tav. 10, 65 a-b; cArAndini 1977, p. 393, tav. 59, fig. 475; cArAndini, ricci 1985, p. 70, tav. 18, 4-6 in partico-lare 5; Ostia 1978, p. 123, fig 122, 401 e p. 163, fig. 156.71.
Cosenza, Duomo
Ceramica a vernice nera
1540. Pisside a vernice neraCosenza, Duomo Inv. 3138 (IM); 71538 (IG); 882 (IP). Sala 9, vetrina 23Argilla colore 2.5YR 6/4, tornita; vernice colore GLEY 1 2.5/NLacunosa. H 5, diam. orlo 8, diam. piede 6Vasca cilindrica con pareti a profilo concavo che terminano con orlo nettamente svasato; fondo piatto; raccordo piede-parete curvo; piede distinto ad anello svasato con fondo ombelicato. Superficie int. ed est. a vernice lucida e compatta.II - I sec. a.C.Non è stato individuato un confronto preciso per questo esem-plare, sebbene sembri assimilabile alle pissidi del genere Morel 7500 (Morel 1981, pp. 409-415, pll. 204-206), dalle quali diffe-risce per il piede alto e svasato, più stretto della vasca e distinto da essa.
Cosenza, loc. Cannuzze
1541. Pseudo-pelike (oinophóros)Cosenza, loc. CannuzzeInv. 3151 (IM); 71551 (IG); 706 (IP). Sala 9, vetrina 25Argilla colore 10R 6/8 dura, compatta, a grana fine, ricoperta da ingobbiatura e sottile vernice, con inclusi micacei di piccolissi-me dim., rari granuli bianchi e neri e piccoli vacuoli. Realizzata
a stampo con doppia valva.Integro. H 17,3; largh. 10,2; diam. 6,3; spess. 0,5Anforetta a corpo ovoide, su piede ad anello legg. svasato e non perfettamente piatto; labbro a colletto con orlo piano irregolare distinto alla base da due sottili solcature parallele, sotto le quali si impostano le anse verticali a bastoncello, che presentano dim. diverse e sui bordi un tratto inciso; collo a profilo continuo. Sulle due facce del vaso campeggiano due figure stanti, attor-niate da rigogliosi tralci di viti caratterizzati da ampie foglie, che costituiscono vivaci riempitivi. La decorazione da un lato presenta Dioniso frontale: il corpo nudo evidenzia i pettorali e i genitali e poggia sulla gamba de-stra tesa, mentre quella sinistra è legg. flessa; un manto ricade dalla spalla sinistra e ricopre soltanto la parte inf. delle gambe; il volto tondo è coronato da grappoli d’uva, poggianti sopra i capelli spartiti sulla fronte che scendono sopra le spalle; nella mano sinistra regge un tirso, mentre il braccio destro è sollevato sul capo secondo un’iconografia che riproduce l’atteggiamento del riposo e/o dell’ebbrezza.Sull’altra faccia vi è un Papposileno dai tratti grotteschi, reso di profilo verso sinistra, ammantato fino ai piedi, con timpano nella mano sinistra e tirso nella mano destra.I tralci con larghe foglie e i grappoli carichi d’uva, che riempio-no tutti gli spazi di risulta della pelike, costituiscono uno dei motivi più frequenti nella produzione di Cnido (Asia Minore), ambito cui ci riporta tanto la forma del vaso, quanto la tecnica di fabbricazione e la caratteristica dell’impasto e della vernice.La produzione di ceramica a matrice decorata a rilievo di Cnido si colloca tra il 60 d.C. circa e gli inizi del IV sec. d.C.Il pezzo, benché decorato, non appare particolarmente pregiato sia per lo stampo irregolare che per la poca cura nella lisciatura a stecca della giunzione delle due valve; anche all’int. si vedono i segni della spatolatura.Bibliografia: GAlli 1934-1935, pp. 46-48, figg. 1-2; Guzzo 1979, p. 26, fig. 3, a-b-c; zuMbini 1988, p. 63; PAoletti 1994, p. 485, fig. 16.Cfr.: Kübler 1928, p. 111, fig. 6; Ferri 1933-1934, pp. 16-32, tavv. I-XVI; GAlli 1934-1935, pp. 46-48; bonis 1952, p. 25, 10, tav. III, 1 a-b; hAusMAnn 1954-1955, pp. 137-138, tav. XLIV, 1; brusin 1960, p. 123, figg. 1a-1b; heres 1968, pp. 185-211; hAyes 1972, pp. 9-96; bAiley 1972-1973, pp. 11-25; heiMberG 1976, pp. 251-290; tortorici 1981, pp. 234, tavv. cXX, 1; cl-XiV, 2; MAndel 1988, tav. 27; MAndel 2000, pp. 57-68; bAldo-ni 2003, p. 10, con bibl.
1542. Sonda o specillo a cucchiaio allungato in bronzoCosenza, loc. CannuzzeInv. 3149 (IM); 71549 (IG); 707 (IP). Sala 9, vetrina 25Bronzo fusoIntegra, con patina chiara. Lungh. 16,4; largh. 0,6; spess. 0,2; peso 8Sonda con lungo stelo a sez. circolare a superficie liscia; presen-
575
ETÀ ELLENISTICA E ROMANA
ta un piccolo ingrossamento ‘ad oliva’ ad una estremità, l’altra invece termina a forma di cucchiaino allungato diviso dallo ste-lo da una serie di sei dischetti aggettanti.I - II sec. d.C.Cfr.: cArbonelli 1904-1905, pp. 427-429; Quilici et Al. 1969, p. 139, n. 654, tav. XXXVII, b, c; Guzzo 1974, pp. 469-478, figg. 32, 35-36; di VAsto 1983, p. 16; lAttAnzi 1984, p. 13; KruG 1980, p. 82, fig. 19; 97, 99, fig. 37a; di VAsto 1995, pp. 181-183; Künzl 1996, pp. 2433-2639, 2574; PAoletti 2002, p. 88, figg. 29-31, 39.
1543. Astuccio-contenitore cilindrico in bronzoCosenza, loc. CannuzzeInv. 3150 (IM); 71550 (IG); 707 (IP). Sala 9, vetrina 25Bronzo fuso laminatoIntegro. Lungh. 9,2; diam. 1,3; spess. 0,2; peso 11Contenitore cilindrico (theca vulnerarea) in sottile lamina bron-zea a superficie liscia con circa metà della lunghezza a diam. ridotto per l’inserzione del coperchio, che è contrassegnato da incisioni a bande orizzontali ai due estremi.I - II sec. d.C.Cfr.: KruG 1980, p. 82, fig. 1. Un contenitore (privo di coper-chio) trovato in una tomba di loc. San Vito nel comune Luzzi (CS), facente parte di un corredo chirurgico, presenta la stessa lunghezza, ma all’inserzione per il coperchio è riservato solo un terzo del cilindro: Guzzo 1974, p. 469, figg. 32-35, inv. 89; PAoletti 2002, p. 88.
* * *
Il territorio di Cosenza in età romana
I reperti di seguito in catalogo, raccolti prevalentemente tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso da Giacinto d’Ippo-lito, ad eccezione di quelli provenienti da Torre del Mordillo già presenti nella collezione del Museo, pur mancando dei dati specifici di rinvenimento, sono una piccola testimonianza del-la realtà storico-archeologica dell’attuale provincia di Cosenza in età romana e ne hanno costituito, per molto tempo e prima delle più recenti e sistematiche indagini archeologiche, l’uni-ca documentazione. Alcuni di essi, come il vasetto in vetro e i frammenti marmorei da Scalea (cat. 1550-1555), rappresentano la prima attestazione della presenza di un insediamento di età imperiale in loc. Fischia, oggetto di rinvenimenti successivi (Pe-sce 1936; Guzzo 1975b) e dove si vuole fosse ubicato l’antico abitato di Lavinium (Greco, lA torre 1999, p. 27).
Torre del Mordillo (Spezzano Albanese, CS)
Terra sigillata italica
1544. Coppa su piede in terra sigillata italica
Torre del Mordillo (Spezzano Albanese, CS) Inv. 2815 (IM); 71215 (IG). Sala 10, vetrina 26Argilla colore 5YR 7/6, tornita; vernice colore 10R 6/8Frammentaria. H. 4; diam. 16Coppa su piede ad anello con parete inclinata verso l’est. Si conserva l’orlo con la parete.Seconda metà del I - II sec. d.C.Sul frammento è riportato un vecchio inv. 359 non registrato nella Schedatura 1995 e che nei Cataloghi d’Ippolito non corri-sponde all’oggetto.Cfr.: atlante I , tav. CXXIV, 10.
1545. Coppa su piede in terra sigillata italicaTorre del Mordillo (Spezzano Albanese, CS) Inv. 2816 (IM); 71216 (IG). Sala 10, vetrina 26Argilla colore 5YR 6/6, tornita; vernice colore 10R 4/8Frammentaria. H 2,7; diam. 12Coppa su piede ad anello caratterizzata da un listello piuttosto alto e sporgente sulla parete est. Nella fascia est., tra orlo e li-stello, è presente una decorazione applicata. Si conserva l’orlo e la parete con la decorazione applicata.Seconda metà del I - II sec. d.C.Sul frammento è riportato un vecchio inv. 368 non registrato nella Schedatura 1995 e che nei Cataloghi d’Ippolito non corri-sponde all’oggetto.Cfr. : atlante II, tav. CXXXI, 15.
1546. Piede ad anello in terra sigillata italicaTorre del Mordillo (Spezzano Albanese, CS) Inv. 2676 (IM); 71076 (IG); 564 (IP). Sala 10, vetrina 26Argilla colore 2.5YR, tornita; vernice colore 10R 3/6Frammentario. H 2,5; diam. 7Piede ad anello. Si conserva esclusivamente il fondo. Sul fondo, delimitato da due cerchi, è presente un bollo in cartiglio circo-lare con lettere capitali: LRTAIPrima metà del I - II sec. d.C. Erroneamente registrato nei Cataloghi d’Ippolito 1942 e 1945 come proveniente da Cozzo Michelicchio, errore che si ripete nelle Schedatura 1995; è invece da attribuire a Torre del Mor-dillo dove fu ritrovato il 14 marzo 1888 (GdO 3).Bibliografia: PAce 2005, p. 676 (attribuito a Cozzo Michelic-chio).
Figline Vegliaturo (CS)
Terra sigillata africana
1547. Coppa con orlo a mandorla (Lamboglia I)Figline Vegliaturo (CS)Inv. 3327 (IM); 71727 (IG); 892 (IP). Sala 10, vetrina 26Argilla colore 2.5YR 6/6, tornita; vernice colore 2.5YR 6/8 Integra. H 6; diam. orlo 18,5; diam. piede 11






















![[rec. a] Alvise Andreose, La strada, la Cina, il cielo. Studi sulla «Relatio» di Odorico da Pordenone e sulla sua fortuna romanza, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2012](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6339de7a2e67deabc605800d/rec-a-alvise-andreose-la-strada-la-cina-il-cielo-studi-sulla-relatio.jpg)