Atlante delle fondazioni florensi, vol. I, a cura di P. Lopetrone, Soveria Mannelli, Rubbettino,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Atlante delle fondazioni florensi, vol. I, a cura di P. Lopetrone, Soveria Mannelli, Rubbettino,...
203
1. Il primo sviluppo di Fiore
1.a. La crescita del patrimonio monastico«In nomine sancte et indiuidue Trinitatis. Hen-
ricus sextus diuina fauente clementia Romanorum imperator et semper augustus. […] nos ad preces Ioachim venerabilis abbatis de Flore […] monas-terio sancti Iohannis de Flore, quod ipse de nouo fundauerat in tenimento Sile, de munificentia nostra concedimus et donamus terras laboratorias, siluas et aquas adiacentes ipsi monasterio»1.
Con queste solenni parole si apre il primo do-cumento superstite della documentazione del mo-nastero di Fiore, che ormai - siamo nell’ottobre del 1194 - si presentava al massimo detentore del pote-re politico del tempo come “abbazia”: l’imperatore Enrico VI infatti si rivolse al fondatore Gioacchino chiamandolo “venerabile abate”. Evidentemente, nel lasso di tempo compreso tra l’estate del 1189 - quan-do l’allora abate di Corazzo si era stabilito con pochi compagni nella località silana oggi detta “Fiore Vete-re” - e la data del privilegio imperiale, la fondazione di Gioacchino aveva superato la timida e sperimen-tale fase del tugurium2 (così lo chiamò un anonimo biografo, secondo una terminologia cara alla tradi-zione eremitica), per accogliere invece la più conso-lidata organizzazione cenobitica. Il sostegno dell’im-peratore tedesco, che assume i concreti contorni di una vastissima donazione di terre demaniali, boschi e acque, esenzioni di diverso genere e concessione di
CapItOlO prImO
FIOrE E la NaSCIta dEl NuOvO ordo (1191-1202)
diritti e redditi, confermava l’indirizzo di vita per cui Gioacchino, nel 1194, aveva chiaramente optato: non più un eremitismo povero e precario, capace di riproporre i valori essenziali che i monaci cistercensi in quei decenni rievocavano come ideali ormai da tempo perduti, ma piuttosto un cenobitismo econo-micamente più tradizionale, fondato com’era su di una vasta proprietà terriera, sull’esercizio di una serie di diritti e il godimento di diversi redditi, che garan-tivano un’esistenza al riparo dalle alterne vicende del tempo, durata e stabilità3.
Il ricordo - e il rimpianto - della fase eremitica non sfumò tuttavia immediatamente. Sopravvisse con toni vivaci nelle parole con cui l’anonimo agio-grafo di Gioacchino, autore di una Vita beati Ioa-chimi abbatis, descrisse il periodo fondativo di Fio-re4. Era in particolare nella descrizione dell’incontro tra l’abate e re Tancredi che l’Anonimo precisava gli ideali che avevano guidato Gioacchino nell’ascesa in Sila: un piccolo e povero “gregge” di compagni, la ricerca del deserto e del distacco dal mondo, la cella e la sobrietà5. Anche la donazione di terra demaniale ottenuta, sembra, in quell’occasione - valutabile in estensione come circa un quarto rispetto alla tenuta offerta da Enrico VI - confermava la volontà di per-seguire, in questo primo periodo, tali ideali di vita. Il documento che comprova una donazione da parte di
204
Tancredi non è giunto fino a noi; ne possediamo tut-tavia alcune notizie indirette: fu conservato nell’ar-chivio florense fino al XVIII secolo (compare infatti nell’Indice fatto trascrivere da Nicola Venusio6); era noto anche a Domenico Martire, uno dei biografi di Gioacchino, il quale ci informa che il documento prevedeva anche alcune donazioni in natura («Gli fe’ bensì il Re una certa donazione di some cinquanta annuali di grano, e di 300 pecore per sostentamento perpetuo dei monaci, e fecegliene spedire il privile-gio sotto l’anno 1190»7). Ma è soprattutto dai regi-stri di papa Innocenzo III che apprendiamo che Tan-credi nell’inverno 1190-1191 donò effettivamente a Gioacchino anche alcuni terreni demaniali8: all’in-terno della fitta corrispondenza tra la curia pontificia e l’arcidiocesi di Cosenza in merito a una contesa insorta tra il capitolo cosentino e il monastero di Fiore, il pontefice riportava anche quella che pro-babilmente era la precisa confinazione della prima donazione del regnante normanno a favore di Fiore. Si trattava di un territorio montano e boschivo, non particolarmente esteso, delimitato da alcuni corsi d’acqua (Argentino - ora Frappa II -, Cassandrella, Garga e Neto) e da strade pubbliche9, forse neppure contiguo al sito in cui Gioacchino e i suoi seguaci si stabilirono, ossia al locum Floris. Quest’ultima lo-calità, che anche la documentazione successiva pre-senta come diversa e distinta dalle donazioni regia e imperiale, era posta alla confluenza dell’Arvo e del torrente Pino Bucato, a più di 1000 metri di altitu-dine, in un luogo in cui i recenti scavi archeologici hanno portato alla luce i resti della primitiva chiesa florense. Il locum Floris era probabilmente compreso tra i terreni di proprietà, o comunque messi in pre-cedenza a disposizione del monastero cistercense di Corazzo, di cui Gioacchino nel primo periodo silano era ancora ufficialmente l’abate10.
Possiamo dunque definire nei tratti principali l’evoluzione dell’entità dei possedimenti di Fiore in questo primo periodo: dall’iniziale base, circoscritta al locum Floris, in cui si insediarono Gioacchino e i suoi discepoli nell’estate 1189, ad un primo amplia-mento grazie alla donazione di re Tancredi nell’inver-no 1190-1191, alla vastissima porzione di demanio regio concessa dall’imperatore tedesco nell’ottobre del 1194.
Qualche mese più tardi Enrico VI, nuovamente di passaggio per la Calabria, da San Mauro diresse a tutti i suoi fideles una lettera; con essa dava notizia di aver concesso a Gioacchino, pro redemptione animae, un consistente reddito di cinquanta bisanti d’oro, che i monaci avrebbero ricevuto annualmente dal-le entrate delle saline del Neto11. Con il precedente
diploma, l’entrata proveniente dalle saline calabresi era stata più generica e solo in natura: «damus etiam predicto monasterio liberam potestatem salem per salinas Calabrie accipiendi»12. Il reddito di cinquan-ta bisanti d’oro concesso dall’imperatore nel 1195 sembra sostituire le cinquanta some di segale offerte pochi anni prima da re Tancredi, non più confer-mate dal diploma di Enrico e che forse Gioacchino aveva rivendicato come dovute di fronte a Enrico13.
All’ingente entrata di denaro nelle casse del mo-nastero si aggiunse ben presto la somma che Gioac-chino, a partire dal 1195, contava di ricevere dai monaci greci del vicino monastero dedicato ai Tre Fanciulli quale annuale pagamento per l’uso di terre-ni e pascoli, dopo un accordo maturato con loro nel tentativo di appianare le tensioni createsi a seguito della donazione imperiale del 1194. Cosa era dun-que successo?
Tra l’aprile e il maggio del 1195, Isaia, abate del cenobio dei Tre Fanciulli, si era presentato all’im-peratrice Costanza (la moglie normanna di Enrico VI), di passaggio per Sant’Eufemia durante il viag-gio che l’avrebbe portata, con il neonato Federico, in Sicilia. Isaia intendeva esporre all’imperatrice i problemi sorti con la comunità di Fiore a seguito della donazione del marito: Enrico aveva infatti con-cesso a Gioacchino anche alcuni terreni ritenuti in realtà di competenza del monastero greco14. L’impe-ratrice avrebbe incaricato allora i suoi funzionari di compiere un’indagine per chiarire la situazione. Nei pressi di Rocca di Niceforo Gioacchino in persona raggiunse la corte di Costanza, per produrre i pro-pri documenti, finché, a Nicotera, i monaci dei Tre Fanciulli ammisero di non avere alcun privilegio che potesse comprovare i loro diritti sui terreni, sui quali in effetti vantavano solo usi consuetudinari. La curia imperiale emise pertanto una sentenza, con cui le terre in questione furono definitivamente assegnate a Fiore15.
In un primo tempo, dopo la sentenza, Gioac-chino si fece promotore di un accordo in grado di salvaguardare comunque la pacifica convivenza: egli avrebbe lasciato che i monaci greci mantenessero al-cuni ovili e pascoli per vacche, cavalli e maiali nei terreni del monastero di Fiore, dietro il pagamento annuo di quattro soldi d’oro; si giunse anche a uno scambio di terre, in base al quale il cenobio di Fio-re avrebbe potuto tenere liberamente, mantenendo ogni diritto sulla coltivazione e sulla costruzione, le terre donate da Enrico, che tuttavia nel corso degli anni erano state dissodate dai monaci greci. Eviden-temente in cambio del faticoso lavoro di dissoda-mento qui compiuto, il monastero dei Tre Fanciulli
205
avrebbe ricevuto altre terre, a partire dal ponte sul Neto, e l’obbedienza di San Martino, beni per i qua-li i monaci greci avrebbero comunque versato ogni anno a Fiore altri due soldi d’oro16. In tal modo, Gioacchino metteva prontamente a frutto il per-messo, ricevuto pochi mesi prima dall’imperatore, di poter riscuotere denaro, «tanto riguardo ai diritti sulla terra quanto all’erbatico e al ghiandatico», da coloro che avessero voluto «lavorare o condurre al pascolo qualche animale negli stessi possessi del no-minato monastero», incrementando così le entrate del monastero17.
A Calosuber, uno dei tenimenti nominati nell’ac-cordo, l’abate ben presto istituì una delle tre prime dipendenze di Fiore, che l’abate chiamò Bonum Li-gnum, forse con significato allusivo a Gn. 3, 6-718. Una volta sorta la nuova piccola dipendenza, tutta-via, gli eventi precipitarono. I monaci greci infatti assalirono la nuova fondazione, e, sostenuti da un gruppo di abitanti di Caccuri, «distrussero l’orato-rio e le sue officine e saccheggiarono ogni cosa che vi trovarono; (…) gli stessi monaci, armati, offesero pesantemente i frati che custodivano le pecore della chiesa (di Fiore) e alcuni li picchiarono, altri li spo-gliarono»19. Qualche tempo dopo i religiosi, sempre appoggiati dagli abitanti di Caccuri, occuparono an-che altre terre di competenza del monastero florense. Tali violenze avvennero poco dopo la morte dell’im-peratrice Costanza, dunque in una data successiva al novembre 119820.
Per fronteggiare la situazione Gioacchino si rivol-se immediatamente (certo in data anteriore al mag-gio del 1199) all’arcivescovo di Palermo, Bartolo-meo, familiare (cioè membro del consiglio) del pic-colo Federico, perché si occupasse del caso. Secondo la testimonianza del presule, per risolvere la contesa intervennero inizialmente i giustizieri di Cosenza, poi Raniero Marchisorti, esponente di una famiglia comitale di Crotone, in quel tempo capitano di Ca-labria, e infine anche un legato pontificio, probabil-mente Gregorio de Sancto Apostolo, cardinale diaco-no di Santa Maria in Portico, legato in Sicilia nei primi mesi del 119921. Questi primi interventi non sortirono evidentemente alcun effetto; per tale moti-vo, Gioacchino fu costretto a rivolgersi nuovamente all’arcivescovo palermitano. Egli convocò ancora una volta, presso San Mauro, i monaci del cenobio dei Tre Fanciulli, ma essi non si presentarono neppure al secondo appuntamento. A quel punto l’arcivescovo delegò l’incarico al collega di Cosenza, Bonomo, il quale, nel giugno 1199, emise infine una sentenza, che stabiliva che i terreni contesi fossero definitiva-mente assegnati a Gioacchino e al suo monastero22.
Nonostante la rapida sentenza in favore di Fiore, sul piano esecutivo l’intervento dei funzionari regi non sortì alcun effetto. I problemi con le comunità vicine infatti si trascinarono ancora per diversi anni. Solo nel 1215 il caso fu risolto, in primo luogo, con i monaci greci dei Tre Fanciulli: essi rinunciarono a ogni ulteriore rivendicazione, lasciando a Fiore an-che i pascoli e i tenimenti che avevano ricevuto con l’accordo del 119523. La comunità evidentemente si era ridotta, e non era più in grado di gestire i pos-sedimenti ottenuti con l’accordo, né essi erano evi-dentemente indispensabili nel regime dei consumi dei monaci greci superstiti. L’anno seguente infine, dopo alterne vicende, ritiri e nuove occupazioni, si giunse a un accordo anche con gli abitanti di Cac-curi, a seguito degli interventi della regina Costanza d’Aragona, moglie di Federico, e di Stefano Marchi-sorti, conte di Crotone, personaggio molto legato al monastero florense24.
La difficile vicenda dei rapporti con la comunità dei Tre Fanciulli rende ben chiaro che il sorgere di una nuova realtà (in questo caso monastica), che do-veva ritagliarsi propri spazi di esistenza tra una selva di poteri ben più radicati, non era mai indolore, e provocava non poche resistenze e opposizioni. Gli scontri violenti con la comunità greca dei Tre Fan-ciulli e con gli abitanti di Caccuri trovano in effetti riscontro in un’ulteriore vicenda: anche una secon-da piccola dipendenza di Fiore subì ben presto una medesima sorte a causa dell’opposizione delle istitu-zioni locali, in questo caso da parte della diocesi di Cerenzia. A quanto sembra, Guglielmo, successore sulla cattedra di Cerenzia del vescovo Gilberto che, nel 1195, aveva concesso a Gioacchino il monastero di Monte Marco, era un esponente di coloro che, nello sviluppo di Fiore, avevano visto toccate le pro-prie prerogative; pertanto, non si era trovato affatto d’accordo sull’operato del predecessore, e, in religio-nis odium, aveva fatto distruggere la chiesa, in cui Gioacchino aveva già distaccato una parte dei suoi seguaci25. L’increscioso episodio non è databile con precisione, ma è comunque collocabile anteriormen-te al 1205, anno in cui il vescovo Guglielmo morì26.
Non sempre, naturalmente, le divergenze e le contese si risolvevano tramite azioni così radicali e violente. Un esempio è quanto avvenne riguardo a un’altra tenuta situata nei pressi di Fiore. L’assegna-zione imperiale della vasta zona di demanio regio a Gioacchino comprendeva infatti anche la tenuta di Vallis Bona, che apparteneva da tempo al mona-stero cistercense di Santa Maria della Sambucina. L’errore da parte dell’amministrazione regia atteste-rebbe che, in qualche caso, il catasto del regno non
206
era esente da lacune27. In quel frangente, tuttavia, l’accordo tra le due fondazioni, Fiore e Sambucina, venne raggiunto rapidamente, dal momento che gli abati dei due monasteri, Gioacchino e Luca, erano da molto tempo in rapporti amichevoli, che non po-tevano evidentemente essere turbati da un incidente amministrativo. I due infatti giunsero a un accordo reciproco, sancito dall’arbitrato dell’arcivescovo di Cosenza e di altri probi viri, e documentato da un instrumentum concordie in seguito perduto. La carta venne presentata alla corte di Costanza nel maggio 1196, quando i due abati furono presenti a Palermo, secondo quanto ricorda lo stesso Luca nel suo scritto su Gioacchino28. L’imperatrice, in quell’occasione, confermò i diritti della Sambucina sul tenimento, correggendo così l’errore del privilegio dell’ottobre 1194, rilasciato dal marito29.
Nel frattempo, i possessi di Fiore si ampliarono ulteriormente. Il vescovo di Cerenzia Gilberto, come abbiamo accennato, nel 1195 aveva donato a Gioac-chino e alla sua comunità la chiesa e il monastero, forse ormai abbandonati, di santa Maria di Abate Marco o Monte Marco30. L’istituzione aveva alcune pertinenze - presumibilmente terreni nei dintorni - e una dipendenza, San Martino del Neto, posta nei pressi dei confini con il monastero di Calabro Maria, che passò anch’essa ai florensi. Il passaggio a Fiore di quest’ultima chiesa è significativo: da un documen-to del 1209 veniamo a sapere, infatti, che da questa fondazione dipendeva anche un certo numero di ho-mines. Anche in questo caso, dunque, Gioacchino accettò senza difficoltà che tra i beni del suo nuovo monastero fossero compresi possessi di tipo tradizio-nale e signorile, quali il controllo di uomini dipen-denti da una chiesa, dimostrando un consapevole distacco dalle normative cistercensi primitive, di cui pure, solo pochi anni prima, aveva intessuto l’elogio richiamando gli abati cistercensi alla loro più stretta osservanza.
1. b. Le prime dipendenzeNel gennaio del 1198 le nuove acquisizioni ri-
cevettero conferma da parte di Costanza, rimasta vedova pochi mesi prima. La regina ripercorse nel-l’occasione il privilegio di Enrico, aggiornando lo status patrimoniale di Fiore con le novità maturate nel frattempo. Di particolare rilievo è in questo sen-so la notizia che il monastero silano aveva ormai or-ganizzato alcune piccole dipendenze, che Costanza elencava nel suo diploma: a Fiore si affiancavano in-fatti le tre dipendenze di Calosuber (ribattezzata Bo-num Lignum; si trattava della dipendenza distrutta dai monaci greci dei Tre Fanciulli), Tassitano e Abate
Marco o Monte Marco31. Appare chiaro che in quei pochi anni, tra il 1194 e il 1198, il sopraggiungere di nuovi compagni aveva posto a Gioacchino nuove questioni: si era reso indispensabile, innanzitutto, organizzare l’accresciuto numero di seguaci in for-me più definite e stabili, dividendoli in sedi diverse. Il moltiplicarsi delle dipendenze rendeva poi neces-saria, evidentemente, l’elaborazione di alcuni statu-ti che regolassero le relazioni tra le diverse piccole fondazioni monastiche. Una volta steso tale testo normativo, Gioacchino si premunì presentandolo al pontefice: con un tale atto, in effetti, avveniva il definitivo distacco dall’ordine di cui, fino ad allora, aveva fatto parte; oltretutto, le institutiones da lui re-datte intendevano realizzare una particolarissima e originale forma di vita religiosa, in grado di integrare tra di loro diversi carismi e espressioni di vita comu-nitaria diffusi a quel tempo nel mondo monastico e in particolare nell’ordine cistercense. Le novità che l’abate si proponeva erano diverse, e dunque l’appro-vazione del pontefice doveva sembrargli indispen-sabile. Probabilmente nel corso del 1196 dunque, egli si recò presso la curia romana; qui ottenne da Celestino III l’approvazione, data oralmente in con-cistoro, delle istituzioni del suo nuovo ordine, che in seguito sarà detto florense32. La successiva lettera del pontefice, in data 25 agosto, non fece che notifica-re tale approvazione, riassumendo stringatamente i punti rilevanti delle istituzioni del nuovo ordo33.
Nel ricevere dal pontefice l’approvazione delle sue institutiones, Gioacchino aveva senza dubbio già chiarito la posizione di Fiore anche nei confronti delle autorità religiose che avevano competenza sul suo monastero: in data anteriore al marzo 1200, ma con ogni probabilità anche all’agosto 1196, l’abbazia florense aveva ormai ottenuto dal papa la protezio-ne pontificia e l’esenzione dall’ordinario vescovile. Nel marzo 1200, infatti Cinzio, cardinale prete di San Lorenzo in Lucina, in quel periodo inviato da Innocenzo nel regno di Sicilia quale suo legato, at-testò innanzitutto che il monastero di Fiore era già in precedenza considerato di proprietà della Santa Romana Chiesa34. Egli poi, presentando la configu-razione istituzionale di una nuova fondazione flo-rense in progetto, affermava che essa sarebbe stata identica a quella già stabilita per l’abbazia di Fiore: risulta dunque che quest’ultima «nulli, nisi Roma-no pontifici debeat subiacere» e che il suo abate «ab aliquo episcopo catholico, quem maluerit, munus benedictionis accipiat, qui munus apostolica aucto-ritate, quod postulatur, impendat»35, parole che si riferiscono proprio all’esenzione dai poteri dell’ordi-nario diocesano. Fin dunque dalla sua origine, Fiore
207
risulta legata direttamente a Roma e al papa, e vice-versa svincolata da quei diritti che un vescovo locale - nel caso di Fiore, l’arcivescovo di Cosenza - poteva rivendicare sui monasteri del proprio territorio36.
Forte dell’approvazione, Gioacchino continuò a seguire con sollecitudine la crescita del nuovo ordo. La morte, sopraggiunta il 30 marzo 1202, fece ca-dere solo in parte quanto egli aveva in mente per il futuro, e se uno dei suoi progetti di sviluppo cadde assai presto, il monastero di Fonte Laurato, di cui l’abate pose le prime basi, divenne la seconda abba-zia dell’ordine, madre a sua volta di altri cenobi.
2. I successivi passi di Gioacchino
2.a. Albeto/Caput AlbumForse per tamponare le conseguenze della distru-
zione di Bonum Lignum, a causa della quale, certa-mente, i monaci qui distaccati erano dovuti rientrare a Fiore, e sulla spinta di nuove adesioni37, nel marzo del 1200 l’abate di Fiore pose mano al progetto di una nuova fondazione. A tale scopo, egli poteva di-sporre di due diverse località: la prima, detta Caput Album, si trovava «in extrema parte Sile, quae adiacet civitati Cusentie»; essa gli era stata concessa da Fede-rico, l’allora giovanissimo re di Sicilia. Egli, o chi per lui, appunto nel marzo 1200 accordò a Gioacchino, presente di persona a Palermo, il permesso di far sor-gere in quel luogo una nuova domus religionis, sulle basi di un piccolo receptaculum che in precedenza l’abate aveva fatto costruire e che i suoi monaci e le persone di passaggio già utilizzavano nei momenti in cui la neve rendeva difficoltoso il collegamento tra la Sila e Cosenza. In quella località Federico concesse alla progettata fondazione un terreno di mille passi sia in larghezza sia in lunghezza, e accolse sotto la propria protezione sia il futuro monastero, sia i mo-naci e i superiori che vi avrebbero abitato38.
Nello stesso tempo e al medesimo scopo, all’abate di Fiore venne offerto un secondo fondo, «in loco qui vulgo dicitur Albetum, de vicino autem fonte fluminis generali nomine Caput Gratis»39. La dona-zione è attestata da un documento del legato pontifi-cio Cinzio, cardinale prete di San Lorenzo in Lucina, in missione nel regno di Sicilia. Il terreno era stato offerto da un certo Unfredo Colino, il quale desi-derava che vi fosse edificato appunto un monastero florense; l’iniziativa era sostenuta anche da Simone di Mamistra, «regius Calabrie magister iustitiarius», che voleva esserne «particeps (...), coadiutorem et cooperatorem»40. Tuttavia, nel documento del car-dinale legato si intravvedono forse alcune perplessità
di Gioacchino riguardo alle caratteristiche di Albeto, dal momento che il cardinale gli lasciava la libertà di optare eventualmente per un altro luogo, giudicato più adatto, appunto Caput Album. Questa seconda tenuta aveva infatti il vantaggio, rispetto ad Albeto, di essere più ricca di acque41.
In realtà, né il luogo chiamato Albetum, né quel-lo detto Caput Album videro mai realizzate le in-tenzioni dichiarate nei documenti. Indubbiamente dovette frapporsi qualche difficoltà o cambiamento di rotta, dal momento che non ritroviamo più, nella successiva documentazione florense, i due terreni in questione, e neppure i diplomi di Federico rilasciati negli anni seguenti fanno mai più cenno alla dona-zione del marzo 1200.
In ogni caso, la carta del cardinale Cinzio ci at-testa non solo i solidi legami di Gioacchino con la curia romana, ma anche quelli con membri della no-biltà regnicola: se non sappiamo nulla di quell’Un-fredo Colino che offrì alla sede romana, nelle mani del suo legato, il terreno per la costruzione del nuovo cenobio florense, il secondo personaggio che vi com-pare, Simone di Mamistra, fu invece figura di spicco tra le fila dell’amministrazione regia a cavallo di due secoli e di due dinastie. Egli era infatti definito, nei documenti relativi alla contesa con il monastero dei Tre Fanciulli, «capitano e maestro connestabile, giu-stiziere della Valle del Crati, del Sinni e del Laino»42; nel marzo del 1200 venne detto gran giustiziere regio della Calabria, e nella fondazione di Fonte Laurato compare in qualità di signore di Fiumefreddo43.
2.b. Fonte LauratoParallelamente al progetto della nuova domus reli-
gionis di Albeto o di Caput Album, Gioacchino pose le basi anche per una nuova fondazione nella limi-trofa diocesi di Tropea. I contatti di fiducia stabiliti in precedenza con Simone di Mamistra indussero il signore del castrum di Fiumefreddo e sua moglie Gattegrima a convocare, nel settembre del 1201, l’abate di Fiore, per vagliare insieme a lui le terre di loro competenza e scegliere quelle più idonee all’edi-ficazione di un nuovo monastero florense. Era loro intenzione infatti «aedificare domum religionis in-fra fines terrae nostrae Fluminis Frigidi, ad laudem et gloriam omnipotentis Dei et salutem animarum multarum»44. Dal momento però che molte altre ini-ziative simili, nate con la medesima intenzione, non avevano superato la prova del tempo per il fatto che non avevano trovato rectores et ordinatores adeguati, su consiglio di Riccardo, vescovo di Tropea, Simo-ne si rivolse all’abate florense, desiderando che la sua fondazione godesse invece di perpetua firmitate.
208
Evidentemente, agli occhi del signore e del vescovo, Gioacchino era in grado di dare garanzie sufficienti per la stabilità di una nuova fondazione45.
Il documento del signore di Fiumefreddo ci pre-senta poi i criteri di scelta del sito per il nuovo mona-stero: anche in questo caso Gioacchino localizzò un sito ricco di acque, posto nei pressi della confluenza di due corsi d’acqua. Qui sorgeva già una chiesa, de-dicata a Santa Domenica, presso cui, al tempo dei predecessori di Simone, abitava una comunità mona-stica. La chiesa aveva un suo tenimentum, conferma-to all’erigendo monastero; ad esso Simone aggiunse un secondo terreno, contiguo al primo, in modo da ampliarlo. La tenuta si estendeva così fino ai confini di Mendicino, nei pressi di Cosenza, e comprendeva corsi d’acqua e una coltura, detta de Barbaro. L’abate florense ottenne dunque, evidentemente secondo i suoi progetti, una vasta proprietà, in luogo solitario, posto a media altitudine (tra i 200 metri del luogo dove sorse l’abbazia fino a circa 350-400 m.), ricca di acqua e dunque adatta alla coltivazione, come at-testa la presenza di arativi (la cultura de Barbaro), e alla costruzione di mulini, a cui i monaci avrebbero potuto attendere senza alcun onere da parte del si-gnore locale. Erano sicuramente compresi pascoli e boschi: la carta di Simone nomina infatti il diritto di libero pascolo e la facoltà di raccogliere legname, estesi a tutto il territorio di Fiumefreddo, probabil-mente nella zona più montuosa della proprietà46.
2.c. La tenuta di CanaleL’esenzione dall’ordinario locale attestata per Fio-
re almeno dal marzo 1200 non aveva comunque na-turalmente precluso le relazioni del monastero con gli arcivescovi che si succedettero sulla cattedra di Cosenza in quei burrascosi anni. Se Bonomo, in ca-rica tra il 1195 e il 1199, fu in contatto con Gioac-chino in particolare a motivo della contesa tra Fiore e i monaci greci dei Tre Fanciulli47, il suo successore Andrea, arcivescovo tra il 1201 e il 1202, stimò cer-tamente l’abate florense, tanto da concedergli, nel marzo del 1201, la chiesa in rovina di San Martino de Jove, detta anche di Canale (località non lontano da Pietrafitta, nei pressi di Cosenza) con tutti i suoi beni e pertinenze48, e da favorire i contatti, l’anno seguente, tra i florensi e il vescovo di Tropea49.
Dalla documentazione relativa ai suoi ultimi anni di vita, è evidente che l’abate calabrese era orienta-to a costituire, nei dintorni del capoluogo della Val di Crati, una tenuta accorpata: nel giugno del 1198 Pietro e Novello, figli Nicola di Canale, gli vendette-ro «nella località detta Canale una terra, che ha sotto e sopra e ai due lati il confine tuo stesso e della tua
chiesa di Fiore»50. Nel marzo dello stesso anno, una vedova, di nome Dulcissima, offrì all’abate di Fiore una foresta, un frutteto e una vigna, ubicati anch’essi a Canale51. Sempre qui, due anni dopo, Gioacchino ricevette in donazione un appezzamento di terra, da parte di un certo Lorenzo de vico Turzani52. A Cana-le Gioacchino ben presto istituì, in data anteriore al marzo del 1201, una piccola dipendenza: la chiesa di San Martino, concessa dall’arcivescovo di Cosenza, confinava infatti con essa53.
Nella medesima direzione sembrano orientate anche le acquisizioni di terre a Pietrafitta, altra lo-calità nei pressi di Canale. L’indice delle carte con-servate nell’archivio di San Giovanni in Fiore attesta infatti sia l’acquisto di alcuni terreni nel territorio di Pietrafitta, nel 1200, sia la donazione di un quer-ceto e di un castagneto nella medesima località, da parte di Rocca, moglie di Ruggero de Tiniano, nel-l’anno successivo54. Non molto distante dalle pro-prietà acquisite in quel periodo dal monastero di Fiore doveva poi essere situato quel mulino presso il fiume Cardone, nel territorio di Pedace (ai confini con quello di Pietrafitta), metà del quale era stata concessa ai florensi nel 119855. A questi beni si deve forse già aggiungere, nella medesima zona, la chiesa di San Nicola di Bottulo e la sua vasta tenuta, che comprendeva vigne, alberi, un mulino e un follone, la cui acquisizione da parte di Fiore è certo anteriore al settembre del 120356.
Con tali acquisti e concessioni, l’abate intende-va certamente potenziare quelle colture che meglio potevano sopperire alle necessità di autoconsumo della comunità monastica: una vigna, di cui tanto il monastero aveva bisogno, un arativo, un frutteto, un castagneto, oltre a un querceto e a una nuova fore-sta57. Tuttavia, ci si può chiedere se in questo modo Gioacchino non mirasse anche a creare, tra Canale e Pietrafitta, un’ampia proprietà accorpata che costi-tuisse la base del patrimonio fondiario per una nuo-va comunità di religiosi. Nel caso del monastero di Fiore, posto sulla Sila, Gioacchino aveva sopperito alla necessità di disporre di una vasta tenuta accorpa-ta ricorrendo a una assegnazione del demanio regio, poiché solo da qui potevano venire estensioni di ter-re sufficientemente ampie da assicurare la vita della comunità58. Nel caso di Fonte Laurato, egli ricorse alla pia devozione del dominus di Fiumefreddo, che gli offrì una vasta tenuta unitaria nel territorio di sua competenza, confermata in seguito, a vario titolo, da Federico, dal vescovo di Tropea e dal pontefice59. Al contrario, per riuscire a costituire una vasta proprie-tà nei pressi di Cosenza, dove evidentemente la mag-gior parte delle terre era ormai indisponibile, l’abate
209
ricorse alla buona volontà dei numerosi proprietari terrieri privati, tramite donazioni, acquisti o scam-bi. In quest’ultimo caso, Gioacchino cedette quelle terre, disperse nella zona, che esorbitavano dal suo progetto unitario60.
Il 30 marzo l’abate si spense proprio presso la chie-sa di San Martino de Jove, a Canale. Qui ricevette la sua prima sepoltura, e qui rimase fino al 1226, anno in cui le sue spoglie vennero finalmente traslate a Fiore61. La lunga permanenza dei resti di Gioacchino a Canale avvalorerebbe l’ipotesi che, nei suoi origi-nari progetti, egli avesse previsto che presso la chiesa
di San Martino fosse organizzata una comunità re-ligiosa e non una semplice grangia, come avverrà in seguito, a partire dal terzo decennio del secolo. In effetti, solo un’ipotesi del genere renderebbe ragione del perché la comunità di Fiore avesse accettato che un bene prezioso come il corpo del fondatore rima-nesse sepolto in quel luogo così a lungo, cioè fino al momento in cui, evidentemente, i florensi non si resero definitivamente conto che il progetto origina-rio del loro abate non era più realizzabile e la tenuta di Canale non venne pertanto destinata a un diverso scopo62.
Note
1 Vol. 2, p. I, doc. n. 2.2 Vita b. Joachimi abbatis, in H. Grundmann, Gioacchino
da Fiore. Vita e opere, a c. di G. L. Potestà, Roma 1997, p. 188
(Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti, 8).3 La lettura del documento di Enrico VI dell’ottobre 1194
rende evidente il tipo di opzione compiuta da Gioacchino, a
favore di una tipologia economica di tipo tradizionale.4 Vita, cit., pp. 187-189.5 Ivi, pp. 188-189.6 Vol. 2, p. I, doc. n. 1.7 D. Martire, La Calabria sacra e profana, II, Cosenza 1878,
p. 85.8 Vol. 2, p. I, doc. n. 40.
9 Ivi, doc. n. 43.10 Gioacchino fu abate cistercense di Corazzo almeno fino
al settembre 1192, data del richiamo da parte del capitolo ge-
nerale cistercense. Sarei propensa pertanto a ritenere che egli
non potesse costruire il suo eremo cistercense che su un terre-
no o di proprietà di Corazzo, o appartenente a un altro ente,
ma già concessogli in qualche forma; rispetto a questa seconda
possibilità, i legami instaurati in quel periodo con la comunità
monastica greca di Calabro Maria e le diverse concessioni avu-
te da Gioacchino dall’abate Kirolus permettono di ipotizzare
che il locum Floris potesse essere una di queste. Priva di docu-
mentazione, allo stato attuale delle conoscenze, rimane invece
l’ipotesi che il locum Floris fosse terra demaniale, che Gioacchi-
210
no avrebbe ricevuto da parte di Guglielmo II in un momento
successivo all’insediamento, in un periodo compreso tra il lu-
glio e il 18 novembre 1189, data in cui il re normanno morì.
Per tale ipotesi, cfr. P. Lopetrone, Il protomonastero di Fiore:
origini, fondazione, vita, distruzione, ritrovamento, in «Abate
Gioacchino. Organo trimestrale per la causa di canonizzazione
del Servo di Dio Gioacchino da Fiore», I, 2-3 (marzo-giugno
2004), pp. 44-45. Una possibile conferma indiretta che il lo-
cum Floris potesse in origine appartenere all’abbazia di Corazzo
ci viene da un documento pubblicato da P. De Leo (Documenti
imperiali e regi, pp. 357-360), del febbraio 1198, con cui l’im-
peratrice Costanza confermava a Corazzo una serie di beni e
proprietà già detenuti, tra cui anche la «Silvam, que dicitur de
Gi<m>mella, in tenimento Sile», una località nei pressi del mo-
nastero silano. Corazzo ricevette poi conferma della proprietà
della località Gimmella da parte di Federico II, nel marzo del
1221 (Constantiae Diplomata, Depp. Ks. 23, pp. 234-235).
Che in Sila, zona di prevalente demanio regio, vi fossero diver-
se enclave di possessi privati - religiosi o meno - è comprovato
dalle fonti documentarie: l’abbazia cistercense della Sambucina
possedeva una vasta tenuta, detta Valle Bona, nelle vicinanze
di Fiore (nei pressi dell’attuale lago Arvo), compresa per errore
nella donazione a favore di Gioacchino da parte di Enrico VI;
nell’ottobre del 1217 il vescovo di Cerenzia Nicola e il suo ca-
pitolo rinunciarono a rivendicare il possesso di un terreno in
località Salice, che ugualmente era compreso nella donazione
imperiale del 1194; anche il monastero greco del Patir detene-
va il possesso sulla tenuta detta Trium Capitum, riguardo alla
quale nel 1223 giunse ad un accordo con Fiore; il monastero
greco di Calabromaria possedeva l’estesa tenuta detta di San-
duca ancora dai tempi dei primi regnanti normanni; infine un
privato, Clementia, moglie di un certo Lorenzo Caballario, nel
gennaio 1226 donò per testamento a Fiore alcuni campi in
località Gimmella. Né mi pare prova sufficiente del fatto che
il locum Floris fosse senz’altro terra demaniale l’intervento dei
funzionari di Tancredi contro Gioacchino e i suoi seguaci, di
cui parla la Vita. Se pure la notizia fosse vera, i funzionari pote-
vano essere intervenuti non tanto a difesa delle terre demaniali,
ma di usi e consuetudini qui detenuti da altri, in particolare da
quei cives di Cosenza di cui parla un documento pontificio. 11 Le saline, appartenenti al demanio regio, si trovavano nel
territorio di Santa Severina, nei pressi del monastero di Calabro
Maria. Per il testo del diploma imperiale, vd. vol. 2, p. I, doc. n. 3.12 Ivi, doc. n. 2.13 Cfr. R. Comba, Le scelte economiche dei monaci bianchi
nel Regno di Sicilia (XII-XIII secolo): un modello cistercense? in I
Cistercensi nel Mezzogiorno medievale. Atti del Convegno inter-
nazionale di studio in occasione del IX centenario della nascita
di Bernardo di Clairvaux (Martiano - Latiano - Lecce, 25-27
febbraio 1991), a c. di H. Houben e B. Vetere, Galatina 1994,
pp. 156-157 (Università degli Studi di Lecce, Pubblicazioni del
Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all’Età Contem-
poranea 28).
14 «Coram eius presentia questionem movit dicens partem
eiusdem tenimenti prefato venerabili abbati Ioachim a iam
dicto domino imperatore (...) concessam, eis pertinere»: Vol.
2, p. I, doc. n. 20. Nel primo volume dei manoscritti di Nicola
Venusio, commissario degli affari silani (N. Venusio, S. Giovan-
ni in Fiore 1-3, Matera, Biblioteca Provinciale, Mss. 21/I-III,
in seguito MBP I-III), sono conservate, nella vasta documen-
tazione, le copie dei documenti florensi tratte dall’Ughelli, ma
verificate e corrette sulla base degli originali allora conservati
nell’archivio del monastero. La copia della sentenza dell’arcive-
scovo Bonomo, in particolare, è in MBP I, ff. 144v-151r.15 «Et cum propter hoc a loco S. Euphemiæ, ubi prius quæ-
stio ipsa mota est, usque ad Rocca Nicephorii utraque pars
prædictam dominam imperatricem nostram subsequeretur, in
eiusdem curia sententiatum est, ut privilegia utrinque exinde
ostenderentur, et pars illa, cui ostensa faverent privilegia, ius
suum plenius obtinerent, ut itaque ventum est apud Nico-
teram, prædicta pars ipsius monasterii SS. Trium Puerorum
confessa est, se nullum exinde privilegium obtinere et sic tan-
dem prædictam dominæ imperatricis curiam iam dictum teni-
mentum prænominato venerabili abbati Ioachim sententialiter
adiudicatum est et per eiusdem privilegium sibi perpetuo con-
firmatum»: Vol. 2, p. I, doc. n. 20.16 Ivi.17 Vol. 2, p. I, doc. n. 2.18 A tale significato richiama forse anche la Vita anonima,
che attribuisce a Gioacchino la citazione di questo passo bibli-
co nel suo discorso di fronte a Tancredi: cfr. Vita, p. 189.19 Vol. 2, p. I, doc. n.20.20 Ivi: «radicem controversie inter monasterium Floris, et
monasterium SS. Trium Puerorum, que decisa in curia im-
peratricis, post obitum ipsius, hanc ipsi monachi SS. Trium
Puerorum resumere presumpserunt»; «iam dicti monachi SS.
Trium Puerorum post obitum prefate domine imperatricis, ut
prelegitur, infregerunt».21 W. maleczek, Papst und Kardinalkolleg von 1191 bis
1216. Die Kardinäle unter Coelestin III. und Innocenz III., Wien
1984, pp. 93-94. Gregorio era stato inviato da Innocenzo nel
gennaio del 1199, come attesta la lettera del pontefice del 25
gennaio 1199. Non accenna a tale legazione M. maccarrone,
Papato e Regno di Sicilia nel primo anno di pontificato di Inno-
cenzo III, in Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva
(1189-1210). Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari
- Conversano, 26-28 ottobre 1981), Bari 1983 (Centro di studi
normanno-svevi, Università degli studi di Bari, Atti 5), pp. 75-
108; di essa in effetti si sa ben poco.22 Vol. 2, p. I, doc. n.23.23 Ivi, doc. n. 89. 24 Ivi, docc. nn. 92 e 94.25 Ivi, docc. nn. 60 e 101.26 Su Guglielmo, vescovo di Cerenzia, vd. N. Kamp, Kirche
und Monarchie im Staufischen Königreich Sizilien. I: Prosopo-
graphische Grundlegung. Bistümer und Bischöfe des Königreichs
211
1194-1266, Teil 2: Apulien und Kalabrien, München 1975
(Münstersche Mittelalter-Schriften 10/I, 2), p. 898.27 T. Kölzer, La monarchia normanno-sveva e l’ordine cister-
cense, in I Cistercensi nel Mezzogiorno, pp.91-116; per tale que-
stione, vd. pp. 101-102.28 Luca di Cosenza, Memorie, in Grundmann, Gioacchino
da Fiore, pp. 191-197. Per il viaggio alla corte di Costanza, vd.
pp. 194-195.29 Kölzer, La monarchia normanno-sveva, p. 102; per la do-
cumentazione in merito, cfr. A. Pratesi, Carte latine di abbazie
calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, Città del Vati-
cano 1958 (Studi e testi 197), n. 47, pp. 109-112; vd. vol. 2,
p. I, docc. nn. 8 e 9.30 Fino al 1181 tuttavia risulta che vi fosse un abate, come
attesta il documento di una sentenza a favore del monastero
di Santa Maria di Cabria (DDFF, I), in cui un Pietro abate di
Santa Maria di Abate Marco compare appunto come teste.31 Vol. 2, p. I, doc. n. 12: «monasteria, que de novo fundasti
in loco, qui olim dictus est Calosuber, nunc autem Bonum
Lignum, et in loco qui dicitur Tassitanum, et monasterium
Abbatis Marci, que et ipsa ad tuam curam constitutis ibi a te
prelatis pertinere noscuntur, et si qua te vel fratres tuos alia in
futurum largiente Domino edificare contigerit, cum omnibus
possessionibus et bonis suis fratres, homines et loca vestra sub
nostra speciali protectione et defensione suscipimus».32 In merito all’approvazione orale data da Celestino III
(vol. 2, p. I, doc. n. 10), vd. le osservazioni di m. maccarrone,
Primato romano e monasteri dal principio del XII secolo ad In-
nocenzo III, in Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in
Occidente (1123-1215), Atti della settima Settimana internazio-
nale di studio (Mendola 28 agosto - 3 settembre 1977), Milano
1980 (Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Miscellanea del Centro di Studi medioevali 9), pp. 47-132, in
part. pp. 77-80.33 Vd. a riguardo Italia Pontificia, X: Calabria - Insulae, a
c. di D. Girgensohn, Zürich 1975, p. 117. Il testo è edito,
tra gli altri, anche in J. p. migne, Patrologiae Cursus completus.
Series Latina, Paris 1841-1864, vol. 206, n. 279, col. 1183 (in
seguito PL). Celestino III così fa riferimento alle istituzioni di
Gioacchino: «quasdam constitutiones de vita monachorum
tuorum et monasteriorum tuo cœnobio subiectorum, et de re-
bus ab ipsis fratribus possidendis et eorum numero». Vd. vol.
2, p. I, doc. n. 10.34 Ivi, doc. n. 25. È necessario chiarire, a questo proposi-
to, che non si deve confondere questo personaggio - Cinzio,
cardinale di San Lorenzo in Lucina, nel 1200 legato pontificio
nel Regno di Sicilia - con il cardinale Cencio Savelli, in seguito
salito al soglio pontificio con il nome di Onorio III. Nonostan-
te già da tempo M. Maccarrone e W. Maleczek abbiano messo
in luce l’errore della tradizione erudita (Maccarrone, Primato
papale, p. 58, n. 30; Maleczek, Papst und Kardinalskolleg), si è
continuato a confondere i due personaggi (per un caso emble-
matico, vd. DDFF, p. 16, n. V).
35 Maccarrone, Primato papale, p. 58, n. 30. Riguardo
alla concessione della protectio apostolica, vd. anche G. penco,
Gioacchino da Fiore e la «protectio apostolica», in «Benedictina»,
40 (1993), pp. 493- 496.36 Riguardo al problema dell’esenzione dall’ordinario dio-
cesano nell’ordine florense, V. De Fraja, Oltre Cîteaux. Gioac-
chino da Fiore e l’ordine florense, Viella 2006 (Opere di Gioac-
chino da Fiore: testi e strumenti, 19), in corso di stampa; vd.
Conclusione, 1. b.37 L’arrivo di nuovi aderenti al monastero di Fiore pare con-
fermato, oltre che dalla necessità di aprire nuove dipendenze,
anche da una lettera di Innocenzo III a Gioacchino; in essa si
fa riferimento a un canonico di Cerenzia il quale, malato, aveva
fatto voto iunctis manibus di fronte a Gioacchino di farsi mo-
naco. Il pontefice ricorda anche che altre persone già ammesse
ad familiaritatem con il monastero, forse in qualità di oblati,
durante un’assenza dell’abate avevano promesso di farsi mona-
ci; una volta riacquistata la salute, erano tuttavia ritornati sulle
loro decisioni. Al di là di questi occasionali ripensamenti, Fiore
appare come un’istituzione dalla forte attrattiva, non solo per
i monaci già in relazione con l’abate, ma anche per i canonici
delle diocesi limitrofe e per gruppi di laici. Per la lettera di
Innocenzo III, vd. die Register Innocenz’ III., I: 1. Pontifikats-
jahr, 1198/1199. Texte, bearbeitet von O. Hageneder - A. Hai-
dacher, Graz-Köln 1964 (Publikationen des Österrechischen
Kulturinstituts in Rom, II/1), n. 524, p. 757; ora anche in vol.
2, p. I, doc. n. 19.38 Vol. 2, p. I, doc. n.24.39 Ivi, doc. n. 25. Riguardo alla donazione del luogo chia-
mato Albetum, cfr. la lettera di Nicola Venusio al marchese Ta-
nucci e al marchese de Marco, Segretario di Stato, nella quale si
approfondiscono, sulla scorta della documentazione superstite,
le ragioni in base alle quali l’abbazia florense deve essere rite-
nuta di regio patronato, e quella al solo marchese de Marco, in
cui si propongono alcune osservazioni sui titoli di proprietà del
monastero florense: in esse il Venusio corregge il nome di Al-
banetum riportato da Giacomo Greco e dall’Ughelli, in quello
corretto di Albetum: de Leo, I manoscritti di Nicola Venusio,
pp. 60-61, 68.40 Vol. 2, p. I, doc. n.25.41 Ivi.42 Ivi, doc. n. 23.43 Ivi, docc. nn. 25 e 30. 44 Ivi, doc. n. 30.45 Ivi.46 Ivi.47 Ivi, doc. n. 23.48 Ivi, doc. n. 29.49 Il vescovo di Tropea Riccardo, nel giugno del 1202 con-
fermò la donazione di Simone, concedendo ai florensi tre chie-
se a favore dell’erigendo monastero. L’arenga del documento
ricalca alla lettera il testo dettato da Andrea, arcivescovo di Co-
senza, per la donazione a Fiore della chiesa di San Martino de
212
Jove. Il documento di Andrea sarebbe servito quindi da model-
lo per la donazione di Riccardo. Dalla conferma pontificia del
possesso delle tre chiese si viene poi a sapere che il documento
del vescovo Riccardo era sottoscritto anche dall’arcivescovo di
Cosenza, dal decano e dal cantore del capitolo, e munito dei loro
sigilli. Vd. vol. 2, p. I, doc. n. 36 e p. II, doc. n. 7. Per la figura
del vescovo di Tropea, vd. Kamp, Kirche und Monarchie, p. 998.50 Vol. 2, p. I, doc. n.14: «terram unam, que est ubi Canale
dicitur, et habet desuper et desubtus et de duobus lateribus
finaytam tui ipsius et ecclesie tue de Flore».51 Ivi, doc. n. 13: «Instrumentum donationis facte mona-
sterio florensi foreste, pomerii et vinealis loco dicto Canale per
quandam viduam nomine Dulcissimam anno 1198». 52 Ivi, doc. n. 27: «Instrumentum donationis facte per Lau-
rentium de vico Turzani abbati Joachim cuiusdam terre in loco
qui dicitur Canale, in anno 1200».53 Ivi, doc. n. 29: «monasterio vestro ecclesiam Sancti Mar-
tini de Iove, cum tenimentis suis, que est in confinis cuiusdam
obbedientie vestre, que vocatur Canale».54 Ivi, docc. n. 28 e n. 34. 55 Ivi, doc. n. 18: «Concessio medietatis molendini in terri-
torio Pedacii prope flumen dictum Cardone, anno 1198».56 Ivi, doc. n. 40. Non siamo in grado di identificare l’esatta
ubicazione della chiesa di San Nicola di Bottulo, né di capire
in che modo il monastero di Fiore ne sia venuto in possesso. I
documenti di Fiore non ne fanno mai menzione, se non come
una proprietà già acquisita. I documenti relativi evidentemen-
te sono andati perduti; dalle conferme successive, tuttavia, le
terre di Bottulo sono sempre legate a quelle di Canale, e poste
nel territorio di Cosenza: «tenimentum Canalis et tenimentum
Bottuli et quecumque alia in tenimento Cusentie (...) possi-
detis» (Ivi, doc. n. 53); «quasdam terras et arbores acquisitas
a te et predecessore tuo oblationibus hominum Turtian. in te-
nimento Cusentie, in loco videlicet Canalis et in loco Bottuli,
(...) de feudo et servitiis obligate» (Ivi, doc. n. 68); da quanto
si può intuire, le terre di Canale e di Bottulo dovevano essere
confinanti: «Canalem cum Bottulo» (Ivi, doc. n. 108). 57 In merito, vd. Comba, Le scelte economiche, p. 158.58 Kölzer, La monarchia normanno-sveva, p. 102.59 Vd. infra, cap. IV.60 Uno scambio con questo obbiettivo è attestato da un do-
cumento del giugno 1198 (Vol. 2, p. I, doc. n. 14): «ego pre-
fata mulier recipi a te, venerabili abbate, in vicaniam vineolam
quandam, que est ubi Miscella dicitur».61 Per la data della traslazione, vd. V. De Fraja, «Post com-
bustionis infortunium». Nuove considerazioni sulla tradizione
delle opere gioachimite, in «Florensia», 8-9 (1994-1995), pp.
129-171, in part. 136, nota 40.62 Anche considerando che nel periodo 1202-1207 i floren-
si miravano a trasferirsi (e dunque avrebbero atteso di traslare
il corpo di Gioacchino nella nuova sede) e che, a partire dal
1215, dovettero ricostruire il loro monastero distrutto in un
incendio (e dunque avrebbero atteso che il nuovo monastero
di Fiore potesse accogliere le spoglie), rimane il fatto che tra
1207 e 1214 lasciarono che le spoglie del fondatore riposassero
proprio a Canale.
213
CapItOlO SECONdO
da FIOrE vEtErE a FIOrE NuOvO
La morte di Gioacchino il 30 marzo 1202 deter-minò l’elezione ad abate di Fiore del monaco Mat-teo, che resse il monastero fino al 1234, anno in cui le fonti lo presentano come titolare della cattedra di Cerenzia. Scarsissime sono le notizie su di lui: a par-tire dal XVI secolo, ma non è chiaro su quali docu-menti, lo si disse appartenente alla famiglia Vitari1. La tradizione agiografica relativa a Gioacchino gli at-tribuisce una provenienza toscana: il narratore di un episodio dei Miracula afferma infatti che Matteo fa-ceva parte di una terna di seniores litterati provenien-ti de Tuscia2. La medesima fonte dichiara che Matteo compì il noviziato a Fiore, probabilmente intorno al 11983. Il luogo e l’ambiente di formazione culturale di Matteo e dei due anonimi litterati sarebbero stati dunque la Tuscia e un centro non monastico, che allo stato attuale delle conoscenze non è possibile identificare con maggiore precisione. La provenienza dalla Tuscia di alcuni dei primi discepoli di Gioac-chino potrebbe spiegare il precoce insediamento del-l’ordine in questa regione, dal momento che certa-mente dal 1216 nella diocesi di Lucca esisteva una comunità di florensi, insediata presso il priorato di Moriglione, tra Lucca e Pisa4.
1. Il progetto di trasferimento e la con-tesa con il capitolo di Cosenza
Il nuovo abate dovette immediatamente fronteg-giare una difficile questione: già in data anteriore al settembre del 1203, i florensi si erano infatti rivolti a Innocenzo III perché sollecitasse l’arcivescovo e il capitolo di Cosenza ad accettare uno scambio di ter-re, mediante il quale Fiore mirava a ottenere il luogo detto Botrano, di proprietà della chiesa di Cosenza5. La comunità di Fiore aveva deciso di trasferirsi da Fiore a un’altra sede più idonea, identificata appunto in Botrano; la scelta fu giustificata di fronte al papa con il fatto che «lo stesso monastero posto sui monti è a tal punto esposto ai venti che, a causa della du-rezza e del protrarsi del freddo, l’inverno non solo rivendica per sé il tempo primaverile e autunnale, ma ha dilatato i suoi termini fino ai mesi estivi»6; Botrano invece, situato molto più a valle e in posi-zione più sicura, poteva garantire un regime di vita meno duro. Indubbiamente, la vita a Fiore fino a quel momento non doveva essere stata facile: la lo-calità scelta da Gioacchino era realmente battuta da gelidi venti aquilonari convogliati dalla valle dell’Ar-vo7, ed è probabile che alle difficoltà normalmente provocate dal rigore invernale si fossero aggiunte quelle derivanti dalle recentissime cattive annate, particolarmente fredde, attestate dalle fonti8. La let-
214
tera di Innocenzo III accenna inoltre al fatto che il luogo subiva diverse scorrerie9. Le parole potrebbero riferirsi a diversi avvenimenti negativi: da una parte il contrasto, apertosi pochi anni prima, con i monaci greci dei Tre Fanciulli e con gli abitanti di Caccuri; altre difficoltà erano forse già sorte - lo abbiamo vi-sto - anche nei rapporti con il vescovo di Cerenzia10. È dunque possibile che questi scontri avessero sco-raggiato i florensi, spingendoli a ricercare un luogo più accogliente e meglio difeso. Un ulteriore motivo di difficoltà stava infine nella situazione politica di quegli anni: secondo il testamento di Costanza, il giovane re Federico era stato affidato al pontefice, ma la tutela era rivendicata dal tedesco Markward di Anweiler, a cui si oppose militarmente Gualtieri di Brienne, alleato del papa; la delegazione dei canonici di Cosenza aveva in effetti dichiarato, di fronte al pon-tefice, che uno dei motivi dell’abbandono della Sila da parte dei florensi era proprio la guerra in corso11.
Ai contrasti con le istituzioni monastiche ed ec-clesiastiche greche e alla situazione precaria del regno si aggiungeva forse un’altra circostanza. Abbiamo vi-sto che, nel settembre del 1201, Gioacchino aveva ricevuto da Simone di Mamistra, signore di Fiume-freddo e funzionario regio di alto livello, un’ampia donazione di terre del suo territorio, perché vi sor-gesse un nuovo monastero florense12. Dopo la morte di Gioacchino, fu naturalmente Matteo che ne gestì la fondazione: nel corso del 1203 si era già costituita una comunità monastica, retta dal priore Benedetto, e senza dubbio i monaci di Fonte Laurato proveni-vano dal monastero silano13. Si può allora ipotizzare che la scelta di coloro che si sarebbero spostati nella nuova fondazione abbia potuto provocare fratture e invidie nella comunità di Fiore: dopotutto, il mo-nastero di Fiumefreddo doveva sorgere in una loca-lità ben più temperata, a non grande distanza dal mare, a media altezza sulla Catena Costiera, e qui la vita sarebbe stata certamente più facile che sulla Sila, a circa mille metri di altitudine e in una zona in cui non erano mancate violenze e contrasti. Chi non fu destinato a Fonte Laurato forse pretese che si cercasse, nella diocesi di Cosenza, una località meno impervia anche per la comunità madre di Fiore. Non si può escludere neppure l’ipotesi che Matteo inten-desse costituire a Botrano la sede centrale dell’ordine florense “settiforme”, riservando al locum Floris, che sarebbe comunque rimasto tra le proprietà dell’ab-bazia, la funzione di eremo avuta in origine, anche perché, da quel che sembra, il progetto di fondare una nuova abbazia ad Albeto/Caput Album era fallito14.
Quali siano state le motivazioni della richiesta, il pontefice scrisse dunque a Luca, nominato da pochi
mesi arcivescovo, e al capitolo cosentino, perché ac-consentissero allo scambio richiesto da Matteo. In caso di opposizione, il pontefice avrebbe incaricato gli abati di Santo Spirito di Palermo e di Corazzo e un certo Ruggero di Turzano, persona evidentemen-te di sua fiducia, di far eseguire il suo mandato. Il presule e i due abati cistercensi risposero ben presto al pontefice, dichiarando di essere giunti, in linea di principio, a un accordo con il monastero: in cam-bio della chiesa di Botrano, del suo tenimento e una parte del bosco pertinente alla mensa del vescovo, questi aveva ottenuto da Fiore la chiesa di Bottulo e il suo tenimento, le proprietà di Canale con la chiesa di San Martino, di recente ricevuta dal predecessore, e una vasta tenuta sulla Sila. Da un punto di vista quantitativo, i beni che la chiesa di Cosenza otteneva erano assai maggiori: «in cambio delle terre, terreni migliori e quattro volte più vasti, in cambio di un mulino, due di cui uno con follone, in cambio di un bosco, uno più grande e migliore, in cambio di vigne, vigne migliori e più numerose»15. Tuttavia, la maggiore ampiezza era controbilanciata dalla gran-de distanza di questi beni da Cosenza, dal momento che il tenimentum silano era «così tanto distante dal-la città, che lo si può raggiungere a malapena in due giorni». Proprio a causa della lontananza eccessiva, i canonici di Cosenza si erano opposti risolutamente allo scambio e di conseguenza gli esecutori del man-dato si erano visti costretti a sospendere i canonici dal ricevere le rispettive prebende16.
Tra il settembre 1203 e il 6 febbraio dell’anno successivo si presentarono di fronte a Innocenzo III le due parti in causa, quella di Fiore, rappresenta-ta da Matteo e da alcuni dei suoi monaci, e quella dei canonici cosentini17. Entrambe fecero presenti al pontefice le loro ragioni: i monaci di Fiore evidente-mente non potevano più reggere una vita così dura; dal canto loro, i canonici ribadivano al pontefice che lo scambio proposto non era equilibrato, né oppor-tuno, né di alcuna utilità per la chiesa cosentina: rinunciare alle terre di Botrano significava perdere possessi da cui in quei tempi di guerra la chiesa non aveva problemi a raccogliere vettovaglie, legname e altri beni18.
Innocenzo intendeva sostenere i monaci di Fiore, ma nello stesso tempo non voleva che gli interessi della chiesa cosentina fossero lesi enormiter. Per tale motivo incaricò il vescovo e il tesoriere di Martirano perché indagassero, insieme agli abati cistercensi di Corazzo e di Acquaformosa, sull’equità dello scam-bio, costringessero i canonici ad accettarlo se lo aves-sero reputato equo, o, in caso contrario, decretassero nullo l’accordo.
215
Nel giugno del 1204 il pontefice fu nuovamente costretto a intervenire, indirizzando ai canonici una lettera estremamente dura con cui li invitava ancora una volta a sottoscrivere l’accordo19. Gli incaricati all’indagine avevano infatti verificato, seppure non all’unanimità, l’equità dello scambio. Innocenzo III accusava pertanto i canonici del capitolo cosentino di non essere mossi né dallo zelo di Dio, né dall’in-dempnitas della chiesa di Cosenza; avrebbero piut-tosto temuto che la vicinanza di una comunità di religiosi mettesse in evidenza la loro irreligio e che l’onestà dei monaci manifestasse ampiamente la loro disonestà. In altre occasioni infatti i canonici aveva-no acconsentito senza problemi alla cessione di beni del capitolo. Per mutare il male in bene, Innocenzo li esortava ad accettare lo scambio e il trasferimen-to a Botrano della comunità di Fiore; egli, da parte sua, avrebbe volentieri accettato la loro obbedien-za, anche se tardiva, e ne avrebbe tenuto conto in altre occasioni future20. Le pressioni ebbero infine l’esito desiderato: nel corso del mese successivo, il documento di scambio fu accettato e sottoscritto da tutto il capitolo. Lo troviamo inserto nella lettera di conferma da parte di Innocenzo, diretta non più alla comunità di Fiore, ma a «Matheo et fratribus mona-sterii sancte Marie de Botrano»21.
Il capitolo di Cosenza cedeva dunque a Matteo - nell’accordo è chiamato ancora abbas Floris - le chie-se di Santa Maria, di San Nicola e di Sant’Angelo, poste nella tenuta di Botrano, e il tenimento stesso. Esso comprendeva un bosco, alcune vigne, alberi, corsi d’acqua e un mulino; la chiesa di Cosenza si riservava l’usum incedendorum lignorum in una sua parte. Da parte sua, il monastero di Fiore cedeva la chiesa di San Nicola di Bottulo con il suo tenimento, e le vigne, gli alberi, il mulino e il follone che vi si trovavano, un secondo mulino, posto sul fiume Car-done, che Fiore aveva acquisito nel 1198, la tenuta di Canale, compresa la chiesa di San Martino de Ioue, ottenuta dall’arcivescovo Andrea tre anni prima, dove ancora riposava il corpo di Gioacchino, e infine parte del vasto tenimento in Sila, probabilmente proprio la sezione concessa da re Tancredi nel 1191. Anche di quest’ultima tenuta si riportavano i confini.
A conclusione della vicenda, Innocenzo III indi-rizzò a Matteo, ormai chiamato abate di Santa Maria di Botrano, la bolla solenne di approvazione della futura nuova abbazia, che doveva sorgere sul terreno ottenuto dal capitolo cosentino, concedeva la pro-tectio apostolica e l’esenzione dall’ordinario diocesa-no22. In essa erano elencati i beni del nuovo cenobio, la maggior parte dei quali ovviamente faceva parte dell’originario patrimonio di Fiore. Vale la pena di
percorrere in modo completo l’elenco, per valutare lo status patrimoniale florense alla fine del 1204. Il monastero che doveva sorgere a Botrano possedeva innanzitutto il tenimento di Botrano stesso con le chiese di Santa Maria, presso cui doveva insediarsi la comunità, di San Nicola e di Sant’Angelo. I beni sulla Sila comprendevano ancora il locum Floris, Calosuber (cioè la dipendenza di Bonum Lignum), Faradomus (o Faraclovus o ancora Faraclomitus) e al-tre tenute, ovvero le terre dette Semigari, Eremita, Campo di Manna, Missi, Gimellara, ciascuna con le proprie pertinenze, ancora i tenimenta di Garga, di Fragulo, di Tassitano (dove era sorta un’altra dipen-denza di Fiore), e di Caput Rose. A queste numerose località si aggiungevano le terre lavorative, i pascoli, i boschi e i corsi d’acqua compresi nella donazione ricevuta da Enrico VI, da cui mancava tuttavia la parte ceduta al capitolo di Cosenza. La donazione imperiale era completata dalla tenuta di Fiuca, in maritima Calabrie, dal reddito di cinquanta bisanti d’oro da trarre dalle entrate della salina del Neto, dal monastero di Abate Marco e dall’obbedienza di San Martino de Neto. Infine il pontefice ricordava anche i beni posseduti nel territorio di Fiumefreddo, le case a Cosenza, una casa offerta dal frater Giovanni di Rogliano e un’altra abitazione, sita in arce Cusentie, acquistata dal monastero. Nei suoi pressi, il nuovo cenobio possedeva anche alcuni casalini, donati da un giustiziere non meglio noto.
La comunità rimaneva in possesso dell’originario locum Floris e di numerosi terreni montani; sempre a detta dei canonici, i florensi, pur dichiarando di non poter più risiedere stabilmente sulla Sila a causa del freddo e delle guerre, volevano tuttavia mantenere i loro usi in quella zona, in particolare probabilmente i pascoli, da utilizzare durante i mesi estivi23.
Colpisce che nel solenne privilegio di protezione concesso dalla Santa Sede non si trovi la tradiziona-le clausola di regolarità nella sua forma completa: il pontefice stabiliva «ut ordo monasticus, qui secun-dum Deum et beati Benedicti regulam in eodem monasterio (...)», senza aggiungere, come invece era accaduto poco tempo prima nel caso dell’analo-go privilegio concesso al cenobio di Fonte Laurato, «atque institutionem Florensium fratrum»24. Potreb-be trattarsi solo di una dimenticanza e di una svista da parte della cancelleria papale, ma forse è possibi-le spiegare altrimenti tale mancanza. Sappiamo con certezza che la fondazione di Gioacchino godeva della protezione pontificia in data anteriore al marzo 1200, ma ignoriamo quando essa fu effettivamente concessa. Potrebbe anche darsi allora che il privilegio fosse stato rilasciato anteriormente all’approvazione
216
delle istituzioni florensi (1196), e che quindi la clau-sola di regolarità non potesse naturalmente specifi-care «atque institutionem Florensium fratrum». In tal caso, il privilegio concesso a Fiore potrebbe esser stato usato come Vorurkunde, modello per quello ri-lasciato a Santa Maria di Botrano: per tal motivo in quest’ultimo non si troverebbe la clausola di regola-rità nella sua formula completa previsto per l’ordo florense, ma solo secondo la formula usata generica-mente per i monasteri benedettini.
Evidentemente finalizzata al trasferimento nelle terre di Botrano fu la concessione, da parte del pic-colo re Federico, di alcuni terreni posti in una loca-lità chiamata Berano, nei pressi di Mendicino, data-bile al marzo 120525. Da un privilegio regio succes-sivo, sappiamo infatti che il «tenimentum terrarum, qui dicitur Bayrani, (...) est iuxta prefatas ecclesias Butrani»26. Ancora nel settembre del 1206 i florensi erano decisi a trasferirsi, dato che Matteo - chiamato tuttavia abate di Fiore - ricevette da parte di Federico re di Sicilia la conferma dei possessi di Botrano27. In questo documento regio, con cui Federico con-fermava anche la confinante proprietà di Berano e tutti gli altri possessi e libertà del monastero, si trova il primo accenno in ordine di tempo, da parte della corte regia, al fatto che il monastero di Fiore fosse stato fondato dai genitori del giovane re28. Proprio sulla base di queste affermazioni, riprese anche in se-guito da Federico divenuto ormai imperatore, si ten-tò a più riprese, nel corso del tempo, di attribuire ai regnanti di Sicilia il regio patronato sul monastero29. In realtà Enrico VI aveva esplicitamente affermato che il cenobio era stato fondato da Gioacchino; egli si era limitato ad ampliare notevolmente, con nuove proprietà di terre, il primitivo locum Floris, del re-sto già in precedenza accresciuto grazie al privilegio concesso da re Tancredi a Gioacchino, e a concedere importanti ed estesi diritti, redditi e libertà.
Il trasferimento tuttavia, inizialmente persegui-to con tanta risolutezza, alla fine non ebbe luogo. A quanto pare, parte dei monaci difese l’originaria sede e riuscì forse a far maturare, in tutta la comu-nità florense, la consapevolezza che il locum Floris avrebbe dovuto essere, in futuro, una nuova Naza-ret, il luogo a partire dal quale il Signore avrebbe operato un’azione di salvezza, e dunque i monaci di Fiore avrebbero infine optato per la permanenza sulla Sila30. Molto più semplicemente invece, può essere che il capitolo di Cosenza, evidentemente molto potente, fosse riuscito comunque a imporre la propria linea, anche contro le direttive papali, e che solo, o anche, per questo motivo i florensi, alla fine, dovettero rassegnarsi a rimanere nel loro origi-
nario monastero. Il ruolo di visitatore del cenobio florense, affidato all’arcivescovo cosentino Luca dal 1206 al 1211, potrebbe aver influito sulla decisione di non dar luogo al trasferimento: Luca si era trovato in aperto contrasto con i canonici della cattedrale, tanto da temere per la propria incolumità, sia perché aveva appoggiato i florensi in occasione dello scam-bio, sia a motivo di un tentativo di riforma degli usi liturgici della cattedrale31. È dunque possibile che, per sanare le tensioni createsi con il capitolo, l’arci-vescovo avesse suggerito e incoraggiato i monaci di Fiore a far cadere lo scambio ormai già approvato.
L’accantonamento definitivo del progetto di tra-sferimento diviene palese a partire dal 1207: i docu-menti pontifici, nel 1204 diretti alla futura comuni-tà di Santa Maria di Botrano, furono nuovamente diretti al monastero di Fiore32. Nel 1208 poi sono attestate a favore di Fiore sia una nuova bolla di protezione e di esenzione, sia un ulteriore privilegio regio, con cui Federico riconfermava a Fiore tutti i beni silani concessi dai genitori e le tenute di Canale e di Bottulo, a riprova che lo scambio con la chiesa cosentina era definitivamente caduto e che Fiore era di nuovo in possesso delle proprietà che in preceden-za erano state oggetto di quello scambio. Non sono invece più nominate, come era invece stato fatto nel documento regio precedente, le terre di Botrano33.
Connessa, dicevamo, alla questione del trasferi-mento e alla sua definitiva chiusura fu probabilmen-te la richiesta, rivolta al pontefice, che il monastero fosse sottoposto alla visita dell’arcivescovo di Cosen-za per un periodo di cinque anni34. Luca non riuscì a svolgere il suo incarico almeno fino all’aprile del 1209: Matteo riferiva infatti che il presule si era scu-sato mediante lettera di non potersi recare a Fiore perché la sua vita era minacciata35. Per tale ragione aveva delegato l’incarico a un confratello cistercense, Alessandro, abate di Santo Spirito di Palermo. Nel corso del quinquennio di visita, le comunità florensi di Fiore, di Fonte Laureato e di Acquaviva riforma-rono le loro istituzioni con il consiglio di Luca e di Alessandro36.
Il privilegio di Federico concesso nel luglio 1208 riconfermava sostanzialmente il privilegio di Costan-za del 1198. Rispetto ad esso, si erano aggiunti beni a Canale, a Bottulo e una serie di proprietà nel ter-ritorio di Cosenza, comprese abitazioni e casalina, e infine i beni nel tenimentum di Cerenzia, in partico-lare il luogo di Albe, vicino al casale di Berdò. Furo-no naturalmente riconfermate le tenute sulla Sila e in maritima Calabrie, le libertà di pascolo in tutta la Calabria, il diritto di ricevere sale dalle saline della
217
regione, di comprevendita senza gabelle, e il reddito di cinquanta bisanti d’oro dalle saline del Neto. Fede-rico ricordava anche i monasteri dipendenti da Fiore, come in precedenza aveva fatto sua madre: Calosuber o Bonum Lignum, Tassitano e il monastero di Abate Marco. Ad essi ormai andavano aggiunti anche i mo-nasteri di Fonte Laurato e di Acquaviva37. Possiamo considerare le parole di Federico come lo status del-l’ordine florense in Calabria nel luglio del 1208.
Nel periodo compreso tra il 1206 e il 1209, il monastero acquisì ulteriori proprietà nella zona nei pressi di Canale: nel 1206 la quarta parte di un mu-lino sul fiume Cardone, e la quarta parte della te-nuta corrispettiva, donate da Maurizio, un miles di Turzano; l’anno seguente si aggiunse la donazione del possesso di mezzo mulino, sempre sul Cardone (non sappiamo se si tratti dello stesso), da parte di Pietro, figlio di tal Michele Spina di Spezzano Parvo. Nel 1211, uno dei mulini posti lungo il corso del Cardone fu dato in affitto alla famiglia de Scarcello di Pedace, e in tal modo il monastero riceveva un nuovo reddito38. A Canale il monastero ricevette, nel 1209, la donazione di un querceto, da un certo Mauro di Tiniano; un altro querceto a Canale era stato acquistato l’anno precedente. Infine, nel 1209, Guido della Macchia donò una vigna sita in Peda-ce39. Alla ben gestita espansione nella zona di Ca-nale, nelle vicinanze di Cosenza, e dunque a ovest del monastero, corrispondeva un’analoga crescita dei possessi a est-sudest, fino a toccare la costa adriatica e ionica, nei territori di Cerenzia e di Santa Seve-rina. Nel settembre del 1209, infatti, il vescovo di Cerenzia, Bernardo, in precedenza abate della Sam-bucina, offrì al monastero florense alcune vigne nei territori di Cerenzia e di Caccuri, presso il casale di Verdò o Berdò, dove Fiore possedeva già alcuni beni in località detta Albe40. La donazione del vescovo Bernardo fu confermata da Innocenzo III nel set-tembre del 121141. A partire dal 1210, la documen-tazione attesta che qui venne costituita una grangia, secondo la tipica organizzazione e lessico cistercensi, a conferma della svolta più generale in questo senso - appunto cistercense - intrapresa dall’ordine dal se-condo decennio del XIII secolo42. Ancora nel 1209 anche l’arcivescovo di Santa Severina, con il consen-so del capitolo, avrebbe contribuito all’espansione di Fiore nella zona est della Sila, concedendo la chiesa di Castellacio, di competenza della sua diocesi, con tutte le sue pertinenze43.
I rapporti con la corte di Federico, re di Sicilia, si intensificarono nel corso del 1210: nel mese di mag-gio, il re riconfermò la donazione delle terre coltiva-te di Berano, nel territorio di Mendicino, concesse
qualche anno prima44. Il re aggiunse anche una «ter-ram laboratoriam ad duas salmatas» nel territorio di Cerenzia, con il permesso di costruire, nei possessi del monastero in quella zona, un mulino e un follo-ne; concedeva infine la proprietà delle miniere che si fossero trovate nel tenimento dell’abbazia, senza pagamento di gabelle. Nello stesso modo, i monaci di Fiore avrebbero potuto cavare et percipere il fer-ro da tutte le miniere della Calabria «absque ulla exactione». Federico giustificò le concessioni per il fatto che il monastero in quel periodo aveva subìto «dapna plurima et dispendia (...) propter temporis turbationem»45, probabilmente dovuti alla discesa in Italia di Ottone IV, che il 4 ottobre 1209 era stato incoronato imperatore a Roma e che in seguito tentò di occupare il regno meridionale.
Nell’agosto dello stesso 1210, l’abate Matteo si recò personalmente alla corte di Federico, a Messina, per ricevere conferma di alcune donazioni e libertà concesse negli anni precedenti. Il privilegio rilascia-to dal re di Sicilia in quell’occasione confermò in particolare un documento di Stefano Marchisorti, conte di Crotone. Costui aveva offerto ai monasteri di Fiore e di Acquaviva la tenuta di Fontana Mura-ta, nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, perché vi svernassero i loro animali, e diverse libertà: di com-pravendita nella terra comitale, di tenere barche sia per la pesca sia per il trasporto, di costruire mulini e folloni, di pascolo e di passaggio senza esazioni46. Il possesso della tenuta fu confermato anche da In-nocenzo III nel febbraio del 121547. Con un docu-mento precedente, rilasciato nel mese di maggio, re Federico riconfermò le terre di Canale e di Bottulo: il monastero avrebbe potuto possederle libere dai vincoli feudali a cui, fino a quel momento, erano state evidentemente sottoposte48. La richiesta di conferma da parte del re fu dovuta probabilmente anche al fatto che, nel corso degli anni precedenti, era stata sollevata una questione riguardo al possesso di queste terre: l’indice dell’archivio di Fiore attesta infatti l’esistenza di un «instrumentum cessionis litis et cause mote per Mattheum de Vico casali Tursani super possessione Canalis grancie monasterii floren-sis, anno 1208»49.
2. La contesa con i cistercensi di Corazzo
Il progetto di trasferimento ventilato fin dal 1203 è probabilmente in relazione con un’altra vicenda, conclusa solo nel 1211: nei primi anni del ‘200 si accese una contesa con il monastero di Corazzo per
218
il possesso della chiesa e del monastero greco di Ca-labro Maria, posto in diocesi di Santa Severina, a non molta distanza da Fiore.
Alla fine del XII secolo il cenobio greco ospita-va ancora un gruppo di monaci, in buone relazioni con le vicine comunità latine; si trattava chiaramen-te, tuttavia, di una comunità in crisi, se, alla morte dell’ultimo abate greco, Kirolus, non sembra che i monaci fossero riusciti a sostituirlo. La comunità era talmente ridotta nel numero da non riuscire più a gestire opportunamente i beni temporali del mona-stero, e così impoverita che si trovò costretta a ri-cevere dal monastero di Corazzo «tam indumenta, calcieamenta, corrigas, quam etiam alia necessaria, praeter victum»50. Il monastero, oltre a tenere buo-ni rapporti con la comunità di Corazzo, si era ben presto legato anche al nuovo gruppo religioso stabi-litosi a Fiore; tale circostanza, nel momento in cui la comunità greca si esaurì, generò un contrasto tra le due fondazioni latine per il possesso del cenobio de-caduto. Nel 1211, infatti, si presentarono di fronte a Innocenzo III i rappresentanti delle due comunità, di Fiore e di Corazzo, che rivendicavano entrambe diritti acquisiti sulla chiesa di Calabro Maria, per ricevere dal pontefice la sentenza definitiva riguar-do alla disputa. I monaci di Corazzo, innanzitutto, fecero presenti al papa i legami che da tempo uni-vano i due cenobi: essi in diverse occasioni avevano amministrato subsidia all’abate e ai monaci di Cala-bro Maria. Dopo la morte dell’abate Kirolus, l’eco-nomo e i monaci del cenobio greco avevano offerto il loro monastero al cellerario di Corazzo (si noti: non all’abate), ricevendone in cambio vari generi di prima necessità. Solo in un momento successivo i monaci cistercensi si erano mossi per far riconoscere ufficialmente il passaggio di proprietà: innanzitutto da parte del re di Sicilia, Federico, dal momento che quest’ultimo era ritenuto il patronum principalem della fondazione greca. Questa prima richiesta an-drebbe posta pertanto in un momento successivo al novembre 1198, ossia dopo la morte di Costanza. Corazzo richiese poi l’approvazione anche da parte del capitolo di Santa Severina, diocesi in cui sorgeva il monastero, e infine quella dell’arcivescovo, di cui avevano atteso la consacrazione a Roma e il rientro in sede51. L’arcivescovo è stato identificato da Nor-bert Kamp con Dionisio, presule di Santa Severina a partire dal settembre 120552. La cessione del mo-nastero di Calabro Maria al cellerario di Corazzo è dunque senz’altro precedente a questa data. I monaci di Corazzo aggiunsero poi di essersi rivolti proprio al monastero di Fiore per avere qualche consiglio sul da farsi; i monaci florensi, nell’occasione, avevano ga-
rantito che avrebbero prestato tutto il loro aiuto per definire al meglio la faccenda53. In seguito tuttavia, dimentichi delle loro promesse, i florensi si sarebbe-ro rivolti ad un certo Pietro Guiscardo, signore di Santa Severina, perché concedesse la chiesa di Cala-bro Maria al loro monastero; il nobile, inizialmente poco disponibile, avrebbe ceduto alle richieste per l’insistenza della moglie. Il nobile aveva poi costretto i canonici della cattedrale a ratificare la concessione, benché l’arcivescovo fosse allora a Roma, minaccian-doli di far cacciare le loro mogli (trattandosi di preti greci erano infatti sposati). Sempre ricorrendo alla violenta autorità di Pietro Guiscardo, i monaci di Fiore avrebbero estorto la conferma della chiesa an-che all’arcivescovo, a cui erano andati incontro men-tre rientrava nella sua diocesi, atto che i monaci di Corazzo denunciarono come irregolare dal momen-to che l’arcivescovo non aveva ancora preso possesso della propria sede54.
Da parte loro, i monaci di Fiore replicarono affer-mando che, sebbene la chiesa fosse stata concessa a Corazzo, tuttavia l’atto non si poteva considerare va-lido, dal momento che era stato compiuto dall’eco-nomo e dai monaci, non da un regolare superiore. Inoltre, ben prima di questo accordo, ancora ai tem-pi dell’ultimo abate greco, la chiesa in questione era stata concessa da quest’ultimo e dai suoi monaci a Gioacchino, e anche dopo la morte dell’abate Kiro-lus i monaci di Calabro Maria avevano confermato in più occasioni tale concessione. Le conferme avute dal capitolo e dall’arcivescovo di Santa Severina, poi, non erano state affatto estorte con la violenza, ma piuttosto «mera et eorum libera voluntate». I florensi contestarono anche l’autenticità del documento re-gio prodotto dai monaci di Corazzo: esso risultava rogato dalla cancelleria diretta da Gualtiero di Pa-learia, ma in realtà la cosa non era possibile perché Gualtiero, alla data del documento, non si trovava più a Palermo e Federico e il suo sigillo erano sot-to la custodia di Guglielmo Capparone55. A questo proposito, c’è da segnalare che in effetti alcuni do-cumenti superstiti di Corazzo risultano falsificati: l’irregolarità del documento presentato dai monaci di Corazzo potrebbe essere dunque un ulteriore te-stimone di una consuetudine alla falsificazione da parte di questo monastero56. Nel testo della sentenza è riportata in dettaglio la lunga discussione, sorta tra i monaci di Corazzo e di Fiore, riguardo alla validi-tà sia del primo documento, sia delle sue successive conferme da parte di re Federico57.
Per inquadrare al meglio i motivi della disputa, è necessario innanzitutto tenere ben presente il ruolo ambiguo che per un certo periodo aveva senza dub-
219
bio caratterizzato Gioacchino, il quale da una parte era ancora ufficialmente l’abate di Corazzo (le fonti cistercensi gli riconoscono la carica ancora nel 1195 circa58), e come tale poteva aver ricevuto dall’abate Kirolus e dai monaci di Calabro Maria la conces-sione di beni del monastero greco anche successiva-mente alla salita in Sila; dall’altra, tuttavia, la con-cessione fu data probabilmente proprio nel periodo in cui l’abate cistercense si era già trasferito a Fiore, pur mantenendo il titolo di abate di Corazzo. Anco-ra sotto questo titolo, ma in realtà già vivendo sulla Sila come guida carismatica di una nuova comunità eremitica, avrebbe ricevuto dunque alcuni beni del cenobio greco. A conferma di ciò vi è forse il fatto che in un periodo successivo, quando evidentemen-te Gioacchino aveva optato definitivamente per la vita a Fiore, fu il cellerario di Corazzo a ricevere i beni di Calabro Maria, e non un suo abate. Lo stesso locum Floris, se non apparteneva al cenobio stesso di Corazzo, potrebbe essere stato uno dei possessi che i monaci greci avevano concesso a Gioacchino nella fase di transizione dal monastero all’eremo ci-stercense, considerata anche la vicinanza delle due fondazioni.
Fino al 1203 i monaci di Corazzo probabilmente non avevano mai pensato di rivendicare le proprie-tà di Calabro Maria concesse a suo tempo al loro abate, con il quale erano forse giunti a un accordo orale. Nel momento tuttavia in cui la comunità di Fiore, morto il fondatore, progettava di trasferirsi a Botrano abbandonando la Sila, i cistercensi si erano fatti avanti, per riavere quanto a loro giudizio spet-tava a Corazzo. Evidentemente, se in precedenza i monaci erano stati disposti a lasciare parte dei loro beni a colui che era stato il loro abate e alla sua nuo-va comunità - piccola cellula distaccatasi proprio da Corazzo - , ben diversa doveva essere la loro posizio-ne nel momento in cui si prospettava l’eventualità che quei beni divenissero oggetto di scambio con la chiesa cosentina, per ottenere terreni nei pressi della città. Oltretutto, i cistercensi erano bene informati sulle intenzioni dei monaci florensi, dal momento che l’abate di Corazzo era uno dei delegati, incaricati nel 1203 da Innocenzo III, di far eseguire il mandato della sede romana e di valutare l’equità dello scambio di terre tra le due istituzioni. A quel punto, dunque, i cistercensi si sarebbero indirizzati a richiedere dap-prima a re Federico, poi ai canonici e all’arcivescovo di Santa Severina, la conferma delle loro proprietà, avute anni prima dal cenobio greco (o a produrre dei falsi, che attestassero i loro possessi).
La questione, demandata direttamente al pontefi-ce dopo l’inquisitio dei vescovi di Squillace e di Mar-
tirano e dell’abate della Sambucina, fu chiusa nel settembre del 1211. Innocenzo non prese posizione rispetto alle contestazioni che erano state sollevate riguardo alla validità dei documenti delle due parti: egli in effetti accantonò tutte le discussioni e asse-gnò il monastero di Calabro Maria ai florensi non sulla base di una maggiore validità della documen-tazione, ma per il fatto che la regola e le istituzioni cistercensi, seguite a Corazzo, proibivano di «labora-re ad obtinendam sic ecclesiam», senza una precisa dispensa dei superiori. La proibizione non sembra valere anche per i florensi, ai quali dunque, da quello che possiamo capire, era permesso possedere chiese, o perlomeno non era esplicitamente vietato59.
3. La prima diffusione
Tra la morte del fondatore e l’incendio del mona-stero l’istituzione florense dovette richiamare indub-biamente molti seguaci: il cenobio silano fu infatti in grado di creare tre nuove comunità autonome e indipendenti, in altrettante diocesi calabresi, e di progettarne una quarta, in realtà poi mai sorta. Il primo di essi fu, come abbiamo in parte già visto, quello di Fonte Laurato, in diocesi di Tropea, di cui già Gioacchino aveva gettato le basi. Seguì, in data imprecisata, ma certo anteriore al 1208, il monaste-ro di Acquaviva, in diocesi di Catanzaro, del quale tuttavia possediamo una scarsissima documentazio-ne e di cui mancano del tutto notizie relative alla fondazione. Qualche anno più tardi si aggiunse il cenobio greco di Calabro Maria, in diocesi di Santa Severina, riformato secondo la regola di Benedet-to e le istituzioni florensi a partire dal 121360. Di questi primi monasteri generati da Fiore seguiremo le vicende nei prossimi capitoli (in particolare nel capitolo dedicato ai monasteri della Calabria); ora vale la pena di soffermarci sul tentativo, che per lun-go tempo rimase disatteso, di estendere l’esperienza florense anche nella limitrofa diocesi di Cerenzia. Qui per un certo periodo, a partire dal 1209, l’abate Matteo tentò infatti di istituire un quarto cenobio: presso il monastero di Monte (o Abate) Marco, dove negli ultimi anni del XII secolo l’abate Gioacchino aveva forse istituito uno dei sette priorati, sarebbe dovuto infatti sorgere un nuovo monastero florense, ora come abbazia indipendente e autonoma61. Con questo scopo il vescovo Bernardo, di provenienza ci-stercense, donò a Matteo le chiese di Santa Maria de Agradia e di San Lorenzo, perché fossero unite al monastero e alla chiesa di Monte Marco. Nell’occa-sione, questa fondazione fu riconfermata all’abbazia
220
di Fiore, dopo le devastazioni subite a opera di Gu-glielmo, predecessore di Bernardo sulla cattedra di Cerenzia. Tra i beni di pertinenza del monastero si-lano era, inoltre, compresa la chiesa di San Martino de Neto, anch’essa riconfermata dal vescovo; come censo ricognitivo complessivo (per Monte Marco, Santa Maria di Agradia e San Lorenzo) si chiedeva l’offerta di quattro libbre di cera e tre di incenso62. La concessione di tre chiese al fine di far sorgere un nuovo monastero florense non pare casuale: una strategia simile infatti aveva mosso i florensi ancora nel 1203-1204, in occasione del tentativo di trasfe-rimento a Botrano. In quell’occasione essi avevano ottenuto dall’arcivescovo di Cosenza e dal capitolo della cattedrale tre chiese site a Botrano, quella di Santa Maria, una dedicata a san Nicola e una detta di Sant’Angelo63.
Sebbene la realizzazione di un monastero floren-se della diocesi di Cerenzia non venne realizzata in quel momento, ma solo alcuni decenni più avan-ti, i documenti di avvio delle relazioni tra Fiore e il vescovo della vicina diocesi permettono di com-prendere le linee con cui si volevano impostare le relazioni tra istituzioni monastiche florensi e quelle ecclesiastiche. Il vescovo di Cerenzia Bernardo, pur accettando il fatto che il nuovo cenobio legato a Fiore avrebbe goduto, al pari della casa madre, del privilegio dell’esenzione64, tenne tuttavia a specifi-care che il superiore del monastero avrebbe dovuto ricevere il munus benedictionis e gli altri sacramen-ta dall’ordinario locale. Da quello che sappiamo, Fiore invece godeva di un’esenzione più piena: se-condo quanto aveva dichiarato il cardinale Cinzio già nel 1200, l’abate della nuova fondazione da lui approvata, come quello di Fiore, poteva ricevere la benedizione abbaziale da un qualsiasi vescovo, a sua scelta. L’abate del monastero nella diocesi di Ceren-zia, invece, avrebbe potuto rivolgersi a un vescovo di sua preferenza solo in casi specifici, quali la vacanza della diocesi o un netto rifiuto da parte del vescovo locale, secondo una prassi e il linguaggio curiale ben attestato presso i cistercensi (e Bernardo era stato in effetti un abate cistercense). Inoltre, egli regolò i rap-porti con il monastero nel caso i canonici e i chierici della diocesi avessero voluto vestire l’abito monasti-co. Le condizioni poste dal vescovo erano precise: se la loro scelta fosse stata compiuta ancora nel pieno delle forze, avrebbero potuto entrare nel monastero con tutti i loro beni mobili; nel caso invece si fos-se trattato di una scelta fatta in punto di morte, in extremis, avrebbero potuto legare al cenobio floren-se solo fino alla terza parte di essi65. Si tratta delle medesime condizioni poste da Riccardo, vescovo di
Tropea, ai propri canonici e chierici nel caso avesse-ro voluto entrare nel monastero di Fonte Laurato, ed è probabile che il suo privilegio del maggio 1204 sia servito da riferimento se non da Vorurkunde per quello di Bernardo.
Nel 1217, a causa della malitia temporum, delle guerre e dell’incendio del loro monastero, i florensi non erano ancora stati in grado di distaccare un loro gruppo nella chiesa di Monte Marco per costituire la nuova comunità monastica florense nella diocesi di Cerenzia66. Il nuovo vescovo Nicola, succeduto a Bernardo, nel mese di gennaio di quell’anno giun-se allora a un nuovo accordo con i monaci di Fio-re. Questi ultimi resero alla diocesi di Cerenzia le due chiese di Santa Maria di Agradisa (o Agradia) e di San Lorenzo, avute da Bernardo, dal momento che esse - come pure quelle di Monte Marco e di San Martino del Neto - sorgevano troppo vicino al nuovo monastero di Fiore, in fase di costruzione, al punto che «sine illius damno, vel scandalo non pos-set in eis cenobium ordinari»67. Il vescovo confermò invece il possesso della chiesa di Monte Marco e del-l’obbedienza di San Martino del Neto, specificando tuttavia che i florensi non sarebbero più stati tenuti a costituire in quella sede un cenobio florense, ma che esse venivano concesse come beni immobili per sostenere il nuovo monastero di Fiore68, al censo an-nuo di un bisante d’oro.
Quanto al monastero florense previsto per la dio-cesi di Cerenzia, Nicola, per rimanere fedele alla vo-lontà dei suoi predecessori e al proposito dei floren-si, concesse il monastero, ormai decaduto, di Santa Maria di Cabria con tutte le pertinenze e beni che possedeva a Cerenzia e nel suo territorio, ad ecce-zione della chiesa di San Nicola de Myliato, e sotto il censo annuo di sei libbre di cera e tre di incenso. Il nuovo monastero sarebbe stato soggetto alle me-desime condizioni relative all’esenzione dall’ordina-rio previste a suo tempo dal vescovo Bernardo per il cenobio che doveva sorgere nella chiesa di Mon-te Marco. Nicola non fece più cenno, invece, alla possibilità che i chierici di Cerenzia vestissero l’abito monastico nel nuovo monastero.
Anche questo progetto non ebbe in realtà seguito; solo alcuni decenni più tardi i monaci florensi furo-no in grado di organizzare un cenobio nella diocesi di Cerenzia, quando, verso il 1259, fu loro affidata la riforma del monastero di Santa Maria Nuova, ov-vero l’ex monastero greco dei Tre Fanciulli.
221
4. L’incendio e la ricostruzione
Il successo che Fiore conobbe a partire dal secon-do decennio del XIII secolo subì una prima battuta d’arresto nel 1214, quando, a causa di un violen-to incendio che distrusse la primitiva fondazione di Gioacchino, le priorità immediate per forza di cose mutarono e i florensi furono costretti a dedicarsi alla ricostruzione della loro nuova sede.
La prima notizia, in ordine di tempo, relativa alla distruzione della primitiva sede florense ci è traman-data da un documento del conte di Crotone, Stefano Marchisorti, che in quell’occasione venne definito come capitateus et magister iusticiarius di Calabria. Già in altre circostanze il conte e la sua famiglia si erano dimostrati protettori e benefattori dell’abbazia silana69; nell’ottobre del 1214 Stefano concesse alla comunità florense, su preghiera dell’abate Matteo, un terreno coltivato detto de Mardati, sito nel ter-ritorio di Cerenzia, libero da ogni esazione e diritto comitale. Tra le ragioni addotte per motivare la sua donazione, egli si dichiarava addolorato per il triste avvenimento che aveva colpito i monaci, appunto il «monasterii Florensis incendio»70. Il termine ante quem dell’incendio di Fiore è dunque da porre nel-l’ottobre del 1214: esso probabilmente cade in un momento non troppo lontano da questa data. Pochi mesi più tardi infatti, nel gennaio del 1215, un pri-vilegio di Costanza d’Aragona - reggente del regno di Sicilia durante l’assenza del marito, in quegli anni in Germania - e del figlio Enrico ricordava l’incen-dio come avvenuto «hiis diebus»71. Nel documento, Costanza ricordava anche che l’incendio di Fiore era stato di notevoli proporzioni: aveva infatti danneg-giato il centro monastico «in omnibus hedificiis suis». Per tale motivo, la regina ed Enrico confermavano, «pro restauratione» degli edifici, la donazione della «culturam Mardati», ottenuta in precedenza dal con-te di Crotone. La terra, che faceva parte del demanio regio, sarebbe stata libera da ogni servitù. Probabil-mente nella medesima occasione la regina concesse a Matteo un secondo privilegio, con cui confermava tutti i beni posseduti dal monastero di Fiore, in par-ticolare la grangia di Albe presso il casale di Berdò, nel territorio di Cerenzia, e prendeva sotto la propria speciale protezione e difesa la comunità e tutti i suoi beni72. Nel giugno del 1216, poi, la stessa Costanza donò un secondo terreno, «dimidium feudum», sog-getto alla fornitura di un miles: la donazione si era resa possibile dal momento che colui che lo aveva fino a quel momento detenuto, un certo Ruggero Saraceno, era morto senza eredi. Anche in questo caso la donazione venne motivata con il restauro e
per il sostegno della sede florense andata distrutta73. Un’ulteriore testimonianza in proposito ci viene an-cora dal conte di Crotone Stefano Marchisorti: nel-l’aprile del 1215 egli dovette riconfermare ai monaci di Fiore una sua precedente sentenza, dal momento che i documenti dell’accordo raggiunto due anni prima erano andati bruciati nell’incendio74.
A differenza di quanto lasciavano intendere i due privilegi della regina Costanza, che accennavano a una restauratio o reparatio degli edifici monastici an-dati distrutti dal fuoco, l’abate Matteo e i suoi mona-ci optarono per una diversa soluzione. Certo a causa della gravità dell’infortunium che li aveva colpiti, ma anche, probabilmente, per limitare le difficoltà dovute al freddo che avevano incontrato nella loro primitiva sede, preferirono trasferirsi e ricostruire ex-novo il loro monastero. Nel febbraio 1215 i florensi ottennero da parte di Innocenzo III il permesso per il cambio di sede. Il pontefice, che nello stesso vol-gere di giorni approvò gli statuti florensi concordati da Matteo e dagli abati di Fonte Laurato e di Ac-quaviva, così si rivolse ai monaci di Fiore: «Poiché il luogo in cui abitate è di scarsa ampiezza e selvaggio, vi sia lecito discendere la Calabria, nei vostri pos-sessi, dove possiate costruirvi un luogo più adatto ad abitare, con la nostra autorità»75. Inizialmente, per superare la prima emergenza e considerato il so-praggiungere della stagione invernale, la comunità di Fiore, molto probabilmente, fu accolta dai con-fratelli da poco stabilitisi nel monastero di Calabro Maria. Al momento della riforma del cenobio greco infatti, come prima cosa Matteo aveva stabilito che, nel caso che una qualche tribulatione vel persecutione avesse impedito alla sua comunità di risiedere ancora a Fiore, a giudizio suo e del capitolo i monaci avreb-bero potuto trasferirsi nel cenobio di Calabro Maria, che evidentemente era tenuto ad accoglierli76. Tra la data dell’incendio e il 1216 le due comunità, sotto la guida di Matteo, condussero evidentemente vita comune, come «unum ovile, et unus pastor omnium abbas Floris»77. I legami in questo senso tra i due gruppi monastici sono infatti attestati ancora nel-l’ottobre del 1216.
Per intraprendere la ricostruzione della loro sede, i florensi non si spostarono di molto: a quanto ci è dato di capire, confermarono ancora una volta la scelta fatta dal loro fondatore, rimanendo sulla Sila, «inter frigidissimas alpes», insediandosi a pochi chi-lometri di distanza, in un sito tuttavia più a valle e maggiormente riparato. Essi infatti si orientarono verso una zona che pare meno esposta ai venti gelidi durante l’inverno rispetto a quella in cui Gioacchino e i suoi primitivi compagni avevano costruito il loro
222
eremum. Il luogo prescelto era denominato Farado-mus o Faraclovus, località in cui sorgono le attuali abbazia e chiesa di San Giovanni in Fiore. Essa fa-ceva parte dei possessi di Fiore fin dai tempi della donazione di demanio da parte dell’imperatore En-rico VI, ed era una delle terre che i monaci greci del monastero dei Tre Fanciulli, fin dal 1195, avevano rivendicato come loro possesso sulla base degli usi consuetudinari che potevano vantarvi e per il fatto che le avevano da tempo dissodate78. L’abate Matteo e la sua comunità avevano evidentemente giudicato quel luogo come il più idoneo per la ricostruzione dell’abbazia; proprio per tale motivo si adoperarono per chiudere in maniera pacifica e definitiva la que-stione con il monastero dei Tre Fanciulli. Nell’agosto del 1215, di fronte all’arcivescovo di Cosenza Luca, le due parti, recisi i documenti dell’accordo raggiun-to circa vent’anni prima e ben presto disatteso dai greci, giunsero a una nuova intesa, che prevedeva che le terre concesse dall’imperatore rimanessero al monastero florense senza più alcuna rivendicazio-ne79. Nonostante il cambiamento di sede, anche il nuovo monastero fu chiamato Flos (Fiore) come il cenobio fondato da Gioacchino («locum ipsum, qui nunc Flos, olim vero Faradomus»)80. Tale nome evidentemente era sentito talmente importante per la storia dell’ordine che i monaci non vi volevano rinunciare.
Una volta risolta la questione e ottenuto final-mente il terreno su cui aveva deciso di far sorgere il loro nuovo cenobio, la comunità florense con ogni probabilità si mise subito all’opera: già nell’an-no seguente un documento fa cenno a una domus florense, che a quanto possiamo capire è comun-que di dimensioni ancora assai ridotte. Nell’ottobre del 1216 infatti, quando si procedette a una nuova fase di riforma del monastero di Calabro Maria, le due comunità, dopo circa due anni di vita comune, vennero definite come distinte e indipendenti, per quanto legate saldamente dal vincolo di filiazione e dal diritto di visita esercitato da Fiore81. Tuttavia, dal momento che la costruzione del nuovo monastero di Fiore non permetteva ancora di accogliere l’intera comunità82, l’abate Matteo stabilì che la comunità di Fiore potesse tenere, presso la vecchia chiesa di Ca-labro Maria, un proprio ospizio, sufficiente per una dispensa e una stalla, e un locum a libera disposizione dei monaci di Fiore. Essi, evidentemente, avrebbero dovuto trascorrere qui un periodo di tempo (presu-mibilmente l’inverno), dal momento che si racco-mandava loro il rispetto dell’abate e dei confratelli di Calabro Maria.
La costruzione del nuovo monastero e della chie-
sa richiese certamente diverso tempo. Troviamo un accenno alla costruzione di Fiore ancora nel 1223, nel documento di accordo tra i monaci di Fiore e quelli greci di Santa Maria del Patir di Rossano, arbi-tro ancora una volta l’arcivescovo di Cosenza, Luca. Tra i monaci di Fiore che apposero il loro signum sulla carta, vi fu anche il monaco Giuliano, che si definiva «sacerdotis et magistri fabrice ecclesie Flo-ris»83. La presenza di un magister fabrice rivela che ne 1223 i cantieri erano ancora attivi e che quindi i lavori di costruzione, almeno riguardo alla chiesa, in quell’anno non erano ancora conclusi. Un’ulterio-re menzione alla fabrica ecclesie è presente anche in uno degli episodi dei Miracula di Gioacchino, nella versione tramandataci da Cornelio Pelusio: un mo-naco, forse Ruggero d’Aprigliano, ricorda in prima persona di quando, dice, «Dormiebam in fabrica ec-clesie, ob causa custodie, circa sepulcrum viri sancti, adhuc conventu inferius commorante in ligneis of-ficinis»84. All’interno della stessa compilazione, infi-ne, troviamo l’episodio che ha come protagonista il monaco Amato, il quale, assunto l’abito monastico, dopo pochi giorni era caduto in tentazione e lo ave-va deposto; l’intervento divino lo convinse però a perseverare. Secondo le parole dell’agiografo, la sua vicenda sarebbe avvenuta proprio «in monasterio novi Floris»85.
5. La condanna di Gioacchino nel concilio lateranense IV
A distanza di poco più di un anno dall’incendio, nel novembre 1215 un secondo avvenimento criti-co colpì i monaci florensi: il concilio lateranense IV condannò la dottrina trinitaria del fondatore Gioac-chino, esposta nel libellus o trattato de unitate seu essentia Trinitatis, considerato perduto, in cui Gioac-chino si era opposto alle posizioni di Pietro Lombar-do su tale materia86.
La condanna conciliare colpì senza dubbio mol-to profondamente le coscienze dei monaci apparte-nenti all’ordine fondato dall’abate. Inquietudini e tensioni in tal senso sono testimoniate sia dalla tra-dizione agiografica sia dalle fonti documentarie, in particolare di provenienza pontificia87. Onorio III, in due diverse occasioni, dovette intervenire diret-tamente a difesa dell’ordine e di Gioacchino stes-so, puntualizzando che la condanna era circoscritta unicamente al pensiero trinitario dell’abate, e non toccava in nessun senso l’ordine nato da lui. Una prima volta, nel dicembre del 1216, ordinò al vesco-vo di Lucca, nella cui diocesi probabilmente si era
223
già stanziato un gruppo di monaci florensi, di far cessare la campagna denigratoria contro Gioacchino e l’ordine da lui fondato, accusati di eresia88; qualche anno più tardi, nel 1220, ordinò a Luca, arcivescovo di Cosenza, e al vescovo suffraganeo di Bisignano di rendere noto in tutta la Calabria che la sede romana considerava il fondatore dell’ordine florense «virum catholicum, et regularem observantiam quam insti-tuit salutarem»89.
Le parole del papa mettono in luce la tipologia dei dubbi che evidentemente circolavano riguardo all’ordine florense: poteva davvero essere salutaris, poteva cioè condurre veramente alla salvezza eterna, un ordine fondato da un monaco le cui dottrine era-no state condannate da un concilio universale? Le inquietudini in merito dovettero essere profonde tra tutti coloro che in qualche modo erano legati al monastero di Fiore e che contavano sulle preghiere dei monaci, e, a maggior ragione, tra gli stessi flo-rensi. Nel 1220 Onorio III, scrivendo ai due presuli calabresi, ricordò che il demonio «aveva scatenato contro di loro <i florensi> diverse persone, sia chie-rici sia laici, prelati e sudditi, perché li distogliessero dal riposo della contemplazione»; in tal modo « non solo i semplici, adatti solo al latte, sono allontanati dalle relazioni con il loro ordine, ma anche i forti, che avevano imparato a nutrirsi con cibo solido, ini-ziano a essere turbati, senza le istituzioni dello stesso ordine»90. Evidentemente, tra i monaci iniziavano a esserci le prime defezioni, come probabilmente te-stimoniava di nuovo il papa con un breve del 1218: già in quell’anno Onorio III si era rivolto all’aba-te e ai monaci di Fiore proibendo che l’abbazia e i monasteri da essa fondati accogliessero senza un permesso speciale della sede apostolica istituzioni di un altro ordine91. Ugualmente, proibiva a chiunque di accogliere i monaci florensi allontanatisi dal mo-nastero senza permesso. Qualche anno più tardi, nel maggio del 1223, il pontefice ricevette le lamentele da parte degli abati di Fiore e di altri monasteri flo-rensi perché, da parte loro, i cistercensi accoglievano senza difficoltà i monaci e i conversi che si allon-tanavano dall’ordine92. Dalle parole di Onorio III, che proibiva agli abati cistercensi della Calabria di accogliere ancora florensi «sine litterarum cautione communium», ordinando di rimandarli, invece, al loro abate, veniamo a sapere che la religio florense era considerata satis arta, e che gli statuti florensi vieta-vano esplicitamente di passare a un altro ordine reli-
gioso. L’anno seguente il papa stabilì, inoltre, che le lettere apostoliche portate dai monaci florensi che si allontanavano dall’ordine per essere accolti altrove, in particolare presso i cistercensi, avrebbero dovu-to menzionare in modo esplicito l’ordine florense e il divieto relativo al transitus93. Ancora nel giugno 1227 Gregorio IX rinnovò le stesse disposizioni rela-tive ai fugitivi dall’ordine florense; è tuttavia difficile capire se, in questo caso, il problema fosse ancora così acuto come negli anni immediatamente prece-denti o se le due lettere fossero una meccanica con-ferma di disposizioni già date, richiamate dal papa all’inizio del suo pontificato parallelamente ad altri documenti94.
La comunità di Fiore cercò di reagire e di supe-rare le difficoltà causate dalla condanna conciliare. Negli anni ‘20 del XIII si impegnò, infatti, nella ricostruzione non solo del monastero e della chie-sa abbaziale, ma anche in quella dell’immagine del fondatore, capace di operare miracoli in vita e post mortem, e dunque, evidentemente, santo nonostante la condanna della sua dottrina trinitaria. Probabil-mente nel 1226 la salma di Gioacchino fu solenne-mente traslata dalla grangia di Canale, dove ancora si trovava, e collocata in una cappella della nuova chiesa florense; lo stesso avvenimento della trasla-zione, secondo le fonti agiografiche, fu occasione di nuovi miracoli95. La raccolta della maggior parte dei Miracula del santo abate di Fiore avvenne indubbia-mente in questa temperie, successiva alla traslazione a Fiore. Gli episodi narrati testimoniano la volontà, da parte dei florensi, certo di difendere la memoria del loro fondatore e di rafforzare il potere salvifico della loro istituzione, ma anche di offrire un’imma-gine di Gioacchino almeno in parte diversa da quella ormai prevalente, cioè quella di un abate esegeta del-l’Apocalisse e profeta degli eventi futuri. Fu dunque lasciato nell’ombra l’aspetto teologico condannato dal concilio; l’abate fu presentato, invece, nella mag-gioranza degli episodi, come un monaco dai poteri terapeutici, vicino alla comprensione e alle necessità della gente comune96. Gli episodi in cui si ricorda la sua attività esegetica concentrano, invece, l’attenzio-ne sull’intervento divino in difesa dell’ortodossia più piena dell’abate e dei suoi scritti97. In questo lavoro di ricostruzione dell’immagine del fondatore svolse un ruolo non secondario anche l’arcivescovo Luca, con la sua Synopsis virtutum98.
224
Note
1 Per un breve quadro delle fonti documentarie su Matteo,
Kamp, Kirche und Monarchie cit., pp. 902-904; riguardo alla
famiglia di origine, vd. ivi, nota 39. 2 Adorisio, La “Legenda” cit., p. 112: «iste qui hodie post
Ioachim in Florem primus est donnus Mattheus, vir vite vene-
rabilis et ultra modernos abbas amabilis universis subditis suis,
cum duobus quoque de Tuscia senioribus litteratis».3 Ivi.4 Cfr. infra, cap. 5.5 Vol. 2, p. I, doc. n. 38. La località di Botrano si trovava
nei pressi di Paternò Calabro: vd. Reg. Inn. VII, n. 148, p. 239,
nota 23; vd. anche Napolitano, S. Giovanni in Fiore cit., II,
p. 242: «Botrano (...) è oggi contrada periferica del comune
di Paterno Calabro, in diocesi di Cosenza, di cui era casale, a
limite coi comuni di Mangone, Belsito e S. Stefano di Roglia-
no, sita tra la destra del torrente Iassa, tributario del Busento,
l’Autostrada del Sole, nei pressi di Pian del Lago, e il tratto di
strada che, muovendo dalla S.S. 19 delle Calabrie, raggiunge
Belsito. È un’ampia, ubertosa collina, ariosa e soleggiata, che
raggiunge i 700 metri di quota (...). Ufficialmente nota col
nome di Monte Vetrano o Beltrano, essa conserva tuttora, quasi
inalterato, il suo nome originario (...). Ricca di acque sorgive,
essa è circondata da rivoli e da contrade».6 Vol. 2, p. I, doc. n. 38.7 Napolitano, S. Giovanni in Fiore, II, p. 247.8 Cfr. Luca di Cosenza, Memorie, p. 195: «Illa hyeme, qua
225
[Ioachim] decessit, fames maxima in Sicilia et Calabria tota
fuit, ita quod multi pauperes pro inedia moerentur»; cfr. anche
i timori espressi in una carta dell’ottobre 1201, relativa all’ac-
quisizione di una casa a Cosenza, Vol. 2, p. I, doc. n. 32: «si
forte clade vel pestilentia aliqua sive guerra evidens fames in
contrata emerserit».9 Vol. 2, p. I, doc. n. 38: «patet (...) locus ipse incursibus
malignorum».10 Cfr. cap. 1, pp. 5-6.11 Vol. 2, p. I, doc. n. 40: « (...) locum, quem dicunt habi-
tare non posse propter frigus et guerras».12 Ivi, doc. n. 30.13 Vd. infra, cap. 5.14 Cfr. cap. 1, p. 7.15 «Pro terris (...) meliores et plures in quadruplum, pro
uno molendino duo cum fulla una, pro nemore nemus maius
et melius, pro vineis vineas meliores et plures»: Vol. 2, p. I,
doc. n. 40.16 Ivi, doc. n. 41.17 Fu forse proprio in questa occasione che i monaci di Fio-
re presentarono a Innocenzo e alla curia romana il testo del-
l’Expositio in Apocalypsim, secondo i desideri di Gioacchino, il
quale, nella sua lettera testamentaria del 1200, aveva incaricato
i suoi coabbati e i suoi monaci di sottoporre al vaglio della
Santa Sede gli scritti che egli non era ancora stato in grado di
presentare a Roma. Il 22 dicembre 1203, infatti, una lettera di
Innocenzo III, diretta a Giovanni Bellesmains, ex vescovo di
Lione ritiratosi a Clairvaux, attesta la conoscenza, da parte del
papa, del Commento di Gioacchino; vd. Reg. Inn. VI, n. 191
(193), pp. 320-327, e la relativa bibliografia.18 «Adeo est utilis, necessarius ac vicinus ecclesie Cusentine,
quod in hiis hostilitatis temporibus in comportandis victuali-
bus, incidendis lignis et percipiendis aliis usibus ecclesia non
laborat»: Vol. 2, p. I, doc. n. 40.19 Ivi, doc. n. 41. 20 Ivi: «evidenter apparet, quod predecessoribus archiepi-
scopi memorati super concessionibus, quas consanguineis suis
fecisse noscuntur, non solum prestitistis assensum, sed eas
propriis subscriptionibus roborastis». Un’analoga promessa ac-
compagnava una lettera del pontefice indirizzata ai cittadini
di Cosenza: la Santa Sede li invitava a convincere i canonici a
cedere la località di Botrano, in modo che i monaci florensi vi
si potessero insediare. Questo sarebbe tornato a vantaggio della
città, che avrebbe avuto il sostegno delle preghiere e dei suffragi
da parte dei religiosi florensi.21 Ivi, doc. n. 43.22 Ivi, doc. n. 45.23 Ivi, doc. n. 40: «locum, quem dicunt habitare non posse
propter frigus et guerras, non deserunt sed suis usibus detinent,
et intendunt habitacula facere in meditullio diocesis Cusentine
ac a loco pristino nolunt aliquatenus separari».24 Si tratta della prima attestazione, a noi nota, di tale for-
mula. Compare nel privilegio per il monastero di Fonte Lau-
rato, concesso da Innocenzo III il 21 gennaio 1204. Vd. ivi, p.
II, doc. n. 7.25 Ivi, p. I, doc. n. 47.26 Ivi, doc. n. 48.27 Ivi: «cum omnibus iustis tenimentis et pertinentiis suis,
iuxta excambium, quod inde cum ecclesia Cusentina de teni-
mentis vestri monasterii contraxistis et secundum privilegium
domine pape exinde vobis factum necnon sicut in vestris scrip-
tis authenticis plenius continetur».28 Ivi: «venerabile monasterium Floris tanto ardentius tene-
mur diligere et condignis beneficiis ampliare, quanto benignius
et devocius felicissimi quondam augusti dominus serenissimus
imperator pater noster et domina gloriosissima imperatrix ma-
ter nostra dive recordationis ipsum monasterium divino intui-
tu construere bonisque, que possidet, dotare corde purissimo
studuerunt».29 Vd. De Leo, I manoscritti di Nicola Venusio cit., p. 8; 13.30 In merito, vd. De Fraja, Oltre Cîteauxs. Introduzione, 2.b.31 Cfr. A. M. Adorisio, Il «Liber usuum Ecclesiae Cusentinae»
di Luca di Casamari arcivescovo di Cosenza. Codice Sant’Isidoro
1/12, Casamari (Veroli) 2000 (Bibliotheca Casaemariensis, 4).32 Vol. 2, p. I, docc. nn. 50 e 51. 33 Ivi, docc. nn. 53 e 54.34 «(...) nos, frater Mattheus, abbas Floris, una cum capitulo
nostro, ex mandato summi pontificis ad nostram petitionem,
dominum Lucam venerabiliem Cusentinum archiepiscopum,
visitatorem ad tempus, ab anno scilicet incarnationis dominice
millesimo ducentesimo sexto usque ad millesimum ducentesi-
mum decimum primum haberemus»: ivi, doc. n. 58. 35 Cfr. ivi: «et ipse, sicut per suas se literas excusavit, in-
sidiantium persone sue manus evitans, nos in Floris claustro
visitare nequiret».36 «In presentia domini Alexandri venerabilis abbatis Sancti
Spiritus de Panormo, quem ipse <Lucas> ad exhibendum nobis
visitationis officium sua vice direxerat»: Vol. 2, p. I, doc. n. 58.
La scelta di sostituire Luca con un abate cistercense sembra
indicare che l’esigenza prevalente, nel compito di visita, fosse
l’esperienza monastica, che anche Luca aveva maturato durante
l’abbaziato alla Sambucina, piuttosto che il ruolo istituzionale
di ordinarius loci rispetto a Fiore.37 Ivi, doc. n. 53: «monasteria, que tu de novo fundasti in
tenimento Fluminis Frigidi in loco, qui nunc dicitur Fons Lau-
reatus, et in tenimento Barbari in loco, qui dictus est Mono-
caria, nunc autem Aquaviva, que monasteria ad Florem et eius
ordinem pertinere noscuntur».38 Ivi, doc. nn. 49, 52 e 74.39 Ivi, doc. nn. 62, 55 e 61.40 Ivi, doc. n. 59.41 Ivi, doc. n. 73. Nella medesima zona, Federico concesse
«terram laboratoriam ad duas salmatas in tenimento Acheren-
tee prope grangiam, quam habetis in loco qui dicitur Albe»:
ivi, doc. n. 53.42 In merito alla svolta in direzione cistercense intrapresa
226
dall’ordine florense nel secondo decennio del secolo, cfr. De
Fraja, Oltre Cîteaux. Conclusione, 2.: La svolta cistercense.43 Vol. 2, p. I, doc. n. 64. Così riporta l’indice dell’archivio
florense; non è chiaro però se la donazione sia stata effettuata
nel 1209 o nel 1219: sono tramandati infatti alcuni passi del
documento dell’arcivescovo Dionisio, del 1219, relativi a tale
donazione; in essi non si accenna al fatto che si tratti di una
conferma di una donazione precedente, fatta un decennio pri-
ma. Potrebbe dunque trattarsi solo di un errore di trascrizione
della data. Tuttavia, le indicazioni archivistiche dei due docu-
menti, relativi al fascicolo e al numero, non coincidono.44 In precedenza, nel maggio del 1207, la tenuta di Berano
era stata confermata anche da parte di Innocenzo III: vd. vol.
2, p. I, doc. n. 51. Il regesto di questo privilegio non è riporta-
to nell’indice dell’archivio trascritto nel manoscritto di Nicola
Venusio.45 Ivi, doc. n. 66.46 Ivi, doc. n. 67. Per il documento del conte Stefano, vd.
ivi, doc. n. 65. 47 Ivi, doc. n. 86.48 Ivi, doc. n. 66: «quasdam terras et arbores (...) in teni-
mento Cusentie, in loco videlicet Canalis et in loco Bottuli,
quia de feudo et servitiis obligate».49 Ivi, doc. n. 56. 50 Ivi, doc. n. 71.51 Ivi.52 Kamp, Kirche und Monarchie cit., I, Teil 2, pp. 884-885.53 Vol. 2, p. I, doc. n. 71.54 Ivi.55 Ivi. Il privilegio rilasciato da Gualtiero di Palearia e pre-
sentato dai monaci di Corazzo andrebbe quindi datato tra il
1202 e 1206, periodo in cui Gualtiero, privato da Innocen-
zo III del titolo di vescovo di Troia, si era spostato nella parte
continentale del regno e aveva intrapreso una campagna mili-
tare, in collegamento con le forze tedesche, contro Gualtieri
di Brienne. Innocenzo continuò a rivolgersi a lui come can-
celliere, anche se fino al 1207 egli non ricompare con questo
titolo nei documenti regi. Proprio negli anni 1202-1206 la
custodia di Federico fu coperta da Guglielmo Capparone. In
seguito Gualtiero rientrò al servizio del re di Sicilia, e nel 1208
fu nominato titolare della sede vescovile di Catania (Matthew,
I Normanni cit., p. 378). 56 Vd. T. Kölzer, Urkunden und Kanzlei der Kaiserin Kon-
stanze, Königin von Sizilien (1195-1198), Köln-Wien 1983,
pp. 145 ss.57 A detta dei monaci di Corazzo, Federico aveva riconfer-
mato la concessione del monastero greco dopo il suo matri-
monio con Costanza d’Aragona, matrimonio che ebbe luogo
nell’agosto del 1209. 58 Rodolfo di Coggeshall, monaco cistercense, ricordando
l’incontro avvenuto probabilmente nel 1195 tra Gioacchino e
il confratello Adamo di Perseigne, definì Gioacchino come un
«abbas (…) ordinis Cisterciensis, sed Cisterciensibus minime
subiectus»: dalle sue parole, sembrerebbe che in quel momento
la posizione del calabrese rispetto all’ordine dei monaci bianchi
fosse ancora molto fluida e non definitivamente chiarita (Ra-
dulphus de Coggeshale, Chronicum Anglicanum, p. 68).59 Vol. 2, p. I, doc. n. 71.60 Per un’analisi dettagliata dei documenti relativi alla ri-
forma di Calabro Maria e gli accenni alle istituzioni florensi
in essi contenuti, vd. De Fraja, Oltre Cîteaux, cap. III, 3. (Gli
Statuta dell’ordo).61 Riguardo al primo tentativo sotto Gioacchino, cfr. le pa-
role di Bernardo: «Quapropter cum pie recordationis Gilbertus
episcopus predecessor noster monasterium, quod dicitur de
Abbate Marco, cum ecclesia Sancti Martini de Neto et teni-
mentis suis domino abbati Ioachim et successoribus eius sub
annuo censu ad collocandum ibi de fratribus suis et consti-
tuendum prelatum iuxta vestrum ordinem concessisset, con-
structum vero et ordinatum ab ipso Guillelmus predecessor
noster invasione illicita destruxisset» (vol. 2, p. I, doc. n. 60).62 Ivi.63 In merito, De Fraja, Oltre Cîteaux, cap. IV, 4. (I tre abati
e le tre chiese di fondazione).64 Vol. 2, p. I, doc. n. 60: «omnibus libertatibus et immu-
nitatibus, quas monasterium Floris, ad ius et proprietatem
Romane ecclesie pertinens, ex apostolica privilegia indulto sibi
habere dinoscitur, ipsum quoque gaudeat et fruatur».65 «Si qui de canonicis vel clericis nostris, ad sancte conver-
sationis abitum et observantiam se conferre voluerit, licebit, eis
viventibus, cum omnibus rebus suis mobilibus ad vos de mundo
transire; si vero, licebit eis usque ad tertiam partem bonorum
suorum vobis, aliqua absque contradictione, legare» (ivi). 66 Ivi, doc. n. 98.67 Ivi.68 Ivi: «ad opus et subventionem monasterii vestri de Flore,
libere, perpetue et quiete».69 Vd. ad esempio ivi, doc. n. 65.70 Ivi, doc. n. 80.71 Ivi, doc. n. 83. Il documento di Costanza d’Aragona -
datato gennaio 1215 - definendo l’incendio come avvenuto ‘in
hiis diebus’ conferma che la datazione dell’incendio va collocata
nel corso del 1214, e che il documento del conte Stefano non è
datato secondo lo stile bizantino - secondo cui andrebbe ripor-
tato all’ottobre 1213 - ma secondo lo stile dell’incarnazione.72 Ivi, doc. n. 84.73 Ivi, doc. n. 93: «pro reparatione quoque ac sustentatione
ipsius monasterii vestri, quod anno preterito est combustum».
74 Ivi, doc. n. 88. Che in un primo tempo la comunità di
Fiore avesse tentato un restauro della prima chiesa, costruita
sotto l’abbaziato di Gioacchino, è confermato dai risultati delle
campagne di scavo condotte negli ultimi anni in località Flore
Vetere: l’abside della navata centrale della chiesa, in un primo
tempo costruita a coro rettilineo, dopo l’incendio (confermato
anche dai resti emersi dagli scavi archeologici) fu spostata più
internamente e ricostruita parzialmente in forma semicircolare.
227
75 Ivi, doc. n. 85: «Quia locus in quo abbitatis est angu-
stus et asper, liceat vobis descendere Calabriam ubi possitis in
possessionibus vestris locum ad habitandum auctoritate nostra
vobis construere aptiorem».76 «Minor maiori cedat»: vd. ivi, doc. n. 78.77 Ivi.78 Vd. supra, pp. 4-5 e vol. 2, p. I, doc. n. 6.79 Ivi, doc. n. 89. Cfr. anche supra, p. 5.80 Ivi, doc. n. 114.81 Ivi, doc. n. 95. 82 Ivi: «domus exilitas minus possit in eorumdem floren-
sium susceptione gravari».83 Ivi, doc. n. 138.84 Adorisio, La “Legenda” cit., p. 143.85 Ivi, p. 127.86 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Basileae etc., Her-
der, 1962², pp. 207-209: Constitutio 2. De errore abbatis Io-
achim. A riguardo, cfr. Reeves, The Influence cit., pp. 28-36; cfr.
anche F. Robb, Did Innocent III Personally Condemn Joachim of
Fiore?, in «Florensia» 7 (1993), pp. 77-91. 87 In relazione ai riferimenti alla condanna conciliare, negli
episodi dei Miracula, cfr. De Fraja, «Post combustionis infortu-
nium» cit., pp. 143-146.88 Vd. vol. 2, p. I, doc. n. 97.89 Ivi, doc. n. 116.90 Ivi: «contra eos nonnullos, tam clericos quam laicos,
prelatos et subditos, concitavit, (…) ut ipsos ab otio contem-
plationis avertant (…) non solum simplices, lactis participes,
a consortio eiusdem ordinis avertuntur, sed etiam fortes, qui
uti cibo solido didicerunt (…) citra instituta eiusdem ordinis
incipiunt fluctuare». 91 Ivi, doc. n. 104: «monasteria que ab ecclesia vestra funda-
ta sunt, et ab ipsa de cetero vel a filiabus suis fuerunt propagata,
recipere nequeatis alterius ordinis instituta, sine mandato sedis
apostolice speciali».92 Ivi, doc. n. 134.93 Ivi, doc. n. 139.94 Ivi, docc. nn. 149-150.95 Per la data della traslatio a Fiore, vd. De Fraja, «Post com-
bustionis infortunium» cit., p. 136, nota 40; riguardo a un mi-
racolo avvenuto in occasione della traslazione, vd. Adorisio, La
“Legenda” cit., p. 131.96 Adorisio, I miracoli dell’abate cit., pp. 13-31. 97 Sono gli episodi del copista Bono (Adorisio, La “Legenda”
cit., pp. 91-92), e quello del copista Ruggero (ivi, pp. 167-170;
cfr. anche p. 137). Per gli accenni, in un episodio miracoloso, a
uno specifico punto dell’interpretazione trinitaria di Gioacchi-
no, vd. De Fraja, Una vocazione d’Oltralpe cit., pp.50-54.98 Riguardo a questi aspetti della tradizione agiografica
gioachimita, cfr. De Fraja, Oltre Cîteaux. Introduzione, 3. (La
Virtutum synopsis di Luca di Cosenza).
229
CapItOlO tErZO
FIOrE tra papatO, ImpErO E rEGNO (1225-1266)
1. I rapporti con la curia romana
1.a. Ugolino-Gregorio IXFin dal suo sorgere, il monastero di Fiore e l’ordi-
ne monastico che ne fiorì tennero con la sede pon-tificia relazioni privilegiate. Esse trovano ragione e fondamento nel positivo rapporto che Gioacchino, il fondatore, seppe costruire con i pontefici che si avvicendarono sulla cattedra di Roma negli ultimi due decenni del XII secolo. Neppure la condanna da parte del concilio lateranense IV nel 1215 com-promise la situazione: subito la sede romana tenne a precisare che il giudizio negativo espresso nell’occa-sione era limitato unicamente alla dottrina trinitaria sostenuta dal calabrese. Esso pertanto non metteva assolutamente in discussione il fatto che egli fosse in ogni caso un vir catholicus e che il suo monastero e la religio a cui egli aveva dato origine fossero da consi-derarsi salutares, in grado cioè di portare alla salvez-za. Nel cosiddetto “testamento”, indirizzato ai suoi coabati, priori e confratelli, Gioacchino aveva in ef-fetti tenuto a precisare la sua piena sottomissione al giudizio e alla correzione della sede romana riguardo alle sue opere, che egli si impegnava personalmente a inviare al papa1.
Il riconoscimento, da parte di Gioacchino, del-l’autorità della chiesa di Roma motiva il fatto che, nonostante Innocenzo III considerasse erronee le sue tesi in materia trinitaria, abbia comunque utilizzato le opere dell’abate calabrese all’interno della sua pro-
duzione epistolare, citandone testualmente lunghi passi e dimostrando così di condividere alcune delle sue interpretazioni ermeneutiche2. Fu questo ponte-fice a confermare al monastero di Fiore quell’esen-zione che probabilmente già il predecessore Celesti-no III aveva concesso, facendo del monastero silano una sorta di enclave papale nel cuore della Calabria normanno-sveva. Il legame privilegiato dell’abbazia florense con la sede romana proseguì anche sotto il successore di Innocenzo III, Onorio III, che difese pubblicamente Gioacchino e Fiore dalle accuse mos-se loro contro dal vescovo di Lucca ed esortò l’arcive-scovo di Cosenza Luca a difenderne la fama in tutta la Calabria, ma si fece particolarmente profondo e significativo durante il difficile pontificato di Grego-rio IX, che governò la chiesa romana dal marzo del 1227 fino all’agosto del 1241, a cavallo dunque del lungo abbaziato di Matteo (1202-1234) e del suo successore Michele.
Ugolino-Gregorio IX, ancora prima di salire al soglio pontificio, aveva dimostrato di riporre molte speranze nel nuovo ordine fondato da Gioacchino. Come cardinale vescovo di Velletri, aveva sostenuto l’insediamento dei monaci florensi, provenienti da Fonte Laurato, nella sua diocesi: nell’ottobre 1216 essi si erano così stabiliti a Ninfa, nei pressi del-la chiesa di Sant’Angelo. Al suo diretto intervento sono dovuti anche l’insediamento dei florensi a San
230
Iacopo di Valle Benedetta, in diocesi di Lucca, e la fondazione, poco prima della sua elezione a pontefi-ce, del monastero di Anagni. Sempre grazie alla sua opera di promozione, nel 1218 Onorio III esentò dal pagamento della vigesima tutto l’ordine florense, composto a quel tempo dai monasteri di Fiore, di Fonte Laurato, di Acquaviva, di Calabro Maria, del Mirteto a Ninfa e dal priorato toscano di San Iacopo di Valle Benedetta3. E ancora nel 1226, fu di fronte a Ugolino, vescovo di Ostia e Velletri, che Matteo, come abate di Fiore, ricevette sotto la propria giuri-sdizione la piccola fondazione toscana4.
Indubbiamente, dunque, Ugolino-Gregorio IX stimava il nuovo ordine monastico e, a fianco delle numerose novità istituzionali della prima metà del XIII secolo da lui direttamente create o comunque sostenute, cercò di appoggiare anche la sperimen-tazione di questa nuova religio, che egli contava di veder crescere accanto ai cistercensi. La fiducia ac-cordata all’ordine era forse dovuta anche ai rapporti personali tenuti da Ugolino sia con l’antico compa-gno di Gioacchino, il monaco cistercense Raniero da Ponza5, sia con un personaggio di rilievo tra i floren-si, il monaco Giuseppe di Fiore.
In seguito, l’interesse dei pontefici della famiglia Conti si concentrò soprattutto sull’abbazia di Santa Maria della Gloria, presso Anagni, considerata un vero e proprio monastero di famiglia, e sul vicino cenobio del Mirteto6; non mancarono tuttavia at-tenzioni anche nei confronti delle altre case floren-si. Fatta eccezione per il monastero di Santa Maria di Laterza, in diocesi di Acerenza, che fu unito al-l’ordine florense per iniziativa del vescovo locale e di Andrea, regni Sicilie prothonotarius et logothetha, l’intervento personale di Ugolino-Gregorio IX fu in effetti alla base delle successive annessioni ai floren-si di diversi cenobi decaduti o bisognosi di riforma, che divennero abbazie dell’ordine o i cui beni en-trarono comunque nel patrimonio florense. Come pontefice, egli riconfermò l’appartenenza all’ordine del monastero di Santa Marina della Stella, in dio-cesi di Maiori, favorito anche da Federico II, ma ri-vendicato dai cistercensi del monastero di Ferraria; concesse ai florensi i monasteri lucchesi di San Pietro di Camaiore e di San Cassiano; per procedere alla riforma di monasteri greci decaduti ed evitare la di-spersione dei loro possessi, in alcuni casi molto con-sistenti, papa Gregorio inaugurò la prassi, poi segui-ta anche dai suoi immediati successori, di affidarli ai florensi, quale ordine monastico di riferimento nella Calabria, in cui numerosi erano appunto i cenobi greci bisognosi di riforma: passarono così ai florensi i monasteri di Sant’Andrea di Cariati e di Sant’Angelo
Militino, presso Campana. L’azione in questo senso coinvolse anche la Puglia: il pontefice assegnò a Fio-re il monastero di San Tommaso di Rutigliano, in diocesi di Conversano, in seguito organizzato come nuova grangia dell’abbazia di Fiore. La cessione del cenobio di Rutigliano, ormai decaduto, fu compiuta nelle mani del monaco florense Giuseppe, delega-to quale rappresentante del cenobio silano. Si tratta dell’unico monaco di Fiore, oltre ai due primi abati, di cui siamo in grado di seguire, a grandi linee, la carriera, che lo portò a divenire notarius nella cancel-leria di Gregorio IX e a svolgere in curia un ruolo di notevole importanza nei primi anni ’30.
1.b. Un florense al servizio del papato: il monaco Giuseppe di Fiore
Il primo accenno a Giuseppe di Fiore compare nella sentenza di Innocenzo III del settembre 1211, con cui il pontefice assegnò all’abbazia silana il mo-nastero di Calabro Maria. In quell’occasione, furo-no i monaci Giuseppe di Fiore e Ugo, quest’ultimo priore di un non meglio identificato monastero di San Giorgio, a sostenere efficacemente le ragioni della loro casa madre in opposizione alle rivendica-zioni dei cistercensi di Corazzo. Fin da quell’anno Giuseppe era dunque un uomo di fiducia del suo monastero, in grado di difendere le posizioni floren-si anche di fronte al pontefice7. Negli anni successivi, nel 1213 e nel 1216, Giuseppe sottoscrisse, insie-me a numerosi altri monaci della sua comunità, le carte relative ai rapporti tra Fiore e Calabro Maria, definendosi, in una di esse, lector8. Negli anni suc-cessivi, Giuseppe instaurò con la curia pontificia, e forse in particolare con il cardinale Ugolino, stretti rapporti di fiducia. Ne fa fede l’incarico, conferi-togli da parte del pontefice il 12 maggio 1220, di unirsi a Domenico, fondatore e priore dei predi-catori, «ad proponendum, quibus expedire uiderit, uerbum Dei»9. Si trattava del progetto di una vasta campagna di predicazione, da attuare forse in Italia settentrionale, all’indomani della missione in quei territori di Ugolino in qualità di legato papale10. La presenza in curia, e precisamente a Viterbo, di un monaco florense è attestata dalla conferma da parte di Onorio III di alcuni documenti a favore di Fio-re, conferma data pochi giorni prima dell’incarico conferito al gruppetto di religiosi sotto la guida di Domenico. Non vi sono tuttavia notizie precise in merito a tale missione, né si sa se essa in realtà poi si svolse davvero. La presenza di un florense - e un flo-rense autorevole - nell’Italia centro-settentrionale è confermata anche dal fatto che pochi mesi più tardi, nel corso del mese di ottobre, un rappresentante del
231
monastero silano era certamente presente presso gli accampamenti imperiali, a Castel San Pietro, vicino a Bologna, per richiedere le conferme di privilegi e donazioni a favore dei monasteri di Fiore, di Fonte Laurato e di Calabro Maria.
I successivi passi del monaco di Fiore rimango-no nell’ombra, ma sappiamo che nel settembre del 1222 era certamente rientrato nel Regno, dal mo-mento che in quella data si presentò a Federico II, allora a Palermo, come nunzio del suo monastero, recando all’imperatore il documento di accordo ri-lasciato dall’arcivescovo di Cosenza Luca e relativo al possesso di alcune terre, perché lo confermasse11. L’incarico di nunzio presso l’imperatore, attestato con certezza nel settembre del 1222, induce a ritene-re che anche due anni prima fosse proprio Giuseppe ad aver ricevuto incarico simile presso la corte im-periale e che dunque egli fosse un personaggio che si muoveva con disinvoltura tra curia papale e corte imperiale.
Giuseppe di Fiore continuò ad essere un per-sonaggio che godeva la fiducia dei pontefici anche dopo aver ricevuto l’incarico per la missione al segui-to di Domenico: nel 1231 ebbe l’incarico di condur-re un’inchiesta sull’operato del vescovo di Acerenza, insieme agli arcivescovi di Bari e di Reggio12. I con-tatti con l’arcivescovo di Bari, stabiliti in quell’occa-sione, motivano probabilmente la concessione che quest’ultimo fece a Giuseppe, su ordine del papa, del monastero di San Tommaso di Rutigliano13. Nel dicembre del 1232 Giuseppe difese ancora una volta gli interessi del suo monastero in qualità di procura-tore di Fiore di fronte a Giovanni, vescovo di Mot-tola, circa il possesso di alcune terre di pertinenza della chiesa di Sant’Angelo di Satrano, ceduta in un momento imprecisato ai florensi14. L’anno successi-vo, infine, Giuseppe concluse la sua carriera come notaio della cancelleria papale. La prima attestazione relativa a questa sua carica è del 28 ottobre 1233: precedentemente a questa data, il monaco, definito dal documento papale notarius di Gregorio IX, aveva sottoposto a visita il monastero Vultuense, in dioce-si di Rapolla (Basilicata), insieme all’arcivescovo di Trani, e lo aveva riformato15. Nel 1235 fu attivo nel-la cancelleria pontificia, a Perugia: tra il 21 aprile e il 22 maggio sottoscrisse come notarius quattro pri-vilegi papali; in essi fu sempre definito frater Ioseph, ordinis Florensis16. Ricoprendo l’incarico di notaio di curia, Giuseppe giocò probabilmente un ruolo signi-ficativo nel programma, elaborato dalla curia di Gre-gorio IX, di progressiva teorizzazione della presenza, nel seno della chiesa, dei due nuovi ordini religiosi del tempo, i frati predicatori e i minori17. Tale teo-
rizzazione pare impostata, nelle sue linee generali, su alcuni testi di Gioacchino relativi alla comparsa, nei tempi ultimi, di due nuovi ordini religiosi che si sarebbero opposti con forza all’azione dell’anticristo e dei suoi emissari attraverso la predicazione. Alcu-ne caratteristiche tematiche gioachimite compaiono infatti, grazie evidentemente alla mediazione di Giu-seppe da Fiore, in alcune importanti lettere papali, tra cui la bolla di canonizzazione di Domenico18.
Si tratta di notizie importanti, che in parte chia-riscono lungo quali percorsi poté costituirsi l’identi-ficazione, da parte della curia pontificia, tra l’impe-ratore Federico e l’anticristo; nel medesimo tempo, queste esili tracce sono le ultime notizie che posse-diamo riguardo a Giuseppe: dopo le sottoscrizioni del 1235, sul monaco florense cade in effetti il più completo silenzio.
1.c. Fiore e l’ordine come strumento di riforma monastica
L’anno precedente si era concluso anche l’abba-ziato di Matteo, senza dubbio il più significativo per Fiore e per tutto l’ordine florense. A partire dal suo successore la documentazione florense si fa purtrop-po estremamente lacunosa: per il trentennio 1235-1266, possediamo solo trentotto documenti, ben poca cosa rispetto ai 178 del periodo precedente.
Di questi trentotto, quattordici sono documen-ti di provenienza pontificia. Solo di alcuni tuttavia è noto il testo completo; quanto agli altri, ci sono giunti i regesti nell’indice dell’archivio florense o il breve sunto dei registri papali. È dunque piuttosto difficile comprendere, se non a grandi linee, la po-litica tenuta dalla sede pontificia nei confronti della fondazione florense.
Da un lato, abbiamo senza dubbio un continuo sostegno alla diffusione dell’ordine, in particolare da parte di Gregorio IX: nel 1237 questo papa notifi-cò all’abate di Fiore l’affidamento agli abati di Ac-quaviva e di San Pietro di Camaiore del monastero benedettino di San Cassiano, in diocesi di Lucca, perché procedessero alla sua riforma19. Nel ceno-bio erano rimasti, infatti, solo due monaci, disposti evidentemente al passaggio alla nuova religio. Nello stesso anno cade un privilegio papale per San Pie-tro di Camaiore, con cui si concedeva all’abbazia la protezione pontificia, l’esenzione dall’ordinario e la conferma di tutti i possessi20.
In seguito, il successore di Gregorio IX, Alessan-dro IV, si rivolse ai vescovi di Cerenzia e di Strongoli perché riformassero il monastero di San Giovanni Calibita, in diocesi di Rossano, probabilmente una fondazione greca ormai decaduta. Il cenobio è de-
232
finito «de fratribus ordinis Florensis»; non è affatto chiaro tuttavia se questo significhi che San Giovanni era già florense o se i vescovi dovessero riformarlo tramite l’introduzione dei monaci di Fiore21.
In effetti, nei confronti delle fondazioni bizantine decadute i pontefici fecero propria la politica inau-gurata da Gregorio IX e indirizzata in questo senso: nella diocesi di Rossano, Gregorio IX nel 1235 come abbiamo visto aveva confermato ai florensi di Fon-te Laurato il monastero di Sant’Andrea di Cariati e, in data imprecisata, aveva loro affidato il cenobio di Sant’Angelo Militino, presso Campana22. Sulla medesima via, nel 1259 Alessandro IV concesse ai florensi di Sant’Angelo del Mirteto, presso Ninfa, il celebre cenobio di Sant’Adriano di Rossano, fonda-to da San Nilo verso il 95023. La concessione però non poté aver subito luogo, date le vicissitudini del periodo, e ancora nel 1296 non era stata messa in atto24. L’azione della sede romana non era mirata solo alla riforma di fondazioni bizantine decadute, ma anche di quelle latine attraversate da simili pro-blemi. Ancora Alessandro IV, nel 1256, concesse ai florensi di Santa Maria della Gloria di Anagni, plan-tatio specialis del suo predecessore e parente Gregorio IX, il priorato di Bagnara, fondato nel 1085 dal duca Ruggero e affidato ai canonici regolari, con tutte le sue numerose pertinenze in Calabria e in Sicilia25. Il priorato non venne eretto in abbazia indipendente, nonostante il pontefice avesse concesso all’abate di Fiore facoltà in merito; esso, con tutti i suoi beni, entrò a far parte dei possessi della badia anagnina. Nello stesso 1256, papa Alessandro incaricò il vesco-vo di Bisignano, l’arcidiacono di Squillace e il ma-gister Amato, canonico di Cosenza, di visitare e di riformare il cenobio di Santa Maria Nuova, presso Caccuri (l’antico monastero greco dei Tre Fanciul-li che tanta parte aveva avuto nella prima fase della storia di Fiore), che probabilmente, nel 1218, era già stato riformato dai cistercensi di Sant’Angelo del Frigilo26. L’ordine florense dunque, ben presente in Calabria, era considerato dalla chiesa romana una valida risorsa per il recupero delle fondazioni greche ormai in rovina, e l’affidamento dei cenobi decaduti ai monaci di Gioacchino, anche nel caso in cui non riprendeva la vita regolare, era una delle vie per evi-tare che i beni appartenuti alle comunità religiose bizantine andassero completamente dispersi e cades-sero nelle mani di signori laici.
Oltre al passaggio di antichi monasteri all’ordine, la documentazione pontificia per il monastero silano attesta una serie di questioni normative e disciplina-ri: nel 1238, su richiesta dell’abate e della comunità di Fiore, Gregorio IX concesse agli abati di Fonte
Laurato e di Acquaviva la visita annuale, a nome del papa, del monastero di Fiore, secondo quanto aveva-no stabilito gli abati florensi nel 1209, al momento della stesura dei nuovi statuta dell’ordine27. In caso di morte dell’abate della casa madre, inoltre, gli al-tri due abati avrebbero avuto la facoltà di istituirvi come nuovo abate colui che fosse stato eletto dai monaci o dalla loro pars sanior, conformemente agli statuti dell’ordine.
Nello stesso anno, il papa affidò all’arcivescovo di Cosenza e all’abate di Fiore l’incarico di assolvere dalla scomunica i monaci e i conversi del monastero che erano venuti alle mani, tra di loro o nei confron-ti di altri religiosi e di chierici secolari della dioce-si di Cosenza, per questioni di proprietà, e coloro che avevano negato l’obbedienza all’abate e avevano messo in atto una forma di conspiratio28. Un incari-co simile fu affidato all’abate florense anche l’anno successivo, quando Gregorio IX concesse la facoltà di assolvere i monaci e i conversi o di dispensarli, nel caso avessero ricevuto gli ordini sacri o celebrato gli uffici divini senza sapere della scomunica o dell’inter-detto contro di loro29. Questi interventi da parte del pontefice trovano ragione nella situazione piuttosto complessa che, come vedremo, si era evidentemente creata nell’abbazia silana: le divisioni nella comunità e gli scontri si spiegano infatti, assai probabilmente, in chiave politica.
L’improvvisa morte di Federico II permise al pon-tefice, a quanto possiamo intuire, di intervenire in modo più deciso nella vita della comunità florense. Innocenzo IV affidò infatti agli abati cistercensi di Casamari, di San Martino, in diocesi di San Marco, e della Santissima Trinità, in diocesi di Rossano, l’in-carico di visitare per tre anni e di sottoporre a rifor-ma il monastero di Fiore e tutte le abbazie dell’ordi-ne. Era infatti necessario risolvere i problemi creatisi nel momento in cui il legittimo abate di Fiore era stato cacciato per ordine dell’imperatore30. Qualche anno più tardi, nel 1258, Alessandro IV confermò le istituzioni dell’ordine florense; non sappiamo tut-tavia se si trattò di una forma di approvazione della riforma operata dai tre abati cistercensi o di una cosa diversa31. Infine, a conferma che il sostegno della sede pontificia a favore di Fiore non si era ancora interrotto, nel 1256 il papa confermò la permuta di alcune terre appartenenti al monastero con altre del priorato di Tacina, posto nel territorio della diocesi di Santa Severina32.
233
2. Federico II: da sostenitore a oppositore
Congiuntamente al sostegno da parte dei diver-si pontefici succedutisi sulla cattedra di Pietro nella prima metà del XIII secolo, il monastero di Fiore e l’ordine florense nel suo complesso ebbero l’oppor-tunità di godere per un certo tempo dell’appoggio anche di Federico, prima come re di Sicilia, in segui-to anche come imperatore.
La lunga assenza del giovane re dal territorio me-ridionale e, nell’autunno del 1216, poco dopo la morte di Innocenzo III, la partenza per la Germania di sua moglie Costanza e del figlio Enrico interrup-pero i rapporti tra il monastero di Fiore e la corte re-gia, esaminati in precedenza. Si conferma, dunque, anche per il caso del monastero silano la constata-zione relativa alla generale oscurità della storia del regno nei quattro anni compresi tra il 1216 e il ri-torno di Federico, ormai imperatore, in Sicilia. Tut-tavia, quando ancora si trovava a Basilea, nel 1219, Federico fu raggiunto dal (o dai) rappresentanti dei monasteri florensi del regno, e concesse alcuni pri-vilegi, a conferma di precedenti donazioni e libertà. Il privilegio rilasciato a favore dell’abate Matteo ri-confermava il possesso delle grange del monastero silano, le numerose proprietà acquisite nei territori di Cerenzia e di Cosenza, le libertà di pascolo, di sfruttamento minerario, di costruzione per mulini e folloni, e le varie immunità, redditi ed esenzioni acquisite nel corso del tempo33.
Viceversa, nei tre anni seguenti, a partire dal ri-torno di Federico II in Italia, le relazioni con la corte regia si fecero estremamente intense. Tra l’ottobre del 1220 e il maggio del 1223 si contano infatti quin-dici documenti rilasciati da Federico al monastero di Fiore, o comunque relativi ad esso. Caratteristica comune a tutti i suoi diplomi è il fatto che Federi-co II tenne sempre a sottolineare che l’abbazia silana era una fondazione creata dai suoi genitori, dotata e beneficiata grazie alla loro munificenza, e che si trattava dell’unica istituzione fondata da Enrico e Costanza nel regno di Sicilia, a cui pertanto egli era tenuto a rivolgere una particolare attenzione e una cura privilegiata rispetto a tutti gli altri enti religiosi posti nelle sue terre34.
Dei tre documenti che Federico rilasciò al mo-nastero di Fiore nell’ottobre del 1220 dall’accam-pamento presso Castel San Pietro nei pressi di Bo-logna, uno riveste particolare importanza. Si tratta di un amplissimo privilegio, munito di bolla d’oro, con cui il re confermava i possessi, le donazioni ri-cevute nel corso del tempo, i vari diritti e libertà di cui godeva l’abbazia35. Offre, pertanto, un’ampia pa-
noramica dei beni acquisiti da Fiore a partire dalla donazione di Enrico VI e insieme attesta l’incom-pletezza dell’archivio florense, dal momento che ri-corda donazioni e acquisizioni di cui non abbiamo altrimenti notizia.
Oltre al patrimonio fondiario di origine dema-niale in dotazione a Fiore, la bolla di Federico attesta innanzitutto che le grange di proprietà del monaste-ro erano ormai tre: una sorgeva a Canale, nei pressi di Cosenza; i beni annessi ad essa comprendevano le varie terre ricevute nel corso del tempo in quella zona, le case e i casalina siti a Cosenza, terre, alberi e vigne a Guarano, donate da un certo Leone Grip-po di Cosenza, e altre terre e vigne presso il casale di Deodato36. Una seconda grangia si era costituita nella tenuta di Fiuca, presso Rocca di Neto, nelle vicinanze del casale chiamato Terrate: in essa sverna-vano le greggi del monastero silano. Alla grangia era annessa anche una chiesa, come a Canale37. Anche il monastero cistercense di Sant’Angelo del Frigilo possedeva una grangia in questa zona, presso il casale di Terrate, destinata con ogni probabilità ai medesi-mi scopi: si trattava evidentemente di una zona par-ticolarmente adatta allo svernare delle greggi e delle mandrie38. Vi era infine la grangia nel territorio di Cerenzia, presso il casale di Berdò, chiamata anche Albe, di cui avevamo notizia fin dal 1210; nel suo patrimonio erano inclusi terre, vigne, alberi, corsi d’acqua e mulini39.
Come già nel privilegio rilasciato un decennio prima, la carta del 1220 presenta poi il quadro dello status dell’ordine in quel momento. Innanzitutto Fe-derico non nominò più, tra monasteri derivati e di-pendenti da Fiore, i tre cenobi di Bonum Lignum, di Tassitano e di Monte Marco: la scomparsa delle tre fondazioni strettamente legate a Fiore, accanto alla creazione di diverse grange, potrebbe testimoniare il tramonto definitivo della volontà di realizzare la settiforme domus religionis auspicata dal fondatore. L’ordine florense adottò invece sempre di più le for-me di organizzazione patrimoniale cistercense, già introdotte nel 1209 sul piano istituzionale, anche a motivo del fatto che i monasteri cistercensi si erano fatti ormai numerosi nel Centro-Sud, e costituivano indubbiamente un modello di riferimento (e anche un concorrente) molto forte.
All’abbazia di Fiore erano legati istituzionalmen-te i monasteri di Fonte Laurato nel territorio di Fiumefreddo, quello di Acquaviva presso Barbaro in diocesi di Catanzaro e quello di Calabro Maria, nel tenimentum di Santa Severina; per ciascuno di essi Federico menzionava il possesso di grange, ter-reni e pertinenze40. È ricordato anche il monastero
234
di Cabria, nel territorio di Cerenzia, che nel 1217 il vescovo Nicola aveva concesso a Fiore perché vi sorgesse un cenobio florense in quella diocesi; non è chiaro, tuttavia, se la fondazione venisse nominata tra i monasteri in cui si conduceva già vita mona-stica a tutti gli effetti o se si trattasse solo di uno tra i molti possessi di Fiore, come la chiesa (non più monastero) di Monte Marco, a cui si accenna nel passaggio immediatamente successivo. Il re rinnovò la protezione e la difesa a favore di Fiore e degli altri monasteri dell’ordine; confermò poi tutte le libertà, le immunità e le esenzioni concesse da Enrico VI, da sua madre Costanza d’Altavilla e dalla sua prima moglie, Costanza d’Aragona. Vi aggiunse il divieto, esteso a tutti, di caccia, di pesca, di costruire forni per la pece nel territorio del monastero senza il per-messo dell’abate. Come nel caso dei diritti di pascolo concessi da Enrico VI nel 1194, chi avesse ottenuto il permesso di compiere le diverse attività ricordate sarebbe stato tenuto al pagamento delle prestazioni all’abate florense. Il monastero era poi libero, come nei decenni precedenti, dal pagamento di censi, di-ritti sulle terre, erbatico e ghiandatico, da ogni red-dito e tributo, da taglie, tassazioni, esazioni e servizi. Unica eccezione che Federico II volle mantenere fu quella relativa alla difesa delle proprietà monastiche poste nelle fortificazioni delle città del regno: per essa il monastero sarebbe stato tenuto a partecipare, in misura anche minima, alla costruzione di mura e di fossati, alla difesa e alla custodia, alla vigilanza diurna e notturna41.
Un secondo privilegio rilasciato nella medesima occasione confermava le diverse donazioni di dema-nio regio acquisite nel corso degli anni dall’abbazia silana42: la tenuta di Berano, nel territorio di Men-dicino, concessa dal re Federico stesso nel 1205 e il feudo appartenuto a Ruggero Saraceno, morto senza eredi, concesso da Costanza d’Aragona nel periodo della sua reggenza. Accanto a questi beni, sono ri-cordate le terre donate da Gismondo, figlio di Raone Battaglia, che si era fatto monaco a Fiore: le terre erano tenute a fornire un servitore, onere da cui il monastero era stato già in precedenza esentato. Vi era, infine, la tenuta di Mardati, presso Cerenzia, concessa dal conte Stefano Marchisorti e conferma-ta da Costanza d’Aragona. Tutti questi possessi di provenienza demaniale sarebbero stati esenti dalla revocatio generalis ordinata da Federico II per tutte le concessioni rilasciate in precedenza43. L’esenzione di Fiore e degli altri monasteri dell’ordine dalla revo-catio fu concessa proprio in ricordo di Enrico VI e di Costanza d’Altavilla: anche il padre di Federico, nel 1197, aveva infatti posto sotto la propria specia-
le protezione il monastero silano contro le richieste dei funzionari del regno che esigevano la restituzione delle terre del demanio regio, in ottemperanza a una analoga revoca decretata dall’imperatore44.
Due mesi più tardi, «post acceptum imperii dia-dema et ingressum regni, ac solemnem curiam Ca-puae celebratam», l’imperatore volle informare le diverse personalità e i funzionari regi della Calabria e della Val di Crati che il monastero di Fiore non era sottomesso, come tutte le altre istituzioni religio-se, ai provvedimenti presi a Capua, in particolare, evidentemente, all’editto de resignandis privilegiis45. Nonostante Federico II avesse voluto escludere l’ab-bazia florense «et eius in Calabria sitas filias abbatias» dall’ordinamento legislativo generale, l’abate Matteo volle ugualmente recarsi presso la corte imperiale, presentando i precedenti privilegi e chiedendo che gli fossero restituiti. Nel marzo del 1221, a Brindisi, Federico II confermò pertanto i documenti di En-rico VI e di Costanza, le terre in località Albe e il reddito di cinquanta bisanti d’oro dalle saline del Neto46. Nel giugno successivo, a Messina, restituì a Matteo i privilegi da lui stesso concessi solo pochi mesi prima, nell’accampamento di Castel San Pie-tro. Con quest’ultimo privilegio, tuttavia, l’impe-ratore non si limitò a confermare i due precedenti diplomi, «unum bulla aurea, aliud sigillo cereo robo-rata», ma concesse all’abate di Fiore poteri giurisdi-zionali relativi al territorio sottoposto al monastero, cioè la libertà di tenere curia o foro per giudicare i reati minori, esclusi quelli «de homicidio, de mutila-tione membri, de sanguine et de his que crimen lese respiciunt maiestatis». Inoltre, il monastero di Fiore e le sue chiese avrebbero goduto del diritto di asilo a favore di chiunque vi si fosse rifugiato47. Grazie a queste ultime disposizioni, l’abate di Fiore acquisì il ruolo di vero e proprio signore feudale sulle terre del monastero, ruolo che ora comprendeva non solo la possibilità di riscuotere denaro per le diverse attività esercitate nelle terre florensi con il suo permesso, ma anche i poteri giurisdizionali a lui delegati dall’im-peratore. La concessione dei poteri giurisdizionali all’abate di Fiore si poneva in netto contrasto con quanto era stato decretato pochi mesi prima a Ca-pua, quando l’imperatore aveva disposto che «nulla ecclesiastica persona vel secularis pro aliqua consue-tudine hactenus facta presumat in terris suis offi-cium iustitiarie modo quolibet exercere, nisi tamen illi iusticiarii, quibus fuerit a nobis officium com-missum; set omnia per iustitiarios ordinatos a nobis finiantur»48. Si trattava, dunque, di un privilegio ec-cezionale, a conferma della posizione particolare che Federico volle riservare al monastero di Fiore.
235
Nonostante gli ampi poteri delegatigli, l’abate Matteo stentava a far rispettare tutti i diritti di cui godeva ormai il suo monastero nel territorio silano, e a più riprese fu costretto a rivolgersi a Federico, ormai imperatore, rientrato nel regno di Sicilia, per-ché difendesse il cenobio nei suoi possessi e nelle sue libertà. Già nell’ottobre del 1220, da Castel San Pie-tro, il re di Sicilia aveva scritto a Luca, arcivescovo di Cosenza e suo familiare, ai giustizieri e al camerario di Cosenza perché risolvessero una questione sorta a seguito della revocatio generalis stabilita per il regno di Sicilia49. Matteo de Romania, magister della doana de secretis, mettendo in atto la revoca, aveva restitui-to al demanio regio la coltura di Berano, donata a Fiore da Federico stesso all’inizio del XIII secolo, e i possessi che erano appartenuti a Gismondo, figlio di Raone Battaglia, monacatosi a Fiore. Il magister doane aveva poi concesso questi beni ad altri, sub servicii recognitione. Federico infine li aveva affidati ad Amato, un suo nunzio, ignorando il fatto che in precedenza questi beni erano stati concessi al mona-stero silano. Nell’agosto del 1221 l’arcivescovo Luca, Landone, arcivescovo di Reggio, anch’egli familiare regio, e Riccardo, camerario imperiale della Val di Crati, risolsero la questione, ponendo l’abate Mat-teo in corporalem possessionem delle terre demaniali, e definendo la coltura di Berano secondo i suoi precisi confini. Il documento di Luca e di Riccardo fu poi confermato dall’imperatore nel settembre del 122250.
Nel giugno del 1221 Matteo si recò personal-mente a Messina per informare Federico riguardo ai numerosi soprusi che il monastero florense subiva, da parte di prelati et abbas ac monachi di chiese e di monasteri, in particolare dai religiosi greci del mo-nastero del Patir di Rossano, dai signori dei castra e dagli uomini delle città vicine51. Il castellano di San-ta Severina, ad esempio, non aveva permesso ai mo-naci di Fiore di percepire il sale dalle saline del Neto secondo quanto era stato loro concesso da Enrico VI, né aveva pagato il reddito di cinquanta bisan-ti dalla stessa salina, di competenza del cenobio fin dal 1195. Matteo si era inoltre lamentato del fatto che vi erano persone che facevano pascolare i propri animali, abitavano, cacciavano, facevano forni, pece, e anche un mulino per la lavorazione del ferro «in Sabuto in Campo Rotundo», senza permesso e senza alcun pagamento al monastero. Sia in questa occa-sione, sia l’anno seguente, durante l’assedio ai sara-ceni asseragliati sul monte Iato, nei pressi di Trapani, l’imperatore si rivolse ai suoi funzionari in Calabria e a tutti i suoi fideles perché riportassero l’ordine e rispettassero i diritti e libertà goduti dalla fondazio-ne silana52.
Ancora nel novembre del 1222 tuttavia Matteo fu costretto a rivolgersi nuovamente alla corte e in-formò l’imperatore del fatto che un certo Simone di Policastro aveva fatto costruire senza alcun permesso un ovile per le proprie greggi nella tenuta di Castel-lacio, donata al monastero di Fiore da Dionisio, ar-civescovo di Santa Severina nel 1209 o nel 121953. Simone poteva vantare una parentela altolocata: era fratello del vescovo di Catanzaro e nipote di Ales-sandro, signore di Policastro54. In seguito all’istanza di Matteo, Federico II incaricò i giustizieri imperiali della Terra Giordana, Giovanni, Nicola e Bartolo-meo de Logotheta, di condurre un’inchiesta sul fatto e, una volta accertate le ragioni di Fiore, di far rimuo-vere l’ovile55. Nel gennaio del 1224 la curia si riunì presso San Pietro di Cachinis, obbedienza di Santa Maria Latina, accolse la rinuncia da parte di Simone di Policastro a ogni rivendicazione sulla liceità del suo operato e confermò pertanto il pieno possesso della tenuta di Castellacio al monastero florense56.
Un ulteriore privilegio imperiale, concesso nel 1222 durante l’assedio al monte Iato, accordò ai florensi, ancora dietro loro richiesta, l’esenzione dal foro civile, secondo quanto il papa, in particolare Innocenzo III, aveva dichiarato nei privilegi di pro-tezione ed esenzione dati a Fiore57. L’esenzione per tutti gli uomini di chiesa del Regno dalla giurisdizio-ne dei tribunali secolari, del resto, era stata accordata dallo stesso imperatore nel novembre del 1220, al momento della sua incoronazione a Roma. La Con-stitutio in Basilica beati Petri, infatti, garantiva in toto le libertà della Chiesa: gli ecclesiastici dovevano essere esentati dalla giurisdizione dei tribunali seco-lari, e per soprammercato dalla tassazione secolare58. Tre anni dopo, nel 1225, si presentò l’occasione di fare uso del privilegio. I florensi infatti erano stati convocati in giudizio da Pietro di San Germano, giudice della corte imperiale, che si trovava a Cosen-za «pro imperialibus servitiis exequendis, et iustitia conservanda», per una sentenza in merito alla que-stione sollevata da Pietro, figlio di Pietro, e da suo figlio Ruggero, relativa al possesso di alcune terre59. I monaci di Fiore fecero presente al giudice la loro esenzione dalla giurisdizione civile, presentando il documento dell’imperatore; tuttavia si sottoposero ugualmente al giudizio di Pietro di San Germano, specificando tuttavia che il loro consenso volontario non doveva creare alcun precedente, nel caso che in altre future occasioni fossero stati convocati in giu-dizio da ufficiali laici.
Un’ultima questione in cui Federico II interven-ne, incaricando quali giudici l’arcivescovo di Cosen-za, Luca, uno dei suoi familiari, e Terrisio, vescovo di
236
Cassano, fu una contesa sorta tra il cenobio florense e il monastero greco di Santa Maria del Patir, presso Rossano, circa il possesso di alcuni pascoli. Le due fondazioni giunsero presto ad un accordo, secondo cui il luogo conteso, detto Trium Capitum, era la-sciato all’archimandrita del Patir, in cambio di un censo ricognitivo di una certa quantità di olio60.
A partire dalla data di quest’ultimo documento, cade un lungo silenzio in merito alle relazioni tra Fiore e la corte imperiale. Indubbiamente, la rottura dei rapporti tra Federico II e il papa, la scomunica lanciata da Gregorio IX nel 1227 e lo scontro armato tra i due avversari, con l’invasione del regno da parte dei clavisignati agli ordini di Giovanni di Brienne, giocarono un ruolo determinante nell’interruzione del favore imperiale per Fiore. Benché manchino pre-cise notizie sugli avvenimenti del periodo successivo al 1223, l’ipotesi che la posizione dell’abate Matteo nello scontro tra papato e impero fosse in favore di Gregorio IX si presenta come una chiave di lettura di immediata evidenza. Poco tempo dopo la scomunica comminata il giovedì santo del 1227 all’imperatore, Gregorio IX, tra giugno e luglio, confermò infatti la protezione apostolica e la dipendenza diretta dal-la Santa Sede, l’esenzione e le numerose indulgenze concesse al monastero silano dai suoi predecessori, inviando a Fiore cinque documenti, in forma di bol-le solenni o di brevi, nel giro di poco più di un mese, segno eloquente della presa di posizione dell’abate di Fiore e dunque di un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproche tra abbazia e sede romana confermato in questo difficilissimo periodo.
Anche successivamente alla chiusura della prima fase del contrasto con la pace di Ceprano, l’assolu-zione di Federico II dalla scomunica e i nuovi ac-cordi tra le parti, non vi sono tracce di una ripresa dell’interesse e del sostegno imperiali nei confronti del monastero silano, se non negli ultimi anni del regno dello svevo. Con la pace di Ceprano, nell’ago-sto del 1230, Federico aveva riconfermato, come nelle costituzioni di Capua, l’esenzione del clero siciliano dalla giurisdizione secolare61; aveva poi indetto un’amnistia generale verso i sostenitori del papa nell’Italia meridionale durante la sua assenza e aveva concesso la restituzione agli ordini del Tem-pio e degli Ospedalieri dei loro estesi possedimenti nel Meridione d’Italia, confiscati dopo la crociata a causa della condotta tenuta nei suoi confronti in Oriente62. Diversa sembra essere stata la sua posi-zione nei confronti dell’abbazia di Fiore: ancora nel 1233, Gregorio IX si trovò costretto a scrivere agli arcivescovi di Palermo e di Capua, familiari del-l’imperatore, perché presentassero a quest’ultimo i
privilegi da lui rilasciati al cenobio florense, lo per-suadessero a mantenerli e lo invitassero «a lasciargli in pace, avendogli a cuore a riguardo di Dio, della Sede apostolica e suo»63. Poco tempo prima, il papa aveva personalmente confermato tre importantissi-mi privilegi, tra cui quello munito di bolla d’oro, concessi tempo prima da Federico, riportandone l’intero testo e conferendo ad esso valore identico agli originali: veniva evidentemente a mancare una conferma simile da parte dell’imperatore, per cui era il papa stesso a provvedere in questo senso. E ancora negli stessi giorni, aveva concesso all’abate di Fiore la facoltà di assolvere dalla scomunica quei mona-ci e quei conversi del monastero che erano venuti frequentemente alle mani, segno di contrasti - di natura forse politica- tra i due partiti opposti che dividevano la comunità monastica, problemi che si ripresentarono ancora nel 123864. Di nuovo, in una data imprecisata ma certamente collocabile in questa delicata fase, il pontefice dovette affidare la difesa del monastero di Fiore al cantore di Cosenza, contro gli interventi di alcune persone, ecclesiastiche e laiche, e ancora nell’ottobre del 1236 incaricò il vescovo di San Marco di difendere Fiore a malis hominibus65. Si tratta di atti significativi, in considerazione del fatto che invece, fino al 1223, era sempre stato Federico il difensore per eccellenza del cenobio, e a lui i monaci florensi si erano rivolti in numerose occasioni perché facesse valere i loro diritti.
Medesime difficoltà nelle relazioni con l’impe-ratore nel periodo della prima rottura tra papato e impero sono testimoniate anche per il monastero florense di Fonte Laurato, che, al pari di Fiore, ave-va ampiamente goduto del favore di Federico II a partire dal suo ritorno nel regno di Sicilia66. Che la rottura con l’ordine florense non fosse generalizzata, ma dovuta probabilmente alla specifica realtà e alla presa di posizione degli abati durante la fase più dura dello scontro pare testimoniato dal caso di un mo-nastero campano. Nel novembre del 1232 Federico raccomandò ai funzionari regi di ogni ordine e grado di rispettare, e di far rispettare, il cenobio florense di Santa Marina della Stella, posto sopra Maiori, e tutti i privilegi di cui godeva, in considerazione della «vitam religiosam et conversacionem honestam pre-dictorum abbatis et fratrum, nostrorum fidelium». In cambio della protezione e dei privilegi concessi, l’imperatore chiedeva «a fratribus enim Florensibus preter oracionum munus, quibus nos iugiter pro-secuntur, nihil exigi volumus et mandamus»67. La durevole fiducia di Federico II verso la fondazione amalfitana, che aveva beneficiato già nel periodo 1225-1226, fu probabilmente dovuta proprio alla
237
fedeltà nei suoi confronti dimostrata dai monaci di Santa Marina.
È certamente molto difficile comprendere che cosa avvenne a Fiore a partire dalla metà del terzo decennio del secolo, considerato il silenzio pressoché completo delle fonti in merito. I pochi documen-ti a noi noti confermano comunque che la politica di Federico II per il controllo dei beni ecclesiastici non escludeva l’abbazia silana, in precedenza salva-guardata delle revoche demaniali e dei privilegi regi promulgate per tutto il regno di Sicilia. Nel 1239, ad esempio, i florensi dovettero presentarsi di fron-te al camerario della Val di Crati per dirimere una questione relativa a una vigna, loro contesa68: nel-l’occasione non ebbero modo di comportarsi come nel caso di quattordici anni prima, quando, nel no-vembre del 1225, avevano fatto presente a Pietro di San Germano, giudice imperiale, di non esser tenu-ti a presentarsi al foro civile, in forza di un privi-legio imperiale. Ancora nel 1248, furono convocati di fronte alla curia dell’imperatore perché era stata loro contestata la mancata consegna dei lignamina galearum a cui erano tenuti per il possesso di nu-merosi beni feudali69. In quell’occasione, tuttavia, i monaci presentarono una lettera dell’imperialis ma-gister doane de secretis et questorum, Matteo Marcla-faba, risalente allo stesso anno, in cui il funzionario richiamava tutti i camerari, i collettori di legname e i procuratori del demanio all’osservanza dei pri-vilegi concessi all’abbazia da parte di Federico II70. I documenti imperiali gli erano stati presentati dai monaci di Fiore, ed egli, nell’occasione, ricordò in particolare l’immunità dalla colletta del legname, di cui godeva il cenobio silano - di cui, peraltro, non abbiamo precedente notizia -.
Evidentemente, nel 1248 si era creata una situa-zione nuova, per cui il cenobio era rientrato nelle grazie di Federico II: con ogni probabilità, si trattò dell’allontanamento da Fiore del partito degli oppo-sitori dell’imperatore e della loro sostituzione con persone di sua fiducia. Grazie a un breve di Inno-cenzo IV, infatti, veniamo a sapere che in una data imprecisata l’imperatore aveva fatto cacciare, tramite un suo nunzio, l’abate eletto di Fiore, Giovanni di Braalla, trovando appoggio e sostegno in alcuni per-versi monaci del monastero71. Evidentemente, nella comunità di Fiore il partito favorevole alla chiesa ro-mana non era affatto compatto e vi erano monaci (appunto i perversi monachi del documento di In-nocenzo IV) che appoggiavano Federico II, come del resto sembrano confermare i provvedimenti del pontefice del 1233 e del 1238 relativi alle violenze insorte tra i monaci. Fu certo successivamente al-
l’episodio dell’allontanamento dell’abate Giovanni e alla sua sostituzione con una persona di sua fiducia - forse un altro Giovanni, come risulterebbe da un breve regesto del 1249 - che l’imperatore riprese il suo sostegno in favore di Fiore72.
Dopo la riconferma, almeno parziale, di alcuni privilegi concessi al cenobio, nel dicembre 1250, pochi giorni prima della morte, l’imperatore accolse l’istanza dell’abate, di cui non conosciamo il nome, e dei monaci di Fiore, che gli avevano presentato un suo privilegio, ormai di difficile lettura a causa della antiquitatis rubigine, per averne una nuova copia73. Federico, «attendentes fidem puram et devotionem sinceram, quam predicti abbas et conventus ad excel-lentiam nostram gerunt, considerantes quoque fidelia servitia, que culmini nostro exhibuerunt hactenus et exhibere poterunt in futurum», acconsentì volentieri alla richiesta del florensi e confermò il documento, con cui, nel 1221, aveva richiamato i suoi funzionari al rispetto delle libertà di compravendita e di passag-gio in terra e in mare concessi all’abbazia74.
Fu questo l’ultimo atto compiuto da Federico II in favore di Fiore, il monastero che per quasi un ventennio, dal settembre del 1206 al 1223, conside-rò come una fondazione dei propri genitori, l’unico cenobio da loro istituito nel regno di Sicilia. Proprio in memoria di Enrico VI e di Costanza la volle soste-nere e proteggere fino al momento in cui la rottura con il papato e la posizione del cenobio a favore di quest’ultimo non lo spinsero ad assumere un atteg-giamento diverso.
Anche nel periodo successivo alla morte dell’im-peratore le notizie relative ai rapporti tra i suoi suc-cessori e l’abbazia silana rimangono molto scarse.
Nel maggio 1252, Pietro Ruffo di Calabria, con-te di Catanzaro passato al partito papale e posto, in qualità di marescalcus del regno, al governo della Sicilia, rivolgendosi al magister camerarius della Val di Crati e della Terra Giordana lo incaricò di resti-tuire al monastero di Fiore il possesso della tenuta di Fontana Murata75. «De beneplacito domini nostri serenissimi regis Conradi», infatti, a tutte le chiese e luoghi religiosi dovevano essere riconsegnati i diritti e le libertà godute in precedenza. Una volta rientrati in possesso della tenuta, posta a Isola di Capo Riz-zuto, i monaci florensi avrebbero potuto condurvi solo «animalia domita, sine canibus et campanis», dal momento che le terre di Fontana Murata erano poste all’interno di una difesa regia.
Dopo l’avvento di Manfredi sul trono di Sicilia l’11 agosto 1258, in due occasioni simili - nel 1259 e nel 1264 - i monaci di Fiore dovettero rivolger-
238
si ai giudici regi della magna curia perché facessero cessare i soprusi del conte di Catanzaro e dei suoi procuratori per il controllo di una tenuta sulla Sila, bagnata dall’Ampollino76. Da quanto si può capire, i problemi sorgevano dal fatto che non era del tut-to chiaro se le terre in questione fossero comprese nel territorio di Cosenza o in quello di Policastro, quest’ultimo di competenza del comitatus di Catan-zaro. Problemi simili erano sorti già in precedenza, quando era titolare della contea Pietro Ruffo di Ca-labria; egli, nel luglio del 1253, era riuscito ad otte-nere l’assegnazione della tenuta, dal momento che gli arbitri incaricati stabilirono che essa faceva parte del territorio di Policastro77. I giudici della corte di Manfredi, invece, rovesciarono la sentenza, e ordina-rono ai conti di Catanzaro succeduti a Pietro Ruffo - Nicoloso nel 1259 e Raul nel 1264 - di far cessare ogni «turbatione, inquietatione et molestatione» nei confronti del monastero di Fiore, e a rispettare i suoi diritti sulla tenuta dell’Ampollino.
Tuttavia, nonostante l’apparente sostegno, in questo caso, da parte dei funzionari regi, problemi con la corte sveva si presentarono anche durante il regno di Manfredi: nel 1266 Clemente IV incaricò un suo legato, il cardinale Rodolfo, di rimettere in carica l’abate di Fiore e gli altri abati florensi, che erano stati allontanati dai loro monasteri dai fauto-ri dell’ultimo regnante svevo78. Il silenzio pressoché completo delle fonti in merito non permette tuttavia di comprendere il tipo di relazioni intercorse tra la corte di Manfredi e l’abbazia silana. Anche in questo caso, come Federico II prima di lui, il re di Sicilia aveva probabilmente insediato a Fiore persone a lui fedeli, allontanando invece coloro che non godeva-no della sua fiducia. Fu forse proprio in relazione all’insediamento di un abate gradito alla corte che è attestato un ultimo atto di favore nei confronti della religio florense da parte della nobiltà regnicola fedele a Manfredi.
Nell’ottobre del 1263, Federico Lancia, conte di Squillace, prese l’iniziativa per la fondazione di un nuovo monastero florense, che sarebbe dovuto sor-gere nelle sue terre. Federico era zio, da parte ma-terna (era fratello di Bianca, madre di Manfredi), del re. Dopo la curia generalis tenuta da Manfredi a Barletta nel febbraio del 1256, era stato nominato vicario generale per la Calabria, ormai sottratta al controllo di Pietro Ruffo, il conte di Catanzaro che alla fine del regno di Federico II era passato al partito di Innocenzo IV.
Rivolgendosi all’abate di Fiore Tommaso, Federi-co offrì a lui e al suo monastero terre, diritti e beni per l’istituzione di un nuovo cenobio florense, che
doveva esser sottomesso a Fiore come una figlia nei confronti della madre79. La nuova comunità mona-stica florense si sarebbe dovuta insediare nel territo-rio di San Martino, località nei pressi di Taurianova, uno dei territori di proprietà del conte. Alla dona-zione delle terre, Federico Lancia aggiunse un’offerta di cinquecento pecore, trenta buoi domati, sedici mucche e cento maiali, donazione che completò quella dei beni di sua competenza posti nel territo-rio di Augusta e di San Martino, tra cui erano com-presi vigne, case, terre colte e incolte, riservando ai monaci florensi tutti i diritti e pertinenze connessi. A questa ampia dotazione, il conte di Squillace volle aggiungere altre terre, in località San Nicola di Con-dano, e il libero pascolo, senza il pagamento dell’er-batico, per mille pecore nel territorio di San Martino e in tutto il suo comitatus, sia nel versante montano dell’Aspromonte, sia nella zona costiera, dove gli animali avrebbero potuto svernare. Come Fiore e Fonte Laurato, il cenobio florense presso San Marti-no, dedicato a San Michele, avrebbe potuto vendere e comprare senza essere sottoposto al pagamento di teleonatico, plateatico e passaggio.
Non sappiamo tuttavia se la nuova comunità flo-rense fu mai costituita. Il documento di donazione di Federico Lancia ne è l’unica testimonianza, e in seguito non possediamo più alcuna notizia relativa a un monastero florense di San Michele. Probabil-mente, la fine della dinastia sveva l’arrivo degli An-gioini nel regno di Sicilia impedirono l’effettivo sor-gere del cenobio. Il privilegio del conte di Squillace rimane dunque solo come l’estrema testimonianza del durevole successo e della stima che l’abbazia di Fiore riscosse, nonostante le alterne vicende e le dif-ficoltà dovute allo scontro tra papato e impero, tra i regnanti e la nobiltà regnicola durante tutto il pe-riodo svevo.
3. Le relazioni con la società regnicola
Il numero degli atti privati conservati nell’archi-vio florense in questo periodo si fa molto sporadico: si è conservato, infatti, solo il regesto di alcuni in-strumenta di acquisto da parte del monastero. Essi attestano in ogni caso il continuo interesse di Fiore per il territorio intorno a Cosenza, evidentemente nella zona della grangia di Canale: nel 1222 il ceno-bio acquistò una parte di un querceto, posto proprio a Canale, e, nel 1231, alcuni possessi in località Bot-tulo, che, come abbiamo visto, doveva essere conti-gua a Canale80. Nello stesso anno è attestato anche la compera di una difesa sita a Petrafitta, luogo nelle
239
immediate vicinanze, appartenente ad Andrisana, fi-glia di Luca di Pedace. Ancora nel 1231 il presbitero Clemente e Martino, figli di Giovanni Cantarello, vendettero a Fiore un oliveto in località Malovici-no81.
Non manca il ricordo di qualche donazione, an-che da parte di personaggi altolocati: sempre nel 1231 Settembruna, figlia di Domenico, offrì al mo-nastero un querceto e mezzo oliveto posti nel casale di Tiniano; l’anno seguente un brevissimo regesto ricorda una donazione di terre da parte di Riccar-do, camerlengo dell’imperatore82; nel 1234, infine, Giovanni Stefanicio, abitante a Santa Severina, donò a Matteo, abate di Fiore - si tratta dell’ultima atte-stazione del suo abbaziato -, alcune terre coltivate in località Rumbalati83. Giovanni doveva essere un per-sonaggio appartenente a un’importante famiglia di Santa Severina: il suo nome è ricordato nei privilegi di Federico II relativi alla concessione della tenuta de Mardati, che confinava appunto con le terre dei figli di Giovanni Stefanicio; nella medesima zona la famiglia possedeva anche un mulino84. Dal 1272 al 1295 un altro appartenente alla famiglia Stephanitius, Ruggero, divenne arcivescovo di Santa Severina85.
Alle brevi notizie relative a questi ultimi atti pri-vati, conservate dall’indice dell’archivio florense, possiamo aggiungere alcuni documenti redatti in lingua greca, dispersi in data anteriore all’unione del monastero di Fiore con i cistercensi o comunque non riportati dall’indice a noi noto. Queste carte at-testano i legami del cenobio florense con la popola-zione ancora bizantina della zona ad est e a sud di Fiore, comprendente i centri di Cerenzia e di Santa Severina, fino alla costa adriatica, dove il monaste-ro silano del resto possedeva vasti interessi e gestiva terre e grange. Le carte greche attestano i legami spi-rituali con i monaci latini, da parte dei quali i do-natori chiedevano preghiere e suffragi, senza sentire dunque alcun contrasto nella diversità di origine e di rito rispetto ai florensi.
Ancora nel 1211, Filippo, figlio di Giovanni di Santa Severina, vendette a Matteo e al monastero di Fiore alcune terre, site in territorio di Cerenzia. Nel documento di vendita si ricorda la precedente dona-zione di un praedium fatta al monastero da un certo domino Nuredo86. Un decennio più tardi, nel 1223, il
prete Andrea Scaldieri e suo figlio Nicola donarono all’abbazia di San Giovanni di Fiore una vigna sita nei pressi di Santa Severina, in località detta Cuttu-fin, e una casa a Santa Severina, posta intra terminos Theologi (cioè del monastero di San Giovanni evan-gelista e teologo, secondo la ricorrente definizione greca)87. Al cenobio florense giungevano anche la-sciti testamentari, come attestano le ultime volontà di Clementia, moglie di Lorenzo Caballario, che nel gennaio del 1226 volle lasciare a Fiore alcuni campi in località Gimmella, nelle vicinanze del monastero88.
Nel 1228, Nicola primicerio, genero del diacono Nicola Prasinaci, donò all’abbazia un campo posto in territorio di Santa Severina, in località detta Bi-tauro; in cambio richiese che i monaci pregassero «in divinis sacrisque diptychis pro meis parentibus et socero meo et me peccatore, ut misericordiam inveniamus in die iudicii»89. Per lo stesso motivo, l’anno seguente Nicola Magidiota e Teodoro suo pa-rente vollero donare al monastero di Fiore tre vigne ormai abbandonate. Nell’occasione, consegnarono all’abate Matteo i quattro documenti relativi all’ac-quisto, compiuto dai loro parenti, delle vigne donate ai monaci90.
Questi documenti sono probabilmente solo una spia del certo più vasto richiamo e della devozione esercitata dai monaci florensi in Calabria, e in parti-colare nella zona della Sila, sia verso il mar Tirreno, nella zona cosentina e della Val di Crati, sia verso l’Adriatico e lo Ionio, nei territori in cui era ancora viva l’influenza bizantina.
La scarsità numerica e la sinteticità dei regesti dei documenti privati, ancora conservati a Fiore verso la fine del ‘700, lasciano ben poco spazio a qualche in-terpretazione. Sono attestate ancora alcune donazioni di terre, vigne e case, sia nella zona di Cosenza, sia in quella di Caccuri e Santa Severina, dunque sia verso est sia verso ovest rispetto al monastero, a conferma che i legami di devozione con la popolazione non erano certo esauriti91. Si è poi conservata un’unica notizia relativa ad un acquisto da parte del monaste-ro nel 1249, mentre non sono attestati documenti di vendita92. In due occasioni avvenne una permuta di terre, e nel 1265 l’abate Orlando affittò una vigna del monastero, al censo annuo di una libbra di cera93.
240
Note
1 «Vniversis quibus littere iste ostense fuerint frater Ioa-chim, dictus abbas de Flore, eternam in domino salutem. (...) rogo ex parte Dei omnipotentis coabbates meos et priores et ceteros fratres metuentes Dominum et ea qua posse videor auctoritate precipio, quatinus, presens scriptum aut exemplar habentes secum ac si pro testamento, opuscula que hactenus confecisse videor et si quid me de novo usque ad diem obitus mei contingerit scriptitare quamcitius poterint collecta omnia, relictis in salva custodia exemplaribus, apostolico examini re-presentent, recipientes ab eadem sede vice mea correctionem, et exponentes ei meam circa ipsam devotionem et fidem, et quod ea semper tenere paratus sim, que ipsa statuit vel statuerit nullamque meam opinionem contra eius defendere sanctam fidem, credens ad integrum que ipsa credit, et tam in moribus
quam in doctrina eius suscipiens correctionem, abiciens quos ipsa abicit, suscipiens quos suscipit ipsa, credensque firmiter non posse portas inferi prevalere adversus eam, etiam si ad ho-ram turbari et procellis agitari contingat, non deficere fidem eius usque ad consumationem seculi».
2 Riguardo all’uso, da parte di Innocenzo III, delle opere di Gioacchino, vd. da ultimo Ch. Egger, Joachim von Fiore, Rai-ner von Ponza und die römische Kurie, in Gioacchino da Fiore tra Bernardo e Innocenzo cit., p. 129-162, e relativa bibliografia.
3 Vd. vol. 2, p. II, doc. n. 13; p. IV, doc. n. 1; p. VIII, docc. nn. 3 e 4.
4 Vd. ivi, p. I, doc. n. 148.5 A questo riguardo, cfr. il numero 11 (1997) della rivista
«Florensia», che riporta diversi articoli dedicati alla suggestiva
241
figura del monaco ponzese.6 Vd. i numerosissimi documenti regestati in vol. 2, p. VIII,
nn. 2 e 5.7 Vol. 2, p. I, doc. n. 71.8 Ivi, p. I, docc. nn. 78 e 95.9 Kouldelka, Monumenta diplomatica s. Dominici, in Monu-
menta ordinis fratrum predicatorum historica, XXV, n. 123, p. 124-125; cfr. H. Vicaire, Histoire de saint Dominique, II, Paris 1982, pp. 194-195; vd. vol. 2, p. I, doc. n. 112.
10 In merito S. Tugwell, Notes on the life of St Dominic [1996], pp. 33-46; che fornisce anche una nuova edizione del-la lettera di Onorio III (pp. 169-173; ringrazio l’autore per la segnalazione); cfr. BOP n. 16, p. 10. Secondo Tugwell, l’inizia-tiva di radunare un gruppo di predicatori sotto la guida di Do-menico si deve proprio allo stesso Ugolino: Giuseppe sarebbe «one of Ugolino’s trusted agents» (Tugwell, Notes on the life of St Dominic [1996], p. 46). Lo studioso sottolinea come la let-tera dovette essere affidata personalmente a Domenico, mentre anche gli altri ecclesiastici destinatari (tra cui Giuseppe; al suo fianco sono nominati anche un vittorino, un vallombrosano e tre monaci appartenenti a fondazioni non meglio identificate) si trovavano presso la curia (ivi, pp. 39-40). A proposito del fatto che l’incarico abbia avuto un’effettiva esecuzione, Tugwell non è d’accordo con Vicaire, per il quale l’attività di Domenico
in Lombardia, nei mesi successivi, costituirebbe la messa in atto di queste disposizioni (ivi, pp. 43-46; cfr. Vicaire, Storia di san Domenico, pp. 564-566). Sulle legazioni di Ugolino nell’Italia settentrionale tra 1217 e 1219: W. Maleczek, Papst und Kardi-nalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coelestin III. und Innocenz III., Wien 1984 (Publikationen des Historischen
Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, I/6), pp. 130-131.
11 Vol. 2, p. I, doc. n. 130.12 Auvray, Le Régistres cit., n. 686; Potthast 8771.13 Vol. 2, p. I, docc. nn. 163 e 167.14 Vd. ivi, doc. n. 164.15 Auvray, Les Régistres cit., n. 1586 (28 ottobre 1233).16 Ivi, nn. 2525, 2535, 2537 e 2653. La carica di notarius
pape era prestigiosa: un notaio dipendeva direttamente dalla giurisdizione del pontefice, il che rafforzava il suo prestigio cu-riale. L’incarico poi poteva essere uno dei gradini per la carriera cardinalizia, come avvenne nel caso di Raniero da Viterbo, che da notaio pontificio, attestato nel 1215, l’anno successivo fu nominato da Innocenzo III cardinale diacono (sul quale vd. W. Maleczek, Raniero (Capocci) da Viterbo, in DBI 18, pp. 608 ss.; Id., Papst und Kardinalskolleg, p. 185). Per tale carriera cancel-leresca era ritenuta indispensabile una specifica preparazione culturale in retorica e in ars dictandi; Giuseppe dunque o aveva conseguito già a suo tempo, ancor prima dell’incarico al fianco di Domenico, una simile preparazione, o vi provvide nel terzo decennio del secolo, nel periodo in cui mancano sue precise notizie sia nei documenti florensi, sia in quelli papali.
17 In proposito, vd. G. G. Merlo, «Militare per Cristo» con-tro gli eretici, in «Militia Christi» e crociata nei secoli XI-XIII, Milano 1992, pp. 355-384, ripubblicato in Id., Contro Gli ere-
tici. La coercizione all’ortodossia prima dell’Inquisizione, Bolo-gna 1996, pp. 11-49, in part. p. 32.
18 V. De Fraja, Usi politici della profezia gioachimita, in An-nali dell’Istituto storico italo-germanico di Trento, 25 (1999), pp. 375-400. M. Rainini, I predicatori dei tempi ultimi. La rielaborazione di un tema escatologico nel costituirsi dell’identità profetica dell’Ordine domenicano, in «Cristianesimo nella sto-ria», 23 (2002), pp. 320-325, ha ulteriormente puntualizzato l’intervento di Giuseppe nella redazione del testo del 10 di-cembre 1233, sottolineando la citazione dell’interpretazione “per concordiam” - la più tipica forma di esegesi di Gioacchi-no - esplicitamente ricordata nel testo della lettera. Vd. anche Id., Giovanni da Vicenza, Bologna e l’Ordine dei Predicatori, in «Divus Thomas», CIX/1 (2006), in preparazione, e la relativa bibliografia. Ringrazio l’autore per avermi messo a disposizione il testo prima dell’uscita a stampa.
19 Vol. 2, p. I, doc. n. 181.20 Ivi, p. VI, doc. n. 7.21 Ivi, p. I, doc. n. 203.22 Cfr. infra, cap. IV, pp. 51-52.23 De La Roncière, Les Régistres cit., n. 2948; Russo, n. 952;
Id., Gioacchino da Fiore e le fondazioni cit., p. 194.24 Russo, Gioacchino da Fiore e le fondazioni cit., p. 194.25 Ivi, p. 192-193. È forse dovuta a questa annessione la
presenza, in Sicilia, di una fondazione definita, in una bolla di Paolo II del 2 gennaio 1467, Ordinis Florensis. Il monastero, o chiesa, di San Benedetto di Ambuali, in diocesi di Agrigento, in quella occasione fu affidato al frencescano Giacomo di San Filippo, lettore e maestro di teologia, perché ne curasse l’am-ministrazione. Cfr. Russo, Gioacchino da Fiore e le fondazioni cit., p. 207.
26 Cfr. infra, cap. IV, pp. 60-61.27 Vol. 2, p. I, doc. n. 183.28 Ivi, doc. n. 182.29 Ivi, doc. n. 184.30 Ivi, doc. n. 193.31 Ivi, doc. n. 205.32 Ivi, doc. n. 200. 33 Ivi, doc. n. 108. Da Basilea è datato anche un privilegio
in favore del monastero di Fonte Laurato.34 «Monasterium Floris, quod solum in Sicilie regno funda-
verunt dominus imperator pater noster et mater nostra domi-na imperatrix bone memorie, dotaverunt prediis, et privilegiis specialiter decoraverunt».
35 Vd. ivi, doc. n. 114.36 Notizie sintetiche riguardanti la grangia di Canale, di
competenza del monastero almeno fino al 1576, in Napolita-no, S. Giovanni in Fiore, II, pp. 206-209, nota 23.
37 La grangia di Santa Maria della Terrata, presso Rocca di Neto, risulta appartenere al monastero silano ancora alla metà del ‘700: per le notizie in merito, cfr. ivi, pp. 227-229, nota 33.
38 La grangia cistercense presso il casale di Terrate è ricorda-ta in un documento di Federico II, a favore dei monaci di San-t’Angelo, del maggio 1223 (Pratesi, Carte latine cit., p. 313).
39 Per quest’ultima grangia, vd. ancora Napolitano, S. Gio-
242
vanni in Fiore, pp. 234-236, nota 35.40 Vd. vol. 2, p. I, doc. n. 114.41 Ivi: «ita tamen ut, respectu domorum et possessionum,
quas nunc habet aut amodo habuerit in forteritiis regni nostri civitatum et tenimentis earum, vel occasione utilitatum, quas pro tempore poterit consequi, solvere aliquid in datiis publicis vel privatis, in constituendis muris, vel carceribus inquerendis, sive faciendis fossatis, sive etiam in defensione aut custodia, vel nocturnis et diurnis vigiliis civitatum, aliquando dare aliquas operas, aut conferre, minime teneatur».
42 Ivi, doc. n. 115.43 Ivi: «Firmissime statuentes ut revocatio generalis de qui-
busdam preteritis concessionibus nostris in regno iussa fieri, nec super dicte culture nec super ipsarum possessionum liber-tate ipsi monasterio noceat, sed earundem rerum omnium tam dono et possessione perpetuo gaudeat, quam etiam libertate».
44 Ivi: «Debitis ceterarum ecclesiarum regni nostri beneficiis pro gratia pie devotionis et innate compassionis intendimus, sed monasterium Floris, quod solum in Sicilie regno funda-verunt dominus imperator pater noster et mater nostra domi-na imperatrix bone memorie, dotaverunt prediis, et privilegiis specialiter decoraverunt, hereditaria pietate, velut quadam beneficiandi successione, tueri, reggere er relevare debemus; et tantum ei gratie et favoris impendimus, ut opus tantorum fundatorum, Deo cooperante, nulli unquam valeat defectui vel despectui subiacere». Per il documento di Enrico VI relativo alla difesa del monastero dalle richieste connesse con la revoca-tio, vd. ivi, doc. n. 11.
45 Ivi, doc. n. 117. In proposito al de resignandis privilegiis, vd. Abulafia, Federico II, pp. 116-118.
46 Ivi, docc. nn. 119 e 120. In quell’occasione, un privilegio analogo fu emesso per il monastero di Fonte Laurato.
47 Ivi, doc. n. 122. Un’analoga concessione a Fiore e al paese di nascita di Gioacchino del diritto di asilo era stata forse data da Enrico VI; cfr. Vita, p. 190: «Denique [Ioachim] tantam invenit gratiam coram eo [Henrico] et principibus eius, ut etiam locum nativitatis sue specialis custos, quam Theotonici stanszaran dicunt, sollecite custodiret. Factaque sunt Florense monasterium et casalis Celicum eius patria quasi due confugii civitates».
48 Ryccardi de Sancto Germano Chronica, p. 92.49 Vol. 2, p. I, doc. n. 113.50 Ivi, docc. nn. 125 e 130.51 Ivi, doc. n. 121.52 Ivi, doc. n. 127.53 Ivi, doc. n. 131.54 Dovrebbe trattarsi del vescovo Roberto, attestato nel-
l’agosto del 1217 e nel settembre 1222: cfr. Kamp, Kirche und Monarchie cit., p. 951.
55 La famiglia de Logotheta, il cui nome allude alla sua prove-nienza dall’aristocrazia burocratica greca, era insediata a Reggio Calabria e dintorni. I suoi membri, sotto Federico II, ebbero
incarichi cavallereschi. Un componente della famiglia, Riccar-do, fu vescovo di Cefalù; altri erano in servizio come tesorieri, amministratori dei beni della corona o castellani in Calabria,
come falconieri a corte, e infine come amministratori della cas-sa di guerra negli Abruzzi. Cfr. N. Kamp, Potere monarchico e chiese locali, in Federico II e il mondo mediterraneo cit., p. 94.
56 Vol. 2, p. I, doc. n. 140.57 Ivi, doc. n. 128.58 Abulafia, Federico II cit., p. 115.59 Vd. vol. 2, p. I, docc. nn. 141 e 142.60 Ivi, docc. nn. 136-138.61 Abulafia, Federico II cit., p. 115.62 Ivi, pp. 167-168.63 Vd. vol. 2, p. I, doc. n. 170. Cfr. anche De Leo, I mano-
scritti di Nicola Venusio cit., p. 75.64 Vol. 2, p. I, docc. n. 168 e 169; per i problemi sorti nel
1238, cfr. ivi, doc. n. 182.65 Cfr. ivi, docc. nn. 191 e 199.66 Vd. infra, cap. IV, pp. 51-53.67 Vol. 2, p. VII, docc. nn. 1-3 (Santa Marina); vd. infra,
cap. V, pp. 68-71.68 Vd. ivi, p. I, doc. n. 185.69 Vd. ivi, doc. n. 190.70 Vd. ivi, doc. n. 189. Matteo Marclafaba è considerato
«persona di fiducia» dell’imperatore, insieme al logoteta An-drea e ad Angelo de Marra, e scelto da Federico II per imporre i nova statuta, in particolare quelli relativi al monopolio regio su alcuni prodotti, in Sicilia e Calabria; cfr. J. - M. Martin, Diver-sità e unità del Regno, in Federico II. Immagine e potere, a cura di M. S. Calò Mariani e R. Cassano, Venezia 1995, pp. 6-7.
71 Ivi, doc. n. 193.72 Ivi, doc. n. 191.73 Ivi, doc. n. 192.74 Ivi, doc. n. 123.75 Vd. ivi, docc. nn. 194-196.76 Vd. ivi, docc. nn. 207 e 212.77 Vd. ivi, doc. n. 197 (deperdito).78 Ivi, doc. n. 214.79 Vd. ivi, doc. n. 211.80 «Instrumentum venditionis facte per Petrum Nigrum de
Casali Pietrafitte decime partis unius querqueti in loco dicto Canale anno 1222»: ivi, doc. n. 132. «Compra d’una posses-sione loco detto Bottulo fatta dal monastero florense 1231»: ivi, doc. n. 158.
81 Vd. ivi, docc. nn. 159 e 160.82 Vd. ivi, docc. nn. 161 e 166.83 Ivi, doc. n. 178.84 Vd. ivi, doc. n. 80.85 Cfr. Kamp, Kirche und Monarchie cit., pp. 890-892. 86 Vol. 2, p. I, doc. n. 70.87 Ivi, doc. n. 133.88 Ivi, doc. n. 143.89 Ivi, doc. n. 154.90 Ivi, doc. n. 156.91 Vd. ivi, docc. nn. 198, 199, 202, 204 e 210. 92 Vd. ivi, doc. n. 191.93 Vd. ivi, doc. n. 209; n. 213.
243
CapItOlO QuartO
l’ESpaNSIONE IN CalabrIa
1. Santa Maria di Fonte Laurato
Se si escludono le tre fondazioni di Bonum Li-gnum, di Tassitano e di Monte Marco, istituite da Gioacchino tra il 1195 e il 1198 in località assai prossime al monastero di Fiore, di cui tuttavia non abbiamo più notizie sicure successivamente al luglio 1208, la prima fondazione derivata da Fiore è l’ab-bazia di Fonte Laurato1.
1.a. La fondazioneLa documentazione superstite ci permette di se-
guire la storia dell’abbazia dalla sua fondazione, a partire dalla donazione del terreno da parte di Simo-ne di Mamistra e di sua moglie Gattegrima, signo-ri del castrum di Fiumefreddo. Come abbiamo già visto, nel settembre del 1201 Simone e sua moglie convocarono Gioacchino per vagliare insieme a lui le terre di loro competenza e scegliere quelle più idonee all’edificazione di un nuovo monastero florense2.
Nel giugno dell’anno successivo3, il vescovo di Tropea Riccardo cedette alla chiesa di Fiore e a Mat-teo, il nuovo abate succeduto a Gioacchino, tre chie-se poste nel territorio di Fiumefreddo, precisamente le chiese di Santa Domenica, di San Pietro e di Santa Barbara, con i loro possessi e terreni, libere da ogni esazione e da ogni servitù ad eccezione di un censo ricognitivo di tre libbre di cera all’anno. L’arenga del documento di donazione ricalca alla lettera le parole
dettate da Andrea, arcivescovo di Cosenza, nel testo della donazione a Fiore della chiesa di San Martino de Iove4. Il documento dell’arcivescovo sarebbe servi-to quindi come modello per la donazione del presu-le di Tropea. Il ruolo di mediazione dell’arcivescovo cosentino non sembra secondario: dalla conferma pontificia del possesso delle tre chiese, datata al 21 gennaio 1204, si viene a sapere che il documento del vescovo Riccardo era in effetti sottoscritto anche dall’arcivescovo Andrea, dal decano e dal cantore del capitolo, e munito dei loro sigilli.
Anche il monastero sorto sul terreno della chiesa di Santa Domenica, che seguiva la regola benedet-tina e le istituzioni dell’ordine di Fiore («secundum beati Benedicti regulam et vestri ordinis instituta»), fu esentato in perpetuo da ogni esazione da parte del vescovo e dei suoi successori. All’ordinario locale era affidato il compito di benedire gli abati del monaste-ro senza oneri e aggravi per il cenobio; non si sarebbe inoltre intromesso in alcun modo nello stabilire o nel rimuovere i prelati e i monaci5. Riccardo garan-tiva poi che il futuro monastero avrebbe liberamente ricevuto le donazioni dagli uomini di Fiumefreddo senza che lui e i suoi successori potessero interferire. Prese infine in considerazione l’eventualità, verifica-tasi in effetti nel monastero di Fiore, che qualche ca-nonico o chierico della diocesi volesse divenire mo-
244
naco del monastero, passando alla regola benedetti-na e all’ordine florense. In questo caso il postulante si sarebbe trasferito nel monastero con tutti i suoi beni mobili. Nel caso invece in cui qualche canonico o chierico avesse voluto far testamento in favore del monastero, gli era permesso di legare ad esso fino ad una terza parte dei suoi beni.
Ancora nel corso del 1203 il monastero ottenne una nuova donazione da parte di un altro signore locale, Matteo di Tarsia, dominus di Regina6, e di sua moglie Gattegrima. Il documento attesta che nel corso di quell’anno si era già costituita una comunità monastica, retta dal priore Benedetto, qui definito semplicemente frater, presso il luogo ormai detto Fonte Laurato. Alla nuova comunità fu donato un oliveto posto in località Malovicino7.
In un periodo forse compreso tra il 25 marzo e il 16 maggio 1204, ma più probabilmente tra il 1° settembre 1203 e il 20 gennaio 1204, Matteo di Tarsia, ora definito signore di Regina e di Fuscaldo, altro castello posto sulla costa tirrenica, effettuò una nuova donazione nelle mani del priore Benedetto8. Ricalcando alla lettera il documento di donazione di Simone di Mamistra, Matteo espresse il desiderio di edificare una domus religionis legata al monastero di Fonte Laurato. Chiese perciò a Benedetto, su con-siglio di Luca, arcivescovo di Cosenza, con il qua-le risulta perciò in diretto rapporto, di ricercare un luogo adatto «pro monasterio edificando» nella sua proprietà, posta a Paola. Dopo aver esaminato con il priore i luoghi più idonei, ripercorrendo dunque l’iter seguito per la fondazione del monastero di Fiu-mefreddo, Matteo dichiarò di averne identificati due «ad hoc congrua». Si trattava di due tenimenta, chia-mati Barrachi e Cammarelle, tra loro contigui, dal momento che ne venne indicata un’unica confinazio-ne. La proprietà, ubicata nel territorio di Paola, sulla costa tirrenica, dal mare risaliva la montagna fino al territorio di Montalto ed era circoscritta dal fiume Calopetro da un lato e da un terreno appartenente al monastero di Santa Maria delle Fosse, dipendente a sua volta da quello della Valle Giosafat, dall’altro9. Il donatore, come aveva fatto in precedenza Simone di Mamistra, non riservò nulla per sé al di fuori del-l’aggregazione alla fraternità monastica, e richiese le preghiere dei monaci per i vivi e per i morti.
Come già Simone, anche Matteo concesse che i suoi vassalli di Fuscaldo e di Paola potessero offrire le loro donazioni, oppure potessero vendere libe-ramente le loro terre al cenobio, eccetto i beni da loro ricevuti in feudo. Il monastero, da parte sua, era libero di far pascolare i suoi animali in tutte le terre del signore senza oneri; infine, sui terreni di
piena proprietà il monastero i monaci avrebbero po-tuto costruire mulini e altri edifici produttivi, esat-tamente come nella donazione di Fonte Laurato, a cui dunque Matteo implicitamente si rifaceva. Il monastero progettato da Matteo di Tarsia in realtà poi non venne mai istituito; il terreno da lui donato rimase in possesso del monastero di Fonte Laurato, che provvide a istituirvi un’importante grangia. La dipendenza florense sembra peraltro avere un ruolo determinante per il sorgere, in quel luogo, di un ca-sale e di un porticciolo: se al momento della fonda-zione non risulta che il luogo fosse abitato, nel 1267 la bolla di Clemente IV attesta la presenza, a Paola, appunto di un casale e del relativo porto.
L’istituzione ormai attiva, chiamata ancora, se-condo l’originario titulus canonico, «monasterium de Sancta Dominica», fu accolta sotto la protezione papale da Innocenzo III, in data 21 gennaio 120410. L’arenga solenne della lettera gioca con immagini della coltivazione: sebbene sia il Signore a far cresce-re, non colui che pianta o che irriga (I Cor 3, 7), tut-tavia spetta alla Santa Sede piantare i tralci, diffon-dere i germogli e irrigare con sollecitudine ciò che è stato propagato o piantato, in modo che la nuova pianta non venga meno e i nuovi tralci non si secchi-no, se il sole o altro calore arda sopra di loro prima che il tronco abbia messo radici nel terreno. Poiché dunque nel monastero di Santa Domenica era stata trapiantata da poco tempo l’osservanza religiosa, dal momento che il monastero di Fiore estendeva fino ad essa i propri tralci, il papa accoglieva sotto la prote-zione di san Pietro e sua lo stesso monastero, perché la nuova pianta fosse irrigata dalla mano apostolica e ricevesse incremento dal papa, dopo aver tratto be-neficio da quello divino. Segue la tradizionale clau-sola di regolarità, espressa per l’ordine florense con la formula «ordo monasticus, qui secundum Deum et beati Benedicti regulam atque institutionem Flo-rensium fratrum»11. Sono poi confermati i beni del monastero, in primo luogo le chiese di Santa Dome-nica, di San Pietro e di Santa Barbara, con tutti i loro possedimenti e le proprietà concesse dal vescovo di Tropea Riccardo nel giugno 1202.
Se nel 1202 si era rivolto all’abate di Fiore, nel maggio nel 1204 il vescovo Riccardo confermava, questa volta direttamente al priore di Fonte Laurato Benedetto e alla sua comunità, la facoltà di costruire liberamente il monastero e di osservarvi sempre la loro forma vitae12. Il presule confermò poi la chie-sa di Santa Domenica, identificata come il luogo più congruo per l’edificazione del monastero, e la chiesa di San Pietro, con le tenute e le pertinenze loro spettanti. Inspiegabilmente invece non si fece
245
cenno alla chiesa di Santa Barbara, nominata nella concessione del 1202 e confermata da Innocenzo, che pure era posta nella proprietà del monastero, né si nominava il censo ricognitivo annuo di tre libbre di cera che il monastero avrebbe dovuto pagare. È possibile che il censo fosse stato azzerato con la resti-tuzione della chiesa di Santa Barbara, già concessa in precedenza e confermata dal papa, forse rivendicata dal capitolo. Il priore e i monaci di Fonte Laurato avrebbero dovuto poi riservare al vescovo la stessa riverenza che i monaci di Fiore erano tenuti a di-mostrare nei confronti dell’arcivescovo di Cosenza13. Non fu specificato però, né esiste un documento di Fiore che lo chiarisca, in cosa consistesse per la pre-cisione la reverentiam richiesta da Riccardo. Il vesco-vo concedeva anche che i monaci vi istituissero o rimuovessero, senza interferenze o impedimenti da parte sua e dei suoi successori, i propri superiori e i confratelli, secondo le istituzioni del loro ordine («de prelatis seu fratribus in vestro monasterio sta-tuendis ac removendis secundum instituta ordinis vestris»). Al nuovo monastero fu inoltre riconosciuta la facoltà di godere dell’esenzione dall’ordinario nel-la medesima forma goduta da Fiore14 A conferma del documento del 1202, poi, il vescovo concedeva che la nuova fondazione ricevesse liberamente e ac-quisisse pacificamente, senza molestia di alcuno, le donazioni mobili e immobili che i chierici, i laici o anche le donne della diocesi, «salvis rationibus ma-tricis ecclesie Tropensis», avessero voluto devolvere al monastero. Ugualmente fu permesso ai canonici e ai chierici della diocesi che avessero voluto passare alla vita monastica, prendendo l’abito e l’osservanza flo-rense, di trasferirsi nel cenobio con tutti i loro beni mobili. Nel caso però che la scelta fosse stata com-piuta in punto di morte, era loro lecito legare a Fonte Laurato fino alla terza parte dei loro beni. Il vescovo infine richiese che i monaci osservassero fermamente quanto su sua richiesta avevano promesso, cioè di celebrare solennemente, alla scadenza annuale, l’an-niversario della morte dei vescovi di Tropea: «depo-sitionis tam nostre quam successorum nostrorum»; la sua richiesta testimonia che anche a Fonte Laura-to era viva una tradizione commemorativa, secondo la quale i monaci del monastero usavano ricordare, nel loro necrologio, i benefattori della fondazione15. Ugualmente essi erano tenuti, così come i loro suc-cessori, a non esigere nessun altro bene temporale appartenente ai canonici della diocesi, dal momento che i monaci florensi desideravano militare per il re eterno in modo pacifico e libero, rispettando il pro-posito della loro santa professione. In queste clauso-le, come nelle limitazioni per i lasciti testamentari
e nella probabile restituzione della chiesa di Santa Barbara, si intravedono le spie di contrasti avvenuti tra i monaci florensi e i canonici del capitolo per il possesso dei beni. I problemi inerenti ai lasciti pro-babilmente erano sorti forse non già tra il capitolo di Tropea e Fonte Laurato, monastero ancora in fieri, ma tra Fiore e il capitolo di Cosenza, o quello di Cerenzia, dal momento che Riccardo doveva avere ben presente la situazione dei rapporti tra Fiore e le istituzioni diocesane e voleva premunirsi contro eventuali contrasti.
In seguito, in un periodo anteriore al 1220, sor-sero nuove tensioni tra il monastero e il capitolo. Per quanto è possibile capire dai due brevi regesti super-stiti16, il papa aveva incaricato il vescovo di Mileto di dirimere la lite sorta tra le due istituzioni per il pa-gamento della decima; a seguito dell’intervento del delegato papale, la controversia fu chiusa e il vescovo Giovanni, con l’approvazione del capitolo, confer-mò e ampliò il privilegio concesso al monastero dal suo predecessore Riccardo.
Nel periodo compreso tra il maggio 1204 e il giu-gno 1205 il monastero, ormai ufficialmente chiama-to Fonte Laurato, ricevette titolo e dignità abbaziali; dovette percorrere dunque quel passaggio istituzio-nale da priorato ad abbazia che, come vedremo, è possibile seguire in dettaglio per il cenobio di Cala-bro Maria.
Il titolo di abate conferito a Benedetto compare per la prima volta in un privilegio del piccolo Fede-rico, re di Sicilia, in quegli anni sotto la tutela di Gu-glielmo Capparone: «Benedictus venerabilis abbas monasterii Sancte Marie de Fonte Laurato in Cala-bria, fidelis noster, et fratrum tuorum»17. Nel giugno 1205 il giovane re accolse sotto la sua protezione il monastero e tutto ciò che ad esso era pertinen-te; inoltre, «intuitu divine retributionis pro salute nostra et animarum divorum parentum nostrorum bone memorie», confermò al cenobio e all’abate di Fonte Laurato le proprietà fino a quel giorno acqui-site, in particolare il luogo in cui era stato costrui-to il monastero e tutti i terreni donati da Simone di Mamistra, di cui si riportarono i confini. Furo-no poi confermate le ampie libertà che il signore di Mamistra aveva concesso al monastero e che erano già state elencate nel documento di fondazione. Il re aggiunse infine l’ulteriore conferma della donazione di Matteo di Tarsia, cioè dei due terreni chiamati Barrachi e Cammarelle, di cui furono riportati i con-fini, e delle libertà concesse sull’esempio di Simone di Mamistra. Con le conferme, pontificia e regia, di tutte le proprietà di pertinenza del monastero, e con la concessione della protezione sia da parte del papa
246
sia da parte del re, poteva dirsi conclusa la fase di fondazione e di prima costituzione patrimoniale di Fonte Laurato, realizzatesi grazie all’interessamento di signori locali e dei vescovi di Tropea e di Cosenza.
I due presuli vollero essere tra i primi sostenito-ri, insieme al predecessore di Andrea, Bonomo, del nuovo monastero di Gioacchino; apprezzavano evi-dentemente il carisma e le capacità organizzative del-l’abate e svolsero un ruolo di promozione e di contat-to tra i monaci e i signori locali disposti a sostenere e a sovvenzionare le nuove fondazioni florensi.
1.b. Lo sviluppo Nel luglio del 1210 Federico, raggiunta ormai la
maggiore età il 26 dicembre del 1208, si rivolse nuo-vamente a Benedetto, abate di Fonte Laurato, per riconfermare tutte le proprietà del monastero18. Nel privilegio ritroviamo le donazioni e le cessioni delle libertà effettuate da Simone di Mamistra, secondo le parole del documento precedente; in rapporto alla donazione di Matteo di Tarsia, caduto il progetto di far sorgere su quei terreni un nuovo monastero florense, i monaci si orientarono verso l’erezione di una grangia, che nel 1208 sembra essere già attiva. Le libertà concesse a Fonte Laurato perché venissero passate al futuro erigendo monastero rimasero per-tanto all’abbazia di Fiumefreddo, che ebbe così la libertà di pascolo, di costruzione di mulini e folloni, di raccolta di legname, di tenere imbarcazioni per la pesca e il trasporto di merci, di compravendita per terra e per mare in due diversi territori, quello appunto di Fiumefreddo e quello di Paola. Federi-co aggiunse poi la conferma di ulteriori proprietà, ottenute per donazione e acquisto, tra il 1205 e il 1210. L’elenco si apre ricordando un oliveto, donato ancora da Matteo e da sua moglie Gattegrima; rima-ne incerto se possa trattarsi dell’oliveto donato nel 1203, chiamato de Malovicino. Esso risultava posto a Guarano, oggi San Pietro in Guarano, nelle vici-nanze di Cosenza. Federico confermò la donazione, ricordando che «oliveto de Guarano quod ipse (Mat-teo) cum <Gattegrima> uxore sua eidem monasterio donavit». Gli stessi coniugi avevano fatto dono al monastero anche di una casa a Fiumefreddo. Altre case si erano aggiunte nel frattempo; Federico infatti ricordò anche una casa a San Lucido, località posta sulla costa tirrenica tra Fiumefreddo e Paola, data al cenobio dall’arcivescovo di Cosenza, molto proba-bilmente Luca19; un’altra domus era stata concessa a Fonte Laurato da un certo Andrea, converso del mo-nastero, insieme a un frutteto e a una vigna. I beni donati dal converso si trovavano a Salerno, città da cui forse Andrea proveniva. Dal documento di Fede-
rico risulta poi che il cenobio aveva acquisito alcune proprietà, tramite donazioni e acquisti, anche nella zona di Amantea, denotando così la scelta di espan-sione lungo la costa del Tirreno, da quella calabrese fino a Salerno.
Il cenobio ottenne poi una nuova conferma da parte pontificia: il 14 luglio 1212 Innocenzo III ri-peté a Fonte Laurato i privilegi e le donazioni rice-vute20. Infine il 19 febbraio 1215, tra i destinatari del documento di approvazione degli statuti stesi nel 1209 dai tre abati florensi e dall’abate cistercen-se di Santo Spirito di Palermo, vi era anche l’abate di Fonte Laurato21. Il successore Onorio III il 23 ottobre 1216 confermò le libertà, le immunità e la donazione delle chiese di Santa Domenica e di San Pietro da parte del vescovo di Tropea Riccardo, ora detto bone memorie, del cui documento il papa ri-portò il testo22. Una nuova lettera, contenente forse la concessione della protezione apostolica, fu data il 1° dicembre dello stesso anno23. All’inizio del 1218 l’abate di Fonte Laurato fu nominato tra i cinque che reggevano le cinque abbazie florensi, cioè quelli di Fiore, di Acquaviva, di Calabro Maria, di Santa Maria de Monte Mirteto, a cui è aggiunto il priore di Tulli. Essi, su istanza del cardinale Ugolino d’Ostia, furono esentati dal pagamento della vigesima, richie-sta per la nuova crociata in Terra Santa24.
Nell’ottobre del 1216, il monastero di Fonte Laurato aveva raggiunto certamente una notevole stabilità economica e la comunità era consistente dal punto di vista numerico: fu infatti in grado di fondare una sua dipendenza, quella che poi diverrà l’importante abbazia di Santa Maria e Sant’Angelo di Monte Mirteto, presso Ninfa, in diocesi di Velle-tri, nel Lazio meridionale. Che il luogo fosse stato o meno legato in precedenza alla memoria di Gioac-chino, che vi avrebbe soggiornato25, ha poca impor-tanza; è certo invece che, nel 1216, un gruppo di monaci florensi aveva raggiunto Ninfa provenienti proprio da Fonte Laurato, a cui il Mirteto fu sempre in seguito collegato. La nuova comunità era guidata dall’abate Benedetto, forse lo stesso che aveva fino ad allora guidato il monastero di Fiumefreddo. Il sor-gere dell’abbazia figlia testimonia dunque che Fonte Laurato era una comunità in crescita per numero di aderenti e in collegamento con i personaggi più in vista nella curia romana, dal momento che il nuovo cenobio sorse grazie all’appoggio del cardinale Ugo-lino, che in quanto titolare della diocesi velletrense donò ai florensi di Ninfa tre chiese per il sorgere del-la nuova fondazione.
Quando ancora Federico, nel 1219 «Dei gratia
247
Romanorum rege semper augusto et rege Sicilie», si trovava Oltralpe, un notevole numero di postulanti provenienti dal Regno si recò in Germania per ot-tenere privilegi dal re26. Tra di essi, vi era di certo almeno una persona in rappresentanza dei monasteri florensi, dal momento che possediamo privilegi di conferma e di nuove donazioni, datati nell’aprile 1219 a Basilea, sia per Fiore sia per Fonte Laurato. Quest’ultimo cenobio ebbe da Federico una terra lavorativa da quattro aratri, posta in località detta Fravette, presso il fiume Torbole27. Da un successivo privilegio di conferma di Federico II, il terreno ap-pare compreso nei confini di Amantea. Esso era ce-duto liberamente, senza il vincolo di alcun servizio. In tale occasione Federico rinnovò la conferma di «omnes libertates et immunitates, possessiones, red-ditus et tenimenta» offerte da Simone di Mamistra, che risultava ormai deceduto. È da rilevare che nel documento di Simone non si faceva in realtà cenno ad alcun redditus di competenza del monastero, esi-stente invece nel 1219. Federico ricordò anche «ter-ras, possessiones et libertates» cedute da Matteo di Tarsia, e precisamente il luogo chiamato Paola, con i suoi uomini, beni e pertinenze. Anche nel caso della grangia di Paola, le originarie competenze destinate da Matteo per una nuova fondazione florense si era-no ampliate; in particolare erano cresciuti i diritti acquisiti sugli homines del luogo.
Grazie al privilegio del futuro imperatore, le libertà e le immunità del monastero si ampliarono in misura notevole, probabilmente sotto l’esempio e il modello dei diritti di cui godevano sia Fiore sia altri monasteri cistercensi del Regno. Federico aggiunse infatti il di-ritto di libero pascolo in tutto il demanio della Cala-bria, la libertà di comprare e vendere senza l’onere del plateatico e del passatico, la possibilità di uso di vasellis suis, cioè delle sue navi, nonchè il libero sfruttamento della miniera di ferro nel tenimento Ruga.
Nel 1220 Federico II ritornò in Italia, per ricevere la corona imperiale: mentre si trovava ancora a Bolo-gna «apud Castrum Sancti Petri», lo abbiamo visto, fu di nuovo raggiunto da un gruppo di postulanti, almeno uno dei quali curava gli interessi dei mona-steri florensi. Si conservano infatti documenti datati da Bologna sia per Fiore, sia per Fonte Laurato, sia ancora per il monastero di Calabro Maria.
Il privilegio rogato per l’abbazia di Fiumefreddo e per il suo abate Rodolfo fornisce un quadro ancora più completo, rispetto a quello dell’anno precedente, delle proprietà, beni e libertà acquisite dal monaste-ro nel corso dei due decenni dalla sua fondazione28. Federico II menzionava innanzitutto i possessi, le donazioni e le libertà donate dal fondatore Simone
di Mamistra. Rispetto ad esse, il sovrano specificava che la revocatio da lui ordinata per l’alienazione dei beni demaniali non sarebbe stata applicata nel caso del monastero, come del resto per Fiore e per tutte le case dipendenti. Richiamò poi genericamente tutte le cessioni fatte «a comitibus et baronibus, aliisque fidelibus nostris», nel corso degli anni: si trattava di possessi, libertà e proprietà. Ad esse si aggiunsero i beni e gli alberi che il cenobio possedeva in Fisca (o Furca?), cioè il tenimento di Mendicino, e un frut-teto, con vigne e altre pertinenze poste in flumaria Amanthee, donati dallo stesso fondatore. Nel privile-gio era poi elencata la grangia di Paola, con uomini, vigne, terre, acque e tutte le altre pertinenze, a Fu-scaldo un luogo detto Campanisii e un oliveto nel territorio di Cosenza. I due ultimi beni erano stati donati da Matteo di Tarsia; l’oliveto nel documento del 1210 risultava posto in Guarano, mentre nella carta del 1220 all’oliveto era associato il possesso di una casa a Fiumefreddo. Il sovrano ricordava poi un lungo elenco di beni di vario genere: dei tenimenta, donati dal castellano Guido di Petramala e da suo figlio Ruggero, fedeli del re; questi terreni erano po-sti nei confini del loro castrum, in luogo chiamato Zuccalatus. Altri terreni, posti tra le pertinenze del castrum Nucerie (Nocera Tirinese) e un terreno col-tivato, detto de Turbula, donati da Pietro di Spino-sa. Infine, nel territorio di Montalto erano ricordati i beni donati dal conte di San Marco, Rinaldo del Guasto, insieme a «excadentia que fuit olim Michae-lis de Diletta». Si trattava di diversi terreni, di diffi-cile identificazione, a parte quelli posti nel territorio di Nocera e di Montalto. I donatori si presentavano come castellani: Guido e suo figlio Ruggero, Pietro di Spinosa, signore del castrum di Nocera, e Rinaldo del Guasto, conte di San Marco, già in un altro mo-mento benefattore del monastero. Nel 1218 infatti, Rinaldo, allora definito anche capitano e maestro giustiziere della Calabria e della Valle del Crati, ave-va concesso al monastero di Fonte Laurato il terri-torio di Falconara, posto sul versante tirrenico della Catena Costiera, tra San Lucido e Fiumefreddo, che fino a quel tempo era stato una spelunca latronum, con tutte le sue tenute e pertinenze29.
Il privilegio di Federico prosegue confermando la proprietà de Fravette, da lui concessa l’anno prece-dente; essa era posta nei confini di Amantea, e avreb-be dovuto essere assegnata ai monaci dal camerario e da due giurati di Cosenza. Sempre nel territorio di Amantea fu confermata una vigna, lasciata in te-stamento da Cardinassa, fedele del re; furono inol-tre ricordate altre vigne e case a Salerno, donate dal converso Andrea e già nominate nel documento del
248
1210, ancora vigne e altre proprietà poste a Cosenza, Amantea, Fiumefreddo, Sabuti, o nei loro territori, avute in donazione o acquistate.
Terminate le proprietà immobiliari, il documen-to elenca varie libertà di cui il monastero godeva, concesse dallo stesso Federico, da Simone e da Mat-teo: libero pascolo per tutta la Calabria per le pecore e altri animali, senza il pagamento di erbatico e glan-datico; libertà di ricevere sale da tutte le saline e di estrarre ferro da tutte le miniere della Calabria, senza alcuna esazione; permesso di sfruttare liberamente le miniere di ferro che accadesse di trovare nel terri-torio del monastero; libertà di comprare e vendere, senza esazioni di alcuno; possibilità di passare per terra e per mare senza il pagamento di «theleonati-co, plateatico et passagio atque portulagio simul et anconatico vel falancagio de navibus et barcis eius in omnibus portubus et litoribus regni Sicilie». Si tratta delle medesime libertà di cui godeva anche il monastero di Fiore. Federico aggiunse la facoltà di far pascolare gli animali dell’abbazia nei pasco-li montani della Sila, presso San Mauro, evidente-mente da sfruttare nel periodo estivo. Riguardo alle libertà concesse da Simone e Matteo, il re confermò la possibilità, per gli uomini liberi dei due signori, di offrire, vendere e legare al monastero possessi e immobili che non fossero stati dati in feudo, di co-struire mulini e battinderia, nonché il libero pascolo, in pianura e in montagna e la possibilità di raccoglie-re e tagliare legna nei boschi. Fu anche permesso di tenere liberamente imbarcazioni per il trasporto di merci e per la pesca nel mare antistante Fiumefred-do, Fuscaldo e Paola.
Riguardo all’assegnazione del terreno detto Fre-vette, ancora da Bologna Federico aveva provveduto a scrivere al camerario della Valle del Crati perché assegnasse al monastero l’appezzamento, secondo le misure che il re aveva stabilito30. Erano infatti probabilmente insorti contrasti con il castellano di Amantea proprio a causa della donazione regia. Il camerario della Valle del Crati, Riccardo, per obbe-dire all’ordine, rogò un documento in cui riportò anche la lettera di Federico; in quest’ultima si rende-vano note le difficoltà a cui il monastero era andato incontro. Pietro de Fos, il castellano di Amantea, «diversos in eis modos molestationis invenit, unde nostram concessionem velut si litiosus et invidiosus angustiaret». Il re pertanto ordinò al camerario di recarsi con due giurati cosentini ad Amantea e di assegnare al monastero il terreno secondo le misure da lui stabilite; avrebbe poi reso noto al castellano di aver provveduto all’assegnazione, secondo gli ordini regi. Riccardo si recò dunque ad Amantea con Bene-
detto e Michele, giurati di Cosenza, a cui si aggiunse anche Giovanni Metreterio, giurato di Amantea; essi procedettero alla stima, per il monastero di Fonte Laurato, non solo della tenuta de Fravette, ma anche di un terreno coltivato, posto presso San Giovanni de Oliva, e della terra tenuta in precedenza da Car-dinassa, nominato anche nel privilegio di Federico, infine di un’altra porzione di immobili, que dicitur de Grima, e di una excadentia posta nelle terre com-prate da un certo Pietro de Uxcocopula e dal milite Riccardo, presso Zuccalato. Tutti questi beni furono valutati dal camerario come capaci di ricevere com-plessivamente ottanta salme di semi di frumento.
Nei due anni seguenti, fino al 1222, al pari di quanto avvenne per Fiore, Federico difese in diverse occasioni il monastero di Fonte Laurato. Nel mar-zo del 1221, da Brindisi, in ottemperanza all’editto generale de resignandis privilegiis promulgato a Ca-pua, l’abate Rodolfo presentò all’imperatore i diplo-mi da lui concessi al cenobio prima di aver ricevuto la corona imperiale, perché gli fossero regolarmente confermati31. Nell’atto di conferma fu inclusa però la clausola «salvo mandato et ordinatione nostra». A seguito di ciò, l’abate di Fonte Laurato si presentò personalmente all’imperatore, e chiese che la clau-sola fosse tolta, forse a imitazione di quanto era av-venuto per il monastero di Fiore, il quale ne aveva ottenuto la dispensa. Federico pertanto, nel dicem-bre 1222 da Foggia concesse che la clausola, «quam generaliter iussimus universis privilegiis regni nostri apponi», fosse eliminata, ordinando nel contempo a tutti i giustizieri, camerari, baiuli, officiali o semplici fedeli di non importunare il cenobio32.
Che il monastero avesse subito, da parte dei rappresentanti dell’amministrazione regia, mole-stie e soprusi era stato denunciato dallo stesso abate a Federico, il quale, nel medesimo mese, scrisse a tutti gli ordini e i gradi dell’amministrazione regia perché non molestassero il cenobio con richieste di collette, esazioni, e con angherie e procure, citando il monastero di fronte al giudizio dei tribunali seco-lari33. A difesa di Fonte Laurato, il sovrano richiamò i suoi rappresentanti al rispetto di tutte le libertà e immunità «quas tempore regis Guglielmi secun-di predecessoris nostri huiusmodi religiosi habere consueverunt». Ovviamente non si tratta di libertà e immunità riconosciute al monastero di Fonte Lau-rato da re Guglielmo, dal momento che il cenobio sorse successivamente, ma di concessioni di carattere generale inerenti ai monasteri, nell’ottica della poli-tica di restaurazione di Federico, volta a richiamare, nel loro complesso, le antiche, buone consuetudini del tempo di Guglielmo II piuttosto che quelle degli
249
anni di suo padre, Enrico VI34. Federico infatti si proponeva di ristabilire nel Regno quell’ordine che era venuto meno per mancanza di capacità di con-trollo da parte della corona.
A partire da questa data, i rapporti con l’impe-ratore si interruppero e non è più attestato alcun documento imperiale indirizzato al monastero di Fiumefreddo, in parallelo a quanto accadde anche per l’abbazia di Fiore dal 1223 al 1248. Le relazioni con l’imperatore erano evidentemente divenute pro-blematiche a causa della lotta che Federico sostenne con il papato, a partire dalla prima scomunica inflit-ta da Gregorio IX all’imperatore, e la cessazione dei rapporti tra l’abate e la corte sveva attesta che Fonte Laurato era senza dubbio schierato, come Fiore, tra i sostenitori della parte papale contro quella imperiale.
1.c. Difficoltà e decadenzaSotto il pontificato di Gregorio IX, il maggiore so-
stenitore dell’ordine florense, la curia stilò diversi do-cumenti che testimoniano le difficoltà di rapporti tra il monastero di Fiumefreddo e il potere regio e locale.
Dopo la conferma di tutte le proprietà dell’abba-zia, data all’inizio del suo pontificato35, già l’11 lu-glio del 1227, a istanza dell’abate e della sua comu-nità, il papa fu costretto a incaricare gli arcivescovi di Reggio, di Cosenza, di Rossano e di Santa Severina e i loro suffraganei, nonché gli abati, i rettori e i decani perché agissero, facendo anche uso della scomunica, contro i detentori dei beni e gli usurpatori di lasciti testamentari spettanti a Fonte Laurato36.
Nel novembre 1228, l’arcivescovo di Rossano, in-sieme al suo capitolo, concesse e confermò all’abate e alla comunità il luogo in cui era sito un monaste-ro, una volta detto di Sant’Andrea, nel territorio di Cariati, in seguito però «dirutus desolatus et velut cataclysmo quodam, sic aquarum subita colluvione subversus (...) ac demersus»37. Per quanto il luogo fosse in condizioni così precarie, doveva tuttavia es-sere dotato di molti beni: tra le sue pertinenze furo-no nominati infatti terre coltivate e incolte, boschi, pascoli, acque, chiese, grange, mulini e uomini. La donazione del monastero fu concessa dall’arcivesco-vo su richiesta dell’abate di Fonte Laurato, che con lui si era lamentato della povertà, dell’aridità e del-l’asprezza dei luoghi in cui viveva con i suoi monaci, e in particolare della mancanza di pascoli per gli ani-mali del monastero, problemi dovuti forse proprio all’usurpazione dei beni del monastero denunciata da Gregorio IX. L’abate aveva pertanto richiesto che venisse concesso loro uno dei monasteri o dei luoghi della diocesi ormai abbandonati dagli abitanti, in modo da compensare la loro penuria. Probabilmen-
te per evitare ulteriori contrasti con i signori locali, che avrebbero potuto usurpare i beni del monastero, l’abate di Fonte Laurato aveva ricercato terreni posti a grande distanza dal suo monastero, sul versante op-posto della Calabria. L’arcivescovo si dimostrò allora disponibile, anche in considerazione del fatto che i monaci di Fonte Laurato in qualche modo risultava-no «nobis, et Ecclesiae nostrae multa (...) in Domino caritate coniuncti». Il monastero era tenuto a dare in contraccambio un censo ricognitivo alla chiesa di Rossano in occasione della festa dell’Assunta.
Solo il 25 ottobre 1232 si ebbe la conferma papa-le della donazione dell’arcivescovo Basilio38. Non è noto tuttavia se, ed eventualmente in che modo, l’an-tico monastero greco sia stato sottoposto all’abbazia di Fonte Laurato, dal momento che esso non fu no-minato tra i beni spettanti al monastero nella lettera di conferma di tutte le proprietà rilasciata da Clemen-te IV, che pure ricordava tutti gli altri possedimenti acquisiti da Fonte Laurato nel corso del tempo.
In una data imprecisata del pontificato di Gre-gorio IX, dunque nel periodo compreso tra il 19 marzo del 1227 e il 22 agosto del 1241, il papa ave-va sottoposto all’abbazia di Fonte Laurato anche il monastero greco di Sant’Angelo Militino, presso Campana, in diocesi di Rossano. Le vicende della riforma di questo cenobio greco, a noi note attraver-so due documenti di papa Alessandro IV del 1256, testimoniano ulteriori contrasti insorti tra l’abbazia florense e i rappresentanti di Federico II. Il pontefice aveva dapprima affidato al vescovo di Bisignano e ad alcuni suoi colleghi non specificati l’incarico di visitare il monastero, che «adeo erat in spiritualibus et temporalibus deformatum, quod vix aliqua reli-gionis vestigia remanserant in eodem». Essi dove-vano riformarlo, se possibile, secondo le osservanze regolari dell’ordine di san Basilio; in caso contrario, constatata cioè l’impossibilità di mantenervi l’osser-vanza greca, avrebbero dovuto affidare il cenobio al-l’abate di Fonte Laurato, perché vi introducesse gli usi florensi. In effetti, nel monastero di Sant’Angelo fu avviata, almeno per un brevissimo periodo, la vita monastica benedettina secondo le istituzioni floren-si. Dai due documenti di Alessandro IV sappiamo infatti che i monaci greci rimasti nel monastero avevano accettato di passare all’osservanza latina, avevano fatto la professione nelle mani dell’abate di Fonte Laurato e avevano promesso di osservare in tutto l’ordinamento florense. Erano tuttavia sorte ben presto difficoltà: alcuni ufficiali dell’imperatore, infatti, avevano spogliato dei loro beni i monaci, che fino a quel giorno li avevano posseduti pacificamen-te. Inoltre lo stesso Federico aveva revocato sotto il
250
suo diretto controllo amministrativo la maggior par-te delle proprietà del monastero di Fonte Laurato, motivo per cui i monaci avevano dovuto sostenere privazioni temporali non indifferenti. L’imperatore evidentemente aveva preteso la restituzione di tutti i beni che in precedenza avevano fatto parte del de-manio regio, che nel 1220 aveva invece escluso dalla revocatio generalis. Non sappiamo a quale momento preciso risalisse la revoca dei beni demaniali di Fonte Laurato da parte di Federico; a quanto sembra, però, sia dalla lettera di Gregorio IX agli arcivescovi cala-bresi sia dalla donazione dell’arcivescovo di Rossano, entrambi del 1227, le difficoltà con la corte o con i suoi rappresentanti dovevano risalire già al primo periodo di crisi tra papato e impero.
In seguito alla morte dell’imperatore nel dicem-bre del 1250, i beni revocati, compresa la chiesa ma non più il monastero, probabilmente ormai decadu-to, di Sant’Angelo, furono restituiti a Fonte Laurato, come risulta dalla bolla di conferma di Clemente IV del 126739. In essa, spedita da Viterbo l’8 febbraio, il pontefice citava in primo luogo il monastero stesso e le sue due chiese, di Santa Domenica e San Pietro. Ag-giunse poi la chiesa di Sant’Angelo Militino, da poco reintegrata tra i possedimenti del monastero; seguiva la grangia di Paola, donazione di Matteo di Tarsia per la costruzione di un nuovo monastero florense, «cum casali et portu, vineis, terris, silvis et aquis». Il pontefice ricordò anche i vari tenimenta monasti-ci: quello detto Campanisii, posto nel territorio di Fuscaldo; l’excadentia, un tempo appartenuta a Mi-chele de Dilecta, posto a Montalto; il terreno detto Gradus Planus e quello posto sulla Sila, nei pressi di San Mauro, con pascoli, usi, e altre pertinenze; infi-ne una casa e un oliveto posti a Cosenza, e altre case e terre nei territori di Fiumefreddo e di Amantea. Ad Amantea, «in flumara eiusdem castri», il monastero possedeva anche un frutteto e una vigna, chiamati Cardinasse, che erano stati di frate Riccardo. Si ag-giungevano ancora i terreni coltivati di Farvetis, da identificarsi forse con la cultura de Frevette donata da Federico II, e i campi de Marretis e di San Giovanni di Oliva, le terre de Grima e di Suberellis, con vigne e possedimenti. Nel documento era inoltre menzio-nata un’altra grangia, posta a Cucculati (o Zucculati), con un mulino e vari terreni, posti a Petramala e a Sabuti; il papa ricordava ancora la tenuta coltivata de Turbulo, ubicata nel territorio di Nocera, con case, campi, alberi, pascoli, terreni coltivati, vigne e altre pertinenze; le proprietà presso Furca o Fisca, Regina e Mendicino; la casa a San Lucido, tutta le tenuta di Falconara, con prati, vigne, terre, boschi, usi su pa-scoli in pianura e in zona boscosa, su acque e mulini,
su strade e sentieri. Clemente IV confermò infine le libertà e le immunità concesse al monastero da Ric-cardo e Giovanni, vescovi di Tropea. I beni elencati dal papa corrispondevano in gran parte alle proprie-tà del monastero elencate da Federico II nel diplo-ma del 1220; a parte qualche eccezione (non sono citate ad esempio le case che il monastero possedeva a Salerno, offerte da un converso, che forse erano state vendute considerata la loro lontananza), il mo-nastero era rientrato in possesso della maggior parte dei beni acquisiti nei primi due decenni di esistenza. Né del resto pare che si sia ulteriormente sviluppato, nel periodo successivo al 1220, a parte l’acquisizione del cenobio di Sant’Angelo Militino con tutte le sue competenze.
Per il periodo compreso tra il 1225 e il 1251 si sono poi conservati i regesti di cinque documenti privati di donazioni e di vendite di beni al monaste-ro di Fonte Laurato. Si tratta di brevissime notizie, che attestano comunque l’esistenza di rapporti con la popolazione locale, che si affidava alla preghiera dei monaci. Vi erano anche contatti con un’altra isti-tuzione religiosa della zona.
Il primo documento privato, datato al 1225, è riassunto nel regesto di una vendita di beni non spe-cificati, forse terre, con la clausola «salva in omni-bus ratione domni imperatoris», da parte di Simeo-ne, figlio di Giovanni, milite e giudice, abitante in Figline nel territorio di Cosenza, all’abate di Fonte Laurato Rodolfo40. Nello stesso 1225, Angelo, figlio del giudice Melitino, cedette all’abate Rodolfo tut-ti i beni che possedeva nel casale di Paola, grangia del monastero, ricevendone in cambio due vigne nel territorio di Fiumefreddo41. Nel giugno del 1229, Sibilia, figlia del fu Ruggero de Angerrano, insieme al marito e al mundualdo, alienò un pezzo di terra all’abate Rodolfo e alla sua comunità42. L’anno se-guente, Palerma, figlia del fu Giovanni di Nicola, giudice di Fiumefreddo, d’accordo con la madre, offrì alla chiesa della beata Maria di Fonte Laurato e all’abate dello stesso monastero la metà delle terre del padre, per la remissione dei peccati suoi e dei suoi genitori43. Nel 1251 infine Giovanni, abate del monastero benedettino della Santissima Trinità di Mileto, con i suoi monaci, donò all’abate Pietro e alla comunità di Fonte Laurato due appezzamenti di terreno in località detta di Santa Maria de Uliva, già concessi all’abate Riccardo e al suddetto monastero, e vi aggiunse un mulino edificato o da edificare, per un censo annuo di sei libbre di cera, da offrire nella festa dell’Assunzione44.
251
1.d. La posizione nell’ordineIl monastero di Fonte Laurato, prima abbazia
originatasi da Fiore, fu considerata uno dei centri principali dell’ordine, secondo solo all’abbazia sila-na. La sua rilevanza all’interno dell’ordine è compro-vata dal ruolo svolto nella visita del protocenobio: nel 1209 fu stabilito che gli abati di Fonte Laurato e di Acquaviva, in comune, avrebbero dovuto visitare il monastero di Fiore, anche se la decisione in quel momento fu considerata solo una dispensatio rispet-to alle norme delle istituzioni dettate da Gioacchino, soluzione temporanea da osservarsi fino al momento in cui non fosse stata trovata una forma più aderente alle indicazioni del fondatore. Tale statutum fissato nell’aprile del 1209 ricevette conferma da parte di Innocenzo III nel febbraio 121545; in seguito otten-ne, almeno indirettamente, una nuova approvazio-ne da Gregorio IX, che il 16 settembre 1238, dietro richiesta dell’abate e della comunità di Fiore, per-mise che gli abati di Fonte Laurato e di Acquaviva svolgessero annualmente, a nome del papa, l’ufficio di visita nel monastero di Fiore e, in caso di morte dell’abate, istituissero quale successore colui che fos-se stato eletto dai monaci del luogo o dalla loro pars sanior, conformemente agli statuti dell’ordine46.
L’abate di Fonte Laurato era inoltre tenuto a compiere la visita canonica nel monastero di Santa Maria del Monte Mirteto, secondo le disposizioni seguite nell’ordine cistercense relative alla visita del-l’abate dell’abbazia madre alla figlia: il fatto è testi-moniato da un documento del 1226, in cui, in pre-senza di Ugolino, in quell’anno ancora vescovo di Ostia e Velletri, all’abate di Fiumefreddo fu affidato il compito di visitare, nel momento in cui si recava al Mirteto, anche il priorato di San Iacopo di Valle Benedetta, in diocesi di Lucca, che in quell’occasio-ne fu posto sotto la giurisdizione dell’abate di Fiore, ma delegata a quello di Fonte Laurato47.
Una lettera di Clemente IV, appartenente al se-condo anno del suo pontificato, quindi al periodo compreso tra il 5 febbraio 1266 e il 4 febbraio 1267, giunta solo in un breve regesto peraltro non molto chiaro, sembra parlare di uno scambio di ruoli tra abbazia madre e abbazia figlia, cioè tra Fonte Lau-rato, Sant’Angelo del Monte Mirteto e Santa Maria della Gloria, presso Anagni, figlia del Mirteto. Nel-la lettera papale si disponeva che il monastero della Gloria divenisse rispettivamente abbazia madre del Mirteto e abbazia figlia di Fonte Laurato, da esso dipendente, secondo quanto, del resto, aveva stabili-to Gregorio IX al momento stesso della fondazione dell’abbazia di Anagni48.
Il monastero di Fonte Laurato, pur ricoprendo
un ruolo importante nell’ordine quale prima abba-zia figlia di Fiore e abbazia-madre degli importanti monasteri del Lazio meridionale, e per quanto il suo primo abate, Benedetto, sia ritenuto uno dei primi seguaci di Gioacchino49, non compare mai, né i suoi monaci vi appaiono come protagonisti o testimoni, nella raccolta dei Miracula compiuti da Gioacchino. Questa assenza può certo dipendere dal fatto che il materiale agiografico e le testimonianze sulle sante virtù dell’abate siano state raccolte solo in zona sila-na e cosentina; vi sono ricordati infatti i monasteri di Corazzo, di Acquaviva, di Calabro Maria, i cano-nici della cattedrale di Cosenza, monaci o conversi distaccati nelle grange di Fiore, costituitesi a Canale e presso il casale di Terrate. Dunque, è possibile che solo per motivi geografici sarebbero stati esclusi altri monasteri che pure, almeno nel primo periodo, ave-vano certamente ospitato monaci che avevano cono-sciuto personalmente Gioacchino. Tuttavia, l’assen-za è forse anche una spia del fatto che, nonostante i legami istituzionali che Fonte Laurato aveva con il protocenobio di Fiore, vi era una certa estraneità e un non-coinvolgimento nelle vicende interne del monastero fondato da Gioacchino, come nel caso della sua ricostruzione e della difesa, con la raccolta dei Miracula, della memoria del fondatore.
2. Santa Maria di Acquaviva
Se per il monastero di Fonte Laurato è attestata l’iniziativa di Gioacchino, almeno nella prima fase progettuale, nella ricerca e nella scelta del sito, la fondazione (o meglio, rifondazione) di un mona-stero nel luogo chiamato Monocaria, o Monacaria, nell’allora territorio di Barbaro, piccolo centro posto nella diocesi di Catanzaro, è certamente avvenuta sotto l’abbaziato di Matteo, per quanto una tradi-zione vorrebbe che anche questo monastero sia stato fondato dallo stesso Gioacchino negli ultimi anni del XII secolo50. In realtà, nel 1208 Federico, re di Sicilia, dichiarò esplicitamente che il monastero era stato fondato da Matteo, insieme a quello di Fon-te Laurato: «nec non et monasteria que tu - si sta rivolgendo all’abate di Fiore - de novo fondasti in tenimento Fluminis Frigidi, in loco qui nunc dicitur Fons Laureatus, et in tenimento Barbari, in loco qui dictus est Monocaria, nunc autem Aquaviva, que monasteria ad Florem et eius ordinem pertinere no-scuntur»51.
La fondazione della nuova casa florense non è at-testato da alcun documento vescovile; si può solo dire che essa sorse sicuramente nel periodo successivo al
252
1198, dal momento che non venne citata nel privile-gio di conferma di Costanza del gennaio di quell’an-no e fu fondata dopo la morte di Gioacchino, ma in data anteriore al 1208: la prima testimonianza sulla sua esistenza è infatti proprio il documento concesso da Federico, che nel luglio del 1208, confermando tutte le proprietà acquisite dal monastero florense, elencò anche le fondazioni religiose ad esso soggette. Nell’aprile del 1209 il monastero fu indicato come abbazia52; se anche per questa fondazione si può ipo-tizzare una fase di avvio come priorato, che nei casi di Fonte Laurato e di Calabro Maria era durata due o tre anni, è possibile proporre come data della fon-dazione un periodo compreso tra il 1206 e il 1207.
Nell’aprile del 1209 l’abate di Acquaviva era no-minato, accanto a Matteo abate di Fiore e a Benedet-to abate di Fonte Laurato, nel documento che stabi-liva alcune riforme alle primitive istituzioni florensi stese da Gioacchino53.
L’anno seguente, nel marzo del 1210, il conte di Crotone Stefano Marchisorti, la cui famiglia, come si è visto, era già in precedenza legata al monaste-ro florense e personalmente allo stesso Gioacchino, fece dono congiuntamente al monastero di Fiore e a quello di Acquaviva di una tenuta nel territorio di Insula (Isola di Capo Rizzuto), chiamato Fonta-na Murata. Il terreno doveva servire a far svernare il bestiame dei due monasteri. Il documento attesta anche il nome di quello che presumibilmente fu il primo abate di Acquaviva, Giordano54. L’abate di Acquaviva era poi ricordato nella lettera di esenzio-ne dalla vigesima, scritta da Onorio III su istanza del cardinale Ugolino, a tutto il piccolo ordine florense. Come abbiamo già avuto modo di vedere, a quella data (23 gennaio 1218) esso era composto da cinque monasteri, ossia Fiore, Fonte Laurato, appunto Ac-quaviva, Calabro Maria, Mirteto, e da un priorato, quello di Tulli, chiamato anche San Iacopo di Valle Benedetta, presso Vorno in diocesi di Lucca55.
Il primo documento noto, concesso esclusiva-mente al monastero di Acquaviva, è una lettera di Onorio III, che il 25 febbraio 1218 confermò la do-nazione fatta da Roberto, vescovo di Catanzaro, del-la chiesa dei Tre Fanciulli, anch’essa posta nel terri-torio di Barbaro. La fondazione in precedenza aveva accolto una comunità monastica greca, ormai deca-duta: «ecclesia sanctorum Trium puerorum desolata, eorum monasterio vicina, quondam Grecorum fuit monasterium»56.
La concessione del vescovo Roberto risaliva al-l’agosto del 1217 ed era indirizzata all’abate di Ac-quaviva, Pietro, succeduto in data ignota al prede-cessore Giordano. L’arenga del documento richiama
in molti passaggi, anche letteralmente, da un lato il testo della bolla di conferma della fondazione di Fonte Laurato concessa da Innocenzo III e dall’altro il testo del documento di riforma di Calabro Maria, steso da Matteo57. Il privilegio di conferma papale per il monastero di Acquaviva, che non possediamo, avrebbe ricalcato forse il testo di quello per Fonte Laurato e il vescovo di Catanzaro li avrebbe poi a sua volta utilizzati come modelli per la sua concessione.
La chiesa dei Tre Fanciulli fu offerta per venire in soccorso dei monaci di Acquaviva, che lamenta-vano la loro povertà, dal momento che il monastero non era stato dotato di beni sufficienti58. I monaci resistevano ormai a fatica in quella condizione disa-gevole, per cui l’abate, per impedire che la sua isti-tuzione si dissolvesse, richiese che il cenobio fosse sostenuto con una dotazione di beni: «Quia spiritua-lis hec structura dissolvitur, nisi citius subventione temporalium fulciatur»59. Il vescovo allora, insieme con i confratelli del capitolo di Catanzaro, donò al cenobio florense la chiesa dei Tre Fanciulli, posta nelle sue vicinanze, con tutti i beni di sua proprietà: erano nominati «tenimentis, obedientiis et pertinen-tiis suis, hominibus, molendinis, aquis, sylvis, vineis et virgultis»60. I beni elencati facevano parte del pa-trimonio del monastero, ormai abbandonato e in rovina, che un tempo sorgeva presso la chiesa61. Tale patrimonio, al momento della cessazione della vita monastica nel cenobio, era evidentemente rientrato a far parte dei possedimenti della diocesi. Le parole con cui il presule ricorda la decisione presa dal ca-pitolo lasciano intravedere dei disaccordi interni ri-guardo alla concessione: «Longa igitur deliberatione cum nostris fratribus habita, Deo, sicut credimus, inspirante»62.
Come precisa condizione posta ai monaci di Ac-quaviva fu stabilito che la chiesa non avrebbe dovu-to essere trasformata in una nuova fondazione mo-nastica indipendente: «numquam teneamini tu, et successores tui, monasterium ibi construere»63. Essa era data in proprietà ai monaci di Acquaviva, che l’avrebbero gestita come grangia del monastero, da sfruttare unicamente per il loro sostentamento. La comunità era tenuta a corrispondere alla diocesi un censo ricognitivo, stabilito in un’oncia d’oro secondo la misura di Catanzaro, da versarsi ogni anno nella festa dell’Assunzione di Maria. Il monastero di Ac-quaviva poteva entrare in possesso della chiesa e dei suoi beni in misura piena, libera e assoluta, dal mo-mento che il vescovo e il capitolo non si riservarono sulla chiesa e sui possessi alcun diritto, né temporale, né spirituale, né alcuna proprietà o consuetudine.
La dedicazione di questa chiesa, intitolata ai tre
253
giovani ebrei condannati al rogo nella fornace da Nabucodonosor e liberati dall’angelo del Signore (cfr. Dan. 3), ha generato una notevole confusione. Si tratta infatti di una dedicazione che ricorre anche per un’altra omonima chiesa, posta tuttavia in dioce-si di Cerenzia e non invece in diocesi di Catanzaro, come la chiesa offerta al monastero di Acquaviva. Anche la chiesa dei Tre Fanciulli sita nella diocesi di Cerenzia era stata sede di un monastero greco - quel monastero che tanti problemi aveva creato alla comunità di Fiore nei primi anni della sua attività in Sila - e ugualmente, in seguito, entrò a far parte dell’ordine florense come monastero autonomo. La storiografia ha spesso identificato e sovrapposto le due chiese, non rilevando come esse in realtà sorge-vano in due diocesi diverse (Catanzaro e Cerenzia) e in due luoghi diversi, una appunto presso Barba-ro, nelle vicinanze di Acquaviva, l’altra nei pressi di Caccuri, nelle immediate vicinanze del monastero di Fiore. Tale confusione ha portato a datare l’affi-liazione del monastero dei Tre Fanciulli, in seguito chiamato di Santa Maria Nuova, nel 1217, in real-tà anno della donazione del vescovo Roberto della chiesa dei Tre Fanciulli presso Barbaro al monastero di Acquaviva64. Come vedremo, invece, il monastero dei Tre Fanciulli entrerà a far parte dell’ordine flo-rense solo nel 1257, probabilmente dopo un periodo di vita cistercense.
Cade poi un lungo silenzio documentario sulla vita del monastero, che dura fino al 1233, quando papa Gregorio IX confermò una nuova donazione fatta dal vescovo di Catanzaro (non è noto se fosse ancora Roberto o un suo successore), il quale aveva affidato al monastero di Acquaviva i cenobi greci di San Filippo e San Filippo di Waldo, decaduti e in rovina, e la chiesa di San Nicola di Zagarise65.
Gregorio IX intervenne ancora nel 1238, quan-do, su richiesta dell’abate e della comunità di Fiore, stabilì che gli abati di Fonte Laurato e di Acquaviva compissero annualmente, a nome del papa, l’ufficio della visita del monastero di Fiore, e, in caso di mor-te dell’abate, istituissero quale nuovo abate colui che sarebbe stato eletto dai monaci del luogo o dalla loro pars sanior, conformemente agli statuti dell’ordine66.
In seguito, sulla fondazione florense di Acquaviva cade un sostanziale silenzio, almeno in base alla do-cumentazione che ci è giunta: il Russo ricorda che nel 1310 l’abate di Acquaviva pagò per la decima 17 tarì, mentre in quella del 1324 non compare neppu-re; in seguito, nel 1335, Benedetto XII confermò la soggezione del monastero alla casa madre di Fiore67. Infine, nel 1561, pochi anni prima dell’unione defi-nitiva con i cistercensi, il cenobio di Barbaro risulta-
va completamente abbandonato e gli edifici mona-stici erano in totale rovina68.
Il monastero di Acquaviva, che, accanto a Fonte Laurato e a Calabro Maria, era uno dei tre immediate subiectum a Fiore, appare legato, come casa madre, ai monasteri florensi della Toscana. Dopo un primo periodo, infatti, in cui la visita del cenobio di San Iacopo di Valle Benedetta, in diocesi di Lucca, fu di competenza di Fiore, che la delegò tuttavia all’abate di Fonte Laurato69, in seguito il compito di visita e di riforma sarebbe passato all’abate di Acquaviva, dal momento che Gregorio IX si rivolse a lui sia perché presiedesse alla riforma di San Pietro di Camaiore, sia per affidargli un altro cenobio della diocesi di Lucca, quello decaduto di San Cassiano70.
Nei racconti dei Miracula di Gioacchino il ce-nobio di Acquaviva compare in diverse occasioni. Il compilatore ricorda ad esempio che uno degli episodi gli fu raccontato da Pietro, abate appunto di Acqua-viva, attestato come abbiamo visto, nell’agosto del 1217. Egli riportò un fatto accaduto nel periodo in cui Gioacchino reggeva il monastero di Fiore: si trat-ta dunque di un miracolo in vita. Pietro era pertanto uno tra i primi seguaci di Gioacchino, appartenente alla prima generazione florense: fu definito infatti dal narratore come «domnus Petrus, omnipotentis Dei famulus, sancti viri monachus, qui adhuc in monasterio Aque Vive Florensis ordinis, cum senec-tute seu infirmitate multa nimis vivit et regitur»71. Pietro riferiva l’episodio in cui Gioacchino, recatosi a Longobucco per ordinare un calice, fu bloccato da un’alluvione disastrosa. La popolazione si era rac-colta nella chiesa, intorno a lui; la sua parola e la sua predicazione, volte a denunciare i loro peccati («super adulteriis et fornicationibus suis, super furtis et maleficiis et aliis quam pluribus»)72 indussero al pentimento gli ascoltatori: tutti promisero infatti di cambiar vita, in particolare «de frequentatione taber-narum, ubi blasphemias et multa alia mala commit-tebant»73. Significativa poi, nel contesto del processo della piena latinizzazione del territorio promossa at-traverso i canali ecclesiastici e monastici, appare la promessa, fatta dagli abitanti di Longobucco, di «ire ad archiepiscopum -cioè l’arcivescovo di Rossano, una delle diocesi più profondamente grecizzate del-la Calabria-, rogaturi ut omnes sacerdotes eicerent concubinas suas»74. Le promesse della popolazione a Gioacchino furono sufficienti a far cessare la pioggia e a far volgere il tempo al bello.
In un secondo episodio, post mortem, viene ricor-dato l’intervento miracoloso di Gioacchino, che fece guarire un giovane diacono ospitato nel monastero
254
di Acquaviva sub favore di un anziano monaco suo parente75. Il giovane, assalito dal demonio, era usci-to di senno; il monaco di Acquaviva, preoccupato e triste, ricevette da un confratello di Fiore «modico de indumentis patris sancti»76; ritornato al suo mo-nastero, lavò la reliquia e ne fece bere il liquorem così ottenuto al suo giovane parente, che subito guarì. I due in seguito si recarono a Fiore, sul sepolcro del-l’abate, per le loro offerte di ringraziamento per la grazia ricevuta.
Il monastero di Acquaviva è nominato una terza volta nei racconti dei Miracula, a ricordare l’episodio accaduto al monaco Riccardo, magister cellerarius del monastero cistercense di Sant’Angelo del Frigilo77. Costui non era riuscito a rientrare nel suo cenobio poiché era stato sorpreso dal buio della notte; decise allora di fermarsi nel monastero di Acquaviva, evi-dentemente più vicino, per trascorrervi la notte. Qui fu accolto amichevolmente e fu invitato ad unirsi ai monaci florensi per la recita delle dodici lezioni in onore di san Giovanni evangelista, di cui i floren-si festeggiavano l’ottava in modo solenne, appunto con la recita di dodici lezioni anziché con tre, come i cistercensi. Riccardo rifiutò, ma durante la notte gli apparve il santo, che lo sollecitò ad adeguarsi agli usi florensi; gli rivelò poi che entro tre giorni il Signore avrebbe chiamato in giudizio papa Innocenzo III e l’abate Gioacchino e che egli sarebbe stato l’avvocato difensore di quest’ultimo. Questo particolare induce a datare l’episodio nel periodo di inquietudine e di tensione successivo alla condanna di Gioacchino da parte del concilio lateranense IV, dal momento che da più parti si considerava Innocenzo III il promo-tore della condanna dell’abate.
Il monastero di Acquaviva è presentato dunque come uno dei centri in cui era ben viva la devozione verso l’abate fondatore; questa devozione era senza dubbio dovuta, almeno nel primo periodo, ai le-gami personali di alcuni monaci di Acquaviva con Gioacchino stesso, di cui si ricorda la potenza nel-la predicazione e la condanna del matrimonio per il clero greco. Tale devozione, in seguito, fu volta a difendere gli usi liturgici florensi, diversi da quelli cistercensi, ma ancor più la figura e l’ortodossia dello stesso Gioacchino, dopo la condanna del suo pen-siero. In una fase ancora successiva (siamo senz’altro dopo il 1226, dal momento che si ricorda la tomba dell’abate a Fiore) il contesto appare più stabile, e le caratteristiche del racconto miracoloso sono concen-trate maggiormente sugli aspetti devozionali e rituali del culto a Gioacchino.
3. Santa Maria di Calabro Maria, o di Altilia
Il monastero di Calabro Maria, chiamato anche Santa Maria di Altilia, era stato fondato da mona-ci greci, forse prima dell’anno 1000, nell’arcidiocesi di Santa Severina, sopra un’alta rupe che sovrasta a picco la valle del Neto. Qui sorse in seguito il casa-le di Altilia, da cui in monastero ha mutuato poi il suo nome78. Fu riedificato verso il 1099 su consilio e mandato del metropolita di Santa Severina Costan-tino, da Policronio, vescovo di Cerenzia, che lo dotò riccamente. Alla ricchezza del monastero contribuì anche il duca Ruggero Borsa, che nel maggio del 1099 fece dono alla comunità del vasto tenimento selvoso di Sanduca, nell’attuale Sila Piccola, e con-fermò anche le concessioni fatte dal metropolita di Santa Severina. Poco più tardi, nel giugno 1115, a petizione ancora del vescovo Policronio, i beni fu-rono confermati da Ruggero II, conte di Calabria e Sicilia, che concesse anche la possibilità di trarre sale dalle saline del Neto, site nei pressi del monastero. I beni del cenobio furono infine nuovamente confer-mati da Ruggero, ormai re di Sicilia, in data 18 otto-bre 1149, in ottemperanza all’editto De resignandis previlegiis del 1144. In tale occasione il re, oltre a ri-confermare i diritti del monastero sulle saline, accor-dò al monastero il permesso di sfruttare le acque del Neto per i mulini, donò un casale, chiamato Corio, con le sue tenute, nonché il libero pascolo nelle terre di Santa Severina e di Roccabernarda79.
Tutti questi beni passarono in seguito ai monaci florensi, quando sottoposero il monastero alla regola benedettina e ai loro statuti. I testi dei documenti in questione, originariamente scritti in greco, ci sono giunti grazie alla traduzione fatta eseguire da Nicola, abate florense di Calabro Maria, nel 1253, secondo quanto si legge nell’atto notarile del dicembre di quel-l’anno, redatto dal notaio Giovanni de Petra Paula, e tradotti da Nicola e Michele, giudici di Crotone80. Fino a quella data non si era sentita la necessità di una traduzione delle carte greche, evidentemente perché vi era ancora qualcuno, all’interno del monastero, in grado di comprenderle, a riprova che fino alla metà del XIII secolo la presenza bizantina non era stata completamente annullata dalla riforma latina.
Abbiamo già visto, nei capitoli dedicati al mona-stero di Fiore, le circostanze in cui il cenobio greco di Calabro Maria fu assegnato ai florensi, contro le rivendicazioni dei monaci cistercensi di Corazzo, e come probabilmente, all’origine della disputa, vi fosse il ruolo ambiguo ricoperto da Gioacchino nel periodo tra il 1189 e il 1194, quando da un lato egli
255
era ancora abate a Corazzo ma nello stesso tempo era a capo del gruppo di monaci eremiti stanziatisi sulla Sila. Dopo aver ottenuto, per sentenza papale, la proprietà del monastero, i monaci florensi provvi-dero ben presto ad introdurvi la loro osservanza. La riforma procedette a partire dal mese di novembre del 1213. Ci sono giunti due documenti florensi re-lativi alle tappe di riforma, tramandatici dai mano-scritti della biblioteca di Matera81. È solo grazie alla copia di queste carte, trasmessaci dal regio uditore Nicola Venusio, che conosciamo, anche se solo in frammento, alcuni minimi particolari delle istituzio-ni redatte da Gioacchino per i suoi monasteri82.
Limitandoci in questa sede all’analisi dell’intro-duzione dell’osservanza florense nell’antico cenobio bizantino, seguiamo i passi compiuti in questo senso da Matteo, l’allora abate di Fiore. Egli, nel primo do-cumento volto alla riforma di Calabro Maria, esor-diva dichiarando di voler procedere «ad ordinandum (...) vel potius ad reparandum», il monastero greco secondo le istituzioni di Fiore, inviandovi un gruppo di monaci guidati da un priore, secondo un numero stabilito. Il primo punto fissato da Matteo riguardo al nuovo monastero florense imponeva che, nel caso qualche difficoltà si fosse acuita (ingravescente tribu-latione) o ci fosse stata una persecuzione (persecutione cogente), e i monaci di Fiore non avessero più potu-to abitare nel loro cenobio, la fondazione riformata avrebbe dovuto accoglierli; la comunità così costitui-ta sarebbe stata guidata dall’abate di Fiore83. Si tratta forse di accenni alle difficoltà e alle polemiche che serpeggiavano tra i monaci florensi riguardo alla du-rezza della vita condotta a Fiore, dal momento che la comunità in quegli anni abitava ancora nel luogo originario stabilito da Gioacchino, e solo in seguito all’incendio del 1214 si trasferì in un luogo meno esposto al clima rigido della zona. Se al contrario i problemi si fossero appianati e la vita a Fiore e a Ca-labro Maria fosse proseguita in modo autonomo, i monaci, i conversi e il priore della nuova casa flo-rense avrebbero posseduto, senza alcuna ingerenza da parte della casa madre, non solo il monastero, ma anche tutte le proprietà e le pertinenze, insieme ai beni che venivano donati loro dall’abbazia di Fiore. Avrebbero goduto poi della libertà prevista e avreb-bero potuto vivere stabilmente nel loro monastero. La libertà non annullava tuttavia i vincoli con la casa madre: la professione fatta o all’abate di Fiore, o al luogo di Fiore, li obbligava a rimanere sottoposti alla disciplina e alla correzione dell’abate florense, così come lo erano i monaci residenti a Fiore. Pertanto, i monaci di Calabro Maria si sarebbero conformati, sia in temporalibus sia in spiritualibus, alla volontà e
decisione dell’abate di Fiore84. La possibilità che potesse sorgere qualche impedi-
mento alla vita regolare del monastero, prevista per Fiore nella prima parte del documento, venne poi prospettata anche per Calabro Maria: se per i mo-naci del monastero fosse stato impossibile, per un qualsiasi motivo, continuare a vivere in quel luogo, la comunità sarebbe dovuta rientrare a Fiore, l’ab-bazia di provenienza; inoltre, tutti i beni consegnati al cenobio riformato sarebbero di nuovo tornati in possesso di Fiore.
Il monastero, al momento della riforma, veniva considerato all’interno della struttura dell’ordine «quasi unus de septem prioratibus quos institutio nostra describit»; unica eccezione era il fatto che, fino a quando non fosse stato stabilito altrimenti, il priore non avrebbe potuto ricevere la professione di monaci o conversi, che dovevano rivolgersi invece all’abate di Fiore85. Fu comunque previsto che tale situazione non sarebbe stata definitiva, perché in se-guito il monastero avrebbe potuto essere guidato da un abate proprio. L’ultima disposizione relativa alla vita monastica riguardava il possesso di libri: i mo-naci di Calabro Maria, secondo quanto era prescrit-to, avrebbero dovuto possedere una piccola biblio-teca, composta da un messale, dal testo della Regola benedettina, dal librum usuum, da un salterio, un innario, un collettaneo, un antifonario e un gradale. Il monastero riceveva in prestito da Fiore i codici in questione, con l’impegno di restituirli non appena fossero stati copiati86. Un identico elenco di libri era previsto per le nuove fondazioni cistercensi, che, se-condo gli Statuta, dovevano essere provviste sin dal loro sorgere dei libri liturgici conformi agli usi del-l’ordine87. Il documento si concludeva con l’accordo secondo il quale fu lasciata in proprietà al monastero di Fiore una tenuta di oleastri, cioè di olivi selvatici, adatti all’innesto e dunque alla produzione di olive. In cambio, si stabilì che una mandria di animali del cenobio appena riformato avrebbe potuto pascolare liberamente nelle tenute di Fiore88.
Il documento fu sottoscritto da trentatrè mona-ci, uno dei quali, Teodosio, si definì sacerdote greco ed ecclesiarca di Calabro Maria: si trattava probabil-mente dell’unico monaco greco superstite del perio-do bizantino della fondazione, il quale aveva deciso di continuare la sua vita monastica sotto l’osservan-za latina e le istituzioni florensi. Gli altri trentadue religiosi attestano la notevole consistenza della co-munità florense, anche in considerazione del fatto che, forse, non tutti i monaci di Fiore sottoscrissero la carta. Fiore era dunque, in quel momento, una comunità numerosa, in grado di creare una nuova
256
fondazione inviando parte dei suoi componenti nel monastero da poco acquisito. I monaci florensi che ormai si definivano appartenenti al cenobio di Cala-bro Maria erano otto, a cui si aggiungevano Teodosio e forse anche alcuni altri, che nel 1213 si sottoscris-sero come monaci di Fiore, ma che, tre anni dopo, sono attestati nel monastero di Calabro Maria.
In seguito all’incendio che distrusse il primo monastero di Fiore, i monaci florensi, sorpresi dal sopraggiungere dell’inverno, furono probabilmente ospitati nel cenobio di Calabro Maria, come del re-sto avevano previsto gli accordi del 1213. Anche in seguito, per quanto ormai l’emergenza fosse stata su-perata, i monaci di Fiore mantennero stretti rapporti con quelli di Calabro Maria, per riceverne aiuto e sostegno. In una fase durante la quale la domus exi-litas non permetteva ancora l’accoglienza dell’intera comunità di Fiore, alcuni suoi monaci furono infatti distaccati, probabilmente per il periodo invernale, presso la vecchia chiesa di Calabro Maria, ove i reli-giosi di quest’ultimo cenobio avrebbero dovuto met-tere a loro disposizione un ospizio, sufficiente a una dispensa e a una stalla, e un locum a loro libero uso. I monaci di Fiore erano tenuti tuttavia al rispetto dell’abate e dei confratelli di Calabro Maria89.
Il documento che testimonia questo accordo di ospitalità nei confronti dei monaci rimasti senza tet-to risale all’ottobre del 1216, anno in cui Matteo, abate di Fiore, stabilì che il monastero di Calabro Maria potesse ricevere la dignità abbaziale. Inizial-mente fu disposta una forma intermedia, per cui fu mantenuta ancora una parziale dipendenza dal mo-nastero fondatore: l’abate di Calabro Maria, infatti, doveva essere eletto sia dal proprio capitolo sia da quello di Fiore, evidentemente tenuti a riunirsi insie-me per l’occasione. L’abate così eletto avrebbe avuto pieno potere sui monaci a lui affidati e sarebbe stato uno dei tre abati previsti dalle istituzioni florensi90. Il documento proseguiva stabilendo che il monastero di Calabro Maria non sarebbe rimasto tra i monaste-ri dell’ordine di Fiore «que ultra unam dietam sunt», ma sarebbe stato invece tra quelli in cui e attraverso i quali si sarebbe conservato l’ordine91.
Matteo procedette poi a definire le norme che dovevano regolare la visita canonica: l’abate di Fiore avrebbe dovuto visitare la nuova fondazione, correg-gendo sia in capite, sia in membris, idest prelato vel subditis, ciò che a suo giudizio non andava. La nuova comunità florense non era tuttavia posta sullo stesso piano istituzionale di Fonte Laurato e di Acquavi-va, dal momento che il suo abate non avrebbe avuto il diritto di visitare reciprocamente quello di Fiore, come invece facevano gli abati delle altre due fonda-
zioni dell’ordine92. Il documento fu sottoscritto complessivamente
da trentasette monaci; ventitrè appartenenti alla co-munità di Fiore e quattrordici a quella di Calabro Maria. Rispetto al documento di tre anni prima, vi era stato un certo avvicendamento di persone: dei ventiquattro monaci di Fiore che sottoscrissero nel 1213 alcuni non compaiono più; probabilmente erano nel frattempo deceduti, o più semplicemen-te erano assenti. Altri sottoscrissero come monaci di Calabro Maria: erano dunque passati alla nuova co-munità; altri infine erano nuovi. Anche la comunità di Calabro Maria si era accresciuta rispetto a tre anni prima: nel 1213 avevano sottoscritto il documento nove monaci; nel 1216 ne erano attestati quattordi-ci, segno che l’istituzione florense nel suo complesso esercitava una forte attrattiva sulla popolazione, che vedeva in essa un’esperienza religiosa significativa e una garanzia per la propria salvezza.
Un terzo documento relativo ai rapporti tra Fiore e Calabro Maria si presenta come una rivendicazio-ne dei libri a suo tempo dati in prestito al nuovo cenobio, perché ne fosse tratta una copia a proprio uso93. L’abate Matteo infatti elencò i vari beni che erano stati ceduti a pieno titolo al monastero di Ca-labro Maria da parte di Fiore: si trattava di «boves, vaccas, oves, equitaturas, sacerdotalia vestimenta et pallas altaris», dunque animali per l’allevamento e oggetti di arredo liturgico. Quanto ai libri dati a pre-stito alla nuova comunità, l’abate tenne a precisare che essi non erano stati donati, ma solo prestati, per cui avrebbero dovuto essere restituiti non appena se ne fosse fatta richiesta. Infine, in cambio di alcuni beni ricevuti nel frattempo, Matteo concesse a Ca-labro Maria «campanas duas, ollam et caldaream de metallo».
Nel 1218 anche Calabro Maria, come gli altri monasteri florensi, fu esentato dalla vigesima, grazie ai buoni favori del cardinale Ugolino94.
L’ultimo documento, per il periodo considerato, riguardante la fase florense dell’ex monastero greco fu la conferma, data da papa Gregorio IX, di un di-ploma di Federico II concesso a Bologna nel 1220. Il futuro imperatore, che si stava recando a Roma per l’incoronazione, concesse al monastero di Calabro Maria il reddito annuo di dodici once d’oro sulla gabella delle saline del Neto e un mulino lungo il corso del medesimo fiume95. Questa offerta di beni e redditi in realtà non risaliva a Federico II, che proba-bilmente si limitò a confermarla; i beni in questione infatti competevano al monastero florense già prima della riforma, dal momento che erano stati concessi a Calabro Maria da Ruggero, ancora gran conte, e
257
poi da lui riconfermati quale re di Sicilia dopo l’edit-to de resignandis privilegiis del 1144. Come si è visto, nel 1253 l’abate di Calabro Maria Nicola chiese a due giudici di Crotone, Nicola e Michele, di tradur-re in latino i tre documenti scritti originariamente in greco. Giovanni di Petra Paola, pubblico notaio di Crotone, ne redasse l’atto notarile, che fu riportato da Ferdinando Ughelli, il quale dichiarava di averne desunto il testo dalla suddetta copia in latino allora esistente nell’archivio di Altilia96.
I tre documenti fatti tradurre dall’abate Nicola riguardavano principalmente il vasto tenimento di Sanduca, nell’attuale Sila Piccola, che appartenne alla fondazione florense fino alla fine del Settecento, ai tempi di Nicola Venusio, che ne fece disegnare una mappa e i precisi confini, mappa inserita poi tra la documentazione da lui raccolta97.
Per il periodo in esame non rimane altra docu-mentazione; il monastero andò soggetto alle vicende degli altri cenobi florensi. Fu dato in commenda nel 1451 e nel 1570, al pari degli altri monasteri florensi superstiti, passò ai cistercensi98.
Anche la fondazione di Calabro Maria, al pari di quelle di Fiore e di Acquaviva, fu teatro di alcuni episodi miracolosi compiuti da Gioacchino. Il pri-mo in realtà è il racconto di un miracolo non avve-nuto, a causa dell’incredulità di un certo Ruggero diacono, abitante di Santa Saverina99: a costui era apparsa Maria, che gli si presentò come «Maria que habito super monte Calabromaria». La Vergine gli or-dinò di riferire al magister Nicola de Leni che doveva recarsi, insieme alla figlia posseduta da un demonio, dall’abate di Calabro Maria, Nicola, che l’avrebbe subito curata. Molto scettico, Ruggero rispose che l’abate di Calabro Maria non era un medico in gra-do curare la giovane; la donna dell’apparizione affer-mò allora che l’abate avrebbe dato da bere alla figlia del magister la lavatura ottenuta con un oggetto che l’abate aveva portato con sé dal monastero di Fiore. Ruggero non eseguì gli ordini della donna apparsagli in sogno; a causa della sua negligenza o dimentican-za, la giovane morì. Il commento finale dell’agiogra-fo spiegava che la donna apparsa al diacono Ruggero era la vergine Maria, a cui era dedicato il monastero di Calabro Maria, e l’oggetto che l’abate Nicola por-tava sempre con sé in pectore era il braccio sinistro dell’abate Gioacchino, «domni Ioachim viri beati»; se il braccio fosse stato immerso nell’acqua o nel vino, e se la bevanda così ottenuta fosse stata data da bere alla ragazza, quest’ultima sarebbe certo guarita e liberata.
Nel racconto del secondo miracolo compare anco-
ra un Nicola, semplice monaco di Calabro Maria100. Caduto insieme alla sua cavalcatura nelle acque del Neto, nei pressi del monastero di Fiore, egli invocò il nome di Gioacchino, che prontamente intervenne in suo aiuto e lo salvò dai flutti.
Infine, la memoria della santità dell’abate conser-vata a Calabro Maria è attestata anche dal fatto che l’abate di Calabro Maria, insieme a quelli di Fiore e di Santa Maria Nuova, verso la metà del XIV secolo pro-mosse una petizione presso la curia di Avignone per-ché fosse esaminata la raccolta dei miracoli ed even-tualmente aperta la causa per la canonizzazione101.
4. Il monastero dei Tre Fanciulli, poi Santa Maria Nuova
Il monastero greco dei Tre Fanciulli, situato in territorio di Caccuri, in diocesi di Cerenzia, fu pro-babilmente l’ultimo monastero ad entrare nell’ordi-ne florense in Calabria e in cui fu condotta effetti-vamente vita monastica regolare. Si tratta dell’unico monastero greco che passò ai florensi dopo aver ospi-tato probabilmente, per un certo periodo, i cister-censi, come dipendenza di Sant’Angelo del Frigilo.
Come si è visto, il cenobio greco aveva condotto, ai tempi di Gioacchino, una violentissima disputa con i monaci di Fiore per il possesso di alcuni ter-reni, per consuetudine di loro competenza ma in-clusi nella prima proprietà di Fiore da Enrico VI nel 1194102.
Il monastero ospitò una comunità di monaci gre-ci fino al 1218, anno in cui fu riformato. Ancora nell’agosto del 1215 la comunità greca era attiva, dal momento che in tale data, per chiudere definitiva-mente la contesa con il monastero di Fiore, essa si era rivolta, congiuntamente ai monaci di Fiore, al-l’arcivescovo di Cosenza Luca, per sottoporgli tutta la questione e perché emettesse il suo arbitrato in proposito. I monaci greci in quell’anno erano ancora guidati dall’abate eletto, Ilario103.
Successivamente a questa data, sembra che il mo-nastero abbia attraversato una fase di crisi: nel 1218 infatti Onorio III incaricò il vescovo di Nicastro e gli abati cistercensi di Corazzo e di Sant’Angelo del Frigilo di visitare e riformare il monastero, a causa di alcuni disordini che si erano verificati. Il greco Ila-rio, infatti, «eiusdem monasterii dictus abbas», aveva espulso con la frode il legittimo abate Isaia - Isaia fu l’abate protagonista del lungo scontro con i monaci di Fiore -, si era sostituito a lui «per simoniacam pra-vitatem» e aveva dilapidato i possessi e i beni della fondazione, soggiogando i monaci al dominio di lai-
258
ci e costringendo così il pontefice ad intervenire104.Il Pressutti ha riportato, sulla base di fonti tardi-
ve, un identico incarico, demandato alle medesime persone, anche nell’anno 1220: si tratta probabil-mente di un errore, dal momento che entrambi gli incarichi sono datati il 12 novembre105. Alcuni ele-menti inducono infatti a ipotizzare che il monastero greco fosse passato all’osservanza latina già dopo la visita ordinata dal papa nel 1218. Il cenobio infatti, nel 1218, era chiamato anche Sancta Maria Nova de Calabria, e un documento dell’aprile del 1219 ricorda un monaco di Santa Maria Nuova, Mileto, appartenente a una comunità cistercense. Egli aveva chiesto e ottenuto infatti di essere accolto nel mona-stero cistercense di Sant’Angelo del Frigilo ai tempi dell’abate Alessandro (1213-1217); era passato poi nel monastero di Santa Maria Nuova; tuttavia, a ricordo dei suoi primi passi come monaco, donava alcune terre ancora di sua proprietà al monastero di Sant’Angelo106. È dunque probabile che, a seguito della visita e della riforma da parte del vescovo di Nicastro e dei due abati cistercensi, la fondazione fosse passata a questa osservanza in data anteriore all’aprile 1219 come abbazia figlia di Sant’Angelo; dalla sua casa madre ricevette alcuni monaci, tra cui Mileto. La bolla di incarico, datata da Pressutti al 1220, identica a quella del 1218, sarebbe perciò la registrazione del documento del 1218, riferito al 1220 da una fonte tardiva.
Non si hanno più notizie sul periodo probabil-mente cistercense fino a quando, nel 1254 o 1255, Alessandro IV ne affidò la visita e la riforma all’elet-to di Cosenza, Cacciaconte, e al suo suffrageneo, il vescovo di Bisignano, a petizione dell’abate di Fiore e dei suoi monaci. Questi ultimi infatti considera-vano il monastero ormai da tempo «in spiritualibus et temporalibus graviter collapsum» e ne richiedeva-no pertanto la riforma107. Un primo tentativo evi-dentemente fallì, dal momento che un paio di anni più tardi, nell’ottobre del 1256, il pontefice dovette rinnovare l’incarico, affidando al vescovo di Bisigna-no, all’arcidiacono di Squillace e al magister Amato, canonico di Cosenza, il compito di visitarlo e rifor-marlo108. Probabilmente in tale occasione il mona-stero fu finalmente affidato ai florensi, dal momento che appena due anni più tardi è sicuramente abitato dai monaci del piccolo ordine.
Nel 1259 infatti Alessandro IV definì il monaste-ro «Florensis ordinis, Geruntinae diocesis»; il papa scrisse al suo abate e al vescovo di Strongoli perché ponessero in possesso del monastero greco di San-t’Adriano di Rossano l’abate del monastero florense di Sant’Angelo del Monte Mirteto, presso Ninfa, nel
Lazio meridionale109.Tra i beni del monastero, oltre ai possessi assegna-
ti definitivamente ad esso nel 1215 dall’arcivescovo di Cosenza Luca, cioè un terreno seminativo di tren-ta moggi nella località chiamata Salice o nelle sue vicinanze, e la tenuta chiamata Mixi110, vi erano altri beni, compresi per lo più tra il torrente Lepre e la sinistra del Neto; vi era inoltre il casale di Cotronei con il tenimento di Cuzuli, sulla destra dell’Ampol-lino. Questi ultimi erano stati confiscati al tempo dell’imperatore Corrado IV, abusivamente occupati da Guido di Amantea e Giordano Maniacasale suo fratello, signori di Melissa, e infine restituiti al mo-nastero da Carlo d’Angiò, con due provvisioni del 1271 e del 1272 dirette al giustiziere della Valle del Crati e Terra Giordana111.
Da questo momento in poi le fonti si fanno estre-mamente lacunose: nel 1346 il cenobio risulta sot-toposto direttamente al monastero di Fiore, insieme a quello di Calabro Maria; in quella data l’abate di Santa Maria Nuova fu accanto ai confratelli di Fiore e di Calabro Maria nella supplica al pontefice per ottenere provvidenze in favore dell’ordine, un cardi-nale protettore e l’istituzione di una commissione di vescovi con il compito di vagliare i miracoli compiu-ti da Gioacchino, per avviare in tal modo l’iter del processo di canonizzazione112.
Il monastero rimase legato direttamente a Fiore fino a quando, nel 1652, non fu soppresso da Innocenzo X e aggregato alla commenda di San Giovanni113.
È certamente molto difficile valutare e trarre conclusioni riguardo alla vita di queste fondazioni florensi in Calabria, data la frammentarietà delle notizie che ci sono giunte. La scarsissima documen-tazione superstite non permette altro che prendere atto del legame che continuò indubbiamente a sus-sistere, in territorio calabrese, tra le fondazioni poste in area silana, con l’esclusione dunque, come sem-brerebbe, del monastero di Fiumefreddo. In partico-lare a riguardo della volontà di conservare memoria del proprio fondatore, le abbazie di Calabro Maria, di Acquaviva e di Santa Maria Nuova si presentano sempre a fianco del monastero di Fiore, sia in occa-sione della raccolta del materiale agiografico relati-vo a Gioacchino, negli anni ‘20 del XIII secolo, sia nel momento in cui, verso la metà del XIV secolo, i florensi cercarono di ottenere, da parte della curia avignonese, la canonizzazione del loro fondatore.
Quanto ai legami istituzionali tra le abbazie, il ruolo centrale dei monasteri calabresi emerge con una certa evidenza. Al di là dei compiti svolti da Fio-re in quanto protocenobio, gli altri monasteri della
259
Calabria hanno ricoperto funzioni di controllo nei confronti delle abbazie sorte in aree più lontane: a Fonte Laurato infatti furono affidate, come abbazie figlie in cui effettuare la visita canonica, Sant’Ange-lo del Mirteto (da cui a loro volta dipendevano le abbazie della penisola sorrentina) e Santa Maria del-la Gloria; il monastero di Acquaviva invece dovette dapprima riformare, in seguito presumibilmente vi-sitare, le abbazie della Toscana. Un unico documen-to ci attesta poi l’azione dell’abate del monastero di
Santa Maria Nuova in favore dei confratelli del Mir-teto, nel Lazio meridionale: si tratta del tentativo, in realtà fallito, di prendere possesso del monastero gre-co decaduto di Sant’Adriano di Rossano. Da questi fragili elementi è possibile comunque evincere che i monasteri florensi calabresi detennero, insieme a Fiore e anche al di là delle difficoltà attraversate, un ruolo di coordinamento nei confronti delle comuni-tà monastiche dell’ordine poste al di fuori dei confi-ni del Regno.
Note
1 Come abbiamo visto, le tre fondazioni silane compaiono
per la prima volta nel diploma dell’imperatrice Costanza del
gennaio 1198 («monasteria , que de novo fundasti in loco, qui
olim dictus est Calosuber, nunc autem Bonum Lignum, et in
loco qui dicitur Tassitanum, et monasterium Abbatis Marci,
que et ipsa ad tuam curam constitutis ibi a te prelatis pertinere
noscuntur»), vd. vol. II, p. I, n. 12; vengono nuovamente ricor-
dati da Federico nella conferma del luglio 1208, che riprende
le parole del precedente documento di Costanza (vd. vol. 2, p.
I, n. 53).2 Vd. ivi, doc. n. 30 = ivi, p. II, doc. n. 1; cfr. supra, p. 8.3 Ivi, p. I, doc. n. 36 = ivi, p. II, doc. n. 2. È il primo do-
cumento che testimonia la morte di Gioacchino e il passaggio
della carica abbaziale a Matteo.4 Vd. testo del documento dell’arcivescovo Andrea, in ivi,
p. I, doc. n. 29.5 Riccardo infatti specificava che «de praelatis et monachis
in ipso monasterio statuendis aut removendis secundum vo-
luntatem et ordinationem vestram vestrique ordinis instituta
procedatis», ricalcando le parole di Simone di Mamistra «ro-
gantes vos ... ordinare de praelatis et monachis qui pro tempore
fuerint statuendi aut removendi secundum ordinem vestrum».
Si tratta evidentemente di una formula per specificare una for-
ma di libertà, sia dall’ordinario vescovile sia dal signore locale,
concessa alla nuova fondazione. Vd. ivi, doc. n. 30.6 Si tratta di un castrum in diocesi di Bisignano, nella Valle
260
del Crati (oggi è la frazione Regina, in comune di Lattarico).
La platea, cioè l’inventario della mensa vescovile, fatta compi-
lare da Ruffino, vescovo di Bisignano dal 1264 al 1269, regi-
stra le chiese censuali del territorio del castello di Regina, in
tutto diciotto. Di esse, tre sono luoghi di culto dipendenti da
altrettante istituzioni religiose, che erano tenute a versare un
censo ricognitivo alla mensa vescovile: la chiesa di San Cipria-
no, dipendente dall’Ospedale di San Giovanni Gerosolimita-
no di Messina, che aveva possedimenti nel territorio; la chiesa
di Santa Maria de Rota, monastero dipendente dall’abbazia di
Cava; e infine una chiesa del monastero di San Benedetto Ulla-
no, anch’esso dipendente da Cava. Per queste notizie, vd. P. De
Leo, Un feudo vescovile, p. 55-58. 7 Vd. ivi, p. II, doc. n. 4. Nel brevissimo regesto conser-
vatosi si aggiunge che Guillelmus de Spinosa et Ricardus Valent
concedunt, senza che venga specificato altro. Si tratta probabil-
mente di persone che vantavano diritti sull’oliveto.8 Si tratta di un riassunto sommario, più esteso di un vero
e proprio regesto, del documento. Vd. ivi, p. II, doc. n. 5. I
problemi relativi alla datazione di questo documento derivano
dal fatto che la conferma da parte di Innocenzo III è datata
al 20 gennaio 1204, quindi anteriormente alla stessa donazio-
ne, secondo quanto riportato dal documento («Anno Domini
.MCCIIII., indictione .VII., anno .VI. regni domni Federici
regis Sicilie, ducatus Apulie et ducatus Capue»). Le indicazioni
dell’anno, dell’indizione e del regno di Federico nel documen-
to di Matteo di Tarsia porterebbero infatti a datare il documen-
to in un periodo compreso tra il 25 marzo (se è seguito lo stile
fiorentino dell’incarnazione) e il 16 maggio del 1204, giorno
in cui si conclude il sesto anno di regno di Federico. Potrebbe
dunque essere errata la data della conferma papale, giunta solo
in un regesto tardivo. È da rilevare tra l’altro che il regesto di
tale conferma è stato tratto non dall’originale, ma da un tran-
sunto conservato almeno fino al 1601 nell’archivio di Fonte
Laurato. Esso era sottoscritto e munito dei sigilli di Giordano,
cardinale prete di Santa Pudenziana del titolo di Pastore, che
è poi Giordano da Ceccano, abate di Fossanova fino al 1188,
anno in cui fu creato cardinale da Clemente III, di «frater Gal-
terius Fossanove dictus abbas», e di «frater Lufridus Fossanove
dictus prior». La copia è perciò antecedente al 23 marzo 1206,
data della morte di Giordano; l’ultima sua sottoscrizione in
documenti pontifici risale al 13 febbraio dello stesso anno. Tra
l’altro è degno di nota che un documento papale per un mona-
stero florense venga copiato e autenticato da un cardinale, un
abate e un priore cistercensi, legati o appartenenti all’abbazia
di Fossanova; esso lascia intravedere rapporti tra cistercensi e
florensi che non si esaurivano evidentemente nella polemica
contro l’abate Gioacchino. Ma vi è anche la possibilità che nel
documento di Matteo di Tarsia sia seguito non tanto lo stile
fiorentino, quanto quello pisano, come avveniva nella curia re-
gia di Palermo in quel periodo, in cui il piccolo Federico era
sotto la custodia di Guglielmo Capparone. Il signore di Regina
e di Fuscaldo si sarebbe allora conformato all’usus in vigore
nella curia di Palermo, mettendo in evidenza i legami con essa
da parte di un signore locale. Se così fosse, il suo documento,
nel caso riportasse l’indizione errata, sarebbe da datarsi in un
periodo compreso tra il 17 maggio 1203 e il 20 gennaio 1204;
nel caso che anche l’indizione sia da considerare esatta, potreb-
be trattarsi dell’indizione greca, seguita nell’Italia meridionale,
per cui il documento potrebbe datarsi tra il primo settembre
1203 e ancora il 20 gennaio 1204, data della conferma da parte
di Innocenzo III (da considerarsi allora esatta, anche perché si
collegherebbe in modo coerente alla immediatamente successi-
va bolla solenne di protezione da parte del pontefice) e periodo
in cui tutte le indicazioni del documento di Matteo trovereb-
bero tra loro corrispondenza.9 Il monastero di Santa Maria delle Fosse era collegato a
quello di Santa Maria di Valle Giosafat, presso Gerusalemme,
costruito negli anni immediatamente successivi alla conquista
della città da parte dei crociati nel 1099, nel luogo dove si ve-
nerava il sepolcro di Maria madre di Gesù. Principi e signori
normanni lo gratificarono ben presto con rilevanti donazioni
nell’Italia meridionale. In Calabria si trovavano numerose di-
pendenze affidate, a partire dal 1110, al monastero gerosoli-
mitano: erano poste nella diocesi di Rossano, di Cassano e di
Cosenza, e in non pochi casi furono dotate con monasteri e
chiese di epoca bizantina.10 Vd. vol. 2, p. II, doc. n. 7.11 Si tratta della prima attestazione, a noi nota, di tale for-
mula, anche se probabilmente si doveva trovare anche nella
bolla di protezione concessa al monastero di Fiore da Inno-
cenzo III il 13 febbraio 1202 (o 1203), conservata solo par-
zialmente.12 Vd. ivi, p. II, doc. n. 8.13 Ivi: «exhibentes nobis et successoribus nostris illam re-
verentiam quam florensis monasterium, a quo procesistis, do-
mino cosentino et ecclesiae cosentine et exhibuit et exhibere
tenetur».14 Ivi: «secundum quod monasterium Floris, a quo proces-
sistis, apostolico privilegio indulto sibi gaudere cognoscitur,
vos etiam nullo mediante absque alicuius contrarietate vel mo-
lestia gaudeatis».15 H. Houben, Il “libro del capitolo” del monastero della SS.
Trinità di Venosa (Cod. Casin. 334): una testimonianza del Mez-
zogiorno normanno, Galatina 1984 (Univ. Degli Studi di Lecce,
Dip. Di Scienze Storiche e Sociali, Materiali e documenti, 1);
La tradizione commemorativa nel Mezzogiorno medioevale: ricer-
che e problemi. Atti del seminario internazionale di studio (Lecce,
31 marzo 1982), a c. di C. D. Fonseca, Galatina 1984 (Univ.
Degli Studi di Lecce, Dip. Di Scienze Storiche e Sociali, Saggi
e ricerche, 12).16 Vd. vol. 2, p. II, docc. nn. 20 e 21.17 Vd. ivi, doc. n. 9.18 Vd. ivi, p. II, doc. n. 10.19 Il castrum di San Lucido era compreso, insieme a quello
di Rende, tra i beni appartenenti alla chiesa di Cosenza: cfr.
261
Kamp, 830, n. 2.20 Vol. 2, p. II, doc. n. 11.21 Ivi, doc. n. 87.22 Ivi, doc. n. 12.23 Ivi, doc. n. 14.24 Ivi, doc. n. 15.25 A. M. Adorisio, Gioacchino da Fiore a Roma e nel Lazio,
«Rivista cistercense», IX (1994), p. 43-4.26 Matthew, I Normanni cit., p. 394.27 Vol. 2, p. II, doc. n. 17.28 Ivi, doc. n. 19.29 Ivi, doc. n. 16.30 Ivi, docc. nn. 18 e 22.31 Ivi, doc. n. 23.32 Ivi, doc. n. 25.33 Ivi, doc. n. 24.34 Matthew, I Normanni cit., p. 401.35 Vol. 2, p. II, doc. n. 29.36 Ivi, doc. n. 30.37 Potrebbe trattarsi in realtà del 1227, dal momento che la
diocesi di Rossano, come quelle circostanti di Santa Severina e
delle sue suffragenee, erano ancora bizantine e seguivano proba-
bilmente ancora gli usi cronologici bizantini. Cfr. ivi, doc. n. 31.38 Ivi, doc. n. 34.39 Permane comunque il dubbio che i beni nominati dalla
bolla pontificia appatenessero al monastero solo sulla carta, ma
che in realtà non fossero rientrati in possesso della comunità di
Fonte Laurato. Vd. ivi, doc. n. 44.40 Ivi, doc. n. 26.41 Ivi, doc. n. 27.42 Ivi, doc. n. 32.43 Ivi, doc. n. 33.44 Ivi, doc. n. 37.45 Ivi, docc. nn. 58 e 87.46 Ivi, p. I, doc. n. 183.47 Ivi, doc. n. 148.48 Ivi, p. VIII, doc. n. 2 (Santa Maria della Gloria).49 Benedetto infatti potrebbe essere colui con il quale l’aba-
te avrebbe discusso le tematiche dei Dialogi de prescientia Dei
et predestinatione electorum. In merito, vd. Russo, Gioacchino
da Fiore e le fondazioni, p. 152-3 e 254-5; cfr. tuttavia Potestà,
Introduzione, in Ioachim abbas Florensis, Dialogi cit., p. 29.50 Russo, Gioacchino da Fiore e le fondazioni cit., p. 148.51 Vol. 2, p. I, doc. n. 53.52 Ivi, doc. n. 58.53 Ivi.54 Ivi, p. III, doc. n. 1.55 Ivi, p. I, doc. n. 102.56 Ivi, p. III, doc. n. 2.57 Ivi, p. II, doc. n. 7; p. I, doc. n. 78. 58 Ivi, p. III, doc. n. 2: «cum monasterium tuum opportuna
praediorum utilitate sufficienter non fuerit ordinatum».59 Ivi.
60 Ivi.61 Ivi: «ecclesiam sanctorum Trium Puerorum sitam in teni-
mento Barbari, quondam monasterium, licet irreligiosum vici-
nitate saecularium personarum, sed nunc funditus desolatum
atque destructum».62 Ivi.63 Ivi.64 Per tutti, vd. Napolitano, San Giovanni in Fiore, I, 2, p.
135, n. 14, in cui è evidente il fatto che lo studioso ha confuso
le due fondazioni.65 Vol. 2, p. III, doc. n. 5.66 Ivi, p. I, doc. n. 183.67 Russo, Gioacchino da Fiore e le fondazioni cit., p. 149.68 Zinzi, Il monastero cit., p. 374.69 Vol. 2, p. I, doc. n. 148.70 Ivi, p. III, docc. nn. 6 e 7.71 Adorisio, La “Legenda”, p. 139.72 Ivi.73 Ivi.74 Ivi.75 Ivi, p. 146.76 Ivi.77 Ivi, pp. 150-1.78 Cfr. Napolitano, S. Giovanni in Fiore cit., I, 2, p. 126,
nota 113.79 Ivi, p. 129.80 Vd. vol. 2, p. IV, doc. n. 8.81 Ivi, p. I, docc. nn. 78 e 95.82 In merito, vd. De Fraja, Oltre Cîteaux, cap. III.83 Vol. 2, p. I, doc. n. 78.84 Ivi.85 Ivi.86 Ivi. 87 Twelfth-Century Statutes, p. 513, X (Capitula); p. 537, III
(Instituta): «(...) nec tamen illuc destinentur donec locus libris,
domibus et necessariis aptetur, libris dumtaxat missali, Regula,
libro usuum, psalterio, hymnario, collectaneo, lectionario, an-
tiphonarium, gradali».88 Vol. 2, p. I, doc. n. 78.89 Ivi, doc. n. 95.90 Ivi.91 Ivi.92 Ivi.93 Ivi, doc. n. 96.94 Ivi, doc. n. 102.95 Ivi, p. IV, docc. nn. 6 e 7. 96 Ivi, doc. n. 8.97 De Leo, I manoscritti di Nicola Venusio cit., p. 22.98 Russo, Gioacchino da Fiore e le fondazioni cit., p. 144.99 Adorisio, La “Legenda” cit., p. 164.100 Ivi, p. 165.101 Baraut, 253, n. 57.102 Cfr. supra, pp. 4-6.
262
103 Il documento dell’arcivescovo Luca ripercorre tutta le vi-
cende del lungo contrasto che aveva opposto le due comunità.
Cfr. Vol. 2, p. I, doc. n. 89.104 Pressutti, I, 279, n. 1676.105 Ivi, I, 460, n. 2771.106 Pratesi, Carte latine, p. 279-282, doc. 117.107 Vol. 2, p. V, doc. n. 1: la notizia relativa all’incarico è
riportata nel documento successivo. Napolitano, S. Giovanni
in Fiore cit., I, parte 2, p. 136, non riporta la sua fonte. Non
ne ho trovato notizia in Kamp, Kirche und Monarchie cit., pp.
844-849.108 Vol. 2, p. V, doc. n. 2.109 Ivi, doc. n. 3.110 Ivi, p. I, doc. n. 89.111 Napolitano, S. Giovanni in Fiore cit., p. 136, che anche
in questo caso non cita però le sue fonti.112 Baraut, 253, n. 57.113 Russo, Gioacchino da Fiore e le fondazioni cit., p. 183.
263
CapItOlO QuINtO
la dIFFuSIONE NEl rEGNO,
NEl PatrImonIum, IN tuSCIa
1. I monasteri nel Regno di Sicilia: la penisola sorrentina
Come per i monasteri calabresi dipendenti da Fiore, anche le notizie relative ai tre cenobi del-l’ordine posti nella penisola sorrentina sono estre-mamente lacunose. Considerando la loro posizione geografica è possibile in effetti accogliere l’ipotesi di A. Vuolo, che vede nelle incursioni barbaresche, e in particolare in quella del 1558, la ragione principale della perdita del materiale documentario relativo alle fondazioni monastiche di questa zona1. Riguardo a questi cenobi florensi, possediamo infatti solo spo-radiche notizie relative al loro inserimento all’inter-no dell’ordine; fa parziale eccezione il monastero di Santa Marina della Stella, presso Maiori, per il quale si sono conservati documenti pontifici, imperiali e privati.
I cenobi di Rovigliano e di Sorrento non furo-no nuove fondazioni istituite dai florensi, ma pas-sarono alla religio di Gioacchino dopo un periodo, probabilmente lungo di secoli, di vita monastica benedettina. In questi due casi, dunque, i florensi svolsero un ruolo simile a quello dei cistercensi, nel momento in cui le comunità stesse, i vescovi locali o la sede pontificia prendevano l’iniziativa della rifor-ma di monasteri decaduti o bisognosi di correzione, analogamente del resto a quanto avvenne anche in Calabria.
1.a. Sant’Angelo di RoviglianoPosto sull’isolotto di Rovigliano, alla foce del Sar-
no, tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, dove è ancora visibile una torre di difesa, la fonda-zione dedicata a Sant’Angelo era un antico mona-stero benedettino. La sua diocesi di appartenenza è alquanto incerta: da un lato infatti pare legato al-l’arcidiocesi di Sorrento, come attestano alcuni do-cumenti a partire dal 1216; dall’altra sembra che il cenobio fosse affidato alla cura del vescovo di Stabia, come proprietà sottoposta alla sua giurisdizione, an-cora all’inizio del XII, come si evincerebbe da due carte datate al 1110 e al 11112 e dai documenti di Gregorio IX inerenti alla chiesa di Santa Marina.
La prima notizia che ne attesta l’esistenza risale al 938: si tratta di un atto di donazione indirizzato al «venerabili abba presbitero monasterii Rubilianae». In seguito tuttavia se ne perdono le tracce fino al XIII secolo3.
Nel novembre del 1220, probabilmente per ini-ziativa dell’abate Stefano e dei suoi sedici monaci, che desideravano accogliere le istituzioni florensi, il monastero fu posto «in societatem et sub paternita-te monasterii Sancte Marie de Monte Mirteto supra Nimpham et domini Benedicti, abbatis monasterii»4. Benedetto, abate di quest’ultimo cenobio, avrebbe dovuto dunque assumerne la filiazione, visitandolo
264
e sottoponendolo al suo controllo. L’unione, a pe-tizione, ancora una volta, del cardinale Ugolino, fu confermata il successivo 5 dicembre 1220 da Ono-rio III, che scrisse sia ai monaci di Rovigliano sia a quelli del Mirteto, autorizzando i primi ad accoglie-re le istituzioni florensi e a sottoporsi alla visita e alla correzione dell’abate del Mirteto, e ingiungendo a quest’ultimo di assumerne il governo5.
Rimane solo un secondo documento riguardante in modo diretto la comunità ormai florense di Rovi-gliano: il 30 gennaio 1224 Onorio III infatti indiriz-zò una lettera al capitolo, nel tentativo di sanare una lite sorta tra l’arcivescovo di Sorrento e il monastero di Rovigliano, «circa monasterium Sancti Renati»6. Il legame istituzionale, risalente al 1222, tra il mo-nastero di Sant’Angelo e un secondo cenobio della zona che ugualmente passò ai florensi, il monaste-ro di San Renato di Sorrento, aveva evidentemente creato malcontento nella curia sorrentina7. Non co-nosciamo quali fossero i motivi precisi della contesa; A. Vuolo ipotizza che fossero dovuti a una rivendica-zione della giurisdizione dell’arcivescovo sorrentino nei confronti dei monaci di San Renato8.
Riguardo al periodo successivo, non si conoscono altri dettagli sulla vita florense del cenobio, se non indirettamente, attraverso le vicende dell’unione ai florensi dei monasteri di San Renato e di Santa Ma-rina della Stella.
1.b. San Renato di SorrentoLa tradizione indica già nel 645 l’esistenza, in
Sorrento, di una basilica dedicata ai santi Renato e Valerio; il primo documento relativo risale tuttavia al 939, anno in cui il console e duca di Napoli, Gio-vanni, donò al monastero di Montecassino diverse proprietà situate nei pressi della chiesa di San Rena-to. Si trattava anche in questo caso, probabilmente, di un antico cenobio benedettino, che appare legato al culto e alla tutela delle reliquie appunto di san Renato, uno dei primi vescovi di Sorrento9.
Nel corso del 1222 il monastero fu unito all’ordi-ne florense e posto sotto il controllo dell’abbazia del Mirteto. Il 19 febbraio di quell’anno infatti, Ono-rio III indirizzò un breve all’abate e al convento del cenobio ormai florense di Rovigliano, incaricandolo di riformare la fondazione sorrentina10. Il mandato fu ben presto eseguito: nel settembre di quell’an-no l’abate di Rovigliano Stefano scriveva di aver sottoposto «sub paternitate Sante Marie de Monte Mirteto et domini Benedicti abbatis eiusdem, mo-nasterium Sancti Renati de Surrento, quod nuper ordinandum recepit de mandato sedis apostolice, secundum Florentini ordinis instituta»11. Non ce ne
rimangono notizie ulteriori per il resto dell’età sve-va; sotto gli Angioini attraversò probabilmente un periodo di relativa floridezza, dal momento che era in grado di pagare annualmente due once d’oro, ses-santa tomolate di frumento e dieci salme di vino al notaio messinese Giovanni di Conia, ospite del mo-nastero per ordine di Carlo d’Angiò. Il re confermò al cenobio sorrentino anche il possesso di un bal-neum a Castellammare. In seguito, fu associato alla congregazione cassinese da Clemente VII nel 1571, e San Renato divenne dipendenza del monastero na-poletano dei Santi Severino e Sossio fino al 1807, quando entrambi furono soppressi12.
1.c. Santa Marina della Stella presso MaioriVicende relativamente meglio documentate sono
quelle del monastero di Santa Marina della Stella, sito a Maiori, nell’arcidiocesi di Amalfi. La circo-stanza per cui la dedicazione del cenobio è giunta in forma erronea, dal momento che spesso si ritrova la forma Santa Maria della Stella anziché Santa Mari-na, ha reso confusa la ricostruzione della sua storia. Lo stesso p. Francesco Russo, nella monografia de-dicata all’ordine di Fiore, chiama il monastero Santa Maria, ed esaurisce in poche righe le notizie relati-ve13. In realtà si tratta di una fondazione dedicata a santa Marina, di cui si hanno notizie a partire alme-no dal 1190. In quell’anno, una certa Tarsia, figlia di Bernaldo de Constantino comite, nel suo testamen-to fece lasciti a favore di molte istituzioni religiose amalfitane, tra le quali è compresa anche quella di Santa Marina della Stella14.
Trentacinque anni più tardi, dopo un periodo di completo silenzio delle fonti, il monastero di Santa Marina era già passato all’ordine florense. Nel mag-gio del 1225 infatti Federico II, scrivendo da Sessa, concesse la propria protezione e difesa al cenobio di Santa Marina de Stella15. Frate Ugolino, evidente-mente il superiore della comunità, e i suoi confratelli accolsero allora «nostre [di Federico II] benignita-tis interveniente convenientia et consensu instituta Florensis ordinis». Con il suo privilegio, l’imperatore confermava tutti i beni appartenenti al monastero, ovvero la chiesa della Santissima Trinità di Maiori con tutte le sue pertinenze, una grangia, detta Aliola, nel territorio di Maiori, coltivata a vigne e olivi, alcune case e pertinenze a Salerno, nel cui territorio era si-tuata anche una seconda grangia dipendente da Santa Marina, sita in località Licilianus. I beni del cenobio giungevano fino al territorio di Nocera, dove, presso il casale di Angria (Angri), deteneva alcune terre, e a Castelnuovo (non identificato), dove, in località detta Alamalta, vi era la terza grangia del monastero.
265
Il privilegio imperiale concedeva a Santa Marina anche alcune libertà: in primo luogo la possibilità di tenere, senza oneri, la planca sive aphoteca, ovvero un magazzino o bottega, in cui gli uomini del cenobio potevano comprare e vendere, sita a Maiori. Dal pri-vilegio dell’anno seguente, sappiamo che la planca doveva essere una sorta di spaccio, in particolare per la vendita della carne. A Maiori il monastero avrebbe potuto costruire, sulle sue proprietà, gli edifici che avesse ritenuto necessari e, nel mare prospiciente il centro abitato, tenere barche sia per la pesca sia per il trasporto. Le libertà del monastero erano poi estese alla possibilità di costruire mulini e folloni, case, magazzini e altri edifici, di comprare e vendere senza esazioni, di spostarsi per terra e per mare senza il pagamento, nelle terre demaniali, di «teloneatico, plateatico, portulagio atque passagio», e, sempre nel demanio regio, di pascolo senza gli oneri di erbatico e ghiandatico. Come era avvenuto nel caso di Fiore e di Fonte Laurato, il privilegio concesso al monastero di Maiori non includeva la clausola «salvo manda-to et ordinatione nostra». Ugualmente, il cenobio di Santa Marina non era tenuto a sottostare alla ge-nerale revoca dei privilegi promulgata a Capua nel 1220, dal momento che, al pari degli altri monasteri florensi, ne era stato dichiarato esente.
Ciò nonostante, in via precauzionale, nell’ottobre del 1226 il superiore di Santa Marina si presentò a corte, perché gli fossero restituiti due privilegi prece-denti16. In particolare, Federico II colse l’occasione per riconfermare al cenobio di Maiori tutte le libertà e le immunità che il «sacer ordo Florensis tempore quondam Henrici patris nostri recolende memorie per regnum nostrum habere consuevit». La confer-ma si estese anche alla libertà di tenere l’apotecha cum planca a Maiori. La concessione imperiale aveva pro-babilmente creato difficoltà al monastero, forse da par-te della chiesa amalfitana o di persone laiche che, sulla base di antiche consuetudini, dichiaravano che non era lecito ad altri tenere a Maiori uno spaccio di quel gene-re per la vendita della carne o di altre merci17.
Nei sei anni compresi tra l’ottobre del 1226 e il settembre del 1232, il monastero di Santa Marina attraversò senza dubbio notevoli difficoltà, forse a causa dello scontro armato tra papato e impero, tan-to che la vita religiosa, a quanto pare, vi decadde probabilmente del tutto e l’unione con l’ordine flo-rense, avvenuta prima del 1225, sembra del tutto di-menticata. Anteriormente al settembre del 1232 in-fatti un certo frater Ugolino, probabilmente lo stes-so che nel 1225, secondo le parole dell’imperatore, doveva essere il superiore della comunità florense, si era presentato all’arcivescovo di Amalfi e si era fatto
assegnare la chiesa di Santa Marina18. Non è chiaro a quale titolo avvenne l’assegnazione; Gregorio IX, in due documenti successivi, dichiarò che il frater l’aveva fondata e l’aveva fatta costruire egli stesso, mentre l’arcivescovo di Amalfi, Giovanni, scrivendo all’abate di Rovigliano, specificò che «tu, Frater Hu-goline, tuo studio interveniente ampliasti, et bonis temporalibus dilatasti, et augebis in posterum volen-te Domino» la chiesa di Santa Marina19. Una volta avuta in concessione la chiesa, il frater Ugolino si era rivolto ai cistercensi di Santa Maria di Ferraria, perché ne facessero un monastero dell’ordine, in cui abitassero almeno quattro monaci. La richiesta fu presto accolta, e alcuni monaci bianchi si trasferiro-no pertanto a Maiori. In seguito, tuttavia, uno degli abati cistercensi incaricati dal capitolo generale della visita di tutti i monasteri del regno aveva decreta-to che la chiesa di Santa Marina non era adatta a diventare un monastero cistercense; ne aveva fatto pertanto rimuovere i monaci già insediati presso la fondazione20. Ugolino allora, visto il fallimento del-l’unione di Santa Marina con i cistercensi, si era ri-volto ai florensi di Rovigliano perché se ne prendes-sero cura. A quel punto, si era evidentemente rivolto nuovamente all’arcivescovo amalfitano chiedendo di affidare la chiesa a Matteo, abate florense di San-t’Angelo di Rovigliano. L’arcivescovo, confermando l’unione ai monaci di Fiore, concesse al monastero anche l’esenzione, esclusi i diritti relativi alla consa-crazione della chiesa e dell’altare, la benedizione del-l’abate eletto dai monaci e l’ordinazione dei religiosi, senza richiedere tuttavia il preventivo esame dei po-stulanti. L’abate avrebbe poi dovuto recarsi in catte-drale il giorno della festa di sant’Andrea e versare il censo di una libbra di incenso. Il presule si riservava infine una provvisione per dodici persone, escluso il consumo di carne, in occasione della consacrazio-ne delle chiese e degli altari del monastero21. Il 18 ottobre dello stesso anno, infine, Gregorio IX con-fermò il passaggio del monastero ai florensi22. Dal 1232, dunque, il monastero di Santa Marina accolse nuovamente i florensi, dopo l’interruzione avvenuta successivamente al 1226 per motivi che rimangono sconosciuti. Nei documenti relativi all’unione ai flo-rensi, tuttavia, non si fece assolutamente cenno al fatto che la fondazione di Maiori già in precedenza fosse appartenuta all’ordine.
Il mese successivo, Federico II indirizzò una let-tera a tutti i suoi funzionari, raccomandando loro il monastero di Santa Marina, ordinando di rispettare i privilegi da lui concessi e confermati dopo la curia di Capua e di non importunare la fondazione con richieste di pagamenti e con esazioni, a cui non era
266
obbligata. Confermò inoltre ancora una volta il pos-sesso della planca di Maiori, tenuta dal cenobio, già concessa nel 1225 e nell’anno successivo23.
L’unione di Santa Marina all’ordine florense, tut-tavia, non era stata gradita dai cistercensi di Ferraria. Sorse pertanto una disputa riguardo al possesso del monastero, in merito alla quale, il 22 marzo 1233, Gregorio IX emise la sua sentenza24. Il procuratore dei monaci cistercensi aveva illustrato al pontefice le vicende precedenti relative al cenobio di Maiori: la prima concessione a loro favore, avvenuta da parte di frate Ugolino, la decisione del visitatore del capi-tolo generale, che aveva giudicato inadatta la chiesa di Santa Marina per l’istituzione di un monastero dell’ordine e il conseguente rientro dei monaci ci-stercensi, provenienti dall’abbazia di Ferraria, che nel frattempo si erano già insediati a Maiori. Il delegato dei cistercensi motivò poi le loro rivendicazioni: la decisione presa dall’abate visitatore era stata ben pre-sto revocata dal capitolo generale; egli tuttavia non era in grado di dimostrare in qualche modo la tale revoca capitolare25. A quanto si capisce, i problemi erano sorti per il fatto che Santa Marina, propter incompetentiam loci, non era adatta ad organizzarsi come monastero; inoltre, dal momento che, fino a quel momento, era stata retta da un priore - proba-bilmente lo stesso Ugolino - l’ordine cistercense non poteva accettarlo come priorato, perché tale forma istituzionale non era prevista dagli statuti cistercen-si, ma avrebbe potuto essere accolta solamente come grangia. Gregorio IX, volendo evidentemente man-tenere in quel luogo la vita monastica regolare, decise di assegnare il monastero ai florensi, le cui istituzioni invece prevedevano la forma istituzionale del prio-rato, condotto da un numero limitato di monaci. Incaricò pertanto Pietro, cardinale diacono di San Giorgio ad Velum, di procedere all’unione, facendo tuttavia risarcire i cistercensi di Ferraria delle perdite economiche subite. Nell’aprile del 1233, infine, il pontefice si rivolse nuovamente agli arcivescovi di Amalfi e di Salerno, ordinando loro di rendere ese-cutiva l’unione e di farla osservare inviolabiliter26.
A Santa Marina riprese dunque la vita monasti-ca florense. Secondo quanto affermato dal pontefice nel 1233, Santa Marina era istituita come caput e Rovigliano era divenuto un membrum della stessa. Nel 1240, tuttavia, furono apportati nuovi cambia-menti: il capitolo generale dell’ordine decise che i monaci di Santa Marina avrebbero dovuto rientrare nella comunità di Rovigliano, da cui provenivano, dal momento che l’abate di Santa Marina non era più in grado di prendersi cura di entrambe le comu-nità a causa della lontananza delle due fondazioni
e dei pericoli che incombevano su chi si spostava, sia per terra sia per mare27. I florensi erano dunque autorizzati a far cadere la stretta unione tra le due fondazioni decretata negli anni 1232-1233, a far ri-tornare a Rovigliano i monaci che si erano insediati nella chiesa di Santa Marina e a ordinarvi un nuovo abate e alcuni monaci che seguissero le istituzioni florensi e che fossero soggetti al monastero di Ro-vigliano. In sintesi, da quanto si può capire, era ro-vesciato il rapporto di dipendenza (forse in quanto uno era abbazia, uno semplice priorato) tra Roviglia-no e Santa Marina.
Secondo le parole del documento del 1240, fu il capitolo generale dell’ordine ad approvare il nuo-vo status dei cenobi di Rovigliano e di Maiori e le disposizioni riguardo al ruolo dell’abate di quest’ul-timo. Si tratta di un’attestazione del fatto che nel-l’ordine florense si teneva il capitolo generale, dopo il documento del 1209 in cui Matteo, abate di Fiore, accennava alla futura messa in funzione di quest’or-gano istituzionale. In qualche modo, dunque, l’ordi-ne funzionava, nonostante il fatto che non ci siano giunti documenti o statuti capitolari, atti a chiarire le forme (sede, periodicità) e le funzioni del capitolo generale.
Le notizie sulla fondazione di Maiori si fanno in seguito molto sporadiche e frammentarie: Santa Ma-rina ricevette ancora qualche lascito testamentario nel 1268 e al 1281 risale un contratto di affitto per due pezze di vigna e di terra28. Nel 1284 il cenobio di Maiori viene definito come cella dipendente dal monastero di San Renato di Sorrento, a conferma che i rapporti con i monasteri florensi (o ex-floren-si: non siamo informati su quanto durò l’osservanza florense in Campania) della penisola sorrentina non si erano ancora interrotti29. Ancora due secoli più tardi vincoli di questo tipo, proprio con San Rena-to, non si erano del tutto sciolti: nel 1424, Martino V ordinò all’abate del monastero di San Renato di Sorrento di far immettere il quattordicenne Raffaele d’Anna nel monastero di Santa Marina de Vistellis (una delle forme con cui era chiamato il cenobio) della diocesi di Amalfi30.
2. I monasteri nel Regno di Sicilia: un monastero in Puglia
La tradizione erudita, a partire dall’opera di Gre-gorio de Laude (o de Lauro) in poi, fino all’edizio-ne del volume del Monasticon Italiae dedicato alla Puglia e alla Basilicata, tra le dipendenze florensi in Puglia ricorda tre monasteri, ovvero Santa Maria di
267
Laterza, in diocesi di Acerenza, San Tommaso di Rutigliano, in diocesi di Conversano, e San Vito di Polignano31. Il Russo, nel volume dedicato all’ordine florense, riporta una quarta fondazione, quella della chiesa di Sant’Angelo di Ascoli Satriano32.
In realtà, uno solo di essi, il cenobio di Santa Ma-ria di Laterza, fece parte dell’ordine florense come comunità monastica autonoma. Riguardo agli altri, appartennero all’ordine come grange, nel caso di San Tommaso di Rutigliano, o come chiese, nel caso di Sant’Angelo. Riguardo a quest’ultima, è bene preci-sare che non si trattava di una chiesa posta nei pressi di Ascoli Satriano, ma di una fondazione denomina-ta “ecclesia Sancti Angeli de Satrano sive secundum quosdam de Chitano”, sita nella diocesi di Mottola. Fu infatti il vescovo di Mottola Giovanni che nel dicembre del 1232 la affidò al monastero di Fiore e al monaco Giuseppe, procuratore dell’abbazia sila-na33. Furono dunque semplici fondazioni poste alla dipendenza di Fiore, come possessi del suo vasto pa-trimonio. Quanto al monastero di San Vito di Poli-gnano, ricordato per la prima volta dal De Laude tra i cenobi florensi, si tratta senza dubbio di un errore: tra le carte dell’abbazia di Fiore, la fondazione di Po-lignano compare solamente nella sottoscrizione che il suo abate, Andrea, appose al documento di ces-sione del monastero di San Tommaso di Rutigliano, da parte di Marino, arcivescovo di Bari, il 9 ottobre 123234. Tuttavia, nel documento non si dice in alcun modo che l’abbazia di San Vito fosse florense.
Nell’archivio di Fiore, in una data imprecisata,
ma naturalmente successiva all’unione ai florensi av-venuta nel 1226, confluirono due carte del mona-stero di Laterza risalenti al periodo precedente. Vi era innanzitutto un privilegio, rilasciato da Ruggero II, re di Sicilia, nel 1133, con cui si confermavano, genericamente, le donazioni, le concessioni e le li-bertà date al monastero, nella persona del suo aba-te Giovanni, da Alessandro, conte di Matera, e suo figlio Roberto di Gravina35. La moglie di Alessan-dro, Matilde, compare quale fondatrice della chiesa di Santa Maria di Laterza, e probabilmente anche del monastero annesso, nell’epigrafe esistente nella chiesa stessa, murata in controfacciata36. Il secondo documento è la sentenza, emessa nel 1192 dall’arci-vescovo di Bari, a favore di Raffaele, abate di Santa Maria, contro un certo Simone, occupatore e de-tentore di alcune possessioni di olivi appartenenti al monastero37.
Le ulteriori notizie sulla fondazione sono del tut-to sporadiche; tra di esse si è conservata tuttavia la carta che attesta la cessione del monastero di Later-
za all’ordine florense, compiuta dall’arcivescovo di Acerenza Andrea e dal capitolo della diocesi38. Fino a quel momento, il monastero probabilmente era stato sottomesso all’arcivescovo, dal momento che la fondazione fu definita monasterium diocesanum. Nel periodo a cavallo tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo, il monastero doveva aver attraversato un pe-riodo di difficoltà e di decadenza; proprio per soste-nere la ripresa del cenobio e la sua riforma interna, Andrea, regni Sicilie prothonotarius et logotheta, per-sonaggio che godeva la fiducia di Federico II, aveva deciso di introdurvi la riforma florense39. L’iniziativa dell’alto funzionario del regno era stata accettata di buon grado anche dall’abate di Santa Maria, Arno-ne, che si era dimostrato disposto a passare, con tut-ta la sua comunità, all’osservanza florense.
L’arcivescovo di Acerenza pertanto, accogliendo l’iniziativa del prothonotarius, dispose il passaggio del monastero alle dipendenze di Fiore, stabilendo che la sede vescovile non avrebbe avuto più alcun diritto di giurisdizione su di esso, salve la benedizione del-l’abate - che avrebbe comunque promesso, nei limiti previsti dalle istituzioni dell’ordine, l’obbedienza e la riverenza al presule -, l’ordinazione dei chierici e la consegna del crisma, dell’olio santo e dell’olio per l’unzione dei malati40. Il passaggio del monastero di Santa Maria di Laterza all’ordine florense fu poi con-fermato da Gregorio IX il 22 luglio 122841.
Riguardo al periodo svevo non rimangono ulte-riori notizie; alla fine del XIII secolo, nel 1283, un certo magister Nicolaus, figlio di Guglielmo de Roda di Castellaneta, fece un lungo testamento, in cui, lasciando una trentina di legati pro anima a luoghi religiosi, monasteri e chierici, ricorda anche l’Eccle-sia Sancte Mariae de Latercia e il monasterio monia-lium sancte Marie de Latercia. L’interesse di questo documento sta nell’attestazione, oltre del legato alla chiesa di Santa Maria, cioè, probabilmente, al mo-nastero maschile, anche di un lascito a una comunità femminile. Non sappiamo tuttavia in che termini, eventualmente, si ponesse il rapporto con la comu-nità maschile florense42.
3. I monasteri nel Patrimonium beati Petri
L’insediamento dell’ordine florense al di fuori della Calabria procedette attraverso modalità che in buona parte sfuggono ad analisi sistematiche, a causa della mancanza di una documentazione pre-cisa che attesti i tempi e i processi della diffusione dei monaci di Gioacchino anche nell’Italia centrale.
268
Il fatto che per quasi tutte le fondazioni al di fuori della Calabria si possa rintracciare l’intervento della curia pontificia, soprattutto da parte del cardinale Ugolino, potrebbe far pensare che tale diffusione sia stata sostanzialmente promossa dal papato, più an-cora che dai vertici stessi dell’ordine.
Delle tredici fondazioni florensi in cui la vita mo-nastica ebbe una certa durata, le due abbazie sorte nella Marittima, corrispondente all’odierno Lazio meridionale, sono quelle le cui vicende ci sono me-glio note. Al primo dei due, il monastero di San-t’Angelo del Monte Mirteto, sorto presso Ninfa, in diocesi di Velletri, ha dedicato un lungo articolo, basato sulla documentazione pontificia, don Mario Cassoni43. Quanto all’abbazia di Santa Maria della Gloria di Anagni, una monografia di Filippo Caraf-fa ne ripercorre le vicende, dalla fondazione fino al momento in cui, verso la metà del XV secolo, esau-ritasi la comunità monastica, i suoi beni furono uniti al Capitolo di San Giovanni in Laterano44. A questi studi si aggiunge l’articolo di Maria Zappalà, dedi-cato agli aspetti economici dell’espansione del patri-monio monastico di entrambi i cenobi laziali45. Infi-ne, le due fondazioni sono schedate nel Monasticon Italiae, che ne presenta le fonti edite e inedite e una bibliografia pressoché completa46. A fronte dunque di un quadro già sostanzialmente tracciato, limitia-mo a presentare alcune brevi considerazioni relative alla fase di fondazione dei due monasteri.
3.a. Sant’Angelo del Monte Mirteto, presso NinfaI primi documenti che attestano la presenza di
monaci florensi nell’Italia centrale sono, da una par-te, quelli relativi al monastero di Sant’Angelo del Monte Mirteto, presso Ninfa, in diocesi di Velletri, risalenti al 1216, dall’altra una carta del 1217 rela-tiva al trasferimento di alcuni monaci florensi cer-tamente già insediati in diocesi di Lucca. Seguiamo dunque l’ordine cronologico e diamo la precedenza ai monasteri della Marittima, anche se la presenza dei florensi in Toscana, attestata nel 1217, si può anti-cipare con ogni probabilità, come vedremo, all’anno precedente - se non prima -, contemporaneamente dunque all’insediamento nel Lazio meridionale.
Il monastero del Mirteto, posto a mezza costa del monte, o meglio, della collina, tra Ninfa e Norma, fu istituito per iniziativa del cardinale Ugolino, vescovo di Ostia e Velletri, nel territorio di quest’ultima sua diocesi. Il documento relativo, rilasciato alla nuova comunità monastica dal futuro papa Gregorio IX e dal capitolo della cattedrale di Velletri, e inserto nel-la conferma pontificia da parte di Onorio III, è data-to all’ottobre del 1216, anteriormente al 12 di quel
mese, data in cui cade appunto la conferma47.Il cardinale, scrivendo sia alla comunità di Fon-
te Laurato, casa madre del nuovo monastero, sia al gruppo di monaci florensi che si sarebbero insediati a Sant’Angelo del Monte Mirteto48, concesse loro tre chiese: la chiesa di Santa Maria Gloriosa, da lui stesso fondata e fatta erigere, nel territorio a lui sog-getto, con i beni ad essa pertinenti, tra cui officinis et domibus; la chiesa di Sant’Angelo, posta in prossi-mità di quella, più antica, sorta sul Monte Mirteto, e la cappella dedicata a San Clemente, sita extra mu-ros Nimphe, anch’essa con tutte le sue pertinenze. In quest’ultima si sarebbero dovuti celebrare i misteri divini, e il sacerdote incaricato sarebbe stato tenuto a rispondere al vescovo de spiritualibus, ai monaci florensi de temporalibus. La nuova fondazione mo-nastica avrebbe goduto di una forma di esenzione dall’ordinario simile a quella dei cistercensi e di altri monasteri florensi, ma non così estesa come quella concessa a Fiore e, in seguito, a Santa Maria della Gloria di Anagni, che erano soggette direttamente al papa.
L’insediamento dei monaci florensi nei pressi di Ninfa è probabilmente in relazione con una precisa circostanza: nel 1206, i monaci cistercensi dell’ab-bazia di Marmosolio, presso Ninfa, ottennero dal capitolo generale il permesso di trasferirsi in un’altra sede, in diocesi di Sermoneta, in quello che oggi è il monastero di Valvisciolo49. Il primitivo monastero di Marmosolio, un antico cenobio benedettino posto appunto nel territorio di Ninfa, era stato donato nel 1153-1154 ai cistercensi provenienti da Fossanova da Ugo, cardinale vescovo di Ostia e Velletri, compa-gno di Bernardo di Clairvaux e a sua volta monaco e abate cistercense50. La donazione del cardinale sem-brerebbe essere stata molto estesa, dal momento che comprendeva il monastero decaduto con tutti i suoi beni, due cappelle derelicte e il monastero di San-t’Eleuterio, reductum in solitudinem. Ugo riteneva invece come possessi della diocesi tre chiese e alcuni mulini di Ninfa, già compresi tra i beni di Marmo-solio, dal momento che «omnia secundum ordinis nostri institutionem retinere non deberetis»51. Alla fine del XII secolo, in ogni caso, il cenobio eviden-temente versava in condizioni troppo difficili perché la vita monastica vi potesse continuare. I monaci dunque costruirono la loro nuova sede nei pressi di Sermoneta, ai piedi del monte Corvino, dove evi-dentemente avevano terre di loro competenza.
Il trasferimento dei cistercensi di Marmosolio nella diocesi limitrofa lasciò il territorio della citta-dina di Ninfa privo di comunità monastiche. Forse proprio per sostituire i monaci di Cîteaux il cardi-
269
nale Ugolino volle chiamarvi i florensi, appartenenti alla nuova religio, che, nonostante la condanna con-ciliare, risalente all’anno prima, del fondatore, egli definiva una «commendanda plantatio», che «in ip-sis cepisset primordiis honestatis flores producere ac odores, et uberrimam fructuum copiam promittere videretur»52.
3.b. Santa Maria della Gloria, presso Anagni.Adenolfo di Mattia, fratello del cardinale Ugolino,
aveva voluto fondare sui possessi della sua famiglia una chiesa, detta de Arantiano dal nome del fondo in cui sorse, chiesa che affidò ai frati minori53. Dopo la sua morte, il futuro Gregorio IX, volendo istituire un monastero nei pressi della chiesa, nel 1226 decise di far trasferire la comunità minoritica, e offrì sia l’ecclesia Arantiani, sia una seconda chiesa, che egli stesso aveva fondato dedicandola a santa Maria Glo-riosa, ai florensi del Mirteto, perché vi conducessero vita monastica54. La nuova comunità, tra il 1226 e il 1228, si insediò dunque nella nuova abbazia di Santa Maria della Gloria, detta anche de Monte Au-reo. L’11 marzo del 1228 fu emesso l’atto ufficiale di fondazione, una bolla solenne di protezione e di esenzione, diretta all’abate Giovanni, primo abate del monastero55. Il privilegio specifica subito che il cenobio era soggetto unicamente al romano ponte-fice; l’abate eletto avrebbe ricevuto la benedizione dal papa, ed era libero di rivolgersi a un qualunque vescovo di sua preferenza per ricevere la benedizione di altari, chiese, e gli altri sacramenti. Il privilegio segue le linee fondamentali degli analoghi privilegi rilasciati ai monasteri cistercensi, con l’ulteriore ec-cezione - accanto all’esenzione completa dall’ordina-rio locale - della libertà di sepoltura per chi ne avesse fatto richiesta, ad esclusione di persone scomunicate o interdette e degli usurai pubblicamente riconosciu-ti come tali. Gregorio IX specificava poi la posizione dell’abbazia anagnina all’interno dell’ordine: Santa Maria della Gloria sarebbe stata l’abbazia madre di quella del Mirteto, e diretta figlia del monastero di Fonte Laurato. Le posizioni tra l’abbazia del Mirte-to e quella della Gloria erano dunque invertite, dal momento che quest’ultima, fondata nel momento in cui Ugolino salì al soglio pontificio, al pari del suo fondatore doveva salire ad un grado superiore nella gerarchia dell’ordine. Infine il pontefice, per impe-dire che la sua abbazia venisse sopraffatta dall’avi-dità e dalla ricerca di beni sempre più ampi, stabilì il numero massimo dei componenti della comuni-tà: il cenobio avrebbe potuto ospitare fino a dodici monaci, l’abate, sei novizi e ventiquattro conversi. Il privilegio di Gregorio IX ci informa anche del fatto
che il monastero aveva una cappella pontificale, do-tata di libri e suppellettili forniti a sue spese che non dovevano in nessun caso essere alienati.
I beni del monastero, fin dalla fondazione, erano numerosi: la torre di Aranzano e tutto il tenimen-to, compresa evidentemente la chiesa, dedicata a san Martino, fatta costruire dal fratello Adenolfo per i frati minori; la valle di Villa Urbana, «cum colle, ter-ris, pascuis, canapinis et omnibus adiacentiis et ac-quisitionibus suis»; un altro tenimento, detto de vico Morricino, un mulino, di proprietà del monastero florense di Ninfa, e mezzo casale con le sue terre, ac-quistati dal papa per donarli alla nuova fondazione. Nel giugno del 1232 i mulini in possesso della Glo-ria erano ormai sette. Si erano aggiunti infatti quel-lo presso il monastero di Santa Cecilia, in diocesi di Terracina, ormai decaduto, altri tre nel territorio di Ninfa, uno presso il castello di Acquapuzza e un ultimo detto «de Curia, deputatum vestibus mona-chorum»56. Ci mancano tuttavia notizie relative alle modalità con cui il monastero gestiva le attività di questi numerosi mulini, che indubbiamente, accan-to a quelle agricole, dovevano costituire una notevo-le fonte di reddito per il cenobio.
Presso la chiesa di San Martino, Gregorio IX, una volta fatti trasferire i minori chiamati da suo fratello Adenolfo, volle costituire una piccola comunità mo-nastica florense, di quattro monaci soltanto, com-pletamente dedita agli uffici divini e alla preghiera in suffragio della sua famiglia, e in particolare pro-prio del fratello. Un converso, a cui era demandato il compito di coltivare l’orto annesso alla chiesa, avreb-be dovuto affiancare i quattro monaci57.
4. Tuscia: dall’eremo di Moriglione a San Pietro di Camaiore
Il 17 luglio del 1217 il cardinale Ugolino, legato pontificio nella Tuscia, di passaggio per Lucca duran-te la sua missione, assegnò il monastero femminile di San Iacopo di Valle Benedetta al priore e ai monaci di Moriglione, dell’ordine florense58. Il monastero di San Iacopo sorgeva nelle vicinanze di Montecalvoli, una piccola località ora in provincia di Pisa. In un centro confinante, Santa Maria a Monte, sorgeva una chiesa molto antica, dedicata a San Frediano, detta a Tolle o Tulli, che almeno dal 1100 al 1181 era stato sede di un monastero femminile. Successivamente a questa data, le monache si erano forse trasferite in una nuova sede a Montecalvoli, nelle immediate vicinanze, presso una chiesa dedicata a San Iacopo. Nel 1217 tuttavia, a detta del cardinale Ugolino, la
270
comunità monastica femminile di San Iacopo ver-sava in condizioni precarie: «dictum monasterium in spiritualibus et temporalibus erat ita collapsum, ut nulla spes quod amplius resurregeret haberetur». Ugolino individuava l’origine e la causa di tale situa-zione proprio nel fatto che esso era condotto da mo-nache, non all’altezza di governare autonomamente la propria domus59. Il giudizio di Ugolino sulla vita indisciplinata delle monache di San Iacopo si collo-ca coerentemente nel grande interesse del cardinale per la vita religiosa femminile e nel suo desiderio di riformarla e di regolarla, secondo un progetto che, proprio a partire dall’anno successivo, vedrà il car-dinale di Ostia impegnato a riorganizzare, in stretto collegamento con Onorio III, le comunità religiose femminili, conferendo loro una fisionomia giuridica ben definita e ponendole alle dirette dipendenze del-la Chiesa di Roma60.
Ugolino, di fronte a questa situazione, fece dun-que trasferire le monache di San Iacopo («remotis inde illis quas ibidem invenimus et cum rebus earum ad alia loca transmis<s>is»); nel documento non vie-ne peraltro specificata la sede a cui le donne furono destinate. A trasferimento avvenuto, il monastero di San Iacopo, con una cappella dedicata a san Fre-diano detta de Tulli61 (l’antico monastero di Santa Maria a Monte) e con tutte le pertinenze dipenden-ti dalle due sedi, fu messo a disposizione del priore e dei monaci florensi, che vivevano nel priorato di Moriglione, che sorgeva nelle vicinanze di Vorno, in una località oggi al confine tra le province di Lucca e di Pisa. Ugolino compì il suo atto grazie all’autorità conferitagli dalla sua legazione; la concessione fu co-munque approvata anche dal vescovo e dal capitolo di Lucca.
Come abbiamo visto, il cardinale riponeva grandi speranze nei florensi, secondo quanto attesta tutta la sua opera di sostegno nei confronti dell’ordine: per Ugolino, infatti, i monaci florensi erano coloro «quos novimus magna religione pollere», e per que-sto motivo furono sostenuti dall’autorità pontificia anche per mezzo della concessione del monastero lucchese.
Il documento del cardinale di Ostia testimonia in primo luogo la presenza, in un momento anteriore al luglio del 1217, di monaci florensi nella diocesi di Lucca, presso il priorato di Moriglione, che in segui-to fu definito eremum. Rimane ignoto il momento in cui il monachesimo florense aveva messo piede in Toscana; tale momento si può probabilmente antici-pare almeno all’anno precedente, dal momento che il 2 dicembre 1216 Onorio III si era visto costretto a scrivere al vescovo di Lucca per difendere dalle accuse
di eresia Gioacchino e i monaci da lui istituiti, accu-se dovute senza dubbio al giudizio emesso sull’abate calabrese da parte del concilio lateranense IV62.
Un ulteriore indizio permette forse di anticipare ulteriormente l’arrivo in Toscana, seppure a livello di ipotesi. Vediamo con ordine: nel 1221 il mona-stero di San Iacopo era governato da un priore di nome Ugo (il documento del cardinale di Ostia non riportava invece alcun nome)63. Ora, nel 1211, la sentenza di Innocenzo III, con cui fu definitiva-mente assegnato ai florensi il monastero di Calabro Maria, accennava ad un certo «Ugone, priore Sancti Georgi»; egli era definito, insieme a Giuseppe, mo-naco dell’ordine florense64. La coincidenza del nome può certo non essere significativa; nello stesso tem-po, non abbiamo ulteriori testimonianze relative ad un priorato dedicato a san Giorgio appartenente ai florensi e sito in Calabria65. È forse allora lecito chie-dersi se l’Ugo, priore di San Giorgio nel 1211, possa identificarsi con l’Ugo che nel 1221 si è trasferito ormai da Moriglione nel monastero di San Iacopo, e se pertanto già nel 1211 i florensi fossero presenti in Toscana, presso uno sconosciuto priorato di San Giorgio, collegato in qualche forma al priorato di Moriglione.
La scelta dell’insediamento in Toscana, nella dio-cesi di Lucca, non dovette essere casuale. Uno dei racconti dei Miracula di Gioacchino attesta infatti che Matteo, il successore di Gioacchino nell’abba-ziato a Fiore, e altri due monaci, che compirono il loro noviziato nel monastero silano probabilmen-te nel 1198, provenivano dalla Tuscia. L’anonimo narratore definiva i tre come «de Tuscia senioribus litteratis»; il fatto che Matteo avesse una notevole preparazione culturale pare attestato anche dalla sua ottima formazione scrittoria66. I tre monaci florensi potrebbero aver mantenuto rapporti con il loro am-biente di origine (un ambiente non monastico, dal momento che a Fiore fecero il noviziato) e aver scelto la Toscana per far sorgere un priorato florense pro-prio in base ai loro rapporti con la terra di origine.
Nel 1218 il priorato de Tullis, identificabile con il monastero di San Iacopo, a cui era annessa la cap-pella di San Frediano detta appunto de Tullis, era nominato in quello che possiamo definire lo status dell’ordine a quella data, cioè il documento con cui Onorio III esentò dalla vigesima i monasteri del-l’ordine florense, grazie ai buoni uffici del cardinale Ugolino67.
Il nome del primo priore a noi noto, Ugo, com-pare, come si è visto, in un documento del 1221. Egli, con il consenso dei confratelli Gregorio, forse colui che gli succederà nella carica, e D<eod>ato e
271
dei conversi Tedicio e Guglielmo, vendette ad un certo Ranuccio di Borgo San Frediano due vigne ed un bosco, che i due conversi, fratelli, avevano dona-to al monastero nel momento della loro conversio68. Il denaro ottenuto dalla vendita dei terreni fu usato poi per onorare un debito contratto dai due con-versi prima dell’ingresso in monastero con un certo Boctricuscio quondam Boctrichelli.
Il priorato toscano non percorse l’itinerario isti-tuzionale compiuto dalle fondazioni florensi in Ca-labria, le quali, dopo un periodo di due o tre anni, passarono dall’organizzazione in priorato a quella in abbazia autonoma; dal 1217 (o forse già dal 1211) in poi fu sempre retto da un priore. Inizialmente, non è chiaro neppure da quale abbazia esso dipen-desse, dal momento che si ignora la provenienza dei monaci di Moriglione, poi trasferiti a San Iacopo. La posizione all’interno dell’ordine fu chiarita nel 1226, nel momento in cui, alla presenza ancora di Ugolino, vescovo di Ostia e Velletri, il priorato di San Iacopo fu posto sotto la giurisdizione dell’abate di Fiore Matteo. Nello stesso tempo, tuttavia, Mat-teo affidò la visita del monastero, a cui erano legati la cappella di San Frediano e gli eremi di Moriglio-ne, di Buggiano e di Montecatini, all’abate di Fonte Laurato, poiché il monastero toscano «non potest de facili visitari a monasterio Floris» a causa della lon-tananza. La visita era invece più agevole per l’abate di Fonte Laurato, dal momento che quest’ultimo era comunque tenuto a risalire la penisola per effettuare la visita canonica in una figlia dipendente, l’abbazia di Sant’Angelo del Monte Mirteto69. La presenza di Ugolino e la data di questo documento (1226) fa-rebbero pensare ai contatti che il cardinale dovette certamente tenere con i monaci florensi al momen-to della fondazione, disposta proprio in quell’anno, della “sua” abbazia florense, cioè Santa Maria della Gloria di Anagni. Il documento di accordo fu sot-toscritto da dodici monaci di Fiore, tra cui l’abate Matteo, il priore Ruggero e il sottopriore Silvestro; come monaci di San Iacopo sono nominati il priore Gregorio, succeduto evidentemente a Ugo, e i due frati Deodato, probabilmente lo stesso che viene no-minato nel documento del 1221, e Benedetto. Po-trebbe infine essere significativo il fatto che al prio-rato di San Iacopo fossero legati tre eremi, quello di Moriglione, ossia il precedente stanziamento floren-se, uno posto a Buggiano e un terzo a Montecatini. Il priorato di San Iacopo, che mantenne per tutta la sua esistenza documentata tale struttura organizzati-va e che riunì attorno a sé tre romitori, sembrerebbe un tentativo di rimanere in qualche modo più fedele agli ideali più ascetici di Gioacchino, che in Calabria
sembrano invece ben presto accantonati a favore di un adeguamento agli usi cistercensi. Ed è significati-vo che questo possa essere avvenuto in Toscana, una regione in cui l’ideale monastico-eremitico vantava una ben radicata tradizione.
In effetti, l’ultima notizia, in ordine di tempo, relativa al priorato di San Iacopo è contenuta nel documento di Gregorio IX del 13 ottobre 1239, nel quale, tra l’altro, è inserita la concessione del 1217, con cui il monastero di San Iacopo fu affidato ai flo-rensi70. Si tratta di una bolla solenne, con cui il papa prese sotto la protezione pontificia il monastero di San Pietro di Camaiore, a cui, in una data non spe-cificata che si può tuttavia situare tra il 1235 e il 1238, era stato unito il priorato di San Iacopo. Tra i beni che il papa accolse sotto la sua protezione vi era anche la «ecclesiam sancti Iacobi de Valle Benedicta ad nos nullo medio pertinentem, quam quondam cum esset monasterium Tullium nuncupata ipsi ve-stro monasterio duximus uniendam». L’unione era stata effettuata con la condizione che a San Iacopo risiedessero sempre un priore con tre o quattro mo-naci per la celebrazione dell’ufficio divino. Potrebbe trattarsi di un’indicazione importante, dal momento che sembra richiamare la divisione di compiti all’in-terno di un monastero auspicata da Gioacchino: il priorato di San Iacopo, unito all’abbazia di Camaio-re, avrebbe dovuto forse accogliere i monaci più con-templativi, a cui era demandato l’incarico specifico della salmodia. Gregorio IX sembrerebbe dunque aver ancora presente, a molti anni dalla morte del-l’abate calabrese, il suo progetto originario, almeno per quanto riguarda la vita più propriamente con-templativa, dal momento che una prassi di questo tipo si ritrova anche nei due monasteri laziali da lui fondati.
Non sappiamo in realtà se le direttive di Gregorio IX riguardanti tale divisione di compiti furono mai eseguite; in effetti, a partire dal 1239, la documen-tazione florense non dà più notizie riguardo a San Iacopo e a Moriglione. In relazione a questo fatto, non pare casuale che, proprio nel momento in cui i florensi si stabilizzarono nel più ricco e dotato mona-stero di San Pietro di Camaiore, un eremo, chiama-to proprio Moriglione, in diocesi di Lucca, compaia nelle liste dei loci eremitici appartenuti alla cosiddet-ta “Congregazione delle Tredici”. Nel 1247 il priore di Moriglione, Matteo, fu posto a capo, come priore generale, dell’intera Congregazione degli Eremiti di Toscana (nata nel 1243), in cui il più piccolo gruppo “delle Tredici” era confluito71. Nella fondazione luc-chese (se effettivamente identificabile con quella in precedenza florense) si volle dunque perseverare in
272
una vita evidentemente più distaccata dal mondo di quanto poteva accadere in un monastero posto nei pressi di un centro abitato come Camaiore.
In seguito, anche il priorato di San Iacopo scom-pare dalla documentazione superstite relativa alla Toscana; la vita monastica florense proseguì appunto nel monastero di San Pietro di Camaiore72. Si trat-ta di un antica fondazione di origine probabilmente longobarda, istituita o almeno beneficiata da un cer-to Pertualdo, padre di Peredeo, il quale fu vescovo di Lucca nel 761. Il primo documento che ne attesta l’esistenza risale al 760, anno in cui Maura, sorella di Pertualdo, aveva donato una casa di sua proprietà ad Alamund, abate del monastero di San Pietro di Camaiore. Esso sorgeva al centro della valle deno-minata anticamente Campo Maiore, ora Camaiore, a circa trecento metri dalla strada che fin dal II secolo avanti Cristo congiungeva la città di Luni con Luc-ca. Nonostante la sua lunga vita, la documentazione è alquanto sporadica; nel 1180 Alessandro III aveva accolto il monastero sotto la protezione della sede apostolica e ne aveva confermato i numerosissimi beni, che comprendevano chiese, cappelle, ospedali. Nel 1217 esso era retto dall’abate Ildebrando.
Contrariamente da quanto affermato in passa-to, San Pietro di Camaiore non passò ai florensi nel 1217. In tale anno infatti, come abbiamo visto, fu assegnato ai monaci di Gioacchino il monastero di San Iacopo; il passaggio del cenobio di Camaiore av-venne probabilmente solo nel 1235. Il 12 novembre di quell’anno, infatti, Gregorio IX scrisse all’abate e ai monaci di Sancte Marie Florentine73: in questa denominazione è da vedere probabilmente il mona-stero florense di Santa Maria di Acquaviva, a cui San Pietro di Camaiore in seguito fu sempre legato. Con la sua lettera, il pontefice ordinava all’abate di San-ta Maria Florentine di accogliere nell’ordine florense l’abate e il convento di Camaiore, nella diocesi di Lucca, poiché essi avevano chiesto di essere accet-tati nell’ordine come figli («ab ipsis in filios recipi petentes»). L’iniziativa dell’unione ai florensi sem-bra dunque essere partita dai monaci di Camaiore, venuti evidentemente in contatto con i florensi di San Iacopo. Gregorio IX stabilì che la riforma fosse compiuta dai monaci di Acquaviva, che non aveva-no ancora altri monasteri alle loro dipendenze. La riforma andò presto in porto: già poco più di un anno dopo a Camaiore erano presenti i monaci flo-rensi, tra cui un certo Ubaldo; a lui, all’abate di Fiore e a quello di Acquaviva Gregorio IX ordinò di rifor-mare il monastero benedettino di San Cassiano, in diocesi di Lucca, in cui erano rimasti solamente due monaci e i cui beni erano ormai in situazione molto
precaria74. È l’unica notizia che possediamo riguardo a questa fondazione, che scompare immediatamen-te dopo questa fugace segnalazione. La comunità di Camaiore probabilmente non era ancora del tutto organizzata, dal momento che non si nominava il suo abate.
Qualche mese più tardi il papa confermò al mo-nastero di San Pietro, in cui erano ormai seguite la regola di Benedetto e «institutionem Florensium fratrum», tutti i beni di competenza, concedendo la protezione apostolica e l’esenzione dall’ordinario, già concesse del resto dai suoi predecessori Adriano, Clemente e Onorio (e Alessandro, che tuttavia non viene citato)75. I beni del monastero corrispondo-no in gran parte a quelli già nominati nella bolla di Alessandro; in particolare comprendevano la chiesa di San Michele e l’annesso ospedale a Camaiore, la chiesa di San Biagio a Lumbrico, la chiesa di San Iacopo a Pedona, la chiesa di San Salvatore presso Sala, la chiesa di Santa Maria presso la porta Bel-trandi, l’ospedale di San Sisto a Ripa; ciascuna chiesa era dotata naturalmente di numerose pertinenze. A questi beni, «que idem monasterium antequam Flo-rensium fratrum instituta susciperet possidebat», si erano aggiunte alcune donazioni fatte da privati, in almeno un caso di notevole entità, dal momento che comprendevano prati, vigne, terre, boschi, passaggi, pascoli, acque, mulini, libertà e immunità.
La bolla solenne di papa Gregorio ripercorreva poi tutto il formulario riguardante le istituzioni mo-nastiche esenti, secondo gli specifici punti previsti anche per i cistercensi: le terre novali, l’accoglienza di chierici e laici, il divieto di passare ad altra reli-gione senza i dovuti permessi, di alienare le terre del monastero, di ricevere prestiti se non in casi ecce-zionali; il diritto di non essere tenuti a partecipare a processi, ai sinodi o a conventus forenses, l’esenzione dal vescovo nei vari ambiti di competenza: elezione dell’abate, consacrazione di altari, chiese, sacramen-ti; infine era compresa la non validità di un eventua-le interdetto all’interno del monastero.
L’anno seguente, papa Gregorio fu costretto ad intervenire presso il priore di San Frediano di Luc-ca, la celebre canonica, perché facesse in modo che l’abate e i monaci di San Pietro non venissero più molestati, in particolare a riguardo della chiesa di San Iacopo di Valle Benedetta76. Connesso forse con questa vicenda e anche per chiarire al meglio la posizione della fondazione come possesso florense, nell’ottobre del 1239 ancora Gregorio IX riconfer-mò la protezione apostolica concessa a San Pietro di Camaiore e ai suoi beni, in particolare il monastero di San Iacopo, relativamente al quale riportò il do-
273
cumento del 1217 con cui esso era stato assegnato ai monaci florensi di Moriglione77.
Qualche ulteriore breve notizia sul monastero to-scano ci è trasmessa ancora da sporadici documenti pontifici: nel 1244 Innocenzo IV, in quel momento a Genova, invitò l’arcivescovo di Pisa e i vescovi di Lucca e di Luni a difendere l’abate e i monaci del monastero florense di Camaiore, che erano stati mo-lestati78. Il documento ci è giunto solo in regesto, per cui non siamo in grado di sapere da chi provenissero le molestie che il monastero subiva, e se esse fossero da collegarsi o meno alle difficoltà già testimoniate nel 1238 per il monastero di San Iacopo, o piuttosto alle notizie fornite da Salimbene de Adam, relative ai timori dell’abate di Camaiore, che paventava un possibile intervento di Federico contro il proprio monastero. Il cronista di Parma infatti così ricordava il suo primo approccio con le opere di Gioacchino da Fiore: «Prius eram edoctus et hanc doctrinam audie-ram, cum abitarem Pisis, a quodam abbate de ordine Floris, qui erat vetulus et sanctus homo, et omnes libros suos a Ioachim editos in conventu Pisano sub custodia collocaverat, timens ne imperator Frederi-cus monasterium suum destrueret, quod erat inter Lucam et civitatem Pisanam, per viam quae vadit ad civitatem Lunensem»79. Salimbene risiedette nel con-vento dei Minori a Pisa tra il 1243 e il 1247, dunque la fuga dell’abate di Camaiore, forse Benedetto80, avvenne in quegli anni. R. Lerner ha proposto che l’episodio possa essere avvenuto nel marzo del 1247, quando l’imperatore passò per la Toscana, in marcia verso le Alpi «presumibilmente con l’intenzione di “fare visita” al papa», che si era rifugiato a Lione81. Tuttavia, le molestie denunciate dal papa nel 1244 potrebbero far anticipare la datazione dell’episodio e la conseguente scoperta, da parte dei francescani di Pisa, delle opere dell’abate calabrese, che suscitarono un grandissimo entusiasmo sia in Salimbene stesso, sia nel lector pisano Rodulfus de Saxonia.
Innocenzo IV intervenne nuovamente in favore del monastero di Camaiore quando, nel febbraio del 1254, assolse l’abate e il convento del cenobio tosca-no dalla scomunica lanciata contro di loro, per motivi non chiari, dal nunzio apostolico82. L’anno seguente Alessandro IV, succeduto a Innocenzo, esentò l’abate e il suo monastero dall’onere di ricevere e provvedere ad alcuno con benefici ecclesiastici o pensioni83. Un ultimo intervento da parte della Santa Sede si regi-stra ancora nel novembre del 1255, quando l’abbazia di San Pietro e il suo abate furono dichiarati esenti dalla giurisdizione dell’ordinario della diocesi84.
Non se ne hanno più notizie per la seconda metà del XIII; il 5 maggio 1329 il monastero fu colpito da
un rovinoso incendio, probabile causa della perdita di buona parte del materiale documentario. Si aprì in seguito un periodo di crisi, motivato forse anche dalle epidemie, per cui la comunità florense non riu-scì più a gestire l’abbazia: nel 1385 fu richiesta l’ag-gregazione alla badia di Camaldoli, che tuttavia non andò in porto; nel 1388 fu allora posto sotto la guida del priore secolare di Santa Maria di Camaiore; nel 1405 passò agli Agostiniani e nel 1418 ai Girolamini del beato Pietro di Pisa85. Infine, nel 1526, Clemen-te VII soppresse il monastero e la dignità abbaziale, e tutti i suoi beni passarono all’Ospedale di San Luca di Lucca86.
***
Rispetto all’ampio quadro delle sessanta fonda-zioni florensi passate in rassegna da Francesco Russo, trentotto nella Calabria, le restanti ventidue nell’Ita-lia centro-meridionale, lo status documentato del-l’ordine risulta in definitiva notevolmente ridimen-sionato. Nel territorio calabrese accolsero comunità monastiche florensi, accanto al protocenobio di Fio-re, solo altre quattro fondazioni, che catalizzarono attorno a sé antichi cenobi greci decaduti, senza tut-tavia rinnovarvi l’osservanza monastica. Il passaggio ai florensi del monastero greco di Sant’Angelo Mi-litino, i cui monaci, sotto il pontificato di Gregorio IX, sembra che abbiano accolto le istituzioni dell’or-dine, se realmente ci fu, fu estremamente fugace e già qualche anno più tardi solamente la chiesa risulta appartenente al monastero di Fonte Laurato, come suo semplice possesso.
Nel regno di Sicilia la riforma florense comun-que, appoggiata e protetta da Federico II e dalla no-biltà regnicola, riscosse un discreto successo, tanto che in più occasioni furono proprio personaggi del più stretto entourage dell’imperatore a sostenere e in-crementare la diffusione dei florensi, con gli estremi da una parte nel 1201, quando Simone di Mamistra, gran giustiziere regio di Calabria e signore di Fiu-mefreddo, fondò il monastero di Fonte Laurato, e il 1263 dall’altra, quando, sotto il regno di Manfredi, Federico Lancia, suo zio, fondò - o meglio tentò di fondare - il cenobio florense a San Martino, nella contea di Squillace. Anche in Puglia, il passaggio del monastero di Laterza all’ordine di Fiore avvenne grazie all’iniziativa del prothonotarius e logoteta An-drea, un personaggio che godeva la fiducia personale dell’imperatore. In Calabria, tuttavia, il sostegno im-periale e della nobiltà legata a Federico, dal 1227 in poi, sembra dipendere sostanzialmente dai rapporti
274
- e dai contrasti - di quest’ultimo con il papato, e dalla fedeltà o, viceversa, dall’opposizione, al partito imperiale dei superiori florensi.
Di più difficile valutazione, anche a causa della frammentarietà delle notizie, appare il caso degli al-tri monasteri florensi nel Regno, in particolare per quelli posti nella penisola sorrentina. Da un lato troviamo, per l’affiliazione di due di essi all’ordine, l’iniziativa del papato e il sostegno in particolare di Ugolino-Gregorio IX. In un altro caso, quello di Santa Marina della Stella, presso Maiori, è attestata maggiormente l’iniziativa dell’imperatore, anche in un momento in cui i monasteri calabresi, e in par-ticolare Fiore e Fonte Laurato, sembrano soffrire le conseguenze dei rapporti problematici con Federico II, dovuti presumibilmente al prevalere, all’interno dei due cenobi, del partito più favorevole al papato.
I monasteri del Lazio meridionale, Sant’Ange-lo del Monte Mirteto a Ninfa e Santa Maria della Gloria ad Anagni, entrambe fondazioni ugoliniane, sono naturalmente legate a doppio filo con la sede pontificia. Sono infatti situate in un territorio in cui la famiglia Conti, da cui provenivano Gregorio IX e in seguito Alessandro IV, deteneva di fatto la supre-mazia. La cittadina di Ninfa, dove, nel 1216, Ugoli-no, in qualità di vescovo di Velletri, aveva fondato il cenobio del Mirteto, era stata concessa in feudo da Innocenzo III, nel 1212, al suo congiunto Giacomo Conti, quale ricompensa delle campagne da lui svol-te in Sicilia contro Markwald di Anweiler. Nel 1217, poi, Giacoma, moglie di Graziano Frangipani, ven-dette a papa Onorio III gli ultimi beni e diritti che la sua famiglia deteneva nel territorio ninfano. In tal modo, in meno di un decennio, la famiglia di Ugoli-no-Gregorio IX si trovò a gestire la sovranità su tutta la zona di Ninfa e la fondazione florense non faceva che completare e integrare in questo contesto, anche da un punto di vista religioso, tale sovranità. Una simile situazione fu quella di Anagni, dove il futuro papa aveva dapprima fondato una chiesa dedicata a Santa Maria Gloriosa e in seguito l’abbazia de Monte Aureo. E in effetti, a quanto sembra, le due fonda-zioni florensi non ebbero mai contrasti significativi né con il potere laico né con altre istituzioni religiose delle rispettive zone. Sono comunque senza dubbio da approfondire le vicende di questi due monasteri ugoliniani-gregoriani, di cui abbiamo visto solo la fase fondativa; nuove ricerche potranno ampliare la riflessione, sulla base della documentazione comple-ta, analizzata fino ad oggi solo in rapidi tratti87.
Gli estremi più settentrionali della relativa espan-sione florense sono costituiti dai due monasteri posti nella Tuscia, anch’essi favoriti e sostenuti da Ugoli-
no-Gregorio IX. Anche riguardo a queste due fon-dazioni non si può che constatare la frammentarietà delle fonti: esse tuttavia lasciano intravedere che il priorato di San Iacopo sia stato, con qualche proba-bilità, la prima fondazione florense al di fuori della Calabria e del regno di Sicilia, forse sulla base di le-gami personali di tre monaci di Fiore (tra cui anche l’abate Matteo, il successore di Gioacchino) con il loro territorio di origine, appunto la Tuscia.
Un ultimo punto rimane da chiarire: la questio-ne del monachesimo femminile florense. Secondo la tradizione erudita che prende origine da Gregorio De Laude, nell’ordine florense sarebbero stati com-presi anche quattro monasteri femminili: tre di essi, Santa Maria de Medio Domini Aegidii a Cosenza, Santa Maria della Fontanella a Mendicino e Santa Maria di Bellofonte, presso Paola, erano compresi nella diocesi di Cosenza; un quarto, il monastero di Sant’Elena, sorgeva invece presso Scala, in diocesi di Amalfi88.
Riguardo a questo problema, bisogna innanzitut-to riconoscere che le notizie sui monasteri femmini-li florensi sono estremamente frammentarie, e non chiariscono affatto in quali termini essi facessero parte dell’ordine.
Il monastero di Santa Maria de Medio Domini Ae-gidii a Cosenza, in merito al quale si afferma che «le Florensi dovettero stabilirvisi all’inizio del Duecento, nel periodo (1202-1234) in cui l’Ordine era retto da Matteo Vitari, successore di Gioacchino»89, in alcu-ni casi è presentato come dipendente dai cistercensi, in altri dai florensi. In realtà, a parte la tradizione erudita locale, non si possiedono fonti documentarie in base alle quali si possa affermare che si trattas-se effettivamente di un monastero florense. Simile confusione circa l’appartenenza si rileva anche per il monastero di Santa Maria della Fontanella, presso Mendicino: dagli eruditi locali fu classificato in alcu-ni casi come benedettino, in altri come cistercense, in altri ancora come florense90. Il terzo cenobio ca-labrese, Santa Maria di Bellofonte, presso Paola, è quello su cui siamo meno informati: il De Laude è l’unico autore che ne parli, ricordando che al termi-ne del periodo florense passò all’ordine cistercense. La contiguità con l’ordine cistercense emerge anche nelle vicende dell’unico monastero femminile, defi-nito florense, sorto al di fuori del territorio di Co-senza, quello di Sant’Elena, presso Scala91.
Per chiarire l’emergere, nella tradizione erudita, di notizie relative a monasteri florensi femminili e far luce sul tipo di rapporti che essi potrebbero aver tenuto con le abbazie del ramo maschile, è possibile
275
forse istituire un parallelo con l’esperienza cistercen-se, minoritica e domenicana: molte comunità fem-minili avevano intrecciato legami con abbazie cister-censi maschili (o con i frati minori e i predicatori) per poter riceverne l’assistenza liturgica, sacramen-tale e spirituale necessaria alla loro vita religiosa. I tre monasteri femminili posti in diocesi di Cosenza potrebbero in tal caso aver ricevuto l’assistenza di re-ligiosi florensi, anche in una forma istituzionalizzata, forse per decisione dell’ordinario diocesano; a moti-vo di tale rapporto, si attribuì loro la definizione di florensi. Una motivazione di questo genere potrebbe spiegare il fatto che gli eruditi del Sei-Settecento at-tribuirono all’ordine florense anche il monastero di Sant’Elena di Scala, località nella penisola sorrenti-na: esso infatti sorgeva probabilmente a non grande distanza dal monastero di Santa Marina della Stella, sito sopra Maiori. I monaci di Santa Marina dunque avrebbero seguito spiritualmente le religiose di San-t’Elena, e tale assistenza spirituale ne avrebbe deter-minato una sorta di appartenenza allo stesso ordine della comunità monastica di Santa Marina.
In realtà, almeno da quel poco che conosciamo ri-
guardo all’ideale monastico di Gioacchino, non pare che nel suo progetto multiforme fosse previsto uno spazio anche per un monachesimo femminile: il te-sto dedicato all’ordinata domus religionis come si tro-va nel V libro della Concordia non accenna mai a un ruolo femminile se non indirettamente, nel momen-to in cui l’abate parla dei laici coniugati e del modo in cui devono vivere con le proprie mogli. Anche nel famoso Liber Figurarum, e in particolare nella tavo-la XII, la Dispositio novi ordinis pertinens ad tertium statum, in cui è possibile ritrovare molte indicazioni relative al progetto di ordine prospettato dall’abate calabrese, le donne compaiono solo con un ruolo del tutto marginale: nell’oratorium dei coniugati e al-l’interno della comunità laicale esse ricoprono ruoli tutto sommato secondari. È dunque difficile pensare che la presenza del ramo femminile dell’ordine fosse stata prevista, programmata e realizzata fin dai primi anni dell’istituzione del nuovo ordine, dallo stesso Gioacchino o dal suo diretto successore Matteo, nel corso della prima metà del XIII secolo, il periodo in cui pure il monachesimo florense conobbe il periodo di maggiore fioritura e diffusione.
Note
1 A. Vuolo Gli insediamenti monastici benedettini nella penisola
sorrentina, in «Benedictina», 29 (1982), 381-404; in part. 397.2 Ivi, pp. 387-390.3 Regii Neapolitani archivi monumenta, a c. di A. Spinelli,
A. D’Aprea, M. Baffi, G. Genovesi, G. Sequino, vol. I, Napoli
1845, doc. XXX. Il testo del documento si legge anche pres-
so il sito internet: http://www.stabiana.it/documrovigl.htm (9
marzo 2006).4 Cassoni, La badia ninfana cit., p. 184.5 Ivi, p. 183; cfr. Vuolo, Gli insediamenti monastici cit., p.
388. Per il documento, vd. vol. 2, p. VI, doc. n. 1 (Sant’Angelo
di Rovigliano).6 Ivi, doc. n. 3 (Sant’Angelo di Rovigliano).
7 Ivi, doc. n. 2 (Sant’Angelo di Rovigliano).8 Vuolo, Gli insediamenti monastici cit., p. 389.9 Ivi, pp. 383, 389, 396-398.10 Vol. 2, p. VI, doc. n. 2 (Sant’Angelo di Rovigliano).11 Ivi, doc. n. 1 (San Renato di Sorrento); cfr. Cassoni, La
badia ninfana cit., p. 185.12 Vuolo, Gli insediamenti monastici cit., p. 397-398.13 Russo, Gioacchino da Fiore e le fondazioni cit., p. 200.14 Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello,
1190-1309. Le pergamene dell’archivio arcivescovile di Amalfi, a
c. di Luigi Pescatore, Napoli 1979, p. 4 (anno 1190).15 Vol. 2, p. VI, doc. n. 1 (Santa Marina della Stella).16 Ivi, doc. n. 2 (Santa Marina della Stella).
276
17 Ivi: «Nos igitur, ob reverentiam beate Marine, ad cuius
honorem monasterium ipsum noscitur esse fundatum, memo-
ratam apothecam cum planca sua et cum omnibus ad ipsam
pertinentibus, ipsi monasterio in perpetuuum confirmamus,
non obstante, quod Amalfitana ecclesia, seu qualiscumque per-
sona ecclesiastica vel secularis, alta vel humilis, sive ex antiqua
consuetudine vel privilegio, vel quacunque ratione aut lege ius
asserant se habere vel habeant, quod non liceat alii habere in
predicto loco Maioris apothecam cum planca facta seu facien-
da seu de vendendis carnibus in ea vel quibuscumque mercibus
impediat seu molestet».18 Ivi, doc. n. 3 (Santa Marina della Stella).19 Ivi; per i documenti del pontefice, vd. ivi, docc. nn. 6 e 7
(Santa Marina della Stella).20 Ivi.21 Ivi, doc. n. 3 (Santa Marina della Stella).22 Ivi, doc. n. 4 (Santa Marina della Stella).23 Ivi, doc. n. 5 (Santa Marina della Stella).24 Ivi, doc. n. 6 (Santa Marina della Stella).25 Ivi.26 Ivi, doc. n. 7 (Santa Marina della Stella).27 Ivi, doc. n. 8 (Santa Marina della Stella).28 Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello,
1190-1309 cit., p. 27 (anno 1268): testamento di Margarito,
figlio di Pietro Marcagella, in cui tra altre cose dispone che
venga lasciato mezzo augustale al monastero di Santa Mari-
na della Stella; p. 74 (anno 1281): Saraphinus de Bibo e suo
figlio Filippo dichiarano di ricevere in locazione per 29 anni
da Giovanni, abate del monastero di Santa Marina di Vistella,
due pezze vinee et terre, site in Tramonti, in località a le Petre,
obbligandosi sotto pena di quattro once d’oro. Codice diploma-
tico amalfitano, a c. di Riccardo Filangieri di Candida, II, Trani
1951, p. 167-169: testamento di Oddone figlio di Pietro; tra
altri enti viene citato anche il monastero di Santa Marina de
Stella, a cui sono lasciati sette tarì e mezzo d’oro.29 Vuolo, Gli insediamenti monastici cit., p. 390. 30 Le pergamene dell’archivio arcivescovile di Amalfi, regesto a.
1103-1914, a c. di Renata Orefice, Massalubrense 1981, p. 98.31 C. dell’Aquila, L’abbazia florense di S. Maria La Grande
a Laterza in Puglia: contributo alla lettura storico-architettonica,
in «Florensia», 2 (1988), pp. 91.32 Russo, Gioacchino da Fiore e le fondazioni cit., pp. 195-197.33 Vol. 2, p. I, doc. n. 164.-34 Ivi, doc. n. 163.35 DDFF II, doc. I (Santa Maria di Laterza), p. 124.36 C. dell’Aquila, L’abbazia florense di S. Maria La Grande
cit., pp. 92-94, con notizie riguardanti la famiglia dei conti di
Matera: Alessandro era figlio di Goffredo, conte di Conversa-
no, signore di Brindisi e Monopoli, che conquistò Matera e
Castellaneta nel giugno del 1064 insieme a Roberto di Mon-
tescaglioso, suo fratello. Dell’Aquila riporta anche, nell’appen-
dice documentaria, la trascrizione dell’epigrafe di fondazione
della chiesa di Santa Maria, e due documenti pontifici del XV
secolo (vd. Appendice documentaria, pp. 112-116).37 DDFF II, doc. II (Santa Maria di Laterza), pp. 125-126.38 Vol. 2, p. I, doc. n. 146.39 Il logoteta Andrea è considerato «persona di fiducia» di
Federico II, insieme Matteo Marclafaba e ad Angelo de Marra,
e scelto dall’imperatore per imporre i nova statuta, in partico-
lare quelli relativi al monopolio regio su alcuni prodotti, in
Puglia e in Basilicata; vd. J.- M. Martin, Diversità e unità del
Regno, in Federico II. Immagine e potere, a cura di M. S. Calò
Mariani e R. Cassano, Venezia 1995, pp. 6-7.40 Vol. 2, p. I, doc. n. 146: «nihil nobis, et nostris successo-
ribus iurisditionis vel proprietatis, ac temporalis dominii in eo-
dem monasterio reservato, nisi ut orationum vestrarum, et re-
tributionis divine mereamur esse participes. Salvo tamen bene-
dictione abbatis, qui, cum benedicendus fuerit, obbedientiam
nobis et reverentiam repromittet, salva in omnibus sui ordinis
libertate, et ordinatione clericorum cum erogatione crismatis,
olei sancti, et olei infirmorum, quos qualiter absque difficultate
fieri debeant sine aliqua pravitate, idem alias monasterium tam
in spiritualibus quam temporalibus absolventes».41 Ivi, doc. n. 155.42 C. dell’Aquila, L’abbazia florense di S. Maria La Grande
cit., p. 98.43 M. Cassoni, La badia ninfana di S. Angelo o del Monte
Mirteto nei Volsci, fondata da Gregorio IX, in «Rivista storica be-
nedettina», 14 (1923), pp. 170-189; 15 (1924), pp. 252-263.44 F. Caraffa, Il monastero florense di S. Maria della Gloria
presso Anagni con una introduzione sui monaci florensi e i loro
monasteri, Roma 1940; Vd. anche Id., I monasteri florensi del
Lazio meridionale, in Storia e messaggio in Gioacchino da Fio-
re, pp.451-471. I documenti che lo riguardano, dall’origine
(1226) al 1767, si conservano nell’Archivio del Capitolo di
San Giovanni in Laterano e sono stati inventariati, con breve
regesto, nel vol. I dell’Index generalis tabularii Sacrosanctae Ba-
silicae Lateranensis, redatto nella seconda metà del Settecento
(ff. 33-44); vd. vol. 2, p. VIII, n. 3.45 M. Zappalà, Gregorio IX e i monasteri florensi della Campa-
gna e Marittima, in Ad Alessandro Luzio gli archivi di Stato italia-
ni. Miscellanea di studi storici, II, Firenze 1933, pp. 387-402.46 Monasticon Italiae, I (Roma e Lazio), pp. 121-122 (Santa
Maria della Gloria di Anagni); p. 136 (Sant’Angelo del Monte
Mirteto). 47 Cassoni, La badia ninfana cit., pp. 175-176. Si tratta
chiaramente di un errore la trascrizione della data del docu-
mento («Actum incarnationis dominice M.CCVI.»), dal mo-
mento che è subito aggiunto «pontificatus domini Honorii III
pp. anno primo». Vd. vol. 2, p. VII, doc. n. 1 (Sant’Angelo del
Monte Mirteto).48 Il documento indirizzato all’abate e ai monaci del Mirteto
è edito da Mario Cassoni (cfr. nota precedente); copia parziale
di quello diretto alla comunità di Fonte Laurato, casa madre
del nuovo monastero, è conservata in MBP III, f. 60r: vd. vol.
2, p. II, doc. n. 13 (deperdito).
277
49 F. Mastrojanni, Precisazioni sulle tre abbazie cistercensi di
Marmosolio, Valvisciolo sermonetano e Valvisciolo carpinetano, in
«Analecta Cisterciensia», 15 (1959), pp 220-264. Cfr. Mona-
sticon Italiae, I, pp. 135-136. Per il permesso di trasferimento,
concesso dal capitolo generale cistercense, vd. Canivez, Statuta
cit., I, p. 332, n. 65 (anno 1206).50 Il documento di donazione del monastero di Marmoso-
lio ai cistercensi provenienti da Fossanova è riportato in primo
luogo da A. Borgia, Istoria della Chiesa e città di Velletri, Nocera
1723, pp. 232-233; una rilettura fu proposta da E. Stevenson,
Documenti dell’archivio della cattedrale di Velletri, in «Archivio
della Regia Società Romana di Storia Patria», 12 (1889), pp.
107-108; è infine ripubblicato da Mastrojanni, Precisazioni
sulle tre abbazie cistercensi cit., pp. 252-253. In merito vd. an-
che C. Ciammaruconi, Vita di un monastero nella Marittima
fra XIII e XVI secolo: l’abbazia di Valvisciolo, in «Benedictina»
38 (1991), pp. 383-414; Id., Da Marmosolio a Valvisciolo. Sto-
ria di un insediamento cistercense nella Marittima meridionale
(XII-XVI secolo), pref. di M.T. Caciorgna, Sermoneta 1998 e
il volume collettivo Il monachesimo cistercense nella Marittima
meridionale. Storia e arte (Atti del convegno, abbazia di Fos-
sanova e Valvisciolo, 24-25 settembre 1999), Casamari 2002
(Biblioteca Casaemariensis, 5). 51 Mastrojanni, Precisazioni sulle tre abbazie cistercensi cit.,
p. 253. Il cardinale Ugo, in ottemperanza agli statuta dell’or-
dine, ritenne alla chiesa di Velletri il possesso dei mulini, ma
concesse ai monaci che potessero recarsi «in quorum <molen-
dinorum> meliore, unum diem cum nocte ad molendum sin-
gulis septimanis». 52 Vd. la bolla solenne di protezione di Santa Maria della
Gloria, o del Monte Aureo, vol. 2, p. VII, doc. n. 2 (Santa
Maria della Gloria). 53 Pressutti, n. 5293; vd. Caraffa, I monasteri florensi del
Lazio cit., p. 461.54 Vol. 2, p. VII, doc. n. 1 (Santa Maria della Gloria). 55 Ivi, doc. n. 2 (Santa Maria della Gloria).56 Caraffa, Il monastero florense cit., pp. 100-106.57 Auvray, n. 4569 (14 ottobre 1238).58 Vol. 2, p. VIII, doc. n. 1.59 Il cardinale dichiarò infatti che i problemi sorgevano
dal fatto che «idem locus ex sua dispositione ad monasterium
monialium nequaquam ydoneus videbatur, omnesque prefa-
ti monasterii moniales erant illitterate et tota fere per easdem
ecclesiastica substantia dissipata, ita quod nec ad divinum offi-
cium aliquos libros haberent et a se omnino excusserant iugum
monastice discipline» (Ivi).60 M. P. Alberzoni, Chiara e il papato, Milano 1995, pp.
38-39.61 Si tratta di una chiesa, definita come “chiesa non-pieve
dotata di cimitero”, di cui si hanno notizie almeno dal 1111;
cfr. L. Nanni, La parrocchia studiata nei documenti lucchesi dei
secoli VIII-XIII, Roma 1948, p. 58, nota 36.62 Vol. 2, p. I, doc. n. 97.
63 Ivi, p. VIII, doc. n. 3.64 Ivi, p. I, doc. n. 71.65 Vedi tuttavia infra, nota 68.66 Adorisio, La “Legenda” cit., p. 112.67 Vol. 2, p. VIII, doc. n. 2.68 Ivi, doc. n. 3.69 Ivi, doc. n. 4.70 Vol. 2, p. VIII, doc. n. 9.71 Ho tratto queste notizie dal sito http://www.cassiciaco.
it/ITA/001ago/Agostiniani/ordine.htm (10 marzo 2006), links
«Storia dell’ordine», «Gli eremiti di Tuscia» e «Eremi lucchesi»
(pagine curate da B. Van Luijk). I nessi tra i florensi e questi
eremi della Lucchesia potrebbero fornire una spiegazione an-
che al “misterioso” Ugo, priore Sancti Georgi, monaco florense,
presente in curia nel 1211. Tra gli eremi lucchesi poi entrati a
far parte della Congregazione delle Tredici vi era anche l’eremo
di San Giorgio di Spelonca; nel 1204 la piccola fondazione
eremitica risulta abitata anche da un frate Ugone. Se si trat-
tasse davvero della medesima persona, Ugo, nel 1204 frate a
San Giorgio di Spelonca, sarebbe entrato in data anteriore al
1211 nell’ordine florense; nel 1211 sarebbe stato presente in
curia, poi sarebbe passato nell’eremo di Moriglione (ante 1217)
e infine a San Iacopo, quando il cardinale Ugolino affidò que-
sto monastero ai florensi. Riguardo agli eremi della diocesi di
Lucca, cfr. anche C. Benedetto, L’eremitismo nel territorio della
diocesi di Lucca nei secoli XII e XIII, in «Bollettino italiano per
la storia della pietà», 1 (1979), pp. 3-19; F. Panarelli, La tra-
dizione eremitica in area pisana: la “vallis heremitae” sul Monte
Pisano, in «Reti Medievali Rivista», V - 2004/2 (luglio-dicem-
bre), consultabile al sito http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/
saggi/Panarelli.htm (1 marzo 2006).72 P. Bianchi, La badia di S. Pietro presso Camaiore, in «Be-
nedictina», 4 (1950), pp. 269-283. Da questo articolo ho trat-
to le notizie sul monastero per il periodo precedente la riforma
florense.73 Vol. 2, p. VIII, doc. n. 5.74 Ivi, doc. n. 6.75 Ivi, doc. n. 7.76 Ivi, doc. n. 8.77 Ivi, doc. n. 9.78 Ivi, doc. n. 10. 79 Salimbene de Adam, Chronica, ed. G. Scalia, Bari 1966,
I, p. 339.80 A. Callebaut, Le Joachimite Benoît, abbé de Camajore et
Fra Salimbene, in «Archivum Franciscanum historicum» 20
(1927), pp. 219-222. Lo studioso si rifà alla bolla di Gregorio
IX del 13 ottobre 1239, ma in essa, in realtà, non è dato il
nome dell’abate. 81 R. E. Lerner, Federico II mitizzato e ridimensionato post
mortem nell’escatologia francescano-gioachimita, in Id. Refrigerio
dei santi. Gioacchino da Fiore e l’escatologia medievale, Roma
1995, p.147-149 (trad. it. di Frederick II, Alive, Aloft and Al-
layed in Franciscan-Joachite Eschatology, in The Use and Abuse
278
of Eschatology in the Middle Ages, a cura di W. Verbeke et al.,
Leuven 1988, pp. 359-384).82 Vol. 2, p. VIII, doc. n. 11.83 Ivi, doc. n. 12.84 Ivi, doc. n. 13.85 Russo, Gioacchino da Fiore e le fondazioni cit., pp. 205-206.86 Bianchi, La badia di San Pietro cit., p. 279.87 Come abbiamo accennato, i due monasteri hanno con-
servato una documentazione abbastanza consistente, in parte
ancora inedita, anche se nel caso dell’abbazia di Anagni essa non
è di facile consultazione (è conservata nell’Archivio del Capito-
lo di San Giovanni in Laterano, posto, indipendentemente, al
piano inferiore dell’Archivio della diocesi di Roma, e l’accesso
alla consultazione delle carte in esso conservate non è affatto
semplice). Migliore la situazione per il monastero del Mirteto,
la cui documentazione è in gran parte conservata nell’Archivio
del monastero di Santa Scolastica a Subiaco. Varrebbe la pena
di riprendere lo studio analitico delle due fondazioni, su cui gli
studi sono ormai superati, anche in tesi di laurea.88 Riassume le notizie su questi monasteri femminili e la
storiografia erudita in merito A. Billi, I monasteri femminili flo-
rensi, in «Benedictina», 36 (1989), pp. 305-328. 89 Ivi, p. 312. 90 In merito, cfr. L. Renzo, Santa Maria della Fontanella
monastero florense femminile di Mendicino, in «Rivista Storica
Calabrese», n. s., 12-13 (1991-1992), pp. 499-506.91 Billi, I monasteri femminili florensi cit., 310-321.
279
bIblIOGraFIa
La seguente bibliografia riguarda i capitoli della sezione storica. Per la bibliografia relativa ai singoli monasteri, si rimanda alle schede corrispondenti.
Abulafia D., Federico II. Un imperatore medievale, Torino 1990 (Biblioteca di cultura storica, 180), trad it. di Frederick II. A Medieval Emperor, London 1988, rist. 1992.
Adorisio A. M., La “Legenda” del santo di Fiore. B. Ioachi-mi abbatis miracula, Manziana (Roma) 1989.
Adorisio A. M., I miracoli dell’abate. I fatti miracolosi compiuti da Gioacchino da Fiore tradotti in lingua ita-liana, Manziana (Roma), 1993.
Adorisio A. M., Gioacchino da Fiore a Roma e nel Lazio, «Rivista cistercense», IX (1994), 33-45.
Adorisio A. M., Il «Liber usuum Ecclesiae Cusentinae» di Luca di Casamari arcivescovo di Cosenza. Codice San-t’Isidoro 1/12, Casamari (Veroli) 2000 (Bibliotheca Casaemariensis, 4).
Alberzoni M. P., Chiara e il papato, Milano 1995.
Benedetto C., L’eremitismo nel territorio della diocesi di Lucca nei secolo XII e XIII, in «Bollettino italiano per la storia della pietà», 1 (1979), pp. 3-19.
Bianchi P., La badia di S. Pietro presso Camaiore, in «Be-nedictina», 4 (1950), pp. 269-283.
Billi A., I monasteri femminili florensi, in «Benedictina», 36 (1989), pp. 305-328.
Callebaut A., Le Joachimite Benoît, abbé de Camajore et Fra Salimbene, in «Archivum Franciscanum histori-cum» 20 (1927), pp. 219-222.
Caraffa F., Il monastero florense di S. Maria della Gloria presso Anagni con una introduzione sui monaci florensi e i loro monasteri, Roma 1940.
Caraffa F., I monasteri florensi del Lazio meridionale, in Storia e messaggio in Gioacchino da Fiore, Atti del I Congresso internazionale di Studi gioachimiti, San Giovanni in Fiore 1980, pp.451-471.
Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, a cura di A. Pratesi, Città del Vaticano 1958 (Studi e testi 197).
Cassoni M., La badia ninfana di S. Angelo o del Monte Mirteto nei Volsci, fondata da Gregorio IX, in «Rivi-sta storica benedettina», 14 (1923), pp. 170-189; 15 (1924), pp. 252-263.
Ciammaruconi C., Vita di un monastero nella Marittima fra XIII e XVI secolo: l’abbazia di Valvisciolo, in «Bene-dictina» 38 (1991), pp. 383-414.
280
Ciammaruconi C., Da Marmosolio a Valvisciolo. Storia di un insediamento cistercense nella Marittima meridiona-le (XII-XVI secolo), pref. di M.T. Caciorgna, Sermo-neta 1998.
(I) Cistercensi nel Mezzogiorno medievale. Atti del Conve-gno internazionale di studio in occasione del IX cente-nario della nascita di Bernardo di Clairvaux (Martia-no - Latiano - Lecce, 25-27 febbraio 1991), a c. di H. Houben e B. vetere, Galatina 1994 (Univesità degli studi di Lecce, Pubbl. del Dip. di Studi storici dal Me-dioevo all’Età contemporanea 28).
Comba R., Le scelte economiche dei monaci bianchi nel Re-gno di Sicilia (XII-XIII secolo): un modello cistercense? in I Cistercensi nel Mezzogiorno, pp. 117-164.
De Fraja V., «Post combustionis infortunium». Nuove con-siderazioni sulla tradizione delle opere gioachimite, in «Florensia», 8-9 (1994-1995), pp. 129-171.
De Fraja V., Una vocazione d’Oltralpe: Iohannes de Baiona, monaco florense, in «Florensia» 11 (1997), pp. 41-66.
De Fraja V., Usi politici della profezia gioachimita, in An-nali dell’Istituto storico italo-germanico di Trento, 25 (1999), pp. 375-400.
De Fraja V. , Oltre Cîteaux. Gioacchino da Fiore e l’ordine florense, Roma 2006 (in corso di stampa presso Viella nella collana “Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti”).
De Leo P., Documenti imperiali e regi di età normanno-sveva in archivi privati calabresi, in «Bullettino del-l’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 88 (1979), pp. 349-377.
De Leo P., I manoscritti di Nicola Venusio e la ricostruzione del cartulario florense, in «Florensia», 10 (1996), pp. 7-107.
Dell’Aquila C., L’abbazia florense di S. Maria La Grande a Laterza in Puglia: contributo alla lettura storico-archi-tettonica, in «Florensia», 2 (1988), pp.
Egger Ch., Joachim von Fiore, Rainer von Ponza und die römische Kurie, in Gioacchino da Fiore tra Bernardo e Innocenzo cit., p. 129-162.
Gioacchino da Fiore tra Bernardo di Clairvaux e Innocenzo III, Atti del V Congresso Internazionale di studi gioa-chimiti, San Giovanni in Fiore 16-21 settembre 1999,
Roma 2001 (Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti, 13).
Grundmann H., Gioacchino da Fiore. Vita e opere, a c. di G. L. Potestà, Roma 1997 (Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti, 8).
Houben H., Il “libro del capitolo” del monastero della SS. Trinità di Venosa (Cod. Casin. 334): una testimonianza del Mezzogiorno normanno, Galatina 1984 (Univ. De-gli Studi di Lecce, Dip. Di Scienze Storiche e Sociali, Materiali e documenti, 1).
Kamp N., Kirche und Monarchie im Staufischen König-reich Sizilien. I: Prosopographische Grundlegung. Bi-stümer und Bischöfe des Königreichs 1194-1266, Teil 2: Apulien und Kalabrien, München 1975 (Münstersche Mittelalter-Schriften 10/I, 2).
Kamp N., Potere monarchico e chiese locali, in Federico II e il mondo mediterraneo, a cura di P. Toubert e A. Para-vicini Bagliani, Palermo 1994.
Kölzer Th., La monarchia normanno-sveva e l’ordine ci-stercense, in I Cistercensi nel Mezzogiorno, pp.91-116.
Kölzer Th., Urkunden und Kanzlei der Kaiserin Konstanze, Königin von Sizilien (1195-1198), Köln-Wien 1983.
Italia Pontificia, X: Calabria - Insulae, a c. di D. Girgen-sohn, Zürich 1975.
Lerner R. E., Federico II mitizzato e ridimensionato post mortem nell’escatologia francescano-gioachimita, in Id. Refrigerio dei santi. Gioacchino da Fiore e l’escatologia medievale, Roma 1995 (Opere di Gioacchino da Fio-re: testi e strumenti, 5), p. 147-149 (trad. it. di Frede-rick II, Alive, Aloft and Allayed in Franciscan-Joachite Eschatology, in The Use and Abuse of Eschatology in the Middle Ages, a cura di W. Verbeke et al., Leuven 1988, pp. 359-384).
Lopetrone P., Il protomonastero di Fiore: origini, fondazio-ne, vita, distruzione, ritrovamento, in «Abate Gioacchi-no. Organo trimestrale per la causa di canonizzazione del Servo di Dio Gioacchino da Fiore», I, 2-3 (marzo-giugno 2004), pp. 39-65.
Luca di Cosenza, Memorie, in Grundmann, Gioacchino da Fiore, pp. 191-197.
maccarrone M., Primato romano e monasteri dal principio del XII secolo ad Innocenzo III, in Istituzioni monastiche
281
e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215), Atti della settima Settimana internazionale di studio (Men-dola 28 agosto - 3 settembre 1977), Milano 1980 (Pub-blicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Miscellanea del Centro di Studi medioevali 9), pp. 47-132.
maccarrone M., Papato e Regno di Sicilia nel primo anno di pontificato di Innocenzo III, in Potere, società e po-polo tra età normanna ed età sveva (1189-1210). Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari - Conversa-no, 26-28 ottobre 1981), Bari 1983 (Centro di studi normanno-svevi, Università degli studi di Bari, Atti 5), pp. 75-108.
maleczek W., Papst und Kardinalkolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coelestin III. und Innocenz III., Wien 1984.
Martin J.-M., Diversità e unità del Regno, in Federico II. Immagine e potere, a cura di M. S. Calò Mariani e R. Cassano, Venezia 1995, pp. 3-7.
Martire D., La Calabria sacra e profana, Cosenza 1876-1878.
Mastrojanni F., Precisazioni sulle tre abbazie cistercensi di Marmosolio, Valvisciolo sermonetano e Valvisciolo car-pinetano, in «Analecta Cisterciensia», 15 (1959), pp. 220-264.
Matthew D., I Normanni in Italia, Roma-Bari 1997 (trad. it. di The Norman Kingdom of Sicily, Cambri-dge 1992).
Merlo G. G., «Militare per Cristo» contro gli eretici, in «Militia Christi» e crociata nei secoli XI-XIII, Milano 1992, pp. 255-384.
Merlo G. G., Contro gli eretici. La coercizione all’ortodos-sia prima dell’Inquisizione, Bologna 1996.
Il monachesimo cistercense nella Marittima meridionale. Storia e arte (Atti del convegno, abbazia di Fossanova e Valvisciolo, 24-25 settembre 1999), Casamari 2002 (Biblioteca Casaemariensis, 5).
Monasticon Italiae. I: Roma e Lazio, a c. di F. Caraffa, Cesena 1985.
Napolitano R., San Giovanni in Fiore monastica e civica. Storia documentata del capoluogo silano, vol. I (Dalle origini al 1215), parte 1ª (L’abate Gioacchino: le fonti),
Napoli 1978; parte 2ª (L’abate Gioacchino: i tempi), Napoli 1981.
penco G., Gioacchino da Fiore e la «protectio apostolica», in «Benedictina», 40 (1993), pp. 493- 496.
Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello, 1190-1309; Le pergamene dell’archivio arcivescovile di Amalfi, a c. di Luigi Pescatore, Napoli 1979.
Potestà G. L., Introduzione, in Ioachim abbas Florensis, Dialogi de prescientia Dei et predestinatione electorum, a c. di Gian Luca Potestà, Roma 1995 (Fonti per la storia dell’Italia medievale, Antiquitates, 4).
Rainini M., I predicatori dei tempi ultimi. La rielabora-zione di un tema escatologico nel costituirsi dell’identità profetica dell’Ordine domenicano, in «Cristianesimo nella storia», 23 (2002), pp. 320-325.
Rainini M., Giovanni da Vicenza, Bologna e l’Ordine dei Predicatori, in «Divus Thomas», CIX/1 (2006), in corso di stampa.
Radulphus de Coggeshale, Chronicum Anglicanum ed. J. Stevenson, London 1875, rist. anast. 1965 (Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, 66).
Reeves M., The Influence of Prophecy in the Later Middle Age. A Study in Joachimism, Oxford 1969 (19932, con aggiornamento bibliografico).
Ryccardi de Sancto Germano Cronica, a cura di C. A. Ga-rufi, Bologna 1938 (RIS² VII, 2).
Robb F., Did Innocent III Personally Condemn Joachim of Fiore?, in «Florensia» 7 (1993), pp. 77-91.
Statuta capitolorum generalium ordinis Cisterciensis, a c. di J. M. Canivez, I, Louvain 1933.
La tradizione commemorativa nel Mezzogiorno medioevale: ricerche e problemi. Atti del seminario internazionale di studio (Lecce, 31 marzo 1982), a c. di C. D. Fonseca, Galatina 1984 (Univ. Degli Studi di Lecce, Dip. Di Scienze Storiche e Sociali, Saggi e ricerche, 12).
Tugwell S., Notes on the life of St Dominic, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», 65 (1995), pp. 5-169.
Twelfth-Century Statutes from the Cistercian General Chapter. Latin Text with English Notes and Commentary, ed. By Ch. Waddell, Cîteaux 2002 (Studia et Documenta, XII).
282
Vita b. Joachimi abbatis, in H. Grundmann, Gioacchino da Fiore, pp. 183-190.
Vuolo A., Gli insediamenti monastici benedettini nella peni-sola sorrentina, in «Benedictina», 29 (1982), 381-404.
Zappalà M., Gregorio IX e i monasteri florensi della Cam-pagna e Marittima, in Ad Alessandro Luzio gli archivi di Stato italiani. Miscellanea di studi storici, II, Firen-ze 1933, pp. 387-402.
Zinzi E., Il monastero di S. Giovanni in Fiore e le unità ex-florensi di Calabria (1561-1650): notizie sullo stato delle fabbriche, in L’età dello Spirito e la fine dei tempi in Gioacchino da Fiore e nel gioachimismo medievale, Atti del II Congresso internazionale di Studi gioachi-miti, a c. di A. Crocco, San Giovanni in Fiore 1986, pp. 367-390.
INdICI
Pasquale Lopetrone
FONDAZIONI, DIPENDENZE FLORENSI
AbbAzie, MonAsteri, Chiese, CAppelle, ospe-dAli, ospizi
Abbazia (Florense) di San Giovanni in Fiore (vedi anche Monastero di Fiore):16, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 222, 223, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 245, 246, 247, 249, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 263, 265, 266, 267, 270, 271, 274
Albe-Bordò (chiesa e abitazioni rupestri): 15, 35, 54, 72, 73
Bonoligno (monastero): 15, 35, 46, 205, 206, 207, 215, 216, 217, 243
Buggiano o Boggiano (eremo): 31, 179, 183, 233, 271
Calosuber: (vedi Bonoligno)Caput Album (Abbazia - ospizio):15, 35, 50,
207, 214Castellace o Castellacio (chiesa): 16, 80, 217, 235Chitano: (vedi Sant’Angelo di Satrano o Chitano)Corio (chiesa): 22, 111, 117, 254Escodenzia o Excadentia (chiesa): 19, 87, 97,
248, 250Faradomus (edificio/chiesa): 15, 17, 35, 48, 49,
215, 222Fiore Vetere (abbazia): 11, 15, 16, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 203Monastero di Fiore: (vedi anche Fiore Vetere):
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 229, 251
Montecatini (eremo): 31, 179, 184, 271Moriglione (eremo): 179, 269, 270, 271, 273Pollitrea (edificio/chiesa): 22, 111, 119Protomonastero di Fiore, 13 (vedi Fiore Vetere)San Berach di Meath: 29San Biagio di Lombrici (chiesa): 32, 185, 195,
200, 272San Cassiano (chiesa): 32, 185, 190, 191, 230,
231, 252, 272San Clemente (chiesa/cappella): 28, 145, 152, 268San Filippo (chiesa): 21, 105, 108, 253San Filippo di Waldo (chiesa): 21, 105, 109,
253San Frediano de Tullis (cappella/chiesa): 31,
179, 182, 246, 252, 269, 270, 271, 272San Giacomo di Bordò (chiesa): 16, 59San Giorgio (priorato): 270San Giovanni di Caloveto (chiesa): 16, 59, 69,
231, 232San Giovanni di Curiano (chiesa): 29, 159, 171San Giovanni di Fiore (chiesa): 15, 16, 17, 59, 70San Giovanni di Piedimonte (monastero): 29,
159, 170San Iacopo di Pedona (chiesa): 32, 185, 196,
200, 272San Iacopo di Valle Benedetta (abbazia): 31,
179, 180, 181, 230, 251, 252, 253, 269, 270, 271, 272, 273, 274
San Leonardo di Magor: 29San Lorenzo (chiesa): 15, 35, 56, 219, 220San Martino di Arantiani o Anagni (chiesa):
29, 159, 166, 268, 269San Martino di Canale o di Iove - (monastero): 9,
15, 16, 35, 51, 52, 53, 208, 209, 214, 215, 243San Martino di Neto (chiesa): 15, 35, 205, 206,
215, 220San Michele a Camaiore (chiesa/ospizio): 32,
185, 192, 193, 200, 272San Michele di San Marino (Abbazia): 238, 273San Nicola di Botrano (chiesa): 215, 220San Nicola di Bottolo (chiesa): 16, 208, 214, 215San Nicola di Pardice (chiesa): 16, 59, 67,San Nicola di Zagarise (chiesa): 21, 105, 110, 253San Pietro (chiesa): 19, 243, 244, 246, 250
San Pietro di Camaiore (abbazia): 32, 185, 186, 187, 188, 189, 200, 230, 231, 253, 271, 273
San Renato di Sorrento (abbazia): 25, 129, 130, 131, 132, 263, 264, 266
San Salvatore a Sala di Pietrasanta (chiesa/ospe-dale): 32, 185, 197, 200, 272
San Sisto a Ripa di Seravezza (chiesa/ospizio): 32, 185, 198, 200, 272
San Tommaso di Rutigliano monastero/ospi-zio): 16, 59, 76, 230, 231, 267
San Vincenzo a Camaiore (chiesa/ospedale): 32, 185, 194, 200, 272
Sant’Adriano: 28, 145, 153, 154, 232, 258, 259Sant’Andrea di Cariati (monastero): 19, 87, 96,
230, 232, 249Sant’Angelo di Botrano (chiesa): 215, 220Sant’Angelo di Monte Mirteto: (vedi Santa Ma-
ria Sant’Angelo di Monte Mirteto e Sant’An-gelo o San Michele Arcangelo)
Sant’Angelo di Pescalo o del Pesclo (monaste-ro): 10, 29, 159, 168, 169
Sant’Angelo di Rovigliano (abbazia): 24, 127 128, 263, 264, 265, 266
Sant’Angelo di Satrano o Chitano (chiesa); 16, 58, 68, 231, 267
Sant’Angelo Militino (monastero): 19, 87, 95, 230, 232, 249, 250, 273
Sant’Angelo o San Michele Arcangelo (chiesa in grotta rupestre): 30, 147, 153, 229, 230, 232, 268
Sant’Elena di Scala (monastero femminile assi-stito): 26, 133, 140, 274, 275
Santa Anania (chiesa): 22, 111, 118Santa Barbara (chiesa): 19, 243, 244, 245Santa Domenica (chiesa): 19, 208, 243, 244,
246, 250Santa Maria de Medio Domini Aegidii (mona-
284
stero femminile): 274Santa Maria del Castello di Rutigliano (chiesa):
16, 59Santa Maria del Soccorso (abbazia): 16, 59, 71Santa Maria dell’Ospedale (chiesa/ospedale):
28, 145, 156Santa Maria della Fontanella (monastero fem-
minile): 274Santa Maria della Gloria (abbazia): 10, 11, 29,
159, 160, 161,162, 163, 164, 165, 230, 232, 251, 259, 268, 269, 271, 274
Santa Maria della Porta (chiesa/ospizio): 32, 185, 199, 200, 272
Santa Maria della Selva: 183Santa Maria delle Terrate di Fiuca (chiesa della
grangia): 16, 59, 74, 75Santa Maria di Acquaviva o monacarla, oppure
Sancte Marie Florentine (abbazia): 21, 105, 106, 216, 217, 219, 221, 230, 231, 232, 233, 246, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 272
Santa Maria di Agradìa (Chiesa): 15, 35, 55, 219, 220
Santa Maria di Balnearia (priorato): 29, 232,Santa Maria di Bellofonte (monastero femmi-
nile): 274Santa Maria di Botrano: 215, 216, 220Santa Maria di Bottulo (Chiesa): 16Santa Maria di Cabria (Chiesa): 16, 59, 66,
220, 234Santa Maria di Calabromaria (abbazia): 11, 22,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 206, 218, 219, 221, 222, 230, 231, 233, 245, 246, 247, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 270
Santa Maria di Fontelaurato (abbazia): 19, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 207, 208, 214, 216, 217, 219, 220, 221, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 238, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 256, 258, 259, 265, 268, 269, 271, 273, 274
Santa Maria di Laterza (abbazia): 27, 141, 142, 143, 144, 230, 267, 273
Santa Maria di Monte (Abate) Marco (mona-stero): 15 35, 45, 205, 206, 215, 219, 220, 233, 234, 243
Santa Maria di Moriglione (abbazia): 30, 177, 178, 213
Santa Maria di Tre Ponti (chiesa): 29, 159, 167Santa Maria la Grande: (vedi Santa Maria di
Laterza)Santa Maria Nuova o Apatia (già monastero ita-
logreco dei SS. Tre Fanciulli): 23, 123, 124, 125, 126, 204, 205, 206, 207, 208, 214, 220, 222, 232, 257, 258, 259
Santa Maria Sant’Angelo di Monte Mirteto (abbazia): 11, 28, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 230, 232, 246, 251, 252, 258, 259, 263, 264, 268, 269, 271, 274
Santa Marina della Stella o Vistellis (abbazia): 26, 133, 134, 135, 230, 236, 237, 263, 264, 265, 266, 274, 275
SS. Tre Fanciulli di Barbaro (monastero): 21, 105, 107, 252, 253
SS. Trinità di Cori (monastero): 28, 143, 155,SS. Trinità di Maiori (chiesa/ospizio): 26, 133,
136, 137, 264Tassitano (monastero): 15, 35, 47, 215, 233, 243
teniMenti, territori, tenute
Albe - Bordò (territorio): 15Altura di Santa Cecilia (territorio): 29, 174, 269Angri (territorio): 10, 24, 264Apatia (tenimento): 23Arantiani o Arenzano (territorio): (vedi Arenza-
no-grangia o San Martino di Anagni)Augusta (territorio): 238Barbaro (tenimento Sersale-Zagarise): 21, 107,
233, 251, 252, 253Barbaro (territorio Fiumefreddo): 208
Barrachi (tenimento): 244, 245Berano (tenimento): 16, 80, 216, 217, 234, 235Bitauro (territorio Santa Severina): 239Botrano (tenimento): 15, 213, 214, 215, 216,
219, 220Bottulo o Bottolo (territorio): 16, 214, 216,
217, 238Buggiano (tenimento): 31, 179, 183, 233, 271Cabria (tenimento): 16, 66, 67Caldopiano (tenimento): 19, 100, 250Cammarelle (territorio): 244, 245Campanisio (territorio): 17, 100, 247, 250Campo di Manna (tenuta): 215Canale (tenimento): 9, 10, 16, 51, 52, 53, 208,
209, 214, 215, 216, 217, 223, 233Caput Rose (tenimento):215Castellace (tenimento): 16, 80, 217, 235Castelnuovo-del Cilento- (territori): 264Cerenzia (tenimento): 216, 217, 221Chitano (tenimento): 68Corio o Carìa (territorio del casale): 22, 111,
117, 254Cuccalati o Cuccalato (vedi Zuccalatus)Cuzuli (tenimento): 258Delli Monaci (territorio): 16, 85Eremita (tenuta): 215Excodentia o Excadentia (territorio): 19, 87,
97, 248, 250Falconara -Albanese- (territoriio): 19, 102,
247, 250Faradomus-Faraclonus- (tenuta): 15, 17, 35,
48, 49, 215Feroliti (territorio): 16, 79Feroluso (territorio): 16, 79,Fiore - Flos (territorio): 15, 17Fiore (tenimento1191): 15, 214, 215Fiore (tenimento1194): 15, 57Fiuca o Juca, poi Terrate (tenimento): 15, 57,
215, 233, 251Fiumefreddo (tenimento): 19, 99, 233Fontana Murata (tenimento): 16, 78, 217, 237,
251Forca - Furca o Fisca (territorio): 19, 103, 247,
250Fragulo (tenimento): 215Frasseto (territorio): 29, 174Fravette o Farvetis di Amantea (territorio): 247,
250Gabella -passo- di Fiore (tenimento): 16, 84Gardo Piano o Gradus Planus: (vedi Caldopiano)Garga (tenimento): 215Gemellara (tenuta): 215Gricciano (territorio): 29, 173Grima (territori): 19, 101, 248, 250Lago (territorio): 19, 104Lepore (tenimento): 16, 81Locum Floris (territorio): 15, 16, 204, 215, 216Malo Herede (tenuta): 16, 84Mardati (tenimento): 16, 78, 221, 233, 239Marretis (territori): vedi San Giovanni de Oliva)Mendicino (possedimenti vari): 19Mixi, Missi o Michisci (tenuta): 215, 258Monacaria o Monocaria (tenimento): 21, 251,Montalto (territori): 247Monte Aureo (tenimento): 29, 269, 274Monte Mirteto (tenimento): 158Montecatini - Riaffrico (tenimento): 31, 179,
184, 271Montemarco (tenimento): 15, 58Nocera Inferiore (territori): 24, 264Pandosia (territorio): 19, 103Paola (territorio): 19, 98, 244, 247, 250Pietra Mala o Petramala (tenimento): 19, 100,
247, 250Pietrafitta (difesa): 238Polligrone (tenimento): 16, 81Porciano (territorio): 29, 173Regina (territorio): 19, 103, 244, 250
Rumbuli o Rumbalati (tenimento): 16, 82, 239Rutigliano (tenimento): 16Salice (territorio): 258San Basilio (tenimento) 22, 122San Biagio a Lombrici (territori): 272San Cassiano (territori): 272San Frediano (territori): 271San Giovanni de Oliva (territorio): 248, 250San Giovanni Monacho (tenimento): 16, 85San Iacopo a Pedona (territori): 272,San Martino di Neto: (territorio) 15, 35,San Martino -di Taurianova- (tenimento): 238,San Mauro (Varco) San Mauro (tenimento):
19, 99, 248, 250San Michele a Camaiore (territori): 272San Nicola di Codano (territori): 238San Pietro a Camaiore (territori): 272San Salvatore a Sala di Pietrasanta (territori): 272San Sisto a Ripa (territori): 272Sanduca (tenimento): 22, 118, 120, 121, 257Santa Maria de Uliva (terreni): 250Santa Maria della Porta (territori): 272Santa Severina (terreni): 16Savuto (tenimento): 19, 101, 248, 250Scillopio (tenimento): 16, 82Simigali o Simigari (tenuta): 215Suvarelli o Suberellis (territorio): 19, 101, 250Tacina (tenimento): 83Tassitano (tenimento): 215Turbolo o Turbula (territorio): 19, 103, 247, 250Valle Moriglione (tenimento): 179, 269, 270,
271, 273Vico Moricino (territorio): 29, 172Villa Urbana (territorio): 29, 172, 269Ypsilocrati (tenimento): 16, 83Zucccalatus, Cuccalati o Cucculati (tenimen-
to): 247, 248, 250
GrAnGe
Aiola o Ariola (grangia): 26, 138, 264Alamalta (grangia): 26, 139, 264Arenzano o Arantiani (grangia): 12, 29, 168,
268, 269Bordò-Albe- (Grangia): 16, 54, 72, 73, 216,
221, 233, 234Cariati (grangie Sant’ Andrea): 249Castellace (grangia): 16, 80, 235Cuccalati o Zuccalatus (grangia): 19, 247Droga (grangia): 29, 175Fiuca o Juca (grangia): 16, 57, 74, 75, 233Licilianus (grangia): 26, 139, 264Paola (grangia): 19, 98, 244, 247, 250S. Lucido (grangia): 19, 98San Martino di Canale (grangia): 9, 10, 16, 51,
52, 53, 208, 209, 214, 215, 216, 217, 223, 233, 238, 251
San Martino di Neto: (grangia) 15, 35San Tommaso di Rutigliano (grangia): 16, 76,
77, 230, 267Terrate -di Neto, già Fiuca - (grangia): 251,Torriano (grangia): 28, 157
CAstelli, CAsAli Amantea (casali): 19, 101Corio o Carìa (: 22, 111, 117Cotronei (casale): 258Lacus Sanationis (metà del Casale): 29Ninfa (mezzo Casale): 269Paola (casali): 19, 98, 244, 250Porciano (metà del Castello): 29Terrate (casale di Neto): 233, 251
rendite e diritti speCiAli
Calabria (esenzione del plateatico, passatico): 247, 248
Calabria (facoltà di costruire mulini e batten-dieri- folloni-): 248
Calabria (libera facoltà di raccogliere e tagliare
285
legna nei boschi): 248Calabria (sfruttamento miniere di ferro): 15,
217, 233Calabria (sfruttamento pascoli demaniali): 247Cariati (diritti sugli uomini che vivono sui luo-
ghi di pertinenza): 249Fiumefreddo (porto, trasporto merci e pesca):
19, 246, 247Fuscaldo (porto, trasporto merci e pesca): 248,Isola Capo Rizzuto (porto): 217, 251Ognissanti (chiesa Leeds-Inghilterra), 29, 176,Paola (diritti sugli uomini che vivono sui luoghi
di pertinenza): 247, 250Paola (porto, trasporto merci e pesca): 19, 98,
244, 246, 248Regno di Sicilia (diritto di alienazione di beni
demaniali): 247Regno di Sicilia (esenzione del theleonatico e
portulaggio, anconatico, falancagio di navi e barche in tutti i porti): 248,
Saline di Neto: 15, 58, 204, 215, 216, 234, 235, 254
Santa Maria di Balnearea (abbazia): 29,Tenimento Ruga (sfruttamento miniera di Fer-
ro): 247Terracina (porto): 28Wyngeham (castello-Inghilterra): 29
piCCole proprietà
Acquapuzza - Castro - (tre mulini): 29, 175, 269Amantea (frutteto): 247, 248, 250Amantea (terre): 247, 250Amantea (vigne): 247, 248, 250Balneum a Castellammare di Stabia: 264Cacculati (mulino): 19Caccuri (case, casalini, vigne e orti): 86, 239,Cardone - fiume- (mulini- follone): 16, 208,
215, 217Cariati: (mulini): 249Cerenzia (mulino e follone):217Cosenza (orti): 16, 104Cosenza (casalini): 16, 19, 104, 215, 216, 233,
248Cosenza (case): 16, 19, 86, 104, 215, 216, 233,
248Cosenza (piccoli terreni): 16, 104, 248Cosenza (uliveti): 19, 104, 247, 248Cosenza (vigne): 16, 104, 248Deodato - Casale - (vigne e terre): 233Falconara - Albanese - (mulini): 250Fiume lepre (mulini): 233Fiumefreddo (case): 19, 246, 248, 250Fiumefreddo (mulini e folloni): 246, 248, 250Fiumefreddo (vigne): 19, 248, 250Isola Capo Rizzato (mulini e follone): 217Maiori (spaccio - Planca sive Aphoteca): 265, 266Malovicini -Malvicino- (uliveto): 239, 246Mardati (mulino): 239Neto - fiume - (diversi mulini): 16, 254Ninfa (quattro mulini): 29, 176, 269Nocera Tirinese (case): 19Paola (mulini e folloni): 246Salerno (casa): 246, 247, 250, 264Salerno (frutteto): 246, 247, 250, 264Salerno (vigna): 246, 247, 250, 264San Lucido (casa): 246, 250San Pietro in Guarano (vigne): 233, 246, 247Santa Maria de Uliva (mulini): 250Santa Severina (case): 16, 239Santa Severina (mulini): 16, 82Santa Severina (vigna Cuttufin e altre tre vi-
gne): 239Tiniano (querceto e uliveto): 239Turbulo (case): 250Zucculati - Cuccalati o Cucculati (mulino):
250
GiuspAtronAti
Littlebourne (chiesa) - diocesi di Canterbury: 28, 158
San Berach di Meath (chiesa): 29, 176San Leonardo di Magor (chiesa): 29, 176, Witley (chiesa): 29, 176
ARCIDIOCESI, DIOCESI
AntiChe
Acerenza: 27, 230, 267Amalfi: 26, 265, 266, 274Anagni: 29, 230, 268Armagh: 29Bari: 231, 267Bisignano: 223, 232Canterbury: 28, 158Cassano: 236Castellammare di Stabia: 263Castellaneta: 27Catanzaro: 21, 219, 235, 251, 252, 253Cerenzia (Acherentia-Geruntia): 22, 23, 67,
219, 220, 231, 234, 253, 254, 257, 258Conversano: 230Cosenza: 15, 16, 23, 204, 205, 206, 207, 208,
213, 214, 215, 216, 220, 222, 223, 231, 232, 235, 236, 243, 245, 246, 249, 251, 258, 274
Leeds: 176Llandaff: 29Lucca: 30, 1, 32, 191, 192, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 213, 222, 230, 231, 251, 252, 253, 268, 269, 270, 272, 273
Luni: 273Maiori: 230Martirano: 219Mileto: 245Mottola: 231, 267Ostia: 230, 268, 270, 271Pisa: 273Rapolla: 231Reggio Calabria: 231, 235, 249Rossano: 231, 232, 236, 249, 250, 253Salerno: 266San Marco (Argentano): 232, 236Santa Severina (Metropolia): 16, 22, 67, 70,
217, 218, 219, 232, 235, 249, 254Sermoneta: 268Sorrento: 25, 263, 264Squillace: 219, 232Strongoli: 231, 258Terracina: 269Trani: 231Tropea: 19, 28, 156, 207, 208, 219, 220, 243,
245, 246, 250Velletri: 28, 230, 246, 251, 268, 271Winchester: 28
AttuAli
Amalfi- Cava dei Tirreni: 26Anagni-Alatri: 29Castellaneta: 27Catanzaro: 21Cosenza-Bisignano: 15, 16, 19, 23Crotone-Santa Severina: 22Latina: 28Lucca: 30Massa Carrara-Pontremoli: 32Pisa: 31Sorrento- Castellammare di Stabia: 24, 25
STATI, REGNI, DUCATI, REGIONI
Calabria: 9, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 44, 45,46, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 95, 96, 97, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119, 153, 156, 204, 205, 207, 221,
223, 229, 232, 234, 238, 249, 253, 257, 258, 259, 263, 267, 268, 270, 271, 273, 274
Campania (penisola sorrentina): 9, 24, 25, 26 136, 140, 263, 266
Ducato di Lucca: 30, 31, 32Galles: 11, 29, 176Inghilterra: 11, 28, 29, 158, 176Irlanda del Nord: 11, 29, 17Irlanda: 11, 29, 176Lazio (Lazio meridionale): 9, 28, 29, 150, 155,
166, 167, 168, 170, 171, 268Magor (Galles): 29, 176Meath(Irlanda): 29, 176Patrimonio San Pietro: 28, 29Puglia: 9, 10, 27, 68, 76, 77, 230, 266, 273Regno di Sicilia: 15, 16, 19, 21, 22, 23 24, 25,
26, 27, 204, 205, 207, 216, 217, 218, 232, 233, 235, 236, 237, 247, 254, 257, 263, 266, 267, 274
Toscana (Tuscia): 9, 30, 31, 33, 182, 183, 184, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 213, 230, 259, 268, 269, 270, 271, 273, 274
TOPONIMI
CoMuni, FrAzioni AbitAte, luoGhi
Acquafredda: 23Acquapuzza: 10, 29, 175Acquaviva: 10, 106Agradìa: 55Albe-Bordò: (vedi Bordò)Albeto: 207, 214Altilia di Santa Severina): 22, 112, 117, 254, 257Altura: 29, 174Amalfi: 10, 140Amantea: 19, 101, 246, 247, 248Anagni: 10, 11, 29, 160, 161, 1620, 163, 164,
165,166, 172, 173, 230, 251, 274Angri: 10, 24Apatia: 23Aprigliano: 47, 222Arenzano: (vedi Torre Arenzano)Armagh (Irlanda del Nord): 29Armirò: 117Badia (Fontelaurato): 20Badia (San Pietro di Camaiore): 32Bagnara: 29Barbaro: 21Bari: 76, 77Barletta: 238Barracchella: 50Belsito: 15Belvedere Spinello: 16Beneficio: 96Bisignano: 15, 16, 19Bivio Ramunno: 15Bogiano: (vedi Borgo a Buggiano)Bologna: 231, 233, 247Bonoligno: 15, 35,46, 1 205, 206, 207, 215,
216, 217Bordò: 15, 54, 72, 73, 216. 233Borgo a Buggiano: 10, 31, 183Borgo di Camiore: 33Botrano: 15, 213, 214, 215, 216, 219, 220Bottolo: 16, 214, 216, 217Cabria: (vedi Cravia)Caccuri: 16, 23, 44, 54, 55, 56, 73, 118, 122,
205, 214, 232Calamandea: 66Calci: 10Caldopiano: 19, 100Calosuber (vedi Bonoligno)Caloveto: 16, 69Camaiore: 9, 10, 32, 186, 187, 188, 189, 192,
194, 195, 196, 272Campana: 19, 95, 230, 232, 249Campanisio: 102
286
Campo San Martino: 26Canalaci: 45Canale: 9, 10, 16, 51, 208, 209, 214, 215, 217,
223, 233Canalone: 28, 150Canterbury: 28Capannoni: 30Cappuccini: 156Capua: 234, 236, 26Caput Album: 207, 214Caput Gratis: 207Cardiff (Galles): 29Cardone (fiume e Val di): 16Caria: 117Cariati: 19, 87, 96, 230, 249Casa Agradìa: 55Casa Andrieri: 46Casa Galli: 44Casa Germani: 184Casa Ghiaccetto: 30Casa Giannini: 184Casa Iure Vetere: 15Casa Natalizi: 184Casa Pasquale: 120Casa Raffisi: 97Casa Vincenzano: 97Case (OVS) Tassitano: 47Case Beneficio: 96Casole Trenta: 16, 71Casoli: 195Cassandrella: 204Castania: 107Castel (Castro) San Pietro: 231, 233, 234, 235,
247Castelfranco di Sotto: 10, 182Castellammare di Stabia: 10, 24, 128, 263Castello di Lombrici: 195Castelnuovo del Cilento: 10, 26, 139Castelsilano: 16, 55, 56, 66Castro Acquapuzza: (vedi Acquapuzza)Castrum Nucerie (Nocera Tirinese): 247Castrum Petramala (Cleto): 247Catanzaro: 21, 107, 108, 109, 110, 237, 238,Ceci: 50Ceprano: 236Ceraso:15, 46Cerchiara: 44, 67Cerenzia: 44, 67, 205, 206, 214, 217, 221,
233, 234, 239Chiarito: 140,Cisterna di Latina: 29, 176Cittanova: 16Cleto: 19, 100, 101Collegio: 153Contrada Canaglia: 110Contrada San Nicola: 110Contrada San Vincenzo: 194Contrada Sant’Angelo: 192Contrada Scillina: 110Controne: 10Corazzo: 15, 203, 208Cori: 10, 28, 155Cosenza: 15, 16, 17, 19, 20, 45, 46, 47, 49 67,
69, 71, 95, 96, 97, 153, 205, 206, 207, 208, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 222, 231, 232, 233, 236, 238, 243, 274
Costa Moriglione: 30, 178Cotronei: 119Cozzo Angiolieri: 95Cozzo Sant’Angelo: 95Cravia: 67Crocevia San Pietro: 95Crotone: 22, 48, 54, 55, 66, 70, 73, 75, 117,
118, 119, 205, 217, 221Curiano: 29Cutro: 16Droga: 29Ecce Homo: 67
Escodenzia: 19, 87Falconara Albanese: 19, 102Fantino: 23, 44Faradomus: 15, 17, 35, 48, 49, 215, 222Ferentino: 29, 173Fiore di Anagni: 29, 160, 166Fiore Vetere: 9, 11, 15, 16, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41,42, 43, 46, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222
Fiore: (vedi Fiore Vetere)Fiuca: 16, 57, 75Fiuggi: 10, 29, 171Fiumara Amantea (Catocastro): 247Fiumara Marviano: 108,Fiumarella San Mauro: 55Fiume Ampollino: 118, 238, 258Fiume Arno (Val di): 10, 31, 182, 213Fiume Arvo (Val di): 15, 204Fiume Calopetro: 244Fiume Cardone: 16, 208, 215Fiume Crati (Val di): 97, 207, 208, 234, 235,
237, 239, 247, 248Fiume Garga: 46, 204Fiume Laino (Val di): 207Fiume Lepre (Val di): 44Fiume Lese: 66, 67Fiume Neto (Val di):, 9, 10, 16, 22, 23, 45, 75,
117, 118, 204Fiume Nievole (Val di): 10, 184Fiume Sarno: 24, 263Fiume Serchio (Val di): 10Fiume Sieri: 108Fiume Sinni (Val di): 207Fiume Tacina (Val di): 9, 10, 119Fiume Torbole: 247Fiume Versilia: 197Fiume Vitravo: 75Fiumefreddo Bruzio: 19, 99, 207, 208, 214,
215, 243, 246, 247, 273Flos: (vedi Fiore Vetere)Fondi: 10, 29, 168Fontana di Fico: 68Fontana Trovara: 68Forca o Furca: 19, 103Frasseto (Frasso): 10, 29, 174Frosinone: 29, 166, 171Fuscaldo: 19, 102, 244, 247, 250Galli: (vedi Casa Galli)Gimmella: 239Gricciano: 29Grima: 19, 101Guamo: 10, 32, 191Isola Capo Rizzuto: 16, 217, 237Jacoi: 15, 46Juca: (vedi Fiuca)Jure Vetere: 15, 16, 17Kent: 28, 158L’Annunziata: 77La Chiesiola: 119La Spezia: 196La Vecchia: 168Laconi: 54, 73Lago Ampollino: 47, 119Lago Arvo: 47, 50Lago di Canterno: 171Lago di Porta: 9, 199Lago Savuto: 47Lago: 19Lama di Castellaneta: 68Lama di Palagianello: 68Lamone Annunziata: 77Laterza: 27Latina: 10, 28, 29, 150, 155, 167, 168, 170Le Casaline: 107Le Corde: 107Le Rene: 27Leeds (Inghilterra): 29, 176
Littlebourne: 28, 158Livorno: 196Llandaff (Galles): 29Lombrici: 32, 195, 200Longobardi: 28, 157Longobucco: 253Lucca:, 9, 30, 32, 191, 192, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 213, 222, 230, 270Macchia di Tuono: 66Macchia: 217Magisano: 108Magor (Galles): 29Maiori: 10, 26, 135, 136, 137, 138, 263, 265,Maiori: 26, 236, 264, 265, 266, 274, 275Mandatoriccio: 95Marittima: 29, 268Massa: 200Masseria Lama Carvotta: 27Masseria Le Rene: 27Masseria Petrosa: 68Masseria Torrata: 68Matera: 10Mavigliano: 97Meath (Irlanda): 29Mendicino: 16, 19, 103, 208, 216, 217, 234,
250, 274Messina: 217, 234, 235Molochio: 16Monacaria: 21, 106Montacolle: 184Montagnagrande: 15Montalto Uffugo: 19, 97, 250Monte Arcano: 168Monte Aureo: 29, 160, 274Monte Castello di Pontone: 140Monte del Carrara: 30Monte Falezio: 135Monte Gimmella: 45Monte Iato: 235Monte Latiglia: 168Monte Mirteto: 10, 11, 28, 146, 150Monte Porciano: 10Monte San Biagio: 168Monte Serra: 10, 178Montecalvoli: 10, 31, 180, 269Montecatini (Terme e Alto): 10, 31, 179, 184Montenero: 47Monti Pisani: 10Monti Pisani: 30Montignoso: 199Moriglione (valle): 30Mottola: 68Napoli: 24, 25Nazareth: 216Nicotera: 204Nievole: 184Ninfa: 10, 28, 29, 176, 229, 246, 258, 268, 274Nocera Inferiore: 10, 24Nocera Tirinese: 19, 103, 250Norma: 10, 28, 146, 150, 158, 268Ospedale Civico: 197Palagianello: 68Palermo: 205, 206, 207, 218, 231, 236Paliano: 10Palla Palla: 67Pandosia: 19, 103Pantane: 107Paola: 19, 98, 244, 246, 247, 274Pardice: 67Pardine: (vedi Pardice)Paterno Calabro: 15Pedace: 50, 208, 217Pedona: 32, 196, 200Perugina: 231Pescia: 10Pianore: 182Piazza Baracco: 22Piazza Cesare Battisti: 109
287
Piazza del Popolo: 198Piazza Diaz: 192Piazza San Giovanni: 69Piazzetta San Nicola: 110Piedimonte: 29, 170Pietra Capalbo: 50Pietra Mala: 19, 100Pietrafitta: 9, 10, 51, 208Pietrasanta (vedi anche Sala di Pietrasanta):
197, 199Pisa: 31, 182, 213, 269, 270Pistoia: 183, 184Policastro (Petilia): 235, 238Pollitrea: 22, 111, 119Ponte a Moriano: 10Ponte della Pescarella: 197Ponte sul Neto: 205Pontone di Sacala: 140Ponza: 230Porciano: 29Porta (Beltrame) o Lago di Porta: 32, 196, 199,
200Quaresima: 50Ravello: 138Regina (feudo): 19, 103, 244, 250Riaffrico: 184Ripa di Seravezza: 32, 197, 198, 200Rocca di Neto: 16, 75, 233Rocca di Niceforo: 204Roccabernarda: 16, 70, 254Rogliano: 15, 215Roma: 207, 218, 223, 235Rose: 19Rovigliano: 10, 24Rutigliano: 10, 16, 76, 77Sala di Pietrasanta: 32, 197, 198, 200Salerno: 10, 26, 136, 139, 140, 246Saline di Neto: 15, 58Salto della Cerva: 199San Cataldo: 96San Demetrio Corona: 28, 153San Giovanni in Fiore: 15, 16, 17, 23, 45, 46,
49, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 118, 208, 222
San Giuliano: 10San Iacopo (piazza): 31San Lorenzo: 15, 56San Lucido: 19, 98, 247San Marco: 66,San Mauro (Corigliano): 204, 205San Mauro (Varco San Mauro): 19, 99San Mauro Marchesato: 16San Renato (Via): 25San Taurina: 157Sant’Adriano: 153Sant’Andrea: 96Sant’Angelo (monte): 168Sant’Angelo Sant’Angelo: 28, 15Sant’Anna: 51,Sant’Eufemia: 204Santa Maria a Monte: 10, 31, 182, 269, 270Santa Maria del Giudice: 10Santa Maria: 138Santa Maria: 26Santa Rania (Santa Anania): 22, 118Santa Severina: 16, 22, 67, 70, 217, 218, 219,
235, 239, 257Santo Spirito: 97Savelli: 66Savuto: 19Scala: 10, 26, 140, 274, 275Scalzati: 16, 71Scandale: 16Seravezza: (vedi Ripa di Seravezza)Sermoneta: 10, 29, 170, 175, 268,Serralonga: 15, 46Sersale: 10, 107Sezze: 10, 29, 174
Sila: 10, 15, 47, 203, 207, 214, 215, 219, 238, 239, 254, 255
Sonnino: 174Sorrento: 10, 25Spezzano Parvo (Piccolo): 217Squillace: 238Sterpina: 68Stragola: 44Strongoli, 16, 75Suvarelli: 19, 101Taranto: 27, 68Tarsia: 243, 244Taurianova: 238Terracina: 10, 269Timpa del Salto: 22Timpone Guardiola: 119Timpone Zacarogno: 119Tiniano: 208, 217Tor Tre Ponti: 10, 167Tornese: 117Torre Annunziata: 10, 24, 263Torre Arenzano: 12, 168, 268, 269Torre Tassitano: 47Torrente Argentino: 204Torrente Frappa II: 204Torrente Ispica: 51Torrente Matassa-Lepre: 54, 73Torrente Mavigliano: 97,Torrente Migliarite: 120Torrente Pino Bucato: 15, 204Torrente Regina: 136Torrente Regina: 19, 103Torrente Rio Lombricese: 195Tre Ponti: 29Trepidò: 119Trinchise: 108Trium Capitum: 236Tropea: 19, 28, 156, 207, 208, 219, 220Turbolo: 103Turzano: (vedi Vico Turzano)Valle Benedetta: 31Valle Bona: 205Valle dei Martiri: 168Valle di Camaiore: 196Valle Moriglione: 30, 178Vallecchia: 197Vallecola (di Camaiore): 32, 195Vallecorsa: 168Vallone Bordò: 54, 73Vallone Cerchiara-Ponticelli: 67Vallone della Silica: 27Vallone Grevone: 140,Vallone Marinazzo: 67Vallone Pollitrea: 119Vallone Tardaniello: 66Versilia: 199Via Anticolana: 10, 29, 166Via Appia: 10, 27, 167Via Archi: 17Via Ariella: 17Via Aurelia: 199Via Badia: 32Via capriglia: 197Via Case Beneficio: 96Via Cavone della Badia: 29Via Celestino III: 28, 150Via Cerere Navicella: 160Via Consolare: 10Via dei Giannini: 184Via dei Martiri di Sant’Anna: 197Via dei Salesiani: 197Via del Callone: 182Via della Chiesa: 196Via di Sottomonte: 191Via Fillungo: 191Via Francigena: 9, 29, 32, 192, 194, 196, 197,
199, 200Via Gorizia: 110
Via IV Novembre: 192, 194Via Livornese; 183Via Nuova: 195Via Nuovo Cimitero: 56,Via Papale: 10Via SS. Trinità: 155Via Terrate: 75Via Ville Landi: 191Via Ville prima: 191Vibo Valentia: 156Vico Moricino: 10, 29, 269Vico Turzano: 208, 214, 217Vico: 10, 32, 191Vicolo Concerie: 136Vigna Baracco: 117Villa Bellavista: 183Villa Comunale: 194Villa delle Pianore: 182Villa Urbana (territorio): 10, 29Viterbo: 230Vorno (Fosso-Rio): 30Vorno: 10, 30, 270Winchester: 29Wyngeham (Inghilterra): 29Zagarise: 10, 21, 108, 109, 110
ALTRI COMPLESSI ECCLESIALI NON FLORENSI
Abbazia del (Marmosolio) Valvisciolo: 175, 268
Abbazia di Acquaformosa: 214Abbazia di Casamari: 232Abbazia di Corazzo: 204, 214, 217, 218, 219,
230, 251, 254, 255, 257Abbazia di Fossanova: 268Abbazia di Montecassino: 264Abbazia di San Martino: 232Abbazia Sant’Angelo in Frigilo: 232, 233, 254,
257Abbazia Santa Maria della Sambucina: 205,
206, 214, 217, 219Abbazia Santo Spirito di Palermo: 214, 216,
246Abbazia SS. Trinità: 232Badia di Camaldoli: 273,Cappella Ecce Homo: 67Cappella Marinazzo: 67Cappella Nielio: 67Chiesa del Carmine: 77Confraternita SS. Sacramento: 192Convento dei Minori di Pisa: 273Madonna della Rocca: 168Monastero del Patir di Rossano: 222, 235, 236Monastero di San Giorgio: 230Monastero Vultuense: 231Priorato di Tacina: 232San Giacomo in Platea: 136San Luca a Lucca (ospedale): 273San Magno: 168San Maria delle Pagliarelle (ex chiesa bizanti-
na): 22San Nicola di Myliato (chiesa): 220San Pietro di Cachinis -Tacina- (chiesa): 235,San Pietro e Paolo (chiesa): 155San Tommaso d’Aquino (ex monastero di Ca-
labromaria): 22San Vito di Polignano: 267Sant’Angelo di Ascoli Satriano: 267Santa Cristina (cappella): 182Santa Maria della Valle di Giosaphat (monaste-
ro): 244Santa Maria delle Fosse (monastero): 244Santa Maria di Ferraria: 265, 266Santa Maria Latina (chiesa): 235Santuario dell’Avvocata: 26, 135SS. Trinità di Mileto: 250

























































































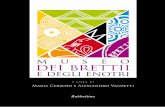



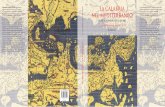





![[rec. a] Alvise Andreose, La strada, la Cina, il cielo. Studi sulla «Relatio» di Odorico da Pordenone e sulla sua fortuna romanza, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2012](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6339de7a2e67deabc605800d/rec-a-alvise-andreose-la-strada-la-cina-il-cielo-studi-sulla-relatio.jpg)

