Cozzo Michelicchio, in M. Cerzoso, A. Vanzetti (a cura di), Museo civico dei Bretti e degli Enotri....
Transcript of Cozzo Michelicchio, in M. Cerzoso, A. Vanzetti (a cura di), Museo civico dei Bretti e degli Enotri....
mu
seo d
ei br
ett
ii e deg
li eno
tr
i
ma c u r a d i
maria Cerzoso e Alessandro Vanzetti
Rubbettino
Ru
bb
ettino
e 49,00
Museo civico dei Brettii e degli EnotriComplesso monumentale di S. AgostinoSalita S. Agostino - 87100 Cosenza - Tel. +39 (0984) 23303 - Fax +39 (0984) 22067www.museodeibrettiiedeglienotri.it - e-mail: [email protected]
Museo dei Brettii e degli EnotriCatalogo dell’esposizionea cura di Maria Cerzoso e Alessandro Vanzetti
Coordinamento redazionale, editing, impaginazione e progetto grafico a cura di Antonio VescioGrafica del logo a cura di Caterina Amendola
Stampato in Italia nel mese di giugno 2014 da Rubbettino print per conto di Rubbettino Editore srl 88049 Soveria Mannelli(Catanzaro) www.rubbettinoprint.it
ISBN 978-88-498-4233-3
© 2014 - Rubbettino Editore88049 Soveria Mannelli - Viale Rosario Rubbettino, 10 - Tel. +39 (0968) 6664201www. rubbettino.it
Progetto cofinanziato con fondi del POR Calabria FESR 2007/2013 L.I. 5.2.2.1
UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA
ITALIANA
REGIONE
CALABRIA
M u s e odei Brettiie degli enotri
C a t a l o g odell’esposizione
a c u r a d i
Maria Cerzoso e alessandro Vanzetti
Rubbettino
V
CATALOGO DELL’ESPOSIZIONE
Indice
VII Presentazione, M. OcchiutoIX Premessa, S. BonomiXI Nota dei curatori, M. Cerzoso, A. VanzettiXV Autori delle schede e dei disegniXIX Referenze fotograficheXXI Abbreviazioni in catalogo e scala delle riproduzioni
Il Museo1 Il Complesso monumentale di S. Agostino, C. Vulcano5 La storia della collezione, M. Cerzoso, F. Quondam17 L’allestimento per il Museo, A. Vanzetti, M. Cerzoso, A. Schiappelli27 Il Museo dei Brettii e degli Enotri: valorizzazione di un territorio, valorizzazione di una città, S. Mancuso
Preistoria e protostoria33 I reperti paleontologici, M.P. Bernasconi35 Il Paleolitico antico e medio della Calabria, E. Spinapolice41 La Calabria dal Neolitico all’età del ferro, V. Tiné, A. Vanzetti45 L’età del ferro del Cosentino nelle collezioni del Museo, A. Vanzetti, F. Ferranti, F. Quondam49 L’età del ferro nel territorio di Crotone, D. Marino
Torre del Mordillo55 Torre del Mordillo: l’abitato, A. Schiappelli61 Pregnanza archeologica della necropoli di Torre del Mordillo, A. Vanzetti65 Caratteri della necropoli di Torre del Mordillo, A. Vanzetti con il contributo di F. Ferranti, F. Quondam71 Le fibule, F. Quondam, F. Ferranti77 L’armamento del guerriero in Calabria durante la prima età del ferro, nel quadro dell’Italia meridionale, S. Abbate85 Il vasellame in ceramica depurata, F. Ferranti91 Il vasellame in ceramica d’impasto, M.A. Castagna
97 Schede di catalogo 1-1104287 Tavole 1-80
Età arcaica e classica373 L’età arcaica, P.G. Guzzo375 Francavilla Marittima, M.T. Granese377 Cozzo Michelicchio, F. Quondam381 Terrecotte architettoniche arcaiche da un santuario greco nel territorio di Sibari, G. Aversa389 La necropoli in contrada Caccia di Favella, M. Cerzoso
395 Schede di catalogo 1105-1319455 Tavole 81-88
VI
MUSEO DEI BRETTII E DEGLI ENOTRI
Età ellenistica e romana469 I Brettii, P.G. Guzzo471 Cosenza metropoli dei Brettii, S. Luppino, M. Cerzoso473 Le necropoli brettie di Villanello e Moio, M. Cerzoso479 I paesaggi dei Bruttii romani, A.B. Sangineto483 Cosenza romana. Appunti per le ricerche future, A. D’Alessio491 Le indagini archeologiche a Palazzo Pompeo Sersale, M. Cerzoso, A. Tosti497 Le indagini archeologiche nell’ex Seminario Arcivescovile, A.B. Sangineto503 Le indagini archeologiche a Piazzetta Toscano, S. Luppino, A. Tosti509 Le indagini archeologiche a Via San Tommaso, A. Tosti515 La tomba alla cappuccina di località Cannuzze, A. La Marca519 Le lucerne di Cerchiara di Calabria, M. Cerzoso527 Le iscrizioni in lingua latina, A. Zumbo
531 Schede di catalogo 1320-1668603 Tavole 89-129
Le monete649 Le monete, A. Polosa
651 Schede di catalogo M1-M300669 Tavole 130-136
Bibliografia681 Indice delle abbreviazioni bibliografiche683 Bibliografia generale
377
ETÀ ARCAICA E CLASSICA
Cozzo Michelicchio
F. Quondam
“I nostri primi saggi furono fortunati”: è con parole fidu-ciose che Francesco Saverio Cavallari informa il Diret-tore Fiorelli dei primi risultati delle sue esplorazioni
nella Serra Pollinara, tra i letti del Coscile e del Crati. È la finedel gennaio 1879 e la prima campagna per la localizzazione diSibari è appena cominciata1.
Giunto in Sibaritide armato di Diodoro Siculo, di Ateneo edella Geografia straboniana, Cavallari si concentra inizialmentesulla fascia di alture che delimitano a occidente la pianura tra idue fiumi, ove “avrebbe potuto trovarsi l’acropoli di Sibari”; in-dividuata una “collina quasi conica, circondata da bassi fondi”,su cui recenti arature avevano riportato in luce “frantumi di ter-recotte antiche”, vi compie saggi e, “a poca profondità”, rinvienetegole e mattoni, una statuetta femminile e “vari frammenti ce-ramici […] i quali parvero doversi riferire al secolo VII. o VI. av.Cr.”2. L’importanza del rinvenimento non sfugge al palermita-no: aveva appena dissotterrato i primi documenti archeologici“che possono appartenere all’epoca della fondazione di Sibari”3.Ma nel giro di pochi giorni i saggi si rivelano infruttuosi e il si-to è abbandonato.
Dieci anni più tardi, Luigi Viola sarà più fortunato: mentrele trivelle operano senza sosta nella pianura, il Direttore dei la-vori compie “continue gite su le alture della Serra Apollinara”in cerca, come il suo predecessore, dell’acropoli della coloniaachea: individuata la collina, vi avvia “un lavoro di scavo; il qua-le non ci fece sentir pentimento d’averlo iniziato”4.
I Giornali degli Oggetti e la restante documentazione d’ar-chivio rintracciata in occasione del nuovo allestimento del Mu-seo, su cui ci siamo già soffermati5, non forniscono sullo scavodi Cozzo Michelicchio novità particolarmente rilevanti, tali daalterare il quadro già tracciato dallo stesso Viola6: la localizza-zione del sito è meglio specificata7; la durata dello scavo circo-scritta alle circa sette settimane comprese tra il 5 dicembre 1887e il 24 gennaio 1888.
Così, dal testo del paragrafo introduttivo al primo GdO ap-prendiamo che nel dicembre 1887, “in seguito ad ordini ricevu-ti dal Vice Direttore Prof. Luigi Viola, sono stati eseguiti due sag-gi di scavo. Il primo non diede alcun risultato soddisfacente per laristrettezza delle dimensioni; mentre l’altro essendo state questemaggiori ha dato alla luce pochi avanzi di antiche costruzioni intufo arenario squadrato”.
Il primo dei frammenti di terrecotte architettoniche, in se-guito erroneamente attribuiti a San Mauro di Corigliano Cala-bro8, è rinvenuto insieme a tegole e mattoni già il 6 dicembre;segue un gruppo di almeno sette altri frammenti, dissotterra-ti tra il 28 e il 30 dicembre 1887, la cui scoperta è tempestiva-mente comunicata a Fiorelli9. Tra i principali bronzi rinvenutidurante il primo mese di scavo figurano inoltre il cavallino cat.n. 1202 (6 dicembre), il pendaglio ornitomorfo cat. n. 1211 (9dicembre) e i pendagli ‘bird-cage’ cat. nn. 1213 (15 dicembre),1215 e 1212 (18 e 19 dicembre); mancano, purtroppo, indica-zioni puntuali sulle modalità di rinvenimento, tali da consenti-
1 Per un breve inquadramento sulle campagne di ricerca ottocentesche,vd. supra, F. Quondam, La storia della collezione, con bibliografia prece-dente.
2 Fiorelli 1879a, pp. 50, 248-249.3 Fiorelli 1879a, p. 249. Sarà poi Galli (galli 1930, p. 27, figg. 11-12)
a identificare i reperti degli scavi Cavallari, depositati presso il municipiodi Corigliano Calabro, e a ordinarne il trasferimento a Reggio Calabria,dove non è stato sinora possibile rintracciarli.
4 gUzzo 1988, pp. 25-26. L’identificazione di Cozzo Michelicchio conil sito già esplorato da Cavallari nel 1879, mai indicato con tale toponimo(vd. infra, nota 7), è in genere accolta in letteratura (da ultima, pace 2005,p. 669), nonostante i dubbi espressi da Viola (secondo cui Cavallari sullaSerra Apollinara “non ebbe il tempo che di fare un saggio di poche ore condue operai”: gUzzo 1988, p. 26). D’altronde, pur avendo identificato an-che altri siti nella Serra Apollinara, è lo stesso Viola a informarci di aver-vi rinvenuto “solo grande quantità di tegole e tegolini” (gUzzo 1988, pp.25, 28): nessuna traccia, quindi, di votivi o altre classi d’oggetti compara-bili con i rinvenimenti di Cozzo Michelicchio.
5 Vd. supra, F. Quondam, La storia della collezione, dove è brevemente
riassunta anche la storia degli studi su Cozzo Michelicchio.6 Ci riferiamo al testo del manoscritto Viola edito da Guzzo (gUzzo
1988), anch’esso citato supra, in F. Quondam, La storia della collezione.7 Generici i riferimenti di Cavallari, che parla di una “collinetta che so-
vrasta la piccola valle detta del Molino”, contrassegnata dall’indicazione“Avanzi Antichissimi” nella pianta a tav. V (Fiorelli 1879a, pp. 50, 248e tav. V); nella medesima tavola è ubicata, in basso a sinistra, la CasinaGruerio, che costituisce uno dei capisaldi per il posizionamento del sitonel manoscritto Viola, dov’è genericamente collocato “a mezza via quasitra [la masseria] Apollinara e la Casina Gruerio”: gUzzo 1988, p. 26. Co-sì invece il Soprastante Tommasini, nel paragrafo introduttivo al GdO 1:“In contrada S. Pietro a Sud della valle così detta del Brachile trovasi unacollinetta denominata Cozzo del Michelicchio, la quale si congiunge alle al-tre adiacenti solamente al lato d’Ovest”.
8 Vd. supra, F. Quondam, La storia della collezione.9 Telegramma di Viola a Fiorelli del 30 dicembre 1888: “Causa genera-
le allagamento pianura ha potuto jeri giungere Apollinara Lavoro trivella-zione intervalli alture Apollinara scopronsi molte terrecotte incrostazionidipinte Viola”.
378
MUSEO DEI BRETTII E DEGLI ENOTRI
re ad esempio di circoscrivere gruppi di oggetti rinvenuti in as-sociazione tra loro, o di delineare casi di contiguità topograficao stratigrafica10.
Con la prosecuzione dello scavo nel gennaio 1888 si rin-vengono nuovi resti strutturali, analizzati con maggiore detta-glio nell’introduzione al secondo GdO: si tratta delle cosiddet-te “basi di colonne”, già note dal manoscritto Viola, delle qualisono meglio specificate forma e dimensioni11. I “pochi avanzi difabbrica” si rinvennero “sparsi a met. 0,30 di profondità dal pia-no di campagna senza alcun nesso, in una zona di circa 600 metriquadrati, essendo stata questa località, in epoca non molto lonta-na, il sito dove i contadini hanno eseguito scavi per ricercare pie-tra tufo”: analogo il resoconto contenuto nel manoscritto Vio-la12.
Ai 230 inventari dei ritrovamenti di dicembre, registrati nelprimo GdO, se ne aggiungono ora altri 261, tra cui il pendaglioa bipenne cat. n. 1210 e l’anello in bronzo con capi revoluti cat.n. 1223, dissotterrati entrambi il 5 gennaio; qualche settimanapiù tardi sarà il turno del piede di tripode cat. n. 1230 (20 gen-naio), mentre tra il 4 e il 16 gennaio sono rinvenuti almeno altriventi frammenti di terrecotte architettoniche.
I ritrovamenti, copiosi sino al 20 gennaio, scemano nei gior-
ni successivi, per poi ridursi solo a poche unità il 24 gennaio:così “Il Direttore dei lavori, avendo osservato che siffatti scavinon davano alla luce altri oggetti, ne ordinò la sospensione, dopodi essersi assicurato con altri saggi che sull’altipiano della collinet-ta citata nulla più si avrebbe potuto rinvenire”13.
Il lungo silenzio che avvolge Cozzo Michelicchio alla conclu-sione delle indagini Viola sarà interrotto da Paolo Orsi, che aiprimi di giugno del 1920 proverà con la sua consueta acribia alocalizzarlo: ma i tentativi dell’archeologo roveretano sono vanie l’esatto posizionamento del sito rimane tuttora incerto14.
Come già Cavallari prima di lui, anche Viola si rende rapida-mente conto che Cozzo Michelicchio non può essere identifica-to con l’acropoli dell’antica Sibari, ma piuttosto con un luogodi culto sito nella sua chora15: tale interpretazione, seguita ancheda tutti i successivi editori, è confermata e rafforzata dal nuovocatalogo complessivo che qui presentiamo.
Espunti dal corpus dei rinvenimenti i manufatti bronzei delprimo Ferro16, l’attivazione del luogo di culto potrebbe forserisalire già all’ultimo quarto dell’VIII sec. a.C. (cat. nn. 1202,1210-1211), all’indomani della fondazione di Sibari e in coinci-denza con l’impianto della fase lignea del santuario di Timpo-ne Motta a Francavilla Marittima17, ma è nel corso del VII sec.
10 I GdO si limitano, infatti, a suddividere i ritrovamenti prima in basealla data di rinvenimento, quindi per materia prima dei manufatti: apro-no gli elenchi giornalieri “dei trovamenti” gli oggetti in argento, ambra,osso e pastiglia, cui seguono quelli in bronzo e ferro; i manufatti d’argilla,in genere ordinati nella sequenza materiali architettonici-coroplastica-ce-ramica vascolare, sono posti in coda. Si tratta comunque di uno schemaflessibile, che conosce numerose deroghe, non solo in rapporto all’effetti-va composizione dei singoli lotti giornalieri di rinvenimenti.
11 “Tra gli avanzi di questo materiale rimasto, meritano di essere menzio-nati alcuni pezzi che si distaccano dalle semplici fondazioni:1º Un pezzo di tufo arenario squadrato di lung. met. 0,88 x 0,80 x 0,23 dispessore il quale ha un lato semicircolare con met. 0,80 di corda.2º Altro di lung. met. 1,00 x 0,85 x 0,35 di spessore avente sulla superficieun rincasso circolare del diametro met. 0,40 x 0,09 di profondità ed al cen-tro vi stà un foro rettangolare di met. 0,16 x 0,13. A fianco del menzionatorincasso havvene altro di forma quasi semisferica, però incompleto nella suaperiferia che misura met. 0,28 x 0,17 di profondità.3º A pochi centim.i di distanza e quasi nella stessa linea se ne rinvenne unaltro il quale misura met. 0,90 x 0,85 x 0,27 ed anche questo ha un rincas-so circolare di diametro met. 0,51 x 0,11 di profondità.4º In fine a quattro metri di distanza e quasi sempre nella stessa linea cioè,da Nord a Sud, trovasi altro frammento di tufo con rincasso circolare, edavente la corda di met. 0,44 x 0,12 di profondità”.
12 gUzzo 1988, pp. 26-27.13 Anche questo passo è tratto dai paragrafi introduttivi al GdO 2 re-
datti da Tommasini.14 orsi 1923, col. 476. In qUilici et al. 1969, p. 130, Torre del Miche-
licchio è identificato con il n. 510, ma gli “Avanzi Antichissimi” dellapianta di Cavallari (vd. supra, nota 7) sono ritenuti corrispondenti al piùsettentrionale sito n. 504. Piero Guzzo (in gUzzo, peroni 1982, p. 25, fig.7) propone la propaggine orientale dell’altura di Casa Caracciolo, sita a68 m s.l.m., corrispondente al n. 507 di qUilici et al. 1969, non privo di
resti archeologici; D’Angelo e Oräzie Vallino (d’angelo, oräzie Valli-no 1994, pp. 800-801) optano per il vasto pianoro alle spalle della Masse-ria Pollinara, dove in qUilici et al. 1969, p. 129, n. 491, si segnalano fitti-li antichi. Nessuna delle localizzazioni proposte sembra comunque coin-cidere con il sito indicato nella pianta di Cavallari, che ricorda invece l’al-tura allungata compresa tra i nn. 504 e 490 di qUilici et al. 1969 (quo-ta 61 m s.l.m. in gUzzo, peroni 1982, p. 25, fig. 7); il posizionamento re-lativo rispetto agli assi stradali riprodotti nella pianta Cavallari potrebbeperò suggerire piuttosto una localizzazione più interna. Sopralluoghi ef-fettuati nel settembre 2013 con A. Vanzetti e M. Gallinaro non hanno da-to riscontri positivi.
15 Così, nella lettera a Fiorelli del 6 gennaio 1888, che accompagna ilGdO 1: “Incominciata la esplorazione, la speranza di trovare avanzi di mo-numenti importanti, i quali avessero potuto designare quello come il sitodell’antica Acropoli, ben presto svanì […]. Dall’insieme degli oggetti rinve-nuti, messi in rapporto con gli avanzi d’edificio si può dedurre che in questalocalità esisteva un tempio antichissimo”. Inoltre, gUzzo 1988, pp. 27-28.
16 Vd. supra, F. Quondam, La storia della collezione. Il GdO 2 menzio-na il rinvenimento, in data 11 gennaio 1888, di una probabile fibula ser-peggiante a occhiello in bronzo, non rintracciata, così descritta: “Grandefibula, composta un’asta di bronzo che ad un estremità facendo ritiene ed inproseguo annodandosi due volte su se stessa continua l’ardiglione ricurvo”.Fibule serpeggianti a occhiello in bronzo ricorrono sporadicamente an-che in sepolture indigene di VII sec. a.C.: de la genière 1991, pp. 109-113, figg. 48, 3-4 e 51 (Murge di Strongoli); de la genière 2012, p. 114,n. 3 (Amendolara, Paladino-Uomo Morto, tb. 195). Questa singola atte-stazione, peraltro non pienamente valutabile, non è quindi sufficiente percomprovare un’occupazione del sito già nel corso del primo Ferro. Pro-viene invece da Cozzo Michelicchio almeno parte della litica già illustrata(vd. supra, E. Spinapolice, Il Paleolitico antico e medio della Calabria).
17 Per la quale kleibrink et al. 2004, pp. 48-55; inoltre, lUppino et al.2012, pp. 646-651.
379
ETÀ ARCAICA E CLASSICA
a.C. che la documentazione si fa cospicua: lo spettro dei rinve-nimenti comprende ceramiche full-sized e miniaturistiche d’im-portazione corinzia e di produzione coloniale, coroplastica vo-tiva, bronzi e ornamenti in ambra, osso, faïence.
Alle fasi più antiche del luogo di culto spettano gli scarabeidel gruppo Perachora-Lindos (cat. nn. 1271-1280), cui dove-vano affiancarsi anche altri aegyptiaca18. Tra i bronzi, predomi-nano in quest’orizzonte fibule e ornamenti: accanto ai pendagli‘bird-cage’ (cat. nn. 1212-1215) compaiono fibule ad arco rive-stito e a sanguisuga (cat. nn. 1203-1207), entrambe note a Fran-cavilla Marittima; eccezionale la presenza di una fibula di untipo transalpino, non altrimenti documentato in Italia meridio-nale (cat. n. 1208).
Nella ceramica corinzia, alle kotylai e alle lekythoi con orna-ti di tipo subgeometrico (cat. nn. 1117, 1122-1124) subentranonella seconda metà del VII sec. a.C. prodotti in black polychro-me style e con decorazione figurata a silhouette (cat. nn. 1118-1121, 1126-1131); precoce è l’apparizione dei coperchi di pissi-di, che dalla prima metà del VII sec. a.C. raggiungono la metàdel secolo successivo (cat. nn. 1132-1137).
Ornati a silhouette ricorrono anche sugli aryballoi, che, do-cumentati a partire dal terzo quarto del VII sec. a.C. nella tipi-ca foggia piriforme (cat. nn. 1138-1140), sono affiancati pocodopo dagli alabastra (cat. nn. 1146-1150), per poi raggiunge-re la metà del VI sec. a.C. con i canonici tipi globulari (cat. nn.1141-1145).
Alla seconda metà del VII sec. a.C. risalgono inoltre le pri-me attestazioni di ceramiche coloniali: prevalgono i kanthari-skoi miniaturistici (cat. nn. 1156-1162), ma non mancano al-tre forme, con significativi paralleli a Francavilla Marittima (cat.nn. 1153-1154); ancora a Timpone Motta rimandano le statuet-te femminili di tipo “dedalico”, che nella seconda metà del VIIsec. a.C. costituiscono le più antiche attestazioni di coroplasticavotiva restituite dal sito (cat. nn. 1177-1185).
Nel VI sec. a.C. sono documentate nuove categorie di ex vo-to. Spiccano le armi difensive, con esemplari sia full-sized (cat.
n. 1226), sia miniaturistici (cat. nn. 1227-1229), mentre solo unapunta di freccia in bronzo superstite documenta l’offerta di ar-mi offensive (cat. n. 1225), in origine ben più consistente: sonoinfatti almeno quindici le cuspidi in ferro registrate nei GdO19.
Tra gli oggetti di parure e legati al vestiario, solo lo spillonein argento cat. n. 1209 è databile al VI sec. a.C., mentre un in-sieme di altri ornamenti è di cronologia incerta (cat. nn. 1216-1224); ugualmente non precisabile è la datazione delle abbon-dantissime lamine bronzee revolute ad anello, in genere ornatecon punti a sbalzo (cat. nn. 1240-1270), documentate in nume-rosi altri complessi cultuali tra Grecia, Italia meridionale e Sici-lia20. Tra le ceramiche, sono frequenti i vasi miniaturistici, conprevalenza di kanthariskoi (cat. nn. 1163-1176).
Per quanto riguarda il vasellame metallico, i GdO menzio-nano coppe d’argento e almeno quattro probabili phialai me-somphaloi bronzee21: gli elementi superstiti annoverano anchearredi bronzei di un certo impegno (cat. n. 1230), ma prevalgo-no anse di varia tipologia, in parte risalenti senz’altro al VI sec.a.C. (cat. nn. 1231-1237). Più che dagli ex voto, la vitalità delsantuario nei decenni anteriori alla distruzione di Sibari è testi-moniata dalle terrecotte architettoniche (cat. nn. 1287-1300), ri-feribili a più edifici di moduli dimensionali differenti, innalzati(o ristrutturati) nella seconda metà del VI sec. a.C.22.
La successiva storia del luogo di culto è più evanescente: co-me Timpone Motta, è probabile che anche Cozzo Michelicchiorisenta della traumatica fine di Sibari. All’assenza di votivi in-quadrabili con sicurezza nella prima metà del V sec. a.C.23 fa se-guito una certa ripresa dell’attività cultuale tra la seconda metàdel V e il IV sec. a.C., in connessione con l’impianto di Thurii:ne sono testimonianza le statuette femminili cat. nn. 1187-1198,comprendenti figure con cerbiatto e con palla, tra cui fa capoli-no Artemis Bendis (cat. n. 1198); la possibile presenza di acroli-ti marmorei è dubbia (cat. nn. 1301-1302). Nessun elemento te-stimonia la sopravvivenza del luogo di culto oltre la fine del IVsec. a.C., orizzonte cui risale anche l’abbandono del santuariodi Timpone Motta24.
18 Galli menziona un pendaglio con immagine di Bes, disperso (galli
1913, col. 476, nota 2). Gli scarabei registrati nei GdO sono in tutto ven-tuno, solo la metà dei quali è stata rintracciata.
19 Tutte frammentarie, a eccezione di una lunga punta di lancia (42 cm)e di due cuspidi di giavellotto (9,5 e 10 cm).
20 Oltre che alle singole schede di catalogo, per un inquadramento ge-nerale si rimanda a papadopoUlos 2003, pp. 92-93 (che raccoglie atte-stazioni non sempre pertinenti). Questi oggetti, variabili per dimensio-ni e ornato e per le modalità di chiusura dei capi (spesso ripiegati sul-le opposte facce della lamina e inseriti l’uno dentro l’altro) sono in gene-re riferiti al mondo degli ornamenti femminili e variamente interpretati(in maniera non del tutto convincente) come diademi, fermatrecce, anel-
li digitali: a Cozzo Michelicchio ne furono rinvenuti più di 580 esempla-ri, spesso raccolti in gruppi di decine sotto il medesimo numero d’inven-tario nei GdO.
21 Rinvenimento del 30 dicembre 1887: “Tazzolina di sottilissima fogliad’argento, con il labbro molto sporgente sul quale havvi ornati a basso rilie-vo”. Per le phialai, così è ad esempio descritto l’esemplare rinvenuto il 10gennaio 1888: “Patera formata di sottilissima foglia di bronzo, avente nelmezzo un risalto di forma semisferica risultante dalla pressione”.
22 Vd. infra, il contributo di G. Aversa, Terrecotte architettoniche arcai-che da un santuario greco nel territorio di Sibari.
23 Solo i cat. nn. 1186 e 1237 si pongono a cavallo tra VI e V sec. a.C.24 Per Francavilla Marittima, granese 2008, p. 418.
380
MUSEO DEI BRETTII E DEGLI ENOTRI
Questo, dunque, il quadro che emerge dall’analisi della do-cumentazione archeologica: tanti i punti di contatto con Fran-cavilla Marittima, sia nella scansione cronologica della storia delsantuario (data d’impianto e d’abbandono; probabile iato incorrispondenza della distruzione di Sibari), sia nelle categoriedi oggetti attestati, quasi tutti ricorrenti identici anche a Tim-pone Motta. Tale identità ‘archeologica’ non è però dirimentenell’individuazione della divinità oggetto di venerazione a Coz-zo Michelicchio. Se registrati all’atto del rinvenimento nelle lo-ro eventuali associazioni contestuali, i ritrovamenti che abbia-mo illustrato ci avrebbero forse consentito di comprendere piùa fondo il regime delle pratiche rituali e dell’offerta votiva delsantuario, ma difficilmente avrebbero potuto fornire indicazio-ni univoche per l’individuazione della (o delle) divinità tributa-ria del culto25: si tratta, infatti, di serie assai comuni, ampiamen-te diffuse nei santuari di Magna Grecia e Sicilia.
Anche la coroplastica, che comprende esclusivamente raffi-gurazioni femminili, non fornisce lumi chiarificatori sull’identi-tà e sugli aspetti assunti dalla divinità venerata: le statuette “de-daliche” presentano caratteri indistinti e i tipi di VI sec. a.C., ingenere più diversificati, sono del tutto assenti26. Se per il Timpo-ne Motta la venerazione di Athena è comprovata su base epigra-fica, a partire dalla prima metà del VI sec. a.C., dalla nota tabel-
la di Kleombrotos, non sussistono indicazioni incontrovertibiliche il culto della dea fosse praticato anche a Cozzo Michelic-chio27, né i dati in nostro possesso sono tali da sostanziare, alme-no per l’età arcaica, interpretazioni alternative: le statuette sug-geriscono che si trattasse di una divinità femminile, ma la suaidentità rimane nell’ombra28. Per la fase turina, qualche lumein più è offerto dalla coroplastica, che comprende raffigurazio-ni di Artemide. Ma la presenza di un singolo esemplare di Arte-mis Bendis non è sufficiente per comprovare l’attribuzione alladea del santuario29: oltre che in luoghi di culto suoi propri (SanBiagio alla Venella nel metapontino), il tipo della Bendis è infattiampiamente documentato anche nei santuari di Demetra a San-ta Maria d’Anglona ed Eraclea, dove Artemis è legata ai ritualipropedeutici all’ingresso nel luogo di culto30; alla dea potrebbe-ro rimandare i pochi altri attributi conservati sulle statuette diIV sec. a.C., ma l’esigua consistenza e lo stato di frammentarie-tà del piccolo lotto superstite impongono prudenza31.
Pur con i limiti imposti dalla documentazione in nostro pos-sesso, l’importanza del complesso di Cozzo Michelicchio, og-gi finalmente ricomposto e presentato in forma integrale, certonon sfuggirà al lettore interessato alla comprensione delle di-namiche di radicamento territoriale di Sibari e delle forme distrutturazione della sua chora.
25 Sul controverso rapporto tra pratiche rituali, coroplastica votiva eidentità delle divinità oggetto di venerazione, parisi 2010.
26 Sulla metodologia interpretativa della coroplastica votiva, fondamen-tale l’analisi di lippolis 2001. Per l’interpretazione delle statuette “de-daliche” di Cozzo Michelicchio come immagine della divinità, granese
2008, p. 442 e supra, P.G. Guzzo, L’età arcaica.27 Come proposto in Martelli 2004, p. 5, con riferimento in partico-
lare alla presenza degli scudi miniaturistici: per la diffusione delle arminei santuari di Magna Grecia e Sicilia e per il loro rapporto ‘polivalente’con le divinità femminili del pantheon greco, la torre 2011 (in part. pp.89-90) e parra 2006 (in part. pp. 232-237). Ad Athena pensa anche pa-ce 2005, p. 670.
28 D’altronde, le stesse problematiche ricorrono anche per un santua-rio assai meglio documentato come Timpone Motta, dove è l’epigrafia acertificare indiscutibilmente il culto di Athena, ma per il quale non man-cano proposte alternative di attribuzione, anche in virtù del carattere ini-zialmente indistinto della divinità e della compresenza di più templi atti-vi contemporaneamente sin dall’impianto del santuario: granese 2008,
pp. 441-450. Per Cozzo Michelicchio, concorrono nell’indicare la venera-zione di una divinità femminile anche la cospicua presenza di ornamentimuliebri e di alcune specifiche forme ceramiche (pissidi, aryballoi e alaba-stra), mentre le forme prevalenti tra le ceramiche miniaturistiche richia-mano lo svolgimento di pratiche libatorie.
29 Come proposto da Fischer-hansen 2009, p. 232.30 Su Artemis Bendis si rimanda a lippolis 2005b, pp. 95-101; berga-
Masco 2006; otto 2008, pp. 81-82; osanna, bertesago 2010, pp. 451-453; parisi 2010. Il tipo compare anche a San Chirico Nuovo: taglien-te 2005, pp. 120-121.
31 Ci riferiamo alla statuetta con cerbiatto cat. n. 2616 e a quella con pallacat. n. 2607; la ritualità di passaggio dall’età infantile a quella adulta evoca-ta da quest’ultima non rappresenta necessariamente, come spesso ritenuto,indicatore esclusivo di Artemis (per Timpone Motta, ad esempio, granese
2008, p. 449), ma costituisce comunque un importante indizio sul regimedelle pratiche votive svolte nel santuario. Infine, è forse identificabile conun melograno l’attributo della statuetta cat. n. 1197, già interpretata comekourotrophos in genoVese 1999, p. 63, ma l’oggetto è di difficile lettura.

















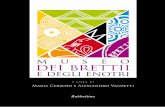



![[rec. a] Alvise Andreose, La strada, la Cina, il cielo. Studi sulla «Relatio» di Odorico da Pordenone e sulla sua fortuna romanza, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2012](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6339de7a2e67deabc605800d/rec-a-alvise-andreose-la-strada-la-cina-il-cielo-studi-sulla-relatio.jpg)





