Mettere radici in città. Donne e relazioni di vicinato negli anni della grande migrazione, in...
Transcript of Mettere radici in città. Donne e relazioni di vicinato negli anni della grande migrazione, in...
© 2011 - Rubbettino Editore88049 Soveria Mannelli - Viale Rosario Rubbettino, 10 - Tel. (0968) 6664201
www.rubbettino.it
Anna Badino
Mettere radici in città. Donne e relazioni di vicinato negli anni della grande migrazione
In un’opera sulla storia della Francia urbana curata da Marcel Roncayo-lo a metà degli anni Ottanta, gli autori di un saggio su “popolazioni e prati-che urbane” scrivevano dell’immigrazione come dell’esperienza che più ca-ratterizza la vita della città contemporanea:
Nous sommes nés ailleurs, nous avons vécu dans quelque autre quartier decette même agglomération ou d’une autre, ou à la campagne. Et même si nous cher-chons incosciemment à rééditer indéfiniment le petite monde familier de notremaison d’enfance et de son quartier, de cette ville et de son enceinte, c’est toujoursen passant plus ou moins par le choc de la découverte et de l’apprendissage ou de laredécouverte de la grande ville, d’un ensemble qui n’est jamais vu ou perçu dans satotalité.” (Chamboredon, Coste, Roncayolo, 2001, p. 570, ed. orig. 1985).
Per il caso di Torino la tendenza molto forte negli anni Sessanta alla mo-bilità della popolazione sul – e attraverso il – territorio urbano è stata ampia-mente documentata dal saggio di Franco Ramella in questo stesso volume.Siamo di fronte a molteplici e continui spostamenti di individui che cambia-no casa, via, quartiere, città e che si troveranno a vivere nel corso della vitauna o più esperienze di sradicamento da alcuni luoghi e di nuovo radica-mento in altri. Su come avvenga questo secondo processo si è riflettuto po-co, almeno in ambito storiografico.
Il capoluogo piemontese può dunque essere un osservatorio significati-vo per cercare di mettere a fuoco alcuni aspetti che riguardano le popolazio-ni urbane in generale.
In questo saggio cercherò di analizzare i processi attraverso cui gli indi-vidui si ancorano allo spazio della città, appropriandosene e attribuendovisignificati, tenendo conto di alcune variabili fondamentali: il genere, l’anzia-nità di stanziamento, la fase del ciclo di vita. Nello studio dei processi di in-tegrazione nel territorio urbano occorre infatti avere presenti queste tre di-mensioni, capaci di condizionare fortemente i percorsi individuali.
35
1. Come si crea un legame con lo spazio urbano?
L’esperienza del radicamento in un quartiere avviene attraverso la crea-zione di relazioni localizzate. In altri termini per poter parlare di radicamen-to lo spazio fisico deve diventare uno spazio di relazioni, uno spazio sociale.
Uno degli elementi che denotano un radicamento nello spazio di resi-denza è la presenza di rapporti di vicinato. La ricerca sociologica mette afuoco gli elementi centrali dei quali occorre tenere conto nell’analisi di que-sto specifico tema: nel condizionare il rapporto di vicinato “la variabile tem-porale, e cioè la durata della residenza, gioca un ruolo rilevante. Essere resi-denti di lunga data o nuovi arrivati fa differenza, così come vivere in insedia-menti vecchi o nuovi, ad alta stabilità o instabilità residenziale. Conta ovvia-mente anche l’ammontare di tempo quotidianamente trascorso in casa: la si-tuazione delle casalinghe, delle persone scarsamente autonome e mobili, deidisoccupati è diversa, sotto questo profilo da quella di coloro che passano,per ragioni di lavoro, gran parte del loro tempo fuori casa”. Ma anche l’età elo stadio nel ciclo di vita sono elementi essenziali nel condizionare l’investi-mento in rapporti di vicinato: “gli adulti con bambini sono ampiamente ri-conosciuti come i più attivamente impegnati nei rapporti di vicinato. Ciò va-le in particolare per le madri, specie se casalinghe, mentre i bambini risulta-no costituire una causa fondamentale dell’intensificazione di tali rapporti”(Mutti, 1992. p. 23). Come ci ricorda Hannerz, già gli studiosi di Chicagoavevano presenti tali fattori. Zorbaugh aveva individuato nell’assenza deibambini la spia che indicava un quartiere povero, se non privo, di relazionidi vicinato. Parlando della zona degli affittacamere di Chicago scriveva: “ibambini sono i veri vicini e questo è un mondo senza vicini” (Zorbaugh,1929. cit in Hannerz, 1992, p. 434)
Queste osservazioni sembrano essere confermate dai materiali di ricercache qui prenderemo in esame, anche se, come vedremo, il quadro sembra ul-teriormente complicarsi. Altri assunti della ricerca sociologica sul tema, infat-ti, risultano meno validi se si tiene conto della mobilità geografica delle per-sone. La questione riguarda ad esempio l’importanza attribuita all’apparte-nenza di classe nella propensione a una maggiore o minore vita di vicinato,che è un aspetto centrale nella sociologia anglosassone sulle città inglesi deldopoguerra. Secondo Allan (1979) la socievolezza della classe operaia sareb-be più legata a un ventaglio ristretto di ambiti quali il vicinato e il luogo di la-voro, mentre la classe media spazierebbe maggiormente, diversificando icontesti di amicizia ed essendo meno vincolata dalla vicinanza geografica.Questi ragionamenti, tuttavia, si riferivano ad un contesto in cui la classe me-dia risultava molto più mobile sul territorio rispetto a quella operaia.
Nel caso degli anni Sessanta a Torino la situazione risulta quasi rove-sciata. Sono soprattutto le masse proletarie a spostarsi da Sud a Nord, anchese non sono le uniche. Se dunque introduciamo la prospettiva della mobilità
36
territoriale degli individui il rapporto tra classe sociale di appartenenza emodelli di socialità diventa nel caso italiano più complesso, con ulteriorinuove variabili. Una di queste è rappresentata dalle modalità attraverso lequali avviene la migrazione (migrazione collettiva o individuale, cioè all’in-terno o all’esterno di fitte catene migratorie, attraverso forme di ricongiun-gimento familiare o no, eccetera).
Inoltre, quanto alla classe operaia urbana e alla sua presunta maggiorepropensione ai rapporti di vicinato, come ci viene suggerito dagli studi an-glosassoni, occorre meglio contestualizzare l’analisi, tenendo conto di un fe-nomeno cruciale che ha caratterizzato l’esperienza di questo gruppo socialea partire dal dopoguerra. Come argomenta Ramella in questo volume, pro-prio gli strati operai sono stati investiti da profondi cambiamenti negli stilidi vita per quanto riguarda i consumi e le relazioni sociali, passando da unmodello street centered ad uno home centered (si veda anche l’articolo diEve, in corso di pubblicazione). In tale passaggio ha avuto un ruolo crucialeil trasferimento da quartieri ad alta stabilità abitativa caratterizzati da retisociali a maglie strette, a quartieri di nuova costruzione in cui le famiglie, al-meno inizialmente, non hanno legami tra di loro e faticano a ricostruirli. Èl’esperienza osservata nel classico studio di Young e Willmott (1957) sulprocesso di trasformazione e di adattamento che il trasferimento da un vec-chio quartiere operaio londinese, Bethnal Green, a un nuovo quartiere diedilizia popolare (distante una ventina di miglia), Greenleigh, comporta nel-la vita relazionale delle famiglie, ma è possibile rintracciare analisi di grandeinteresse su tale esperienza anche in altri autori.
Bourdieu (1977) ad esempio, ci fornisce elementi utili per riflettere suglieffetti di questo tipo di trasferimento sulle donne. Descrivendo il passaggioda una baraccopoli a un quartiere di case popolari in Algeria durante gli an-ni Sessanta, lo studioso rileva come per le donne tale passaggio abbia inatte-si aspetti negativi sul piano delle loro relazioni di vicinato: il venir meno dialcuni fondamentali momenti di incontro con altre donne in occasione deilavori domestici, che prima erano svolti fuori casa e in comune e che nelnuovo contesto sono invece confinati all’interno delle singole abitazioni, hareso molto più solitaria la loro vita.
Sono le donne a soffrire particolarmente per questo restringimento del camposociale (…) Il nuovo habitat isola mentre il vecchio quartiere univa. In una casa del-la Casbah, ad esempio, la separazione degli spazi occupati da differenti nuclei è piùsimbolica che reale. La casa o il quartiere sono il prolungamento dello spazio inter-no. Lo spazio della vita della donna si estende fino alle case o alle camere vicine, fi-no alla fontana, alla drogheria; l’appartamento o la baracca sono circondati da tuttauna serie di punti più o meno lontani, corrispondenti a luoghi differenti dell’attivitàfemminile, attività che riunisce un gruppo che si fa sempre più ampio col cresceredelle distanze: nell’angolo della camera adibito a questa funzione, la donna cucina;nel cortile prende l’acqua e fa talvolta il bucato; sulla terrazza stende la biancheria
37
lavata; al bagno turco, comune a tutto il quartiere, incontra i vicini. Così, la maggiorparte dei compiti che le spettano contribuiscono a inserirla in una rete sociale ester-na alla famiglia propriamente detta. Al contrario, la cellula abitativa di un immobiledeve fornire a coloro che vi abitano tutto ciò di cui hanno bisogno. Tutte le attivitàfemminili (bucato, stesura del medesimo, stiraggio, cucina, ecc.) possono esservirealizzate. (…) Lo sconvolgimento che l’installazione nel nuovo appartamento hadeterminato tocca tutti gli aspetti dell’esistenza. (…) la parcellizzazione della fami-glia e la separazione da vicini familiari inducono l’isolamento della famiglia nuclearee l’allentamento dei legami di solidarietà: non vi è più nessuno con cui passare iltempo per strada; all’ atmosfera viva della bidonville si sono sostituite le relazionisuperficiali e occasionali”.
2. Arrivare da donna in città: l’esperienza delle immigrate degli anni Sessantae Settanta
La mia analisi di alcuni aspetti del processo di radicamento nel territoriourbano si concentrerà sull’immigrazione degli anni Sessanta e Settanta a To-rino che presenta forme di radicamento nella nuova realtà urbana molto di-verse a seconda del genere e della fase del ciclo di vita in cui gli individui sitrovano. Cercherò di riflettere sull’esperienza femminile che, per quanto ri-guarda le migrazioni interne degli anni del boom verso i grandi centri urbanidel Nord, è stata finora poco studiata. Si è dedicata più attenzione all’espe-rienza maschile, che nell’ambito di questo fenomeno ha goduto di maggiorevisibilità. Troviamo alcune informazioni nel noto volume di Fofi (1976) de-dicato all’immigrazione meridionale a Torino, ma le notizie sulla vita delledonne sono per lo più indirette, dal momento che l’autore ha intervistatoquasi esclusivamente maschi. Uno dei rari lavori condotti all’epoca sullacondizione femminile è quello di Fortunata Piselli (1976), che prende inesame l’arrivo delle immigrate meridionali in un’altra grande città del Nord,Milano. Scopo principale di questa ricerca era dimostrare come il passaggiodal mondo rurale alla città industriale non fosse di per sé sufficiente a causa-re un’emancipazione della donna. Al contrario, le precarie condizioni di vitanel nuovo contesto urbano rischiavano, secondo l’autrice, di aggravare unasituazione di subordinazione e sottomissione femminile.
Al di là di tale intento che è estraneo al nostro tema, l’opera risulta oggiutile per fornire qualche descrizione sulla nuova vita delle donne immigratein un quartiere periferico di Milano, il Gallaratese. Il quadro descritto dellavita in questo quartiere di case popolari è quello di un generalizzato isola-mento sociale delle donne immigrate che non lavorano. Le intervistate si la-mentano di trascorrere tutto il giorno in casa, sentendosi delle recluse, masoprattutto di non essere riuscite a legare con nessuno. Attribuiscono la re-sponsabilità di questa difficoltà nell’intrecciare relazioni alla mancanza dei
38
ballatoi che a parer loro rendevano più facile l’interazione tra vicini e dete-stano il nuovo quartiere per l’assenza di servizi e potenziali punti di ritrovo(i negozi di quartiere). L’assenza di luoghi e di occasioni di incontro è rileva-ta anche nel citato studio di Young e Willmott come una delle cause checontribuiscono ad accentuare l’isolamento relazionale delle donne. Ma, co-me la stessa Piselli rileva, sono i criteri di assegnazione delle case popolari adaccrescere le difficoltà nella ricostruzione di rapporti di vicinato. Le famiglieaccedono alle case dello IACP attraverso una graduatoria, il che rende im-probabile che all’interno di uno stabile finiscano persone che si conoscono.
Molto diversa, come si vedrà, è la situazione che si può creare in quartie-ri di edilizia privata, dove invece interi condomini si possono popolare dicompaesani o familiari attraverso il noto meccanismo delle catene migrato-rie. Si pensi al caso della comunità cerignolana a Torino che ha colonizzatoparte del quartiere di Barriera di Milano attorno all’ex piazza Foroni, rino-minata negli anni Ottanta piazzetta Cerignola (Basile, 2003). Il confronto traquesti due casi opposti suggerisce una prima spiegazione del perché alcuniimmigrati riescano a ricreare in città fitte reti sociali di vicinato ed altri ri-mangano in una condizione di isolamento sociale. L’analisi di alcune intervi-ste condotte a donne immigrate a Torino potrà fornirne ulteriori ipotesi dispiegazione1.
3. Diversi modi di inserimento nel nuovo quartiere: una tipologia
a. “buon giorno, buona sera”. L’assenza del vicinato
Il modello migratorio prevalente – anche se non l’unico – negli anni delmiracolo economico vedeva gli uomini arrivare per primi in città, attratti daun mercato del lavoro trainato da alcuni specifici settori che reclutavanopraticamente solo manodopera maschile, come il metalmeccanico e l’edilizia(Ramella 2003). Le donne migravano in un secondo momento, ricongiun-gendosi a mariti, padri e fratelli. Questa condizione di partenza poteva ren-dere per loro più difficile un nuovo radicamento per l’assenza di contattifemminili propri sul posto (parenti o conoscenti originarie dello stesso pae-se). Ma ulteriori fattori potevano contribuire a rendere difficile la costruzio-ne di relazioni sociali localizzate nel quartiere di residenza. Il lavorare in unluogo lontano da casa per l’intero arco della giornata è uno di questi.
In uno studio condotto a Torino su un gruppo di donne immigrate cheabitavano nella stessa scala nei primi anni Ottanta Gabriella Gribaudi face-
39
1 In questo saggio utilizzo interviste in profondità realizzate nell’ambito di diverse ricer-che dal 2004 ad oggi.
va notare come fossero le casalinghe ad avere il tempo di investire in intensirapporti di vicinato. Le testimoni da lei intervistate avevano potuto cono-scersi e frequentarsi con intensità perché non andavano a lavorare fuori: Ab-biamo legato perché eravamo tutte a casa …c’è stato un po’ di tempo da dedi-care all’amicizia… (Gribaudi 1981, p. 226). Quando una di loro trova un im-piego, perché il suo bambino incomincia la scuola, le cose cambiano. Anchese va fiera del nuovo lavoro, riconosce che il fatto di restare fuori casa sei oreal giorno ha avuto delle ripercussioni negative sulla sua vita sociale: ha persoil contatto con le vicine e non è riuscita a crearsi nuove amicizie sul lavoro.Le è capitato proprio ciò che diceva degli uomini, il loro problema è che la-vorano troppo e così, a Torino, sono più isolati delle donne.
Anche nelle mie ricerche sono numerose le testimonianze in cui le don-ne lavoratrici affermano di non avere avuto il tempo di investire sui rapportidi vicinato. Una tra tante è quella di Maria, pugliese sposata con un uomo diorigine calabrese. La donna, immigrata da sola per trovare un lavoro, non haparenti a Torino. Dopo il matrimonio va a vivere in un quartiere semicentra-le (Vanchiglia) e per molti anni lavora come inserviente in una clinica dall’al-tra parte della città (San Donato). Da un lato le risulta difficile frequentarele colleghe all’infuori del lavoro, dall’altro ha poco tempo da dedicare allacostruzione di rapporti di vicinato. La sua vita di relazione è circoscritta allafamiglia del marito e non è localizzata nel quartiere:
Frequentavo i parenti di mio marito, perché io i miei ce li avevo giù. Quando misono sposata, frequentavo la sua famiglia e andiamo avanti ancora così. Sul lavoroavevo tanti amici, ma ognuno a casa sua, non quella cosa, non sono il tipo io che mipiace sapere i fatti degli altri, pettegolare…non sono…. Nella nostra scala “buon-giorno, buonasera”, ognuno a casa sua, non stiamo a fare come tanti …Nel nostrocondominio2 qua è così: ognuno a casa sua, quando ci incontriamo ci salutiamo, manon siamo come alcuni che vanno a chiedere il sale e qui e là. Da noi niente. Se unonon sta bene, uno si presta, ma ognuno si fa la sua vita, non sarei di quel parer, eh?Non mi piace proprio sapere i fatti degli altri. Amico il giusto…Noi qui ci vogliamotanto bene, ma non siamo lì a pettegolare di quello, di quello… Noi quando ci dob-biamo dire qualcosa ce lo diciamo per noi e basta! Quello che diciamo, sia là che so-pra, rimane lì. Non che io vado…no no!
Io andavo a lavorare, non è che stavo a casa, facevo 8 ore al giorno e quando an-davo a casa dovevo fare i miei lavori, e quindi non stavo lì…!
La difficoltà per una donna sposata che lavora lontano da casa nel colti-vare rapporti di vicinato può essere acuita da un altro fattore: la mancanzadi stabilità residenziale. I frequenti cambi di abitazione e di quartiere molti-plicano le esperienze di sradicamento. Emblematico risulta il caso di Isabel-
40
2 Uno stabile del quartiere Vanchiglia, ma costruito negli anni 70.
la, nata a Siracusa nel 1937, arrivata nel capoluogo piemontese nel 1958, do-po aver sposato un operaio metalmeccanico torinese conosciuto quando fa-ceva il militare nella città siciliana. La sua storia abitativa è caratterizzata dadiversi spostamenti sul territorio urbano finalizzati a un avvicinamento alluogo di lavoro del marito: lo stabilimento Fiat di Mirafiori. La prima casadella coppia è all’estremo opposto della città (nel quartiere di Barriera diMilano). Poco dopo il suo arrivo la donna riesce a farsi assumere come ope-raia in una grande azienda di confezioni con sede nel quartiere: la Facis. Madopo qualche anno la famiglia si trasferisce nella zona sud di Torino, con laconseguenza che Isabella deve licenziarsi dal lavoro.
Poi, visto che lui lavorava in Fiat, quindi era troppo lontano per lui, ci siamo av-vicinati e siamo venuti ad abitare a Santa Rita in via Monte Temolo. (…) Poi ci sia-mo spostati che abbiamo comprato l’appartamento in corso Orbassano davanti allaFiat (…) Ci siamo avvicinati al lavoro di mio marito. Io ho cambiato lavoro, non la-voravo più in Facis. Quando vivevo a Barriera di Milano ero vicina al lavoro, equando ci siamo trasferiti sono andata via dalla Facis…quando ci siamo trasferiti invia Gorizia mi sono licenziata dalla Facis e c’era un’azienda tessile, di abbigliamentouomo, in via Gorizia, ma avevano un’altra azienda da donna ad Orbassano. Quandoio mi sono spostata, poi, in Corso Orbassano, sono andata a finire ad Orbassano alavorare.
Non ci sono relazioni di vicinato nella storia di vita di Isabella, come nonci sono rapporti con la parentela del marito tali da rappresentare una fontedi amicizie. La donna trova il modo di costruire una propria rete di relazioniin città attraverso l’attività sindacale. È questa e non il quartiere a costituireil teatro dei suoi rapporti sociali:
Da quando sono arrivata a Torino non frequentavo nessuno, qui c’era solo lasua famiglia e basta. La sua famiglia non aveva amicizie. a parte qualche conoscentecon cui sono cresciuti assieme, o dello stesso paese e che sono venuti a Torino, di-versamente non è che loro socializzassero con qualcuno. C’era il lavoro, la sera a ca-sa, poi l’indomani di nuovo il lavoro. Quella era la loro vita. E la domenica andava-no a prendersi il gelato in centro, oppure andavano a Superga a farsi la gita… Sì, iparenti di mio marito magari facevano i pranzi in famiglia, una volta da uno, unavolta dall’altro, ma sempre tra parenti strettamente. Non c’era questo spaziare…Per me era un morire! Si, un grosso dispiacere. Meno male che poi al lavoro… Nellavoro recuperavo.
b. Il vicinato coeso delle casalinghe
Nora arriva da Napoli a Torino nel 1962 assieme al marito, impiegato al-le Poste, subito dopo le nozze. Ha 26 anni e con il matrimonio lascia defini-
41
tivamente il mercato del lavoro (per dieci anni è stata commessa alla Rina-scente). L’anno successivo partorisce il primo figlio e subito avverte lo spae-samento per il fatto di non avere legami propri sul posto:
Ho avuto il primo bambino, nel ‘63, e quindi mi sono trovata da sola in unacittà sconosciuta, alle prese con il figlio…
Con la famiglia piemontese che vive nel suo pianerottolo si instaura unrapporto cordiale di reciproco aiuto, ma è con la famiglia di origine sicilianache arriverà dopo nella casa dei vicini che si instaurerà una vera amicizia. Lacoppia, arrivata a Torino qualche anno prima, farà da guida per conoscere lacittà e la regione. Le due coppie entrano in relazione perché i mariti sonocolleghi e le mogli casalinghe hanno il tempo e l’interesse a rafforzare il rap-porto di amicizia.
La nuova rete di relazione di Nora nel quartiere si arricchisce in mododeterminante grazie all’incontro derivante da un canale proprio: la figlia diun’amica della madre. A partire da lei la donna ricostruisce una fitta tramadi rapporti, basati sulla comune origine geografica e localizzati in gran partenella stesa scala condominiale:
(…) poi sono arrivati degli altri amici da Napoli, con i quali si è creato, diciamo,una specie di clan.
È stata un po’ una catena. Quando ero ragazza a Napoli, c’erano delle famiglieche erano amiche di mia madre e avevano dei figli più o meno dell’età nostra. Emamma si frequentava molto con queste signore. Io sono venuta a Torino e loro so-no rimaste a Napoli. Quando uno dei figli ha vinto un concorso all’ispettorato dellavoro ed è venuto a Torino, mamma ha detto a questa amica: “Guarda, a Torino c’èmia figlia…” Combinazione ci siamo trovate che abitavamo a un angolo di strada. Equindi la prima è stata lei a venire a Torino. Io sono stata contenta, ma lei ancora dipiù, perché è venuta come me, sprovveduta, anche lei senza conoscere nessuno… epoi a lei, con il tempo, le sono arrivati dei parenti, una sorella dall’Argentina. Equindi si è allargato il clan. E allora tramite questa amica di Napoli che con il maritoci conoscevamo da una vita è stata la prima coppia che è venuta su, e poi è venuta lasorella, poi sono cresciuti i figli… e poi uno chiamava l’altro. Ma non è che ci siamochiamati per lavoro, ci siamo chiamati quando ognuno ha saputo che l’altro era arri-vato e abbiamo cercato di incontrarci….ci vedevamo e ci vediamo ancora spesso.
Non ho avuto nessun disagio ad inserirmi come amicizie.
La descrizione che Nora fa della rete di immigrate che si forma nello stabilein cui vivono, costituita di rapporti vecchi e nuovi, è particolarmente efficace:
In quel palazzo lì abitava la mia amica Rosa al quinto piano, io al quarto piano,al secondo piano abitava quell’amico che è passato adesso e andava dalla moglie, eal quarto piano dell’altra scala abitava la madre di lei. Un giorno l’amministratoredisse: “Io non ho capito bene in questo palazzo che succede: vedo pentole che pas-
42
sano da un piano all’altro…” (…) alla fine la maggior parte eravamo tutti di noi, gliamici che già ci conoscevamo e che ci siamo ritrovati. E il punto di riferimento era lafamiglia dei genitori di rosa – madre e padre, loro erano 4 fratelli – e quindi tutte leoccasioni erano buone per divertirci. E allora veniva Lucia, che era la sorella dellamamma di Rosa. E tutti quanti abitavamo nello stesso posto e tutti quanti stavamo,quando capitava l’occasione, sempre insieme.
È interessante rilevare che questo caso ricorda quello di Cornel, immi-grato rumeno che “riproduce il suo paese a Torino”, descritto da P. Cingola-ni nel suo saggio pubblicato in questo volume. Un’ulteriore conferma delfatto che i processi migratori, indipendentemente dalla lunghezza dello spo-stamento o dal superamento o meno di confini nazionali, possono dar vita ameccanismi analoghi (Arru, Ramella, Caglioti, 2008).
Il radicamento di Nora nella nuova realtà è così forte da spingere la cop-pia a rifiutare il trasferimento a Napoli arrivato dopo tanti anni di attesa.
All’inizio chiedevamo il trasferimento verso Napoli, perché mio marito poteva evoleva un avvicinamento per la mia famiglia e non è riuscito ad averlo. Quando poiglielo potevano dare non lo abbiamo più voluto. Alla fine io ero… Io mi sono am-bientata, poi non sono un tipo difficile, nel senso che faccio amicizia con molta faci-lità, non ho trovato difficoltà, non ho avuto disagi, mio marito aveva il suo lavoro…
Il caso descritto mostra come sia improprio attribuire la propensione airapporti di vicinato ai soli strati sociali di estrazione operaia. La famiglia diNora appartiene al ceto medio impiegatizio, e così le famiglie con le qualientra in relazione. Eppure esse hanno creato una forma di socialità forte-mente legata a uno spazio ristretto del quartiere. Come nota la stessa testi-mone, il fatto di essere immigrati ha spinto questi individui ad unirsi e acreare rapporti di vicinato di tipo comunitario:
(…) quando si è lontani dalla propria città si sente il bisogno di creare una spe-cie di comunità. E allora, io sono stata la prima ad arrivare a Torino di questo grup-po, poi è venuta l’altra, poi l’altra ancora e ci si incontrava, si organizzavano le cose:una partita a carte, le chiacchiere, qualcosa.. e ci si riuniva molto, e ancora adessoquando possiamo ci riuniamo ancora.
Evidentemente queste mogli hanno potuto investire in relazioni di vici-nato tanto strette grazie al fatto di non lavorare fuori casa ed è in particolareattorno all’accudimento dei bambini piccoli che si sono create le situazioniper trascorrere del tempo con altre madri, dentro casa e nei giardini pubbli-ci di quartiere:
Quando avevo i bambini piccoli, al mattino io – quando ero da sola lo facevo dasola e quando è arrivata questa amica Lucia lo facevamo insieme – prendevamo i
43
bambini con i passeggini, perché poi anche lei ha avuto una bambina, li portavamoal parco Rignon, facevamo il nostro giro, quando la primavera era avanzata ci anda-vamo ad abbronzare sulle panchine, i bambini giocavano e noi prendevamo il sole.Poi al pomeriggio ognuno tornava a casa sua e ogni tanto ci vedevamo a cena…
Inoltre il processo di radicamento nel quartiere e nel vicinato è stato favori-to, per queste donne immigrate, dalla presenza di contatti personali propri (enon derivanti dalla rete sociale dei mariti) che hanno svolto un’importante fun-zione di ponte rispetto alla costruzione di una fitta rete di nuovi rapporti.
c. Il vicinato che sostituisce la parentela
I ricongiungimenti con elementi maschili della famiglia emigrati per pri-mi potevano riguardare anche ragazze molto giovani in una fase del ciclo divita che precede il matrimonio. Tipico è il caso di figlie adolescenti mandatea Torino dai genitori per prendersi cura di fratelli maggiori che qui avevanotrovato un lavoro. La storia di Nina, originaria di Melfi, è una delle tante.
Quando nel 1968 arriva in città ha appena 13 anni e, come tiene lei stessa asottolineare, non è ancora “signorina”. Va a vivere con il fratello, che fa il mura-tore, in un minuscolo e poco ospitale appartamento da lui affittato nel quartie-re di Barriera di Milano: un’unica stanza con i servizi esterni affacciata sul corti-le interno, situata al piano terreno di un vecchio caseggiato di ringhiera.
Credo che era autunno, non ricordo bene il mese. Verso novembre, perchéquando sono arrivata c’era la nebbia: questo me lo ricordo. Ricordo questa stazionetutta cupa, così che ero spaventata; questa cosa grande… che non ero andata mai danessuna parte, in poche parole; sono sempre stata al mio paese, che è piccolino.Adesso è un po’ più grande, ma una volta non c’era nulla. (…) Quindi, quando sonoarrivata qui, ero spaventatissima. C’era anche una zia a Torino, però io non volevostar da lei; volevo stare con mio fratello che aveva affittato una stanza (…) vicino aCorso Giulio Cesare. (…) io ero sotto in questo scantinato qua (…) nel cortile. (Miha accompagnato) una conoscente di famiglia, una che si conosceva nel paese, co-mari di cresima. (…); la loro famiglia stava qui e i miei genitori mi hanno mandatocon questi signori; e, quindi, impaurita, spaventatissima perché anche queste perso-ne sì, le conoscevo, ma non è che li conoscessi bene.
La descrizione cupa della misera abitazione e dell’impatto disorientantecon la grande città contrastano con la vivacità e il calore dei rapporti personaliche in breve tempo si creano attorno alla ragazzina all’interno del palazzo incui va a vivere. Il suo compito è occuparsi delle faccende domestiche e accudi-re l’“uomo di casa”, come una piccola adulta, e per un anno vive qui senza igenitori. Ma questa condizione potenzialmente difficile per un’immigrata po-co più che bambina è mitigata dal fatto di poter contare su una fitta rete di re-
44
lazioni di vicinato. Alcuni inquilini del caseggiato sono originari del suo stessopaese, altri sono conoscenze del fratello intrecciate sul luogo di lavoro. Al suoarrivo molti sono perciò pronti ad accoglierla come se fosse “una di famiglia”.Per alcuni diventa una “figlia”, per altri una “sorella minore”.
Quando sono arrivata qui con questi conoscenti c’era una nuora siciliana diquesti signori, che era giovane e che non poteva avere bambini allora; io ero una ra-gazzina credo dolce, che non davo fastidio, ero timida, molto ubbidiente e lei mi hapreso in ben volere, quindi mi trattava come una sorella. (…) Non ero ancora signo-rina quando sono arrivata qua. Lo sono diventata quando ero qua e, quindi, ancoraun altro trauma. Quindi questi signori mi hanno trattato proprio bene e poi ognitanto veniva mia zia lì che anche conosceva, a dare un’occhiata, come si suol dire, eio stavo con mio fratello; ma poi c’era il titolare di mio fratello, che oggi è mio co-gnato, (…) e, siccome era più grande di lui – aveva una decina d’anni in più, era ca-labrese – mi trattava come una sorellina minore. Insomma, si erano tutti affezionatia me, devo dire la verità, mi volevano proprio bene; e, quindi, mi sentivo coccolata.
Nel vicinato la ragazzina trova dunque figure sostitutive dei propri fami-liari. Le donne sposate più grandi di lei diventano un punto di riferimentosu diversi fronti. In primo luogo osservandole apprende regole e trucchi permandare avanti una casa e gestire un budget domestico.
No (amiche coetanee non ne avevo), perché non c’erano; c’erano delle altre fa-miglie. Ecco, c’era una famiglia accanto alla mia, sempre in questi scantinati, peròloro avevano 2 camere – noi ne avevamo 1 – sempre con questo bagno fuori; c’era lamamma, il papà e i figli più giovani. Quindi con loro avevo poi fatto un po’ amicizia;però loro avevano già i genitori qua, quindi erano un po’ più seguiti, anche per farcolazione, mangiare. Mi ricordo un particolare: loro la mattina mangiavano il latte,con tanto pane, me lo ricordo (…) E quindi dicevano non bere tutto il latte, perchése no poi finiva; allora bagnavano tutto questo pane che avanzava il giorno prima,così veniva buono e così ti riempivi la pancia. Era così perché avevano 3 figli, perfarli mangiare. Il lavoro era anche così… e quindi mangiavano così e io vedevo loroe quindi dicevo: “Faccio anch’io così”. Io imitavo perché non ero capace a far tuttequeste cose. Giù ti insegnavano le cose già da piccolini, però non è che ero autosuf-ficiente. Piano piano, chiedendo a questi signori, cominciavo a preparare da man-giare, a lavare le coperte di lana; come facevo non lo so.
Dalle vicine di casa riceve inoltre un piccolo lavoro a domicilio che di-venta, oltre che fonte di guadagno, l’occasione per trascorre il proprio tem-po libero in compagnia quando il fratello è fuori casa. A differenza di lui, in-fatti, Nina non ha la libertà di movimento e le conoscenze per avere una vitasociale esterna al caseggiato. Tutta la sua vita si svolge qui.
Dovevo far da mangiare a mio fratello, lavare la biancheria, fare la spesa; peròpoi mi annoiavo, sì, mi annoiavo.
45
E sì, ero da sola, con questo fratello giovane (18 anni. ndr), che comunque ave-va altre cose da fare; e, quindi, io la sera magari stavo con loro perché non avevonemmeno la televisione. Avevamo una tenda, una cucina con mio fratello e io stavolì. (…) Nel frattempo avevo trovato un lavoretto: facevo le caramelle, perché questasignora qua, la nuora, faceva i fiocchettini di Pasqua, le uova di Pasqua. (Lavorava)per un’azienda: le davano questi fiocchetti da fare, oppure incartare i Cri Cri, le ca-ramelline. Quindi gli dovevi mettere la carta, oppure questi fiocchetti per le uova diPasqua e, quindi, aiutavo anche a fare queste piccole cose. (…) in famiglia, andavoda loro; loro avevano questo, io aiutavo e loro mi davano qualcosa.
Il cortile diventa un’unica grande casa e il vicinato una grande famiglia at-traverso rapporti che ricostruiscono parzialmente il mondo sociale e la vita af-fettiva che con la migrazione si è lasciata al paese di origine. Il bar situato appe-na fuori dal portone dell’edificio è quasi il prolungamento del cortile, il luogoin cui si trascorrono in compagnia le serate estive seduti nei tavolini all’aperto.
Sì (c’era un via vai nel condominio), tutti ragazzi più giovani; c’erano i bar, unavolta si usavano i bar, quindi i ragazzi la sera si intrattenevano così; ma era comun-que una famiglia, alla fine. È logico, in mezzo a questi ci poteva essere anche qualcu-no un po’ più malintenzionato; però erano tutti meridionali, che comunque ci si fa-ceva forza uno con l’altro. C’era questo bar, stavamo lì d’estate. Sì, (anche noi anda-vamo al bar) perché era lì. (…) Però il bar… uscivi dal portone e c’era il bar con i ta-volini; l’attività era tutta lì. D’estate si stava in compagnia lì tutti insieme. Sì (si face-va amicizia), ma tutti ci si conosceva. Si stava bene alla fine, non è come adesso cheti devi guardare, così le porte si lasciavano aperte.
No (non ho patito la solitudine), a parte i primi tempi che dovevo abituarmi allepersone; poi dopo no, perché mi sono fatta volere bene, sì sì.
d. Lavorare nel quartiere
Nei due casi appena descritti il fatto di non lavorare fuori casa ha favori-to l’investimento in relazioni di vicinato. Ma in alcune specifiche condizioniil lavoro extradomestico può non essere di ostacolo alla creazione di tali rap-porti e può addirittura favorirli. Ciò avviene quanto l’occupazione delladonna è svolta all’interno del quartiere di residenza.
Un primo caso di questo tipo è quello di chi possiede un’attività com-merciale vicino all’abitazione che la porta a stare a contatto diretto con ilpubblico. In tali condizioni è possibile consolidare giorno per giorno il lega-me con un vicinato che si sovrappone alla clientela.
Filomena, un’immigrata di origine campana, ha vissuto in modo stabilea Vanchiglia fin dal suo arrivo a Torino nel 1959, avvenuto subito dopo ilmatrimonio per ricongiungersi al marito emigrato qualche anno prima.
Nell’arco di pochi anni la coppia riesce ad aprire il primo negozio di ab-bigliamento di tutta l’area proprio nel centro del quartiere in cui risiede. È
46
nell’ambito di tale attività che la donna lavora per anni sfruttando le compe-tenze sartoriali acquisite al paese, occupandosi delle riparazioni dei capivenduti. Nonostante gli intensi ritmi di lavoro, la testimone si impegna percostruire solide relazioni di vicinato e di quartiere, raggiungendo, nel corsodegli anni, un radicamento molto forte:
Io sono 47 anni che vivo in questa zona, mi conoscono tutti come il sette di denari!
Consapevole dell’importanza di crearsi una rete sociale sul posto, Filo-mena da subito intrattiene intensi rapporti di vicinato tanto con immigratimeridionali come lei, quanto con vicini di origine piemontese:
Sì, con questi vicini calabresi ci davamo una mano e anche con quelli pugliesi. Ame mi volevano bene come ad una figlia. (…) Poiché questa pugliese che aveva la fi-glia che faceva la prostituta aveva due bambini – il marito era finito in galera e lei fa-ceva la prostituta. E la nonna doveva tenere questi due bambini. Allora che è suc-cesso: io, anche se non avevo niente io, compravo due bistecche e gliele portavo.Compravo i biscotti e li portavo ai bambini. Poi quando compravo la verdura nebuttavo più di quella che cucinavo e lei quando mi vedeva buttare le foglie, mi dice-va: “dammele a me, che le cucino io!” E io le davo a lei e lei le cucinava.
Anche a Cuneo siamo stati, che lì avevamo tante amicizie. La famiglia A. abita-vano da me in via Buniva e loro ci invitavano. (…) E poi c’era un’altra famiglia cheerano piemontesi, di Asti, e anche da loro ci invitavano ad andare. Loro avevano lacampagna…Quasi tutti piemontesi abitavano qui una volta. Li abbiamo conosciutiqui all’inizio, subito.
Per entrare in relazione con alcuni vicini piemontesi l’impegno di Filo-mena è maggiore, perché deve superare le loro iniziali diffidenze:
Solo una piemontese, che non so di dove fosse, il figlio era un uomo molto gen-tile, veniva con noi… si trovava… e invece lei: “Voi siete terroni!” e io le facevo: tuun giorno da noi napoletani avrai bisogno!” E infatti…di fronte a casa sua abitavauna famiglia calabrese, lei cade a terra, svenuta, strisciando per terra va a suonare asta famiglia calabrese: “Mi chiamate l’ambulanza che sto male!” e allora quando sta-va meglio io gliel’ho detto: hai visto? Te l’avevo detto io che avevi bisogno di noi“napuli”!” Però dopo ha preso confidenza…. Si vede che i primi anni era un po’ co-sì, che non ci conosceva… e infatti poi il figlio mi ha venduto le case a me.
È dunque il tipo di attività svolta ma soprattutto il fatto che si svolga al-l’interno dello stesso quartiere in cui risiede a permetterle di intrecciaremolti legami e di consolidarli.
Avevo il negozio… abbiamo servito tanta gente: tutti, tutti …(…) noi conosceva-mo TANTA gente! Tantissima proprio! Grazie all’attività abbiamo conosciuto geo-metri, ingegneri, giudici…. pensa che i giudici che abbiamo conosciuto e quelli della
47
polizia non mettono firme per quelli che non con conoscono, e quando è mancatomio marito, loro mi hanno presa, mi hanno portato loro con la macchina, mi hannomesso la firma! Dell’atto di morte di mio marito. Hanno fatto tutto loro, che nessunolo fa, perché vanno in galera pure loro se…e invece me lo hanno fatto. (…)
Avevamo un giro enorme. Prima venivano in via Buniva nell’interno cortile. Mavedesse che c’era. Provi a chiedere a qualcuno! È lì che si guadagnavano i soldi,quando eravamo nell’interno cortile. C’era la coda fino a fuori dell’androne.
Come si è prima accennato, anche alcune caratteristiche del quartiere incui ci si stabilisce possono influire sui modelli di radicamento. I vecchi quar-tieri operai di inizio Novecento erano caratterizzati da una forte prossimitàterritoriale tra i luoghi di lavoro e le abitazioni: le “barriere” nascevano in-torno alle fabbriche (si pensi ai numerosi studi sui quartieri operai “tradizio-nali” delle città industriali). La Torino degli anni sessanta vede molto affie-volito questo legame territoriale tra luoghi della produzione e luoghi di resi-denza della manodopera. Tuttavia, è possibile individuare delle eccezioniche, se osservate in profondità, possono offrire utili suggerimenti d’analisisul tema del rapporto tra donne immigrate e spazio urbano.
Una delle maggiori aziende cittadine che negli anni sessanta ha offertoposti di lavoro alle donne è il Gruppo Finanziario Tessile (GFT), la cui prin-cipale sede torinese era collocata nel quartiere popolare di Barriera di Mila-no. Le vecchie case di quest’area urbana, con i bassi costi, attiravano moltiimmigrati, specie nella fase iniziale dell’insediamento a Torino (cfr. Ramellain questo libro). Alcune famiglie, quando possibile, lasciavano il vecchioquartiere per trasferirsi in altri di nuova costruzione (lo si è visto, ad esem-pio, nel caso di Isabella), dove la qualità delle abitazioni era migliore, ma al-tre rimanevano qui stabilmente. Per la socialità delle donne lavoratrici lapresenza della fabbrica all’interno del quartiere poteva avere un’influenzanon trascurabile. In primo luogo proprio questo nesso stretto tra residenza eluogo di lavoro che caratterizzava la vita di tante famiglie operaie insediatenel quartiere offriva l’opportunità di accedere in tempi brevi a un’occupa-zione. La vicina di casa diventava un canale di accesso al lavoro:
Nel cortile dove abitavamo, una ragazza lavorava in un laboratorio, e alloram’ha fatto andare dove lavorava lei...
In secondo luogo i rapporti stabiliti in fabbrica si rafforzavano fuori dellavoro: abitare vicine rendeva infatti possibile la frequentazione delle colle-ghe, in uno spazio urbano che sembrava facilitare i rapporti.
Sì, compagne di reparto (…) queste abitavano vicine. Ce n’erano tante che sta-vamo vicine.
Subito si faceva amicizia, nel cortile, per la strada, sui pullman. Eravamo così.Poi essendo che eravamo tutti... diciamo “stranieri”, e allora eravamo tanta solida-
48
rietà. Io ho avuto in questi giorni un’amica che... ce l’ho da 40 anni, da quando sonoarrivata, subito dopo poco tempo mi sono fatta amica con lei. Ma prima di questa cene ho una, è pugliese... Questa abitavamo proprio vicine vicine: il suo balcone davadentro il cortile dove stavo io... e prendevamo lo stesso (tram)... andavamo a lavora-re, prendevamo, facevamo la stessa strada...
e. Molti parenti in città: un’alternativa al vicinato?
Uno dei fattori che possono condizionare il rapporto di vicinato è la pre-senza o l’assenza di fonti di socialità alternative (Mutti, 1992 cit.). Nei casiche tratteremo adesso risulta particolarmente rilevante la competizione neiconfronti dei rapporti di vicinato rappresentata dalla rete parentale.
I casi fin qui considerati avevano in comune l’assenza di forti legami diparentela sul posto. Si trattava soprattutto di donne immigrate a seguitodei mariti o dei fratelli che, non potendo contare su punti di riferimentopropri in città, si trovavano a vivere nel periodo immediatamente successi-vo alla migrazione una condizione di isolamento sociale. Tale condizioneveniva superata – se le condizioni lo consentivano – con un forte investi-mento nei rapporti di vicinato. Ma quando invece la migrazione non com-porta una dispersione dei legami parentali – come nel caso di giovani don-ne che emigrano a Torino con la propria famiglia di origine – proprio lapresenza sul posto di parenti stretti che tendono a esaurire la sfera dellasocialità può finire per rappresentare di fatto un impedimento alla crea-zione di nuove relazione nel contesto urbano di arrivo (Cfr. Ramella, 2001cit; e M. Eve, 2001).
Rosa, emigrata a Torino con la famiglia di origine dalla provincia di Reg-gio Calabria nel 1957, nel 1960 sposa un compaesano e va ad abitare nelquartiere periferico di Madonna di Campagna, dove l’uomo ha un negozioda parrucchiere. Per alcuni anni si dedicherà alla cura dei figli e della casa ein seguito troverà lavoro come donna delle pulizie in una caserma del centrocittadino. Un altro caso di donna, dunque, che lavora in un quartiere lonta-no da quello in cui abita:
La casa l’abbiamo comprata nella zona del lavoro di mio marito. Io invece nonsono stata mai vicina. Lui era a quattro passi! Io prendevo i mezzi pubblici. Di soli-to due o tre.
Ma nel caso di Rosa non è soltanto il lavoro a impedirle di investire neirapporti di vicinato. È la parentela presente in città ad esaurire la sfera dellesue frequentazioni, tanto prima, quanto dopo il matrimonio:
Quando sono arrivata qua frequentavo solo la parentela. Anche dopo sposata,solo parenti. (Da nubile) non frequentavo le colleghe di lavoro. Mai. Non avevo l’a-
49
bitudine di andare in giro. Mia mamma poi! Lasciamo perdere. Una volta mica limandava in giro i figli ! No, no.
Dopo sposata neanche, perché tra il lavoro, una cosa e l’altra, poi ho avuto i figli,è finito lì. Andavo a trovare i parenti, mia mamma, mia zia… (…) Con i vicini di casa“Buon giorno” e basta. Erano per lo più meridionali, ma non avevamo rapporti.
Come Rosa, anche Clara emigra con la propria famiglia di origine, com-posta da padre, madre tre figlie e due figli (due rimangono in Sicilia, al paesedi origine). La ragazza ha 13 anni e un anno dopo il suo arrivo, comincia alavorare come operaia in un’azienda dolciaria. Diversamente dalla vicendaappena descritta, in questa seconda storia migratoria sono ben individuabilimodelli di socialità diversi a seconda del ciclo di vita della testimone. La suavita da nubile è caratterizzata da rapporti sociali che esulano dalla ristrettacerchia della parentela e dei compaesani immigrati. Stringe amicizia con al-cune colleghe di lavoro di origine veneta e con loro va a ballare. È attraversoquesto canale che in una sala da ballo conosce il futuro marito, un operaio diorigine ferrarese. Il lavoro le offre l’occasione di entrare in contatto con unambiente sociale non composto esclusivamente da parenti e compaesani, di-versamente dalle sue sorelle – una emigrata già fidanzata – le quali sposeran-no ragazzi dello stesso paese di origine.
Io sono l’unica delle sorelle che ho un forestiero. Perché le altre sono tutte con ipaesani. Al paese si conoscevano fin da piccoli.
Dopo il matrimonio, e la nascita dei figli, la sua vita sociale sembra cam-biare radicalmente, finendo per esaurirsi nella frequentazione della propriaparentela o di quella del marito:
Da sposati frequentavamo solo parenti, di tutti e due. Non c’era differenza. Iparenti di mio marito vivevano (…) vicini, si poteva andare a piedi. Tutti in zona,andavo a piedi o al massimo in pullman. Ci si faceva compagnia o qualche volta siandava anche in campagna. Se avevi i bambini piccoli si andava nei prati… cenaviassieme, facevi due chiacchiere … compagnia.
Questo cambiamento potrebbe essere spiegato in parte con il cambia-mento di situazione occupazionale della donna: non potendo contare sul-l’aiuto della madre per la cura dei figli piccoli, a 23 anni Clara lascia la fab-brica e va a lavorare nel negozio di alimentari della sorella maggiore e delcognato. Il nuovo ambiente di lavoro è costituito da parenti e le amicizie cheaveva intrecciato nel precedente luogo di lavoro, non coltivate quotidiana-mente, finiscono per perdere di importanza.
Ma la socialità di questa donna può essere compresa meglio se osservataanche sotto un’altra prospettiva, utilizzando il modello proposto da Eliza-beth Bott, che mette in relazione modelli familiari e reti sociali dei coniugi
50
(Bott 1957). Il marito di Clara si dimostra molto collaborativo in tutto ciòche riguarda la gestione della casa. Abituato a svolgere lavori domestici finda quando viveva nella famiglia d’origine, l’uomo cucina, amministra la casae svolge una serie di mansioni legate alla gestione domestica.
Lui era più capace di me a fare i lavori di casa. Perché lui era l’unico che aiutava lamamma quando era in casa. Perché lui era capace a fare tutto. Sapeva far da mangiare,tante cose le ho imparate da lui… Perché io ero la più piccola in casa e andando noi fi-gli a lavorare, mia mamma non ci faceva fare niente a noi, per non farci stancare… ioho cominciato a far da mangiare quando mi sono sposata… Allora tra tutti e due…
Io facevo il risparmio, ma anche lui, perché non è mai andato al bar… Lui se hauna lira te ne può fare due, ma non è che sprechi. (…) Poi a casa mia non è mai en-trato nessuno a fare dei lavori, perché lui è capace a fare TUTTO! Tutto tutto.Quindi era già un risparmio.
La gestione domestica di questa coppia sembra aderire perfettamente almodello di famiglia a “ruoli congiunti” teorizzato da Bott, in cui, a una fortecondivisione e collaborazione tra i coniugi per tutto ciò che concerne la sfe-ra familiare corrispondono reti sociali di moglie e marito sovrapposte tra lo-ro, frequentazioni comuni, tempo libero trascorso prevalentemente insieme.In questo quadro si comprende meglio perché la testimone, nella sua vita dasposata, non senta il bisogno di investire in una sfera di socialità propria,magari con le donne del vicinato, che escluda il marito, come nel modellosopraccitato descritto da Gabriella Gribaudi.
Nella casa di quando mi sono sposata era misto: c’erano calabresi, pugliesi…Con alcuni vicini c’era un buon rapporto, ma non da mangiare assieme, o cose delgenere… ma ancora adesso (…) ci incontriamo, ci salutiamo… Forse andando a la-vorare non si aveva tempo di… ma poi io non avevo bisogno di fare amicizie, avevole mie cognate… perché dalla parte di mio marito sono tanti. Quindi avevo tutti pa-renti giovani, io stavo bene con loro. Mi trovavo benissimo con loro. Non c’era pro-blema di andare a cercare in giro altre amicizie… Avevamo le stesse amicizie io e lui.
Conclusioni
L’analisi dei diversi modi di vivere il vicinato da parte delle donne immigra-te negli anni del lungo miracolo economico può offrire alcuni nuovi elementi diconoscenza su un fenomeno cruciale per la storia di Torino, come la grande mi-grazione interna dal Mezzogiorno. Fino ad oggi, come si è detto, l’esperienzafemminile in tale contesto storico è stata, e continua ad essere, poco studiata.
Ma soprattutto, l’osservazione dei processi di radicamento di questaspecifica popolazione in città può offrire qualche utile contributo di rifles-sione al tema generale del rapporto tra individuo e spazio urbano.
51
In questo saggio ho tentato di mettere a confronto i risultati di alcunicontributi tratti dal ricco panorama di studi sul tema del vicinato – dai clas-sici della sociologia sulle città inglesi del dopoguerra, agli studi etno-antro-pologici di Bourdieu sul Maghreb, alle inchieste sulle migrazioni interne inItalia condotte negli anni Settanta – con i materiali da me raccolti riguardan-ti le donne immigrate a Torino negli anni del boom economico.
Sul piano metodologico, l’acquisizione più significativa di questo con-fronto credo consista nell’aver messo in rilievo le importanti implicazionidella mobilità intra ed extra urbana sulla costruzione di relazioni sociali lo-calizzate e sui modi del radicamento nel luogo di residenza. È importante te-ner presente la varietà di modi attraverso cui tale mobilità si può realizzare.Negli studi sulla grande immigrazione interna è stata posta maggiore enfasisulle migrazioni che ricreano in ambiente urbano fitte comunità di compae-sani; negli studi inglesi citati si è dedicata invece più attenzione al processodi sradicamento degli individui a seguito del trasferimento da un vecchioquartiere con reti a maglie strette ad uno di nuova costruzione in cui le per-sone inizialmente non hanno rapporti tra di loro. Ma l’esperienza delle don-ne immigrate a Torino negli anni Sessanta ci ricorda che entrambi i modellisono presenti in questo complesso processo migratorio e che, persino all’in-terno di una stessa storia personale, gli individui possono attraversare diver-se esperienze di sradicamento e ri-radicamento. Le vicende femminili, poi,confermano più che mai il fatto che tale esperienza non possa essere studiataestrapolandola dal contesto familiare (cfr. ad es. Bott, 1957).
Sono dunque molte le variabili di cui occorre tenere conto quando si af-fronta il tema del rapporto tra individui e spazio urbano: la maggiore o mi-nore distanza tra abitazione e luogo di lavoro, la mobilità residenziale sulterritorio urbano le motivazioni che spingono ad investire su un terreno disocialità localizzato nel quartiere di residenza e quelle che invece sfavorisco-no questo processo. Inoltre i canali di socialità cui un’immigrata sposata puòaccedere nella fase iniziale del suo inserimento in città appaiono cruciali.Molto diverso può essere l’esito della costruzione di una nuovi legami sulposto a seconda che si possa contare su canali provenienti dalla propria retesociale oppure da quella del marito. La diversa combinazione di tali variabilipuò dar vita a diversi modelli di radicamento nello spazio. In questo saggiosi è tentato di considerarne alcuni. Ma questo sintetico tentativo e i suoi ri-sultati suggeriscono soprattutto la necessità di approfondire ulteriormente ilproblema, con l’introduzione di nuovi elementi di riflessione.
52
Indice
Introduzione. Città di persone e luoghi. Un percorso di lettura di Maria Carmen Belloni p. 5
PARTE PRIMA
Essere/diventare parte della città
Franco RamellaLa città fordista: un crocevia di movimenti 19
Anna BadinoMettere radici in città. Donne e relazioni di vicinato negli anni della grande migrazione 35
Pietro CingolaniTorino, Romania. Un viaggio negli spazi urbani dell’immigrazione romena 53
PARTE SECONDA
Pratiche dei luoghi
Lorenzo TodescoUna città in movimento. I mutamenti nell’uso dei luoghi tra fordismo e post-fordismo 69
Flavio CeravoloGli spazi a Torino visti e vissuti dai giovani adulti 87
Renzo CarrieroUna mappa dei luoghi dell’infanzia 107
PARTE TERZA
Politiche urbane
Luca DavicoLa sostenibilità nei luoghi urbani 133
Giulia Maria Cavaletto e Manuela OlagneroQualità dell’abitare e innovazionenell’edilizia residenziale pubblica 151
Riferimenti bibliografici 169
Gli Autori 181
Finito di stampare nel mese di ??? 2011dalla Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali
per conto di Rubbettino Editore Srl88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)




























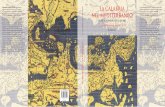



![[rec. a] Alvise Andreose, La strada, la Cina, il cielo. Studi sulla «Relatio» di Odorico da Pordenone e sulla sua fortuna romanza, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2012](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6339de7a2e67deabc605800d/rec-a-alvise-andreose-la-strada-la-cina-il-cielo-studi-sulla-relatio.jpg)
















