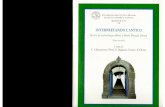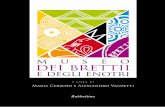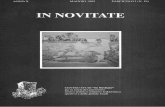Subiaco: rinvenimento di materiali ceramici e osteologici nella grotta in località Le Camere...
Transcript of Subiaco: rinvenimento di materiali ceramici e osteologici nella grotta in località Le Camere...
miniStero per i Beni e Le attività cuLturaLi
Soprintendenza per i Beni archeoLogici deL Lazio
Lazio e Sabina8
a cura digiuSeppina ghini e zaccaria mari
Atti del Convegno
Ottavo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina
Roma30-31 marzo, 1 aprile 2011
edizioni QuaSar
estratto
miniStero per i Beni e Le attività cuLturaLi
Soprintendenza per i Beni archeoLogici deL Lazio
a cura diGiuseppina Ghini e Zaccaria Mari
CoordinamentoGiuseppina Ghini
L’editore si dichiara pienamente disponibile a soddisfareeventuali oneri derivanti da diritti di riproduzione.È vietata la riproduzione con qualsiasi procedimento dellapresente opera o di parti di essa.
© 2012 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
© Roma 2012, Edizioni Quasar di Severino Tognon srlvia Ajaccio 43 - 00198 Roma,tel. 0685358444 fax 0685833591e-mail: [email protected]
ISBN 978-88-7140-476-9
estratto
91
1. Premessa
I risultati dello studio proposto in questa sede sono frutto di comuni riflessioni maturate, da una par-te, in seguito ai recenti scavi archeologici realizzati dall’Università di Roma – “Tor Vergata” presso la Grotta di Mora Cavorso (Jenne)1 e, dall’altra, dai ri-sultati delle indagini svolte in seno al dottorato di ricerca recentemente completato da chi scrive pres-so l’Università di Roma - “Sapienza”, incentrato su tempi, modi e direttrici dello sviluppo patrimonia-le benedettino nella regione sublacense2. Partendo dalla medesima esigenza di definire in maniera più puntuale le evidenze archeologiche presenti sul ter-ritorio3, si sono avviati, con il beneplacito della So-printendenza per i Beni Archeologici del Lazio e, in particolare, della Dott.ssa Maria Grazia Fiore, fun-zionario di zona, diversi survey di superficie nell’alta valle dell’Aniene, ovvero il tratto del bacino idrogra-fico compreso tra le sorgenti del fiume fino a Subia-co, il centro demico di maggiore rilevanza4.
I dati raccolti finora stanno man mano confluen-do in un GIS che, si ritiene, potrà contribuire a ri-costruire tempi e modi, persistenze e trasformazioni dell’insediamento nella regione sublacense, da epoca preistorica fino al Medioevo5.
Il sito che presentiamo oggi, anch’esso oggetto di ricognizione, è ubicato in località Le Camere (lo-calmente “Le Cammore”), a quota 585 s.l.m., poco a nord-est del moderno centro abitato di Subiaco (fig. 1)6. Si tratta di una cavità che era stata già se-gnalata nel 2003 dal gruppo speleologico di Subiaco “Shakazulu”, in seguito al rinvenimento, da parte del proprietario del terreno, Benedetto Appodia, di
1 Per maggiori specifiche riguardo i risultati delle indagini pres-so la grotta di Mora Cavorso si rimanda a Rolfo – Salari – Zarat-tini 2009 e Rolfo – Mancini – Salari – Zarattini 2010.2 Dottorato di Ricerca in Archeologia Post-Classica, “Sapien-za” - Università di Roma (XXII Ciclo). Titolo della tesi: Le dipendenze dei monasteri benedettini sublacensi nel Medioevo: l’alta valle dell’Aniene. (Tutors del progetto Prof.sse Letizia Er-mini Pani e Francesca Romana Stasolla). Per la pubblicazione di parte dei risultati della ricerca: Appetecchia – Mayer c.s.3 Gli incoraggianti risultati ottenuti durante le indagini presso la grotta di Mora Cavorso hanno comportato una necessaria defi-nizione delle emergenze nel territorio, per individuare ulteriori siti verso i quali indirizzare le ricerche. Per quanto riguarda il progetto di ricerca di dottorato, si è scelto un approccio meto-dologico in cui la ricomposizione dei caratteri della maglia inse-diativa precedente lo stanziamento benedettino fosse premessa/presupposto necessario al lavoro, al fine di verificare l’eventuale impatto provocato dall’impianto dei monasteri nel territorio.4 Le ricognizioni, avviate dal 2009 e ancora in corso di svolgimen-to, sono state estese alle cavità della zona segnalate nel Catasto delle Grotte d’Italia, anche alla luce dei significativi rinvenimenti che sembrano suggerire, per la grotta di Mora Cavorso, una fre-quentazione in epoca storica. L’apertura di un saggio antistante la grotta, infatti, già oggetto di parziale esame nella preceden-
te campagna (2009), ha confermato una fase di frequentazione dell’area, protrattasi, in base allo studio dei reperti ceramici e numismatici rinvenuti, dal XVII al XX secolo. I focolari rinve-nuti, l’’alta concentrazione di manufatti intorno a questi, sem-brano potersi identificare come residuo di una frequentazione di carattere rurale-pastorale del sito. La grotta è stata utilizzata, del resto, come riparo per il bestiame fino ai nostri giorni.5 Il GIS, denominato “Anio”, è stato strutturato da chi scrive nell’ambito del progetto di dottorato di ricerca assegnato, te-nendo presente i caratteri di quanto si sta parallelamente realiz-zando per il medio corso del fiume, a cura del Dott. Lorenzo de Lellis e della Prof.ssa Giorgia Maria Annoscia dell’Università di Roma - “Sapienza” nell’ambito del progetto “Valle dell’Aniene”, con leggere differenze strutturali motivate dalle specifiche esi-genze del tema trattato. Il materiale di partenza (ortofoto e car-tografia georeferenziata) è stato gentilmente concesso dal Parco Regionale dei Monti Simbruini che si ringrazia sentitamente per la consueta disponibilità.6 Il toponimo compare nelle pergamene e nei cartulari monasti-ci sublacensi a partire dal 1749, figurando la località come parte integrante delle proprietà del monastero di S. Scolastica, che qui possedeva modesti appezzamenti arativi. Cfr. Archivio del Mo-nastero di Santa Scolastica, Pianta dei possedimenti (23 agosto 1749) e Pianta di un fondo arativo in località Le Camere (1776).
Subiaco: rinvenimento di materiali ceramici e osteologici nella grotta in località Le Camere (Subiaco, Roma)
Maria Grazia Fiore – Agostina Appetecchia – Ivana Fusco – Leonardo Salari – Daria Passacantando
Fig. 1. Posizionamento della grotta in località Le Camere (Stralcio IGM 1:25.000, F. 151, IV NE, Subiaco)
estratto
92
MARIA GRAZIA FIoRE – AGoSTINA APPETECChIA – IVANA FUSCo – LEoNARDo SALARI – DARIA PASSACANTANDo
2. Il dato antropologico
I reperti presi in esame presentano una generaliz-zata frammentazione dovuta in parte alla difficoltà del recupero ed in parte alla tipologia di deposizione stessa dei resti, che giacevano caoticamente sparsi nel sedimento senza alcuna connessione anatomica. Discreto è il loro stato di conservazione, nonostante la natura del deposito suggerisca un ciclico appor-to d’acqua che, insieme ad altri agenti diagenetici, potrebbe essere la causa di alcune alterazioni tafo-nomiche riscontrate sulle ossa. Analizzando il cam-pione è stato possibile verificare la presenza di quasi tutti i distretti anatomici, anche se non ugualmente rappresentati in proporzione al numero di individui stimato. La prima fase dello studio ha riguardato la determinazione del numero minimo, la stima del ses-so, dell’età e della statura degli individui. Il numero minimo di individui è stato determinato sul totale dei crani e delle mandibole, accertando la presenza di almeno 4 individui di cui 2 maschi e 1 femmina, determinabili mediante la morfologia ed i marcatori sessuali di cranio e bacino8. Non determinabile è in-vece il sesso del quarto individuo. La stima dell’età alla morte è stata calcolata sul grado di usura den-taria e sul grado di usura della superficie auricolare dell’ileo9. Il calcolo ha permesso di attribuire i re-perti analizzati a soggetti di età adulta, con un ran-ge compreso tra i 20 ed i 40 anni. In tutti i reperti analizzati l’accrescimento scheletrico è completo, i resti ossei provenienti dal deposito appartengono pertanto tutti ad individui di età adulta. La statura, determinata dalle ossa lunghe degli arti10, è stata sti-mata in media 170-175 centimetri per i maschi e 155-165 per le femmine. Nella seconda fase dell’analisi antropologica è stato osservato il grado di sviluppo delle inserzioni muscolari sulla superficie delle ossa degli arti e dei cingoli11, per verificare la presenza di tracce da stress biomeccanico dovute a specifiche at-tività svolte in vita. Nel complesso le ossa degli arti superiori presentano un grado di robustezza me-dio. Sugli omeri marcata è l’inserzione del muscolo deltoide, responsabile dei movimenti della spalla. Nell’avambraccio più sviluppate sono le inserzioni dei muscoli coinvolti nei movimenti di pronazione e supinazione. Di particolare interesse è la formazione di osteofiti lungo il margine mediale e laterale verso la superficie palmare delle prime falangi sia destre che sinistre, riconducibili verosimilmente allo stes-so individuo, attribuita in letteratura a movimenti di flessione continua delle dita a carico del legamento flessore (grasping)12, ma che potrebbe verosimilmen-
8 Canci – Minozzi 2005.9 Brothwell 1981; Lovejoy 1985; Lovejoy et al. 1985.10 Trotter e Gleser 1952, 1958, 1977.11 Mariotti et al. 2007.12 Capasso et al. 1999.
7 La grotta corrisponde al n. 1576 nel Catasto delle Grotte d’Ita-lia (Foglio IGM 1.25.000 151, IV NE, Subiaco). Si coglie l’oc-casione per ringraziare sentitamente il gruppo “Shakazulu” e i coniugi Emanuele e Alberta Cappa per l’entusiasmo da sempre dimostrato nei confronti delle ricerche avviate nel territorio su-blacense e per la loro fattiva partecipazione alle stesse.
sporadiche ossa e lacerti ceramici affioranti7. In se-guito ai sopralluoghi effettuati nell’autunno del 2009 considerata la volontà del proprietario di obliterare il pozzo con materiale edile, e valutata la consistenza del deposito, che presentava diverse potenzialità ar-cheologiche, si è proceduto immediatamente, d’ac-cordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, al recupero del materiale che altrimenti sarebbe andato perduto.
La cavità si presenta come un’apertura oblunga di m 2 x 0.50, che si sviluppa in verticale lungo ripide pareti per m 15 ca., per ampliarsi sul fondo in una “sala” di m 9 x 2 (fig. 2). La conoide del deposito, insistendo proprio sul fondo della sala, si collocava tra -8 e -12 metri dall’attuale piano di campagna. Per permettere un più agevole accesso allo stretto con-dotto ed il contestuale recupero del materiale, si è dovuto provvedere in primo luogo al leggero am-pliamento meccanico dell’apertura e alla messa in si-curezza della stessa, approntando una carrucola per l’estrazione dei reperti e della terra. Il deposito era costituito da un accumulo di ossa umane, resti fau-nistici e materiale ceramico in terreno sciolto, senza apparente distinzione stratigrafica (A.A.).
Fig. 2. Subiaco. Sezione e planimetria della grotta in località Le Camere.
estratto
93
SUBIACo: RINVENIMENTo DI MATERIALI CERAMICI E oSTEoLoGICI NELLA GRoTTA IN LoCALITà LE CAMERE
na-marrone; diverse ossa giovanili o più fratturate, inoltre, appaiono variamente pigmentate nelle aree di maggiore porosità. Le ossa appaiono in uno stato di conservazione buono, ma sono molto frammenta-te, come si può desumere dal rapporto tra il numero degli elementi anatomici e il numero dei frammenti; secondo il conteggio dei frammenti, infatti, i resti dei bovini risultano sovrastimati (cfr. fig. 3), sia per la loro riconoscibilità che per la maggiore frammenta-zione cui sono state sottoposte le ossa di maggiori dimensioni.
Non sono stati osservati evidenti indizi di contat-to col fuoco, mentre le tracce lasciate da strumenti da taglio e riferibili a pratiche di macellazione (ab-battimento, spellatura e pezzatura) sono numerose, particolarmente sulle ossa di pecore e/o capre e dei bovini. Generalmente si sono conservati integri i denti e le ossa di struttura più compatta e/o che sup-portano porzioni di scarso interesse alimentare, tut-tavia tra le ossa dei suini ce ne sono parecchie inte-gre, comprese alcune, come il femore e l’omero (fig.
ripartiti secondo le dimensioni: quelli di taglia più grande sono ovviamente riferibili ai bovini, quelli di taglia media/piccola si distribuiscono tra le altre spe-cie (cane, maiale, capra e pecora).
I resti ossei e dentari sono prevalentemente di co-lore bianco-avorio, salvo alcune ossa bovine ed un paio di emimandibole di cane che sono di colore ava-
te essere anche l’esito di un trauma. Per gli arti in-feriori è possibile evidenziare un grado di rugosità medio-alto delle inserzioni dei muscoli coinvolti nei movimenti di flessione ed estensione della coscia13. Questo tipo di attività, svolta in maniera intensa e prolungata, ha probabilmente provocato l’appiatti-mento della diafisi di un femore14 e la presenza in un altro del terzo trocantere. Riscontrabili sono anche tracce di movimenti più complessi dell’arto, come la rotazione dell’articolazione dell’anca, visibili nel-la formazione di spicole ossee all’interno della fossa trocanterica femorale15. Le inserzioni muscolari delle tibie invece non sono particolarmente marcate. Solo in una tibia è possibile riscontrare l’appiattimento della diafisi, in genere ricondotto all’uso intensivo dei muscoli del polpaccio. Tracce di un uso intensi-vo dell’arto inferiore provengono anche dalle spicole ossee presenti sulla rotula e sul calcagno16. Lo stato tafonomico e la frammentarietà dei resti non hanno impedito di riscontrare comunque sui reperti diverse patologie. Su 3 dei 4 crani analizzati è stata rilevata una diffusa porosità sul tavolato esterno, riconduci-bile a cribra cranii, mentre in un cranio la forte po-rosità sull’occipitale farebbe addirittura pensare ad un caso di iperostosi porotica17. Per il postcranio, fenomeni di osteoartrosi di grado lieve sono presenti sia sulle teste degli omeri che dei femori, mentre una tibia mostra segni di diffusa infiammazione del pe-riostio18. La cattiva conservazione delle vertebre ha reso impossibile l’osservazione sui corpi di eventuali patologie. Lo studio dentario ha risentito della par-zialità delle ossa mandibolari e mascellari, tuttavia i denti recuperati non presentano particolari affezioni, ad eccezione della lieve presenza di tartaro, di una carie destruente di un primo molare e della perdita ante mortem di un terzo molare. L’analisi sull’ipo-plasia dello smalto condotto sui canini inferiori ha evidenziato almeno tre momenti di rallentamento nell’accrescimento dei denti che testimoniano alme-no tre fasi di stress nutrizionali. I dati presentati sono da considerarsi preliminari, in quanto i resti schele-trici dovranno essere oggetto di più approfondite indagini antropologiche e paleopatologiche, mentre da chiarire resta il loro rapporto con le modalità di formazione del deposito (I. F. – D. P.).
3. Il dato faunistico
Sono stati esaminati 1620 resti faunistici, di cui 698 (43,1%) sono stati determinati a livello tassonomico; 696 appartengono ai mammiferi domestici e 2 agli anfibi, probabilmente intrusi naturali (fig. 3). I fram-menti di coste e vertebre sono stati contati a parte e
16 Capasso et al. 1999.17 Fornaciari – Giuffra 2009.18 Fornaciari – Giuffra 2009.
13 Capasso et al. 1999.14 Buxton 1938.15 Capasso et al. 1999.
taxon NF % NME % NMI %Rospo 2 0,3 2 0,3 1 2,9
Cane 51 7,3 47 8,1 4 11,4
Maiale 104 14,9 87 15,1 5 14,3
Bue 205 29,4 140 24,2 6 17,1
Capra 46 6,6 45 7,8
Pecora 69 9,9 66 11,4
Pecora e/o Capra 221 31,7 191 33,0 19 54,3
tot. determinati 698 43,1
coste GT 64 4,0
coste m/pT 242 14,9
vertebre GT 46 2,8
vertebre m/pT 117 7,2
indeterminati 453 28,5
TOTALE 1620 100 576 100 35 100
Fig. 3. Grotta in località Le Camere: numero dei frammenti (NF), numero minimo degli elementi anatomici(NME) e numero mi-nimo degli individui (NMI); GT: taglia grande, m/pT: piccola e media taglia. Le percentuali dei frammenti dei singoli taxa sono calcolate sul totale dei resti determinati; le percentuali di coste, vertebre, indeterminati e totale determinati sono calcolate sul to-tale generale.
estratto
94
MARIA GRAZIA FIoRE – AGoSTINA APPETECChIA – IVANA FUSCo – LEoNARDo SALARI – DARIA PASSACANTANDo
dei bovini (fig. 5). I maiali (1 giovanissimo, 2 giovani e 2 adulti) erano utilizzati ovviamente per la carne, mentre i piccoli e i grandi ruminanti potevano forni-re anche altre risorse. Le pecore erano poco più nu-merose delle capre (fig. 3) e l’andamento dell’età di morte delle due specie considerate congiuntamente (3 giovanissimi, 3 giovani, 8 giovani-adulti, 2 adulti di 2-3 anni e 3 adulti tra 3 e 5 anni) indicherebbe uno sfruttamento del gregge primariamente per la carne, mentre sembra che ci sia stato minore interesse per il latte e la lana: la grande maggioranza dei capi (68%), infatti, era abbattuta tra i 6 mesi e il terzo anno di vita, quando una maggiore quantità di carne viene resa con più bassi costi di produzione. Anche i bo-vini (3 giovani, 2 adulti e 1 senile) potevano fornire carne pregiata, ma anche il latte, la forza lavoro e il letame per l’agricoltura, le corna, le ossa e le pelli da lavorare; l’alta percentuale di giovani (50%) non è molto frequente in Italia centrale durante il I millen-nio a.C.: solitamente i bovini erano abbattuti in età avanzata, a fine carriera, quando non erano più utili nel lavoro agricolo o nella produzione di latte21.
Le altezze al garrese, ricavate moltiplicando le lun-ghezze massime di alcune ossa degli arti per i coeffi-cienti di Teichert e di Schramm22, prospettano l’esi-stenza di maiali alti tra cm 60 e 62, di capre alte cm 66-67 e di pecore alte tra cm 60 e 65. Non è stato pos-sibile stimare l’altezza al garrese dei bovini, ma sono state rilevate alcune misure significative23. Utilizzando i coefficienti di harcourt e di Clak24, inoltre, risulta che i cani erano alti tra cm 49 e 55; considerando la snellezza degli arti e l’altezza al garrese, infine, i cani di Sublaqueum erano di taglia media e con arti slanciati e avevano plausibilmente un aspetto generale interme-dio tra i moderni setter e wippet (L. S.).
4, c), che supportano porzioni palesemente ricche di carne. Anche un IV e un V metacarpo di cane presen-tano tracce di strumenti da taglio (spellatura?) (fig. 4, a-b). Non c’è certezza che anche i cani (1 giovane e 3 adulti) siano stati consumati, tuttavia esiste una vasta letteratura sulla cinofagia, praticata usualmente nella pre-protostoria19. Nel I millennio a.C. in Italia centro-meridionale l’uccisione di cani è documenta-ta prevalentemente in contesti cultuali, sia nelle pra-tiche di sepoltura dell’animale (area perimetrale di Fidene, necropoli di Porte di Ferro, Poggio Somma-villa, Amelia e Sulmona), sia nei rituali con sacrificio di animali (santuari di Pyrgi, Eraclea Lucana e Sa-triano, area sacra di Sant’omobono a Roma, stipe di S. Cecilia a Anagni, pozzo US 469 a Veio, bothroi di Locri Epizefiri, di Vaste e dell’Heraion alla foce del Sele)20. Il sacrificio del cane, inoltre, è descritto nelle Tabuale Iguvinae e trova vasta eco nella letteratura classica (inter alios ovidio, Plinio il Vecchio, Festo, Columella, Pausania, Plutarco, Eliano).
Tra gli animali solitamente utilizzati nell’alimen-tazione, sia considerando il numero dei resti che il numero minimo degli individui, sono più numerose pecore e/o capre, seguite dai bovini e poi dai maiali, mentre, considerando la carne che questi animali po-tevano fornire, risulta evidente la grande importanza
23 Lungh. M3: mm 34,1-40,5; diam. trasverso prossimale del ra-dio: mm 87,2; diam. trasverso distale del radio: mm 78,4-87,6; diam. trasverso distale del femore: mm 77,2-99,0; diam. trasverso prossimale della tibia: mm 98,1; diam. trasverso distale della tibia: mm 65,5 - 66,5; lungh. laterale dell’astragalo: mm 69,7-70,4.24 harcourt 1974; Clark 1995.
19 De Grossi Mazzorin – Tagliacozzo 2000 con bibl.20 De Grossi Mazzorin – Minniti 2000; Wilkens – Delussu 2002; Salari – Sardella 2005; Coppola 2006; Salari et al. 2006; De Grossi Mazzorin 2008; Cucinotta et al. 2010.21 De Grossi Mazzorin 2006.22 Schramm 1967; Teichert 1969; Teichert 1973.
Fig. 4. Grotta in località Le Camere: cane: a) IV metacarpo, b) V metacarpo; maiale: c) omero (riferimento metrico: cm 5; ingrandimenti: 300%).
Fig. 5. Grotta in località Le Camere: numero dei frammenti, degli individui e resa in carne dei principali animali domestici.
estratto
95
SUBIACo: RINVENIMENTo DI MATERIALI CERAMICI E oSTEoLoGICI NELLA GRoTTA IN LoCALITà LE CAMERE
ti curve e piede “sub-rettangolare”, affine alla serie Morel 2783, che appartiene al tipo dell’Atelier des petites estampilles (fig. 7, a). La presenza di un uni-co bollo centrale, di dimensioni pari a cm 1 ca., ci permette di inquadrare cronologicamente il reperto intorno alla metà del III secolo a.C., momento per il quale, è noto, si colloca il passaggio dai bolli late-
5. I reperti ceramici
Il contesto in esame ha restituito, finora, 220 reperti ceramici, caratterizzati da un indice di frammenta-rietà piuttosto consistente25 (fig. 6).
La ceramica a vernice nera è quantificabile in 34 frammenti; tra questi si distingue una coppa a pare-
struibili. Molti dei reperti si presentano fluitati, con smussature degli spigoli, segno evidente di ripetuto contatto con acqua.
25 È stato possibile identificare solo il 23% del materiale ceramico rinvenuto (50 frammenti su 220 totali), pertinenti a 29 vasi rico-
CLASSI CERAMICHE FORMA PRODUZIONE TIPO DATAZIONE Vasi Frr. Fig. Ceramica a vernice nera Coppa Petites Estampilles Morel 1981, 2783g 1
Ferrandes 2008, GPS IV/V260-210 1 1 Fig. 7, a
Ceramica a vernice nera Coppetta Morel 1981, 2783 1 1 Fig. 7, b
Ceramica a vernice nera Coppetta Morel 1981, 2783 1 4 Fig. 7, c
Ceramica a vernice nera Coppetta Miniaturistica
Morel 1981, 2783a III a.C. 1 3 Fig. 9, d
Ceramica a vernice nera Coppetta Miniaturistica
Morel 1981, 2783 1 2 Fig. 7, e
Ceramica a vernice nera Piatto da pesce Petites Estampilles Morel 1981,1124b 1 285-220 ca. 1 1 Fig. 7, f
Ceramica a vernice nera Piattello Gruppo Genucilia Morel 1981, 1112a 1 330 ca-250 1 1 Fig. 7, g
Ceramica a vernice nera Non id. Non id. Non id. / / 21
Ceramica depurata Cratere Laziale Morel 1981, 3524 a2 Fine IV-inizi III a.C. 1 10
Ceramica depurata Non id. Non id. Non id. / / 11
Impasto Sabbioso olla Non id. Non id. 1 1
Impasto Sabbioso olla stamnoide Laziale Moltesen-Brandt 1994, p. 117, fig. 77, n. 203
IV-III a.C. 1 1 Fig. 9, a
Impasto Sabbioso Mortaio Laziale Auditorium, tav. 32, n. 281 IV-III a.C. 1 2
Impasto Sabbioso Piccolo dolio Laziale Moltesen-Brandt 1994, p. 133, fig. 82, n. 296
Fine IV-seconda metà III
1 6 Fig. 9, b
Impasto sabbioso Non id. Non id. Non id. / / 50
Internal Slip Ware olla Laziale T. - T. 1970, fig. 31, A, n. 9 Metà III a.C. 1 8 Fig. 9, c
Ceramica comune da cucina olla Laziale Dyson 1976, fig. 2, CF 17 275-150 1 1 Fig. 10, a
Ceramica comune da cucina olla Laziale T. - T 1970, fig. 28, h, n. 1 Fine IV-280 1 1 Fig. 10, b
Ceramica comune da cucina olla Laziale Dyson 1976, fig. 2, CF 26 275-150 1 1 Fig. 10, c
Ceramica comune da cucina olla Laziale Dyson 1976, fig. 2, CF 26 275-150 1 1
Ceramica comune da cucina olla Laziale Dyson 1976, fig. 2, CF 26 275-150 1 1
Ceramica comune da cucina olla Laziale Dyson 1976, fig. 4, CF 42 275-150 1 1 Fig. 10, d
Ceramica comune da cucina Pentola Laziale Dyson 1976, fig. 8, FG 17 200 ca. 1 1
Ceramica comune da cucina olla Non id. Non id. / 1 1
Ceramica comune da cucina olla Non id. Non id. / 1 1
Ceramica comune da cucina Piccolo tegame Laziale Moltesen-Brandt 1994, p. 127, fig. 80, n. 269
Fine IV-seconda metà III
1 2 Fig. 10, e
Ceramica comune da cucina Presa di Coperchio
Laziale T. - T. 1970, fig. 25, C, n.7 Fine IV-seconda metà III
1 1 Fig. 10, f
Ceramica comune da cucina Presa di Coperchio
Laziale T. - T. 1970, fig. 25, C, n. 8 Fine IV-seconda metà III
1 1 Fig. 10, g
Ceramica comune da cucina Ciotola-Coperchio
Laziale T.-T. 1970, fig. 24, B, n. 2Stanco 1988, tav. 2, n. 15
Fine IV-280 1 1 Fig. 10, h
Ceramica comune da cucina Ciotola-Coperchio
Laziale T. - T. 1970, fig. 24, B, n. 4Stanco 1988, tav. 2, n. 15
Fine IV-280 1 3 Fig. 10, i
Ceramica comune da cucina Ciotola-Coperchio
Laziale T. - T. 1970, fig. 24, B, n. 5Stanco 1988, tav. 2, n. 15
Fine IV-280 1 4 Fig. 10, l
Ceramica comune da cucina Non id. Non id. Non id. / / 50
Anforaceo Non id. Non id. Non id. / 1 33
Opus doliare Non id. Non id. Non id. / / 5Totale 29 220
Legenda: Auditorium = Carandini - Di Giuseppe - D’Alessio 2006; Artena = Lambrechts 1989; T. - T. 1970 = Threipland - Torelli 1970
Fig. 6. I materiali ceramici rinvenuti nella grotta in località Le Camere.
estratto
96
MARIA GRAZIA FIoRE – AGoSTINA APPETECChIA – IVANA FUSCo – LEoNARDo SALARI – DARIA PASSACANTANDo
Morel 1124 (fig. 7, f)29 e un piattello del tipo Genu-cilia, purtroppo molto mal conservato, con modesto diametro all’orlo e vasca poco profonda (fig. 7, g)30. Per quanto riguarda le coppette miniaturistiche, si vogliono sottolineare stringenti confronti morfo-logici e tecnologici con alcuni materiali pertinenti una ricca stipe votiva rinvenuta, negli anni Quaran-
rali di piccole dimensioni ad uno solo di dimensio-ni maggiori26. Il nostro si presenta come una rosetta di otto petali con punto centrale e corona di otto puntini intorno ai petali stessi (fig. 8)27. Sono state identificate, poi, due coppe a pareti curve di minori dimensioni (fig. 7, b-c)28, due coppette miniaturisti-che (fig. 7, d-e), un piatto da pesce affine alla serie
lare a Morel 1124b 1: presenta orlo arrotondato e labbro pendu-lo a profilo curvilineo, superiormente distinto dalla vasca da una sottile scanalatura. L’argilla dell’impasto è di colore arancio chia-ro, dura, a frattura irregolare. La vernice è nera lucida, coprente e ben aderente. Il piatto viene comunemente definito “piatto da pesce”, perché probabilmente destinato al consumo di questo alimento; risulta molto diffuso tra la ceramica greca o italiota a figure rosse, spesso impreziosito da soggetti legati al mondo marino, in particolar modo pesci. Sull’origine del nome e sulla produzione di questa tipologia di piatto: Morel 1981, 82-87, con ampia bibl. di riferimento.30 Riguardo le funzioni dei piattelli Genucilia si sono avanzate diverse ipotesi: il loro utilizzo in contesti votivi come recipien-ti per le offerte, sembra ad oggi ancora l’ipotesi più plausibi-le, essendo invece l’uso in ambito domestico poco probabile o comunque considerato riduttivo. La bibliografia a cui fare riferimento è molto corposa, si rimanda pertanto solo ad alcu-ni lavori fondamentali: Del Chiaro 1957; Cristofani – Proietti 1982; Bacchielli 1986; Cristofani 1995, 21-24; Ambrosini 2001, 81-82.
26 Sulla produzione romana a piccoli stampigli si rimanda Morel 1969 e ai più recenti contributi di olcese 1998; Stanco 1999; Stanco 2004; Ferrandes 2008; Stanco 2009; olcese et al. 2010.27 Questo tipologia di bollo, piuttosto frequente, trova confron-to puntuale, tra i numerosi, con un esemplare rinvenuto presso una domus del Palatino: Ferrandes 2008, 367, fig. 3, n. 13. Il tipo è riconducibile al GPS (Gruppo Piccoli Stampigli) IV/V (260-210 ca.) e sembra avere buona diffusione anche nell’officina lu-coferoniense attiva nello stesso periodo, considerato da Stanco come un esempio decorativo del secondo momento di attività della fornace, quarta e quinta fase di influsso romano (265-210 ca.): Stanco 2009, 187, n. 158.28 Delle coppe si conservano i fondi, con piede “sub-rettango-lare”, insieme a piccole porzioni delle pareti; i vasi presentano fondo esterno e piede completamente verniciati, con impronte di immersione all’attacco del piede. L’argilla dell’impasto è di colore arancio chiaro/beige. La vernice è nera lucida, coprente e piuttosto aderente. I due esemplari sono affini alla serie Morel 2783: Morel 1981, tav. 72.29 Il frammento rinvenuto sembra potersi avvicinare in partico-
Fig. 7. Ceramica a vernice nera. 7, a: coppa con stampiglio centra-le; 7, b-c: coppe. 7; d-e: coppette miniaturistiche; 7, f: piatto da pesce; 7, g: piattello Genucilia.
estratto
97
SUBIACo: RINVENIMENTo DI MATERIALI CERAMICI E oSTEoLoGICI NELLA GRoTTA IN LoCALITà LE CAMERE
presumere, forse, una produzione e una circolazione regionale sublacense/aniense (vicina, senza dubbio, ma ben distinta dalle produzioni del periodo più note e documentate).
Le forme in impasto sabbioso, Internal Slip Ware e ceramica comune da cucina, destinate alla pre-parazione, cottura e conservazione dei cibi, hanno restituito un totale di 150 frammenti (v. fig. 6). La ceramica d’impasto sabbioso è rappresentata da una discreta percentuale di reperti (29%), tutti accomu-nati da un impasto arancio chiaro, con abbondante presenza di inclusi augitici di minute dimensioni, distribuiti in maniera abbastanza uniforme. Si distin-gue, in particolare, un’olla stamnoide con orlo svasa-to a sezione triangolare, che mostra evidenti segni di cottura riducente (fig. 9, a)33 e un mortaio con orlo a fascia34; tra il vasellame di medio-grande taglio, un piccolo dolio (fig. 9, b)35. Si segnala una sola olla in Internal Slip Ware, che presenta il tipico orlo a man-dorla schiacciata e consistenti tracce di rivestimento interno (fig. 9, c)36. Infine, per ciò che concerne la ceramica da cucina, il contesto esaminato ha resti-tuito sei olle (fig. 10, a-d)37, una pentola38, un picco-lo tegame con incavo interno (fig. 10, e)39, due po-
ta del secolo scorso, presso il vicino centro di Trevi nel Lazio (Frosinone), in località S. Nicola (ai piedi del moderno centro abitato), deposito per il quale S. Quilici Gigli avanzò una proposta di datazione alla metà-fine del III sec. a.C.31. I reperti recuperati a Trevi si inseriscono bene nelle più ampie e note produzioni etrusco - italiche del periodo, mostrando tuttavia caratteri di una “produzione locale”32; le si-militudini rilevate con il nostro contesto sembrereb-bero, al momento, confortare tale ipotesi, lasciando
“Tipo 1” di olcese 2003, 78-79. Diffusa tra IV e III sec. a.C., si rintraccia molto frequentemente insieme all’olla in fig. 10, c. Si propone qualche confronto: Artena: Lambrechts 1990, 70, n. 4 (fine IV-III sec. a.C.); Cosa: Dyson 1976, fig. 2, CF 17 (275-150); Satricum: Bouma 1996, II, 31, fig. 5 (III sec. a.C.). Fig. 10, b: olla con orlo estroflesso, molto simile a olcese “Tipo 1”, ma più tendente al triangolare; Artena: Lambrechts 1990, 70, n. 3 (fine IV-III sec. a.C.); Casale Pian Roseto: Threipland – Torelli 1970, 113, fig. 28, h, n. 1; Cosa: Dyson 1976, fig. 8, FG 21 (200 a.C. ca.); La Giostra: Moltesen – Brandt 1994, 123, fig. 79, n. 229 (fine IV - inizi III sec. a.C.). Fig. 10, c: olla “con bordo svasato ed ingrossato” (corrispondente al “Tipo 2” di olcese 2003, 78-80, partic. 78), conosciuta in ambito etrusco-laziale già a partire dal VII sec. a.C., trova particolare diffusione tra IV e III a.C. Se ne individuano numerosi confronti: Roma, S. omobono: Mer-cando 1963-64, 42, tav. I, n. 11; Roma, Villa dell’Auditorium: Carandini – D’Alessio – Di Giuseppe 2006, tav. 34, n. 300 (300-200 a.C.); Artena: Lambrechts 1989, 67, fig. 11, n. 136 (seconda metà IV-III sec. a.C.); Bolsena, Bolsena VII 1995, 183-184, fig. 58, n. 480 (seconda metà III-prima metà II sec. a.C.); Casale Pian Roseto: Threipland – Torelli 1970, f112, fig. 27, G, nn. 6 e 11; Cosa: Dyson 1976, fig. 2, CF 26 (275-150 a.C.); La Gio-stra: Moltesen – Brandt 1994, 123, fig. 79, 232 e 126, fig. 80, n. 264 (fine IV-seconda metà III sec. a.C.); ostia, Taberna dell’In-vidioso, strato VII B2, Carta 1978, fig. 72, n. 41 (250-200 a.C.); Pyrgi: Colonna 1988-89, fig. 59, nn. 44, 47, 50 (metà IV-metà II sec. a.C.). Ulteriori confronti in olcese 2003, 79-80. Per Fig. 10, d: Artena: Lambrechts 1996, 111, fig. 58, n. 249 (seconda metà IV-III sec. a.C.); Casale Pian Roseto: Threipland – Torelli 1970; 112, fig. 27, G, n. 5 e 116, fig. 31, A, 22 (esemplare in Internal Slip Ware); Cosa: Dyson 1976, fig. 4, CF 42 (275-150 a.C.); La Giostra: Moltesen – Brandt 1994, 123, fig. 79, n. 232 e fig. 80, n. 266 (fine IV-seconda metà III sec. a.C.).38 Pentola con orlo svasato, a tesa arrotondata nella parte supe-riore. L’esemplare non trova confronto puntuale, ma può essere avvicinato al tipo Dyson 1976, fig. 8, FG 17 (200 a.C. ca.). 39 Recentemente catalogato come Tegame “Tipo 1” dall’olce-se (olcese 2003, 85-86), è attestato in diversi contesti tra IV e II sec. a.C. Si propone qualche esempio di confronto: Roma, presso S. omobono: Mercando 1963-64, 61, tav. VI, nn. 4-5; Roma, villa dell’Auditorium: Carandini – D’Alessio – Di Giu-seppe 2006, 398 e tav. 35, n. 305 e D’Alessio – Di Giuseppe 2004, 10, fig. 10, n. 10; ostia, Taberna dell’Invidioso: Carta
31 Quilici Gigli 1987, partic. 155-169. Per fig. 7, b si veda 166, tav. 21, n. 41. I due esemplari rinvenuti si inseriscono bene nella serie Morel 2783; presentano fondo esterno e piede parzialmen-te verniciati, con colature e impronte di immersione all’attacco del piede. La vernice è nera-lucida, coprente e aderente con spo-radiche trasparenze rossastre sul fondo delle coppette. 32 I confronti più vicini sono stati individuati con l’Abruzzo, in particolare Carsoli, Alba Fucens e Chieti: Quilici Gigli 1987, 132 con bibl. di riferimento.33 Per la forma si sono individuati numerosi confronti, di cui si indicano di seguito i più significativi: Roma, S. omobono: Mer-cando 1963-64, 64, tav. VIII, n. 5; Roma, Villa dell’Auditorium: Carandini – D’Alessio – Di Giuseppe 2006, tav. 30, n. 267; Veio, Campetti: Comella – Stefani 1990, 160, tav. 57, M 186 (IV-III sec. a.C.); Artena: Lambrechts 1989, 86, fig. 20, nn. 216 e 169, fig. 44, n. 460 (fine IV-III sec. a.C.); Lambrechts 1996, 59, fig. 26, n. 105 (fine IV-inizi III sec. a.C.); La Giostra: Moltesen – Brandt 1994, 118, fig. 77, n. 203 (fine IV-inizi III sec. a.C.); Satricum: Bouma 1996, 374, tipo VII (440/430-200 a.C.).34 Forma ampiamente documentata fin da epoca arcaica per sminuzzare e macinare alimenti e granaglie, sembra trovare am-pia diffusione tra IV e III sec. a.C.: Roma, Villa dell’Auditorium: Carandini – D’Alessio – Di Giuseppe 2006, tav. 32, n. 281; Casa-le Pian Roseto: Threipland – Torelli 1970, 103, fig. 18, D, n. 1.35 Si tratta di un contenitore ad orlo estroflesso, del quale si è rinvenuta anche una piccola ansa orizzontale, a maniglia. Il tipo sembra potersi avvicinare ad alcuni esemplari rinvenuti a La Giostra: Moltesen – Brandt 1994, 133, fig. 82, n. 296 (fine IV-seconda metà III sec. a.C.). Si segnala inoltre il rinvenimento di 5 frammenti ceramici che per dimensioni e forma sembrerebbero essere pertinenti un dolio per la conservazione di derrate; per essi tuttavia non si sono potuti stabilire confronti o una possibile cronologia.36 Per un inquadramento generico della classe si veda Di Giu-seppe 2006, 394-395. Si propongono solo alcuni confronti per il tipo: Roma, Villa dell’Auditorium: Carandini – D’Alessio – Di Giuseppe 2006, tav. 33, n. 292; Casale Pian Roseto: Threipland – Torelli 1970, 116, fig. 31, A, n. 1; Cosa: Dyson 1976, fig. 2, CF27 (275-150 a.C.); ostia, Taberna dell’Invidioso, strato VII B2, Car-ta 1978, fig. 72, n. 38 (250-200 a.C.); Veio, Campetti: Comella – Stefani 1990, p. 161, tav. 58, M190 (IV-III sec. a.C.). 37 Si propone qualche esempio di confronto. Fig. 10, a: olla con orlo estroflesso arrotondato e collo concavo, corrispondente al
Fig. 8. Coppa in ver-nice nera con stam-piglio centrale.
estratto
98
MARIA GRAZIA FIoRE – AGoSTINA APPETECChIA – IVANA FUSCo – LEoNARDo SALARI – DARIA PASSACANTANDo
un intero servizio vascolare, o almeno un compen-dio di questo: alla preparazione dei cibi si riferisce il mortaio, utilizzato per sminuzzare granaglie e ce-reali o preparare salse; alla cottura degli alimenti il piccolo tegame, le olle42 e i coperchi, che potevano essere utilizzati come chiusura delle olle o essi stessi come recipienti43. Alla conservazione delle derrate alimentari si potrebbe riferire il dolio d’impasto sab-bioso, così come l’anforaceo restituito dal contesto, purtroppo non identificato, poteva essere utile per la conservazione dell’acqua. Più strettamente legate alla mensa invece sembrano essere l’olla stamnoide, le coppe in vernice nera e il piatto da pesce. La pre-senza di un piattello genucilia e delle due coppette miniaturistiche in vernice nera, piuttosto comuni nei contesti votivi, potrebbero inoltre orientarci verso un possibile carattere rituale del pasto, così come
melli di coperchio a sezione trapezoidale, appiattiti superiormente (fig. 10, f-g)40 e tre ciotole-operchio (fig. 10, h-l)41.
Sebbene alcune delle forme presentate, come il mortaio con orlo a fascia, l’olla in Internal Slip Ware o le ciotole-coperchio, siano frequentemente attestate per un lasso di tempo abbastanza ampio, si ritiene di poter ammettere una coerenza cronologica del con-testo presentato, considerando il III sec. a.C. come il più plausibile per un inquadramento temporale e ipotizzando un restringimento del range cronologico alla metà del secolo o poco oltre, qualora si consideri come fossile guida la coppa a vernice nera con stam-piglio centrale.
Riflettendo sulla tipologia dei reperti ceramici rinvenuti, seppur ancora i dati siano parziali, sem-brerebbe più che plausibile ipotizzare la presenza di
1970, fig. 25, C, n. 8; La Giostra: Moltesen – Brandt 1994, 131, fig. 81, n. 280.41 La forma è molto diffusa in area etrusco-laziale in un ampio lasso di tempo, dall’età orientalizzante al II sec. a.C.: olcese 2003, 98-99. Fig. 10, h: Casale Pian Roseto: Threipland – Torelli 1970, 109, fig. 24, A, n. 2; Cosa: Dyson fig. 4, CF 54 (275-150 a.C.). Fig. 10, i: Artena: Lambrechts 1996, 61, fig. 27, n. 130; Casale Pian Roseto: Threipland – Torelli 1970, 109, fig. 24, A, n. 12. Fig. 10, l: Artena: Lambrechts 1996, 200, fig. 103, n. 554; Casale Pian Roseto: Threipland – Torelli 1970, 109, fig. 24, A, n. 11; Segni: Stanco 1988, tav. 2, n. 15 (la stessa è riprodotta in olcese 2003, 143, tav. XXXII, n. 1).42 L’olla in Internal Slip Ware, ad esempio, col suo spesso rive-stimento antiaderente, era adatta per la cottura di cibi grassi o collosi, come il maiale. Stanco 2001, 97-130; Di Giuseppe – Ser-lorenzi 2008, 9.43 Il discorso vale in particolare per il pomello di coperchio ri-prodotto in fig. 10, f.
1978, 59, fig. 72, n. 44. Altre attestazioni del tipo anche a Cosa: Dyson 1976, FG 11, La Giostra: Moltesen – Brandt 1994, 128, fig. 80, n. 269; Tarquinia: Chiaramonte Treré 1999, 68-69, tav. 31, nn. 3-4.40 Considerato l’esiguo mutamento morfologico nel tempo che caratterizza tale tipo di manufatto, è difficoltoso, in genere, sta-bilire cronologie puntuali: olcese 2003, 89. Tuttavia, è possibile riconoscere come più frequenti, in contesti medio e tardo-re-pubblicani, coperchi simili ai nostri esemplari, con pomello a profilo trapezoidale e appiattito nella parte superiore e proba-bile sviluppo troncoconico della vasca (Di Giuseppe 2006, 399). Per Fig. 10, f: Artena: Lambrechts 1996, 59, fig. 26, n. 122; Casa-le Pian Roseto: Threipland – Torelli 1970, fig. 25, C, n. 7; ostia, Taberna dell’Invidioso, Carta 1978, 59, fig. 68, n. 47; La Gio-stra: Moltesen – Brandt 1994, 131, fig. 81, n. 278. Per Fig. 10, g: Roma, Villa dell’Auditorium: Carandini – D’Alessio – Di Giu-seppe 2006, tav. 34, n. 300 (300-200 a.C.); Artena: Lambrechts 1996, 61, fig. 27, n. 140; Casale Pian Roseto: Threipland – Torelli
Fig. 9. Ceramica d’impasto sabbioso. 9, a: olla stamnoide; 9, b: dolio; Internal Slip Ware; 9, c: olla.
estratto
99
SUBIACo: RINVENIMENTo DI MATERIALI CERAMICI E oSTEoLoGICI NELLA GRoTTA IN LoCALITà LE CAMERE
l’analisi dei materiali ceramici, abbiamo visto, sem-brerebbe indirizzare verso una datazione coerente del contesto alla metà (o poco oltre) del III sec. a.C., fatto che potrebbe confortare l’ipotesi di una o più azioni di accumulo in un lasso di tempo contenuto.
Ciò detto, sono da chiarire altri aspetti, come il carattere intenzionale o meno del deposito e, in questo caso, il tipo di evento legato alla deposizione. La natura del contesto e la selezione dei frammenti ceramici, faunistici e antropici, questi ultimi carat-terizzati dalla presenza di distretti anatomici sele-zionati (ossa lunghe e crani), ci indirizzano verso un carattere intenzionale e verosimilmente rituale della deposizione.
La presenza di un servizio vascolare o almeno parte di questo, in particolare, lascia presumere un pasto rituale seguito da frantumazione dei recipien-ti con contestuale mantenimento di alcune parti per ciascun esemplare, deposte poi in una fossa ricavata per l’occasione, sfruttando una cavità naturale pre-esistente45. L’associazione di materiale ceramico,
ci indirizza in questo senso il carattere selettivo del materiale depositato: si conservano per ogni vaso, infatti, solo alcuni frammenti che non permettono di ricostruire il profilo completo degli esemplari44 (A. A.).
6. Note conclusive
Alla luce di quanto appena esposto, in attesa di completare l’indagine del deposito e le ricognizioni nell’area circostante, si ritiene interessante avanza-re alcune ipotesi interpretative sulla natura del gia-cimento, adottando ovviamente tutte le cautele del caso.
Premessa necessaria a qualsivoglia considerazione riguarda le circostanze del rinvenimento che, inevita-bilmente, condizionano l’interpretazione univoca del contesto. La totale assenza di dati stratigrafici precisi, ad esempio, non ci permette di individuare in maniera puntuale le modalità di deposito dei reperti. Tuttavia,
esempi in Bartoloni – Colonna – Grottanelli 1989-90.45 Per confronti e ampia casistica si rimanda Di Giuseppe – Ser-lorenzi 2008, 10, nota 51.
44 Tale pratica risulta ben documentata in contesti votivi-sacrali; per ciò che riguarda le fonti ne abbiamo testimonianza, ad esem-pio, nelle celeberrime Tavole Iguvine: Ancillotti – Cerri 1996. Per la casistica archeologica si rimanda invece ai numerosissimi
Fig. 10. Ceramica comune da cucina. 10, a-d: olle; 10, e: tegame; 10, f-g: coperchi; 10, h-l: ciotole/coperchi.
estratto
100
MARIA GRAZIA FIoRE – AGoSTINA APPETECChIA – IVANA FUSCo – LEoNARDo SALARI – DARIA PASSACANTANDo
convegno I riti del costruire nelle acque violate (Di Giuseppe – Serlorenzi 2010). Tra i vari casi presentati si ritiene interessante menzionare quello di un deposito votivo rinvenuto in una ci-sterna presso Populonia: De Grossi Mazzorin – Mascione 2010, 325-334; si segnala inoltre, sebbene siano da ascrivere ad un periodo più antico (dall’età del Ferro al VI sec. a.C.), alcune testimonianze di rituali di compensazione presso una sorgente rintracciate nella pianura pontina, in località Campoverde: Mo-dica 2010, 367-378.
46 Ne abbiamo diverse testimonianze archeologiche anche in contesti repubblicani; il sacrificio del cane era connesso, oltre che alla pratica divinatoria augurale, anche a rituali legati a porte urbiche e mura. Si rimanda a Zeggio 2005, 74, nota 55, con am-pia casistica e bibl. di riferimento.47 Di Giuseppe – Serlorenzi 2008, 15-16.48 Di Giuseppe – Serlorenzi 2008, 16.49 Sulla problematica in generale si veda Seppilli 1977. Il tema è stato esaustivamente ed acutamente affrontato nel recente
in tal caso probabilmente le Ninfe, notoriamente le-gate alle acque49.
Vorrei concludere sottolineando che, d’altro can-to, allo stato delle indagini, non si può escludere l’ipotesi di un deposito dei materiali sì intenziona-le, ma di altra natura, che comunque avrebbe una sua valenza perché sintomatico di una frequentazio-ne consistente e articolata nel Sublacense in epoca medio-repubblicana (M. G. F.).
maria grazia Fiore
Soprintendenza per i Beni Archeologici del [email protected]
agoStina appetecchia
“Sapienza” Università di [email protected]
ivana FuSco
Università di Roma “Tor Vergata”[email protected]
daria paSSacantando
Università di Roma “Tor Vergata”[email protected]
Leonardo SaLari
Collaboratore scientifico del Dipartimento di Scienze della Terra, “Sapienza” Università di Roma
reperti faunistici e antropologici, le tracce di scar-nificazione rinvenute su parti scelte dei cani (2 me-tapodiali) potrebbero suggerire, in prima istanza, che il pasto fosse accompagnato da sacrifici cruenti. Tuttavia, se per i cani questo può anche essere am-missibile46, per ciò che concerne i sacrifici umani, sebbene non manchino testimonianze del manteni-mento di tale pratica, questi si ritengono in genere espressione di tradizioni più arcaiche47. Alla luce di tale considerazione, allora, la deposizione di ossa nella nostra cavità potrebbe essere interpretata come una sostituzione simbolica del sacrificio reale, ipotesi ben documentata in letteratura e recentemente pro-posta, ad esempio, per alcune fosse rituali rinvenute presso la via Campana48.
Per quanto riguarda infine le divinità a cui asso-ciare il rituale, i dati in nostro possesso sono ancora troppo labili per avere certezza in tal senso, pertanto ci si limita a formulare solo qualche ipotesi, ancora da verificare. In tal senso, il recente rinvenimento di altro materiale ceramico in superficie nei terreni cir-costanti la cavità, l’individuazione di un pozzo qual-che metro a nord della stessa, potrebbero rappresen-tare interessanti spunti di riflessione. La costruzione di pozzi, cisterne o altre strutture finalizzate alla cap-tazione delle acque, è noto, è da sempre interpretata come forma di profanazione/violazione del terreno, una sorta di sacrilegio che avrebbe ben motivato, nel nostro caso, la necessità di un rituale espiatorio per la violazione perpetrata nei confronti della divinità,
estratto
101
SUBIACo: RINVENIMENTo DI MATERIALI CERAMICI E oSTEoLoGICI NELLA GRoTTA IN LoCALITà LE CAMERE
de groSSi mazzorin J. – maScione c. 2010: “Populonia, acro-poli: un deposito rituale dalla cisterna pubblica”, in di giuSeppe h. – SerLorenzi M. (eds.), I riti del costruire nelle acque violate (Atti del Convegno internazionale, Roma, 12-14 giugno 2008), Roma, 325-334.de groSSi mazzorin J. – minniti c. 2000: “Le sepolture con cani della necropoli di Età imperiale di Fidene - via Radicofani (Roma): alcune considerazioni sul loro seppellimento nell’anti-chità”, in Atti 2° Convegno nazionale di archeozoologia, Forlì, 141-161.de groSSi mazzorin J. – tagLiacozzo A. 2000: Morphologi-cal and osteological changes in the dog from the Neolithic to the Roman Period in Italy (BAR, International series, 889), 141-161.deL chiaro m.a. 1957: The Genucilia Group: a Class of Etrus-can Red-figured Plates, University of California Press.di giuSeppe h. – SerLorenzi m. 2008: “La via Campana e le ac-que violate” (FOLD&R Italy Series http://www.fastionline.org/docs/FoLDER-it-2008-107.pdf).di giuSeppe h. – SerLorenzi M. (eds.) 2010: I riti del costruire nelle acque violate (Atti del Convegno internazionale, Roma, 12-14 giugno 2008), Roma.dySon S.L. 1976: Cosa: the utilitarian pottery (MAAR, 33), Roma.FerrandeS A. F. 2006: “Ceramica e santuari urbani. Produzione, distribuzione e consumo di manufatti ceramici a Roma tra IV e III sec. a.C.: il contributo dei depositi votivi”, AIACNews, 2, 2, 8-10.FerrandeS A.F. 2006: “Produzioni stampigliate e figurate in area etrusco-laziale tra la fine del IV e il III secolo a.C. Nuove rifles-sioni alla luce di vecchi contesti”, ArchCl, 57, 115-74.FerrandeS A.F. 2008: “Produzione di ceramiche a Roma tra IV e III secolo a.C. Nuovi dati”, The Pottery of the Via Egnathia. Cultural Exchange between Est and West (Atti del 25° Congresso internazionale Rei Cretariae Romanae Fautores, Durazzo, 24 set-tembre-1 ottobre 2006) (ReCretActa, 40), 363-372.Fornaciari g. – giuFFra v. 2009: Lezioni di paleopatologia, Ge-nova.gazzetti G. 1982: “Villa romana con fornace di ceramica locale presso olevano”, in IV Convegno dei Gruppi Archeologici del Lazio (Rieti, 8-9 dicembre 1979), Roma, 73-78.harcourt R.A. 1974: “The Dog in Prehistoric and Early his-toric Britain”, JAScien, 1, 151-175.LamBrechtS r. 1989: Artena 2. Rapports et Etudes, Bruxelles-Rome.LamBrechtS r. 1990: La civita di Artena. Scavi belgi 1979-1989, Roma.LamBrechtS r. 1996: Artena 3. Rapports et Etudes, Bruxelles-Rome.LoveJoy c.o. 1985: “Dental Wear in Libben Population: Its Functional Pattern and Role in the Determination of Adult Skel-etal Age at the Death”, American Journal of Physical Anthropol-ogy, 68, 47-56.LoveJoy c.o. – meidL r.S. – pryzBecK – t.r. – menSForth r.p. 1985: “Chronological Metamorphosis of the Auricolar Surface of the Ilium: A New Method for the Determination of Adult Skeletal Age at the Death”, American Journal of Physical Anthro-pology, 68, 15-28.mariotti v. – Facchini F. – BeLcaStro mg. 2007: “The Study of Entheses: Proposal of a Standardised Scoring. Method for Twenty-three Entheses of the Postcranial Skeleton”, Collegium Anthropologicum, 31, 1, 291-313.mercando L. 1963-64: “Area sacra di S. omobono. Esplora-zione della fase repubblicana. I saggi di scavo sulla platea dei Templi Gemelli”, BC, 79, 33-67.modica S. 2010: “Azioni rituali di compensazione/integrazio-ne: il caso di località Campoverde (LT)”, in di giuSeppe h. – SerLorenzi M. (eds.), I riti del costruire nelle acque violate (Atti del Convegno internazionale, Roma, 12-14 giugno 2008), Roma, 367-378.moLteSen m. – raSmuS Brandt J. 1994: Excavations at La Giostra. A mid-republican fortress outside Rome (AnalRom, Sup-pl., 21), Rome.moreL J.P. 1969: “Études de céramique campanienne, I: l’Atelier des petites estampilles”, MEFRA, 81, 59-117.moreL J.P. 1981: Céramique campanienne: les formes (BEFAR, 244), 1-2, Roma.
Bibliografia
amBroSini L. 2001: “Il riempimento della grande cisterna”, in SguBini moretti a.m. (ed.), Veio, Cerveteri, Vulci. Città d’Etru-ria a confronto (Catalogo della mostra), Roma, 79-88.anciLLotti a. – cerri R. 1996: Le Tavole di Gubbio e la civiltà degli Umbri, Perugia.appetecchia a. – mayer m. c.s.: “S. Scolastica e le prime di-pendenze tra fonti documentarie, strutture materiali e nuove tecnologie”, in De Re Monastica III. Le valli dei monaci (Atti del Convegno internazionale di studi, Roma-Subiaco, maggio 2010), c.s.BacchieLLi L. 1986: “I piattelli Genucilia”, in SwaddLing J. (ed.), Iron Age Artefacts in the British Museum, London, 375-380.BartoLoni g. – coLonna g. – grottaneLLi c.: Anathema. Re-gime delle offerte e vita dei santuari nel Mediterrane antico (Atti del Convegno internazionale, Roma, 15-18 giugno 1989) (ScAnt, 3-4), 1989-90.Bouma J. 1996: Religio votiva: the archaeology of latial votive re-ligio; the 5th-3rd c. BC votive deposits south west of the main temple at Satricum (Borgo Le Ferriere), I-III, Gröningen.BrothweLL d.r. 1981: Digging up Bones, oxford.Buxton L.h.D. 1938: “Platymeria and Platycnemia”, Journal of Anatomy, 73, 31-37.canci a. – minozzi S. 2005: Archeologia dei resti umani. Dallo scavo al laboratorio, Roma.capaSSo L. – Kennedy a.r. – wiLczac C.A. 1999: Atlas of Oc-cupational Markers on Human Remains, Teramo.carandini a. – d’aLeSSio m.t. – di giuSeppe h. 2006 (eds.): La fattoria e la villa dell’Auditorium nel quartiere Flaminio di Roma, Roma.carta m. 1978: “Materiali rinvenuti”, in carta m. – pohL i. – zevi F., “ostia, la Taberna dell’Invidioso. Piazzale delle Corpo-razioni, portico ovest: saggi sotto i mosaici”, NS (Suppl., 32), 9-164.cheruBini S. 2004: “Una fossa rituale nella domus Regis sa-crorum” (FOLD&R Italy Series http://www.fastionline.org/docs/2004-27).chiaramonte treré 1999: “La ceramica d’impasto arcaica ed el-lenistica”, in ead. (ed.), Tarquinia. Scavi sistematici nell’abitato. Campagne 1982-1988. I materiali, 1, Roma, 43-97.cLarK K.M. 1995: “The later prehistoric and protohistoric dog: the emergence of canine diversity”, Archaeozoologia, 7, 9-32.coLonna g. 1988-89: “Pyrgi, scavi del santuario etrusco (1969-1971)”, NS (Suppl., 2), 1-335.comeLLa A.M. – meLe S. 2004: Depositi votivi e culti dell’Italia antica dall’età arcaica a quella trado-repubblicana (Atti del Con-vegno di studi, Perugia, 1-4 giugno 2000), Bari.comeLLa a. – SteFani g. 1990: Materiali votivi del santuario di Campetti a Veio. Scavi 1947 e 1969 (Corpus delle stipi votive in Italia, 5, Regio VII, 2), Roma.coppoLa F. 2006: “Il sacrificio del cane in un centro di culto messapico: i resti faunistici provenienti dal bothros 1 di Piazza Dante a Vaste (LE)”, in Atti 4° Convegno nazionale di archeozoo-logia, Pordenone, 307-314.cucinotta c. – de groSSi mazzorin J. – minniti C. 2010: “La città etrusca di Veio: analisi archeozoologica del pozzo US 469”, in Atti 5° Convegno nazionale di archeozoologia, Rovereto, 235-238.criStoFani m. – proietti g. 1982: “Novità sui Genucilia”, Pro-spettiva, 31, 69-73.d’aLeSSio m.t. – di giuSeppe h. 2005: “La villa dell’Auditorium a Roma tra sacro e profano”, in SantiLLo FrizeLL B. – KLynne a. (eds.), Roman Villas around the Urbs. Interaction with landscape and environment, Proceedings of a conference held at the Swed-ish Institute in Rome, September 17-18, 2004 (The Swedish In-stitute in Rome. Projects and Seminars, 2), Rome, 177-196.de groSSi mazzorin J. 2006: “Il quadro attuale delle ricerche archeozoologiche in Etruria e nuove prospettive di ricerca”, in curci a. – vitaLi D. (eds.), Animali tra uomini e dei. Archeozoo-logia del mondo preromano (Atti del Convegno internazionale, 8-9 novembre 2002), Bologna, 77-96.de groSSi mazzorin J. 2008: “L’uso dei cani nel mondo antico nei riti di fondazione, purificazione e passaggio”, in d’andria F. – de groSSi mazzorin J. – Fiorentino g. (eds.), Uomini, piante e animali nella dimensione del sacro, Bari, 71-81.
estratto
102
MARIA GRAZIA FIoRE – AGoSTINA APPETECChIA – IVANA FUSCo – LEoNARDo SALARI – DARIA PASSACANTANDo
so Segni”, in Ricognizioni archeologiche, 4 (Gruppo Archeologi-co Romano), 12-42.Stanco E.A. 1994: “La ceramica a vernice nera”, in BaLzano m. – camiLLi A. (eds.), Ceramica romana: guida allo studio, I, Roma, 19-90.Stanco E.A. 1999: “La ceramica a vernice nera dello scavo di Lungotevere Testaccio”, BC, 100, 1-29.Stanco e.a. 2001: “Un contesto ceramico medio-repubblicano nella valle del Mignone (Frassineta Franco Q. 266)”, PBSR, 69, 2001, 97-130.Stanco E.A. 2004: “La ceramica a vernice nera della stipe di Lucus Feroniae: analisi preliminare”, BC, 105, 29-46.Stanco e.a. 2009: “La seriazione cronologica della ceramica a vernice nera etrusco laziale nell’ambito del III sec. a.C.”, in JoLi-vet v. – pavoLini c. – tomei m.a. – voLpe r. (eds.), Suburbium II. Il Suburbio di Roma dalla fine dell’età monarchica alla nascita del sistema delle ville (V-II sec. a.C.) (Atti del Convegno, Roma, 16 novembre, 3 dicembre 2004, 17-18 febbraio 2005), Roma, 157-193.SwaddLing J. (ed.): Iron Age Artefacts in the British Museum, London.teichert m. 1969: “osteometrische Untersuchumgen zur Be-rechnung der Widerristhöhe bei vor- und frühgeschichtlichen Schweinen”, Kühn-Archiv, 83, 237-292.teichert m. 1973: “osteometrische Untersuchungen zur Be-rechnung der Widerristhohe bei Schafen”, in cLaSon a.t. (ed.), Archaeozoological studies, Amsterdam, 51-69.threipLand L.m. – toreLLi m. 1970: “A semi subterranean Etruscan building in the Casale Pian Roseto (Veii) Area”, PBSR, 38, 62-121.vagnetti L. 1971: Il deposito votivo di Campetti a Veio (materia-le degli scavi 1937-1938), Firenze.white t.d. – FoLKenS p.a. 2005: The human bone manual, Aca-demic Press.wiLKenS B. – deLuSSu F. 2002: “I resti faunistici”, in pianu g., L’agorà di Eraclea Lucana, Roma, 299-342.zeggio S. 2005: “Un santuario alle pendici del Palatino ed i suoi depositi votivi fra età arcaica e mediorepubblicana”, in comeL-La a.m. - meLe S. (eds.), Depositi votivi e culti dell’Italia antica dall’età arcaica a quella trado-repubblicana (Atti del Convegno di studi, Perugia, 1-4 giugno 2000), Bari, 63-76.
oLceSe g. 1998: “Ceramiche a vernice nera di Roma e area ro-mana: i risultati delle analisi di laboratorio”, in Frontini P. – graSSi m.t. – arSLan e.a. – roSSignani m.p. – Sena chieSa g. (eds.), Indagini archeometriche relative alla ceramica a vernice nera: nuovi dati sulla provenienza e la diffusione (Atti del Semi-nario internazionale di studio, Milano, 22-23 novembre 1996), Como, 141-152.oLceSe G. 2003: Ceramiche comuni a Roma e in area romana: produzione, circolazione e tecnologia (Tarda età repubblicana – prima età imperiale), Mantova.oLceSe G. 2010: Immensa Aequora. Un atlante e un database del-le fornaci e delle ceramiche dell’Italia centro-meridionale (Etruria, Lazio, Campania e Sicilia) (RCRF, 41), Bonn, 275-282.oLceSe g. – capeLLi c. – carconi a. – ceccareLLi L. – giunta S. – manzini i. – montaLi i. – Scorrano a. 2010: “Le ceramiche a vernice nera nel IV e III secolo a.C. dell’Ager Portuensis e di ostia: notizie preliminari sulle ricerche archeologiche e archeo-metriche”, Bollettino di Archeologia on line, 1, vol. speciale B/B8/ 2, 5-22.QuiLici gigLi S. 1987: “Appunti di topografia per la storia di Trevi nel Lazio”, MEFRA, 99, 1, 129-169.roLFo m.F. – mancini d. – SaLari L. – zarattini a. 2010: “La grotta di “Mora Cavorso” a Jenne (Roma). Nuove ricerche”, La-zio e Sabina, 6, 11-17.roLFo m.F. – SaLari L. – zarattini a. 2009: “Nota preliminare sulle indagini archeologiche presso la grotta “Mora di Cavorso” (Jenne, Roma)”, Lazio e Sabina, 5, 14-22.SaLari L. – SardeLLa r. 2005: “Il cane della necropoli di Porte di Ferro a San Cipriano Picentino (Salerno)”, Atti Società Preistoria Protostoria Regione Friuli Venezia Giulia, 15, 155-165.SaLari L. – SardeLLa r. – SQuazzini e. – LiSciareLLi a. – Suado-ni t. 2006: “Il cane della necropoli di Amelia (Terni, Umbria)”, in curci a. – vitaLi D. (eds.), Animali tra uomini e dei. Archeo-zoologia del mondo preromano (Atti del Convegno internaziona-le, 8-9 novembre 2002), Bologna, 197-203.Schramm z. 1967: “Long bones and height in withers of goat (poln. engl. u. russ. Ausz.)”, Roczniki Wvzsej Szkolv Rolniczei w Poznaniu, 36, 89-105.SeppiLLi A. 1977: Sacralità dell’acqua e sacrilegio dei ponti: persi-stenza di simboli e dinamica cultuale, Palermo.Stanco e. a. 1988: “Una officina di ceramiche ellenistiche pres-
estratto