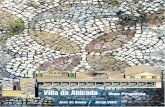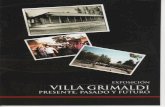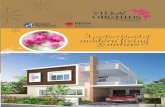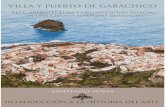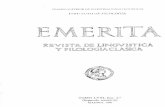Musica nel tempo a Vercelli e a Casale. Aggiornamenti bibliografici
PIAZZA ARMERINA Studi recenti sulla Villa del Casale: gli interventi della Sapienza - Università di...
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of PIAZZA ARMERINA Studi recenti sulla Villa del Casale: gli interventi della Sapienza - Università di...
Estratto dai RENDICONTI della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, volume LXXXIII 2010-20 Il ----------(fuori commercio) ----------
PIAZZA ARMERINA
Studi recenti sulla Villa del Casale: gli interventi della Sapienza - Università di Roma
V. Nuovi contesti ceramici di età medievale dalla Villa del Casale
DI
E. GALLOCCHIO, E. GASPARlNI
Tipografia Vaticana
["r'J
" >-Vl
~ ~
r" Ci
f:: r-Cl C"l C"l J: i3 "'-z c::
~ C"l Cl Z >-Ì M
j C"l M
~ B ~ M >-Ì >-, ;;: M
P <:)
r:;;
~ H
b;
~ tcL h:)
O"> u-<
Fig. l. Villa del Casale, Pianta generale con indicazione dei 38 pozzi e fosse rinvenuti con le campagne di scavo 2007-2009 (dis. E. Gallocchio)
DEI.L'" PONT. ACCAD. :11. - LXXXIII
tuìre utilizzo di un per altro scopo, bensì
l'obiettivo primario per il quale il taglio sarebbe stato praticato.
Prima di adden trarci nell 'analisi dei materiali rinvenuti, appare neces
saria una precisazione sulla tipologia del contesto di indagine: va infatti sot
tolineato come owiamente non si sia potuto operare Sll riempimenti
intatti, dal momento che di essi mancava la porzione superiore, owero l'in
terro, rimosso durante i grandi scavi degli anni '50, che dal piano di vita
sino a quello tardoan
permisero il riconoscimen
u~ando definizione di Gentili, come
cosicché le ultime indagini
in lisi in modo capillare
i ed i tempi dei lavon
'sacche medievali'.
riempimenti di
ricostruire un panorama
abi tativo, rivestivano
mario: in seguito al sistema degli acquedoui
antichi, nuovi abitanti dell'area colsero infatti appieno il valore della
falda, individuata anche grazie alle recenti analisi idro-geologiche," che ali
menta le numerose sorgive captate dai tagli, e misero in atto un ramificato
sistema di raccolta dell'acqua, specialmente su tutta l'area incentrata
attorno alla corte quadrangolare del Peristilio, lungo una linea est-ovest,
che segue i margini del pendio naturale.
le
e
appare stabilire il momento
l'azione attraverso la
e furono tolti dalla
utilizzati come disc1
forse anche in coincidel
loca la formazione
gli oggetti persero
da un'altra i pozzi veri
concomitanza del loro
evento storico di notevole
rilevanza. Il fatto che i riempimenti possano essere connessi con un qualche
episodio violento è parso possibile alla luce di due rinvenimenti particolari:
nel primo caso si tratta di uno scheletro integro di equino, posto in un pozzo,
nel settore a nord delle Terme, a circa 1 m di profondità dal piano a cui si
interrompeva lo scavo Gentili (figg. 2a-2b). Lo scheletro si collocava in posi
zione rannicchiata, chiaramente derivante dalla deposizione di un animale
che macellazione.
nlo.
tava
proveniente questa
in uno scheletro
su periore del cranio
sia dato conoscere
alle spalle del Tricli
adulto che presen
lrauma da corpo cont1l11-
nei livelli superiori
dei riempimenti implica un limite nelle possibilità di definire i termini ero-
" GRAZIANO-SCAI.ONE 2007, p. 89.
E. GAS PARI N I, E. GALLOCCHIO - V. NUOVI CONTESTI CERAMICr DI ETA MEDIEVALE.. 267
CItUDItR'/O NOR'D
f"Io50lco
~u ~u~pen5Urae
~chddlO di ---'5:>2 t:quino
plaleo di fondazione
-'5:>1 delle leme
laqlialo dal pozzo
-'5;>0
fodero/uro In blocchelll
a
---------l~-
\ '\
probabile quolo abilalo f'ledievo/e
'xqf'l~nlo di pozzo
x ovolo ~qli anni ''50
~------------~ R'dnlerro po~1 ''50
--r--<::------.=:...L
piano
Fig. 2. a. Scheletro integTo di equino rinvenuto in un pozzo nel settore a nord
delle Terme; b. Sezione dello stesso pOLlO
b
268 RENO. DCLLA PONT ACCAO. ROM. O'ARCI~. - VOL LXXXflI
Fig. 3. Scheletro umano di individuo adllito
con trauma da corpo COnllIrldente sul cranio
nologici di tali evidenze. Qualche dato sui materiali presenti alle quote supe
riori si può tuttavia intuire dal resoconto del Gentili circa lo scavo della Sala
dei Massaggi: nel complesso termale, dove era stato creato un pozzo
bucando il pavimento mosaicato: a 3 m dal piano di campagna egli registra
la presenza di un "complesso di materiale medievale ", che potrebbe facil
mente identificarsi con la parte superiore del riempimento dello stesso pozzo
rinvenuto, 2 m più in basso, al di sotto del pavimento, nell'angolo nord-ovest
della stanza. Tra i materiali presenti in quello che si ricostruisce essere il set
tore più recente del riempimento, il Gentili cita" sei monete in bronzo nor
manne del tipo con testa di leone e palmizio ", identificabili come follari di
Guglielmo II: questo unico elemento potrebbe attestare il perdurare dell'u
tilizzo dei pozzi come discariche, a quote più alte, anche durante il XII
secolo,
Analizzando la ceramica proveniente dai contesti indagati è stato possi
bile rimarcare una differenza qualitativa rispetto al materiale coevo rinve
nuto nel quartiere scavato a sud della Villa: oltre che alle modalità di giaci
tura, il fenomeno potrebbe attribuirsi ad una diversa connotazione sociale
dei due settori dell'abitato, Si delineerebbe sempre più dunque l'immagine
di un quartiere occupato dalla popolazione più abbiente, sorto in corrispon-
I GFNTII.I 1999, I, pp, 236-237,
270 RENO. DEI.LA PONT. ACCAD. ROM. D·Al~CH. - VOL LXXXJIl
Piazza Armerina -Villa del Casale pozzo n. 20 classi ceramiche (tot 118 esemplari min.)
5
Piazza Armerina -Villa del Casale pozzo n. 20 ceramica comune
• ceramica comune
• ceramica Invetrlata
• anfore
• contenitori da derrate
• bottiglie
• scodelle
brocche
tazze 3L-______________________________ ~
fig. 4. Il taglio rinvenuto ilei conile
tra il Peristilio e lo XySlus, che risulta
riempito da materiali riferihili alhl
fìn e dell'XI - prirn;r metà del XII
secolo. È anche presente Ulla frazione
di follaro in rame con tondello otta
gonal e di Rug'gero Il, databile al
li 27-1 142
Piazza Armerina -Villa del Casale pozzo n. 20 ceramica invetriata
• scodelle
• tazze
• brocche
bottiglie L-______________________________ ~2
Piazza Armerina -Villa del Casale pozzo 20 ceramica da fuoco
. olle
• pentole
. tegaml
L-______________________________ --' 4
fig. é>. Dati quantit;}tivi sul riempimento del pozzo rinvenuto nel Peristilio della Villa (pozzo 22)
L GASPARlNI, E GALLOCCI-1I0 - V NUOVI CONTCSTI CERAMICI Dl ETA MEDIEVALE.. 271
Fig. 6. Manufatti di forma aperta e chiusa in ceramica comune acroma o schiarita in superficie
(fig. 6). Queste ultime, caratteristiche di produzioni di matrice africana, ma
molto comuni anche in ambito siciliano, sono contenitori per liquidi, la
brocca dotata e l'anforetta priva di beccuccio. Esse presentano, tra l'alto
collo troncoconico ed il corpo globulare, un setto traforato formato da
numerosi fori ed incisioni che, oltre ad avere valore funzionale, riveste anche
un ruolo decorativo. Le scodelle ed i bacini, soprattutto carenati ma anche a
parete emisferica, si distinguono in più tipi, con orli che presentano dimen
sioni variabili da un minimo di 15 cm a un massimo di 30 cm di diametro:
come è stato evidenziato nella storia degli studi, gli esemplari più grandi
erano destinati ad un utilizzo al centro della tavola, come piatti da mensa
comuni per i commensali che da esso attingevano, mostrando, anche da un
punto di vista morfologico, una discendenza dalle forme aperte prodotte nel
Nord Africa in sigillata D sino al \111 sec. d.C. 6
Il contenitore da derrate monoansato, manufatto numericamente più
rappresentato (34 esemplari) nel pozzo rinvenuto nel peristilio, prevede
larga imboccatura, corpo globulare con cordonature e fondo umbonato: la
forma era destinata a contenere prodotti solidi o semisolidi e la si riscontra
"ARDIZWNE 2004, pp. 191-203.
272 REND. DlLLA PONT. ACCAD. ROM. D'ARCH. - VaL LXXXl1l
Fig. 7. Tra la ceramica invetriata si rinvengono le stesse fonne prodotte anche in ceraTniOl acroma
in contesti di fine X - inizio XI secolo anche nella Sicilia occidentale. In
alcuni casi si osserva la presenza di una decorazione ad onda su tre registri
che sottolinea collo e spalla,
Quasi tutti i contenitori privi di decorazione, così come avviene anche
per le lucerne sia a vasca chiusa che a vasca aperta, venivano prodotti, con i
medesimi tipi cii argilla, anche nelle più pregia te versioni rivestite da vetrina
piombifera, sotto la guale, prima della seconda cottura, veniva stesa una
dipintura omogenea monocroma o a motivi policromi sia geometrici che
fitomorfi (fig. 7). Possiamo identificare manufatti collocabili tra la fine del X
e gli inizi dell'XI secolo, dunque ancora in età isJamica e con ogni probabi
lità riferibili al primo periodo dell'insediamento medievale, in guanto sono
abbastanza ben databili le scodelle carenate con all'interno decorazioni
verde ramina e bruno manganese su fondo giallo crema e talvolta con al cen
tro del cavo animali campiti con il tipico motivo a gridiron, mentre sul bordo
compaiono motivi pseudocufici. Interessante appare anche la notevole atte
stazione di scodelle con decorazione a tratti verticali e a sfiammature verdi e
brune su fondo giallo (splashed ware) , che non solo compare anche nel
Nord Africa, ma, attestandosi sin dal IX-X secolo, si configura come distintiva
delle più antiche produzioni invetriate policrome. Puntuali confronti pos
sono infatti stabilirsi tra i nostri materiali e ceramiche da siti dell ' Ifriqyia di
fine X- inizio XI secolo: da Raqgada, Cartagine, Uchi Maius, Chemtou eJama
in Tunisia, da Qal 'a Banu Hammad in Algeria, da Medinet al Sultan, Ajda
biya e Sidi Khrebish in Libia, solo per citarne alcuni.'
' DAOUIJ\TLI 1995, pp. 68-93; VIHI.U 1981; FERI .·\OUI-ToUHIRI 2003, pp. 87-1 Il; COLVIN
1965; MII.'lNESr-CELlCI-II 1997, pp. 49-94; KENNCT 1994, pp. 275-285; FEHERVARY '·.T ,lw2002.
274 REND. DELLA. PONT. ACCAD. ROM. D'ARCH. - VOL. LXXXIII
Fig, 8.1. AnFora a canne/ures rinvenuta in lino dei Fig. 8.2. Pentola ad impasto rinvenuta in lino
pozzi ~ nord delle Terme dei pozzi a nord delle Terme
gli esemplari rinvenuti a Trani l'; ha permesso di avviare un congiunto pro
getto di indagine archeometrica che per ora si è tradotto nell'analisi delle
peculiarità tecnologiche dei manufatti di Piazza Armerina, definendone i
caratteri chimici e mineralogico-petrografici (si veda l' AjJpendice). Tale pro
getto si svilupperà approfondendo il confronto con i manufatti pugliesi, al
fine di inquadrare possibili analogie composizionali e/o tecnologiche.
La vastità di contatti testimoniata dalle ceramiche fini non può non riflet
tersi sui contenitori da trasporto: le anfore a cannelures attestano rapporti com
merciali di corto raggio (sia con l'area nord-occidentale che con quella sud
orientale della Sicilia), di medio raggio (con la Calabria tirrenica e la Campa
nia) e di ampio raggio (con il Nord Mrica e con l'Adriatico orientale) (fig. 8.1).
Il quadro così delineato si traduce in una vera e propria koinè culturale
del Mediterraneo islamico, che investe persino i manufatti destinati alla pre
parazione degli alimenti: la tipica pentola ad impasto con orlo indistinto,
fondo piano e prese a linguetta sia orizzontale che verticale ricorre non solo
in Sicilia, ad esempio negli importanti centri di Segesta Ili e Monte Iato 17 ma
anche in Andalusia, dove si attesta sin dalla metà del IX secolo IR (fig, 8,2).
J; Essi sono stati analizzati da un puntO di vista archeometrico dal Dipartimento di Dia
gnostica per i Beni Culturali della Facoltà di Scienze Matematiche fisiche e Naturali del
l'Università di Bari (Dott.Ssa Annarosa Mangone). Ili ÌVl o l. U, AR I 1997, pp. 122-124.
"RlBI-Is.l.ER 1988, pp. 61-72.
" GL'TIF.RREZ LLORET J 986, pp. 147-J 68.
276 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. l)·ARCH. - VOL. LXXXIII
Fig. 9. Esemplari rn;\I cOlti, delorlll;.\[j, con superlicic corrugala (' percorsa da rraollre t'
fori, insieme CO\1 s(,lllr1ici gl'limi di (-lrgill~1 iperc()(t(l c di \'t'lrin:l
Fig. lO. Barre eia fornace e impronte eli distanziatore slIlIa superficie eli una ciotola
invetriala