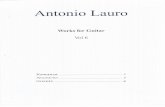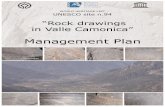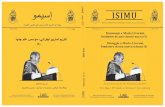A De Filippis, A. Mazzocchi, M.G. Ruggi d'Aragona, Nota preliminare sulla necropoli di Località...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of A De Filippis, A. Mazzocchi, M.G. Ruggi d'Aragona, Nota preliminare sulla necropoli di Località...
IMMENSA AEQUORAWorkshop
Ricerche archeologiche, archeometriche e informaticheper la ricostruzione dell’economia e dei commerci
nel bacino occidentale del Mediterraneo(metà IV sec. a.C. - I sec. d.C.)
Atti del convegnoRoma 24-26 gennaio 2011
a cura diGloria Olcese
9 788871 405407
EDIZIONI QUASAR
IMM
ENSA
AEQ
UO
RA
Workshop
ISBN 978-88-7140-540-7
€ 65,00
ESTRATTO
Ideazione e coordinamento scientifico Gloria Olcese - www.immensaaequora.com
Redazione scientificaIlaria Manzini
Progetto di copertinaGloria Olcese, Emanuele Gabellini
In copertinaMare di Ischia (fotografia di Andreas Hiener)
Ove possibile sono stati richiesti i permessi di riproduzioni di foto e disegni, si resta comunque a disposizione di eventuali detentori dei diritti che non è stato possibile contattare
ISSN 2240-9831
ISBN 978-88-7140-540-7
© Roma 2013, Edizioni Quasar di Severino Tognon srlvia Ajaccio 43 - 00198 Roma, tel. 0685358444 fax 0685833591e-mail: [email protected] – www.edizioniquasar.it
Volume finanziato grazie ai fondi del MIUR, Progetto FIRB 2005-2011 RBNE03KWMF “Ricostruire i commerci nel Mediterraneo in epoca ellenistica e romana
attraverso nuovi approcci scientifici e tecnologici”
Dipartimento di Scienze dell’Antichità“Sapienza” – Università di Roma
ESTRATTO
IMMENSA AEQUORAWorkshop
Ricerche archeologiche, archeometriche e informatiche per la ricostruzione dell’economia e dei commerci
nel bacino occidentale del Mediterraneo (metà IV sec. a.C. - I sec. d.C.)
Atti del convegno Roma 24-26 gennaio 2011
a cura di Gloria Olcese
Immensa Aequora 3
Edizioni Quasar
ESTRATTO
This paper presents the first results of the analysis of the funerary sets, found during the of archaeological investigations carried out in the territory of Sessa Aurunca (CE), at Piscinola site, West of the ancient Suessa Aurunca. The necropolis has graves dating from the late fifth and early third century B.C., which offer new and interesting ideas for research, not only on pottery production and on the presence and commerce of graeco-italic amphoras, but also on social, economic and political dynamics, in a time of profound and traumatic changes, marking the Roman conquest of Southern Italy.
keywords: Suessa Aurunca, Aurunci, necropolis, roman conquest of Southern Italy, Graeco-italic amphoras, northern Campania.
Le indagini archeologiche, che hanno portato al rinvenimento della necropoli di località Piscinola, sono state condotte fra il 2003 e il 2006 nel territorio di Sessa Aurunca (Fig. 1) ad W dell’attuale centro urbano, lungo la fascia pedemontana posta tra il massiccio del Roccamonfina e la sponda Sud del Garigliano2. Si tratta di un’area caratterizzata da terrazzamenti, ancora oggi intensamente coltivati e digradanti verso la pianura costiera, laddove in antico correva il tracciato della via Appia, non lontano dalle colonie romane di Sinuessa e Minturnae. Le inda-gini archeologiche benché fortemente condizionate, nella localizzazione e nella estensione, dalla natura e dalle caratteristiche delle opere da realizzare, hanno tuttavia consentito di esaminare una porzione sufficientemente estesa della necropoli, tanto da fornire elementi utili a formulare ipotesi di ricerca più ampie. Le sepolture si dispongono su almeno tre terrazzamenti (Fig. 2), orientati E-W e digradanti verso Nord, dove un piccolo corso d’acqua a carattere stagionale interrompe il pendio. L’esplorazione archeologica ha permesso l’in-dividuazione di 59 tombe (Fig. 3) che rispettano rigidamente un comune orientamento E-W dell’asse maggiore, disposte parallelamente l’una all’altra ed estremamente addensate, soprattutto nel settore Sud. Tratto distintivo e costante del costume funerario è la presenza del corredo ceramico all’esterno della fossa o della cassa, gene-ralmente posto in prossimità del lato Sud della sepoltura stessa, condizione questa che ha spesso compromesso fortemente la conservazione degli oggetti (Fig. 4)3. I contesti rinvenuti4 hanno offerto lo spaccato cronologico della necropoli, oltre che un quadro delle produzioni ceramiche rappresentate all’interno dei corredi. La loro composizione, anche se condizionata dalla disponibi-lità offerta dalle produzioni locali, manifesta una serie di mutamenti rappresentati dall’acquisizione di modelli culturali diversi, nonché alcuni fenomeni di conservazione, che assumono una notevole rilevanza nella lettura della necropoli stessa e nel quadro più generale delle considerazioni di carattere storico-archeologico che ne conseguono.Il nucleo delle sepolture più antiche, databili tra la fine del V e i primi decenni del IV secolo a.C., sembra loca-lizzarsi nel settore Sud dell’area; si tratta di tombe a fossa terragna, scavate nel banco naturale tufaceo, talvolta con una copertura piana costituita da sottili lastre di tufo grigio. Il corredo di queste sepolture è caratterizzato dalla presenza dell’olla, spesso replicata in più esemplari, alla quale si associa il repertorio di ceramica a vernice nera di produzione locale. L’olla rappresentata in questi corredi è quasi costantemente del c.d. tipo “a bombarda”, elemento costituisce un indicatore culturale specifico in contesti di necropoli e abitato della Campania Setten-trionale dal VII al IV secolo a.C. senza sostanziali mutamenti ed evoluzioni morfologiche5. Tra i vasi a vernice nera, di produzione locale, ricorrono costantemente lo skyphos con vasca a profilo troncoconi-co, e la coppa con labbro verniciato, ingrossato e aggettante, vasca a profilo curvilineo continuo, decorata con una fascia a vernice nera sulla superficie esterna. Si tratta, nel complesso, di insiemi costituiti da un numero piuttosto ridotto di oggetti e di forme, sostanzialmente ripetitivi e ricorrenti.A questo gruppo di sepolture si riferisce anche la Tomba 63 (Fig. 4), il cui corredo costituisce al momento un uni-cum in tutta la necropoli6. Questo è composto da una coppa tipo “bolsal”7, una coppa monoansata8, una coppetta
Nota preliminare sulla necropoli di Località Piscinola a Lauro di Sessa Aurunca (CE)
Angela De Filippis*, Angelo Mazzocchi*, Maria Grazia Ruggi d’Aragona**1
* Ricercatore indipendente; ** Soprintendenza per i Beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta
ESTRATTO
190 Angela De Filippis, Angelo Mazzocchi, Maria Grazia Ruggi d’Aragona
Fig. 1: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: stralcio I.G.M. 1:25.000 con posizionamento del sito.
Fig. 2: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: panoramica da Sud.
Fig. 3: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: planimetria generale, elaborazione grafica E. Valletta.
ESTRATTO
Nota preliminare sulla necropoli di Località Piscinola a Lauro di Sessa Aurunca (CE) 191
a profilo concavo-convesso9, un’altra piccola coppa a vasca emisferica, tutte forme a vernice nera di produzione locale. A queste si associano una olpetta a vernice nera parziale, un’olla acroma e un anfora di impasto nero lustra-to, riconducibile chiaramente alle produzioni ceramiche della civiltà della media valle del Liri10 (Fig. 5). L’anfora, databile non oltre la seconda metà del VI secolo a.C., non è cronologicamente compatibile con gli altri elementi del corredo, rispetto ai quali sembra rappresentare una sorta di “relitto”, un elemento fortemente connotato, testi-mone di un patrimonio culturale cui le popolazioni di questo territorio restano fortemente radicate anche in una fase storica di profondi e rapidi mutamenti, secondo un modello di “luogo di accantonamento e conservazione” che è stato attribuito a questo comparto territoriale da E. Lepore11. Diverso il quadro offerto dalle sepolture di pieno e avanzato IV secolo. Le tombe di questa fase sono rappresenta-te dal tipo a cassa di tufo con coperture piana o a doppio spiovente, spesso decorata da cornici interne modanate (Fig. 6) e da motivi lineari sulla superficie dei timpani delle testate, secondo uno schema che risulta ben noto nelle grandi necropoli coeve di Teanum Sidicinum e di Cales12. Di un certo interesse è il dato che si ricava dal gruppo delle tombe con grande cassa litica e copertura a doppio spiovente. A queste risulta associato un corredo, sempre deposto all’esterno della cassa (Fig. 7), il cui elemento caratterizzante è l’anfora vinaria13, associata al cratere a campana, a vernice nera o figurato e alle altre forme del servizio potorio, rappresentato tuttavia in una forma estremamente ridotta. Le anfore presenti sono riconducibili essenzialmente alla produzione delle greco italiche, di tipo IV e V14.Il tipo IV compare sia nella sua variante più piccola e slanciata (Fig. 8; Tomba 59), che in quella presente negli esemplari del relitto F di Filicudi15 (Fig. 9; Tomba 88). Appare più che evidente l’associazione stretta, all’interno del corredo funerario, dell’anfora con il cratere, che nel caso della Tomba 59 si presenta in una variante adottata in maniera quasi esclusiva in una produzione a figure rosse sovraddipinte della fine del IV secolo a.C, riferibile alla Campania settentrionale interna16.Ad una officina sidicina è riferibile il piccolo cratere figurato della Tomba 70 (Fig. 10), opera del Pittore di Vi-tulazio. I tratti distintivi della sua produzione sono ben riconoscibili nelle teste femminili realizzate a semplice contorno nero su un fondo di argilla molto chiara, generalmente riprodotte senza variazioni sostanziali, su crateri a campana di piccole dimensioni. L’incidenza dei vasi attribuiti a questa officina è piuttosto rilevante sia negli scarichi dei santuari che nelle necropoli di Teanum, ma essi sembrano avere un certa diffusione territoriale, che coinvolge sia l’area di Cales che il territorio di Suessa, sul finire del IV e i primi anni del III secolo a.C.17 Partico-larmente monumentale risulta il contesto della Tomba 5718 (Fig. 11), nel quale all’anfora risulta associato un grande cratere a campana, a vernice nera, con il labbro decorato da un motivo ad onda corrente, che al momento costituisce un esemplare unico all’interno della necropoli. Non mancano le consuete forme del servizio potorio, rappresentate da due coppe, una kylix e una piccola olpe-attingitoio a vernice nera. La stessa associazione dell’anfora vinaria al cratere si ritrova in un altro gruppo di sepolture che scelgono la greco italica di tipo V19. A questo raggruppamento si riferiscono la Tomba 83 (Fig. 12) e la Tomba 11020 (Fig. 13) dove però il cratere, al quale si accompagna il consueto servizio per bere, si presenta in una dimensione quasi minia-turistica, a sottolinearne la necessità imprescindibile, anche se in una elaborazione quasi simbolica. Fa eccezione al modello anfora-cratere la Tomba 77, il cui corredo presenta una greco italica di tipo V, ma non il cratere che sembra sostituito da una piccola pelike a vernice nera (Fig. 14).Le anfore di tipo greco italico sono sicuramente le più attestate all’interno della necropoli, ma non mancano tut-tavia esemplari riferibili ad altre produzioni, provenienti dall’area del Mediterraneo o da officine locali. A questo proposito vale fare una notazione relativamente al corredo della Tomba 86 (Fig. 15) in cui compare un’anfora del tipo Corinzia A´21, associata ancora ad un piccolo cratere dell’officina del Pittore di Vitulazio, quest’ultimo rea-lizzazione estremamente corsiva della produzione di questo atelier, e dal consueto servizio di forme per mescere e bere. Ad una produzione locale sembrerebbero invece attribuibili le due anfore a fondo piatto della Tomba 100 (Figg. 18-20), che non trovano repliche all’interno della necropoli e che, ad un esame macroscopico delle argille, sembrerebbero del tutto simili agli esemplari di greco italiche presenti nei corredi. Un caso a parte è rappresentato dalla Tomba 84 (Fig. 16), il cui corredo propone l’associazione anfora-cratere, utilizzando invece che la greco italica, una neck-amphora a figure rosse, attribuibile ad una officina cumana22, una delle pochissime attestazioni di ceramica a figure rosse all’interno dei contesti della necropoli, insieme alla lekythos del corredo della Tomba 78 anch’essa attribuibile alla produzione figurata cumana, e parte di un contesto che contiene l’anfora greco italica tipo V e il cratere a campana (Fig. 17).Un’ultima considerazione è rivolta all’individuazione delle aree di provenienza di alcuni degli oggetti presenti nei corredi: sembra di poter affermare che, oltre a centri di produzione locale sicuramente attivi e ben rappresentati
ESTRATTO
192 Angela De Filippis, Angelo Mazzocchi, Maria Grazia Ruggi d’Aragona
Fig. 4: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 63, corredo. Fig. 5: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 63, anforisco di impasto, elaborazione grafica E. Valletta.
Fig. 6: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 57, interno della cassa.
Fig. 7: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 83.
nel repertorio ceramico della necropoli, con tutta probabilità parte dei prodotti a vernice nera proviene dalle of-ficine teanesi, che riforniscono la necropoli di Piscinola anche della ceramica figurata prodotta dagli ateliers della fine del IV secolo a.C. Non mancano, come già detto, anche acquisizioni dalle officine ceramiche di Cuma, che tuttavia sembrano rappresentare un bacino di rifornimento estremamente limitato. Molto più complessa la problematica dei centri di produzione delle anfore greco italiche così ben documentate nei corredi di Piscinola, anche se un recente studio, basato sull’analisi archeometrica di campioni di argilla dei contenitori provenienti dalla necropoli, ha dimostrato che gli impasti sono del tutto diversi da quelli ben identifi-cati per le produzioni campane di Ischia e del Golfo di Napoli23. La prosecuzione delle analisi mineralogiche delle argille, condotte non solo sulle anfore ma, in maniera incrociata, anche sulle produzioni ceramiche associate in contesto, potrebbero porre punti fermi in questo senso, fornendo ulteriori ed importanti dati sia per l’individua-zione delle aree di provenienza, sia per la definizione dei circuiti commerciali di distribuzione di questi prodotti nel breve e medio raggio (Campania) e nel bacino del Mediterraneo.
ESTRATTO
Nota preliminare sulla necropoli di Località Piscinola a Lauro di Sessa Aurunca (CE) 193
Fig. 8: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 59, corredo.
Fig. 9: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 88, corredo.
Fig. 10: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 70 corredo.
Fig. 11: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 57, anfora e cratere.
Fig. 12: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 83, anfora.
Fig. 13: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 110, anfora.
ESTRATTO
194 Angela De Filippis, Angelo Mazzocchi, Maria Grazia Ruggi d’Aragona
Fig. 14: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 77, corredo.
Fig. 15: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 86, corredo.
Fig. 16: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 84, corredo.
Fig. 17: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 78, corredo.
Fig. 18: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 100, anfora.
Fig. 19: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 100, anfora, elabo-razione grafica E. Valletta.
Fig. 20: Sessa Aurunca (CE), necropoli, loc. Piscinola: Tomba 100, anfora, elabo-razione grafica E. Valletta.
ESTRATTO
Nota preliminare sulla necropoli di Località Piscinola a Lauro di Sessa Aurunca (CE) 195
Il quadro culturale che emerge da questa prima e del tutto preliminare disamina dei contesti della necropoli di Piscinola assume ulteriore significato se posto in relazione alle complesse vicende storiche che segnano questo territorio e le popolazioni che lo abitano per tutto il IV secolo a.C. La storia degli Aurunci24 appare segnata dal conflitto con Roma già agli inizi del V secolo, quando si ha notizia di un attacco a Roma nella regione dei colli Albani25, in un settore che probabilmente doveva trovarsi al margine settentrionale dei territori in loro possesso a quell’epoca26. Le fonti storiche non forniscono notizie dettagliate sulla storia successiva di questa popolazione, ma appare assai probabile che alla metà del IV secolo a.C. il territorio degli Aurunci si sia notevolmente ridotto rispetto a quello indicato dalle fonti per i periodi precedenti, tanto da essere ormai circoscritto alla zona del con-fine campano-laziale con il Latium Adiectum. Il IV secolo segna sicuramente la fase cruciale nella storia di quest’area e di queste popolazioni. È il momento dei grandi conflitti nei quali Roma dà corso alla politica di espansione che la vede proiettata ormai in maniera irreversibile verso l’Italia meridionale. In questo quadro caratterizzato da un generale clima di inquietudine, gli Aurunci compaiono nel giro di pochi anni, alla fine della guerra tra Roma e i Volsci nel 346, e successivamente nella Guerra Latina a seguito della quale, nel 338, si sottomettono a Roma. In questo modo consentono, di fatto, l’inizio dell’espansione romana, concretizzatasi oltre che con l’acquisizione nel 340 del territorio a Nord del Vol-tuno, divenuto Ager Falernus, anche con la fondazione della colonia latina di Cales nel 334 a C. Piuttosto confusi sono gli eventi che seguono la sconfitta del 338; tra questi è riportata la notizia, l’anno successivo, di un attacco dei Sidicini agli Aurunci, con il conseguente saccheggio del territorio e la distruzione di un oppidum27, ma è solo nel 314 che questi ultimi subiscono la disfatta e conoscono di fatto l’annientamento delle loro strutture socio po-litiche da parte dei Romani con la confisca delle terre, divenute nel 314 a.C. ager populi Romani, e la fondazione della colonia di diritto latino di Suessa nel 313. Difficile dire se e quanto il fenomeno di aggregazione urbana degli Aurunci sia stato una realtà alla fine del IV secolo anche perché i dati archeologici in tutto il bacino del Garigliano non forniscono elementi utili a stabilire l’esistenza di centri urbani organizzati prima della colonizzazione romana. L’ipotesi più probabile e quella mag-giormente sostenuta in studi recenti è che gli insediamenti della fase preromana siano riconducibili essenzial-mente a piccoli villaggi o fattorie, le cui tracce sono state rinvenute distribuite in maniera irregolare su tutto il territorio preso in esame28. È plausibile ritenere che a seguito delle vicende determinate dalla conquista romana, la popolazione aurunca fece ritorno ai villaggi e alle fattorie di origine, in quelle terre che non erano state com-prese nelle prime assegnazioni del 313 a.C., ridando vita ad una forma di popolamento che non ha soluzione di continuità con la fase precedente e che sembra durare almeno un cinquantennio, prima della totale assimilazione nelle nuove strutture territoriali.La necropoli di località Piscinola può fornire alcuni elementi utili a definire la fisionomia di una delle piccole comunità insediate sul territorio, nel momento in cui si passa da una condizione di relativa tranquillità ad una di trasformazioni e conflitti, dovuti al contatto con sistemi politici e culturali diversi. L’immagine che si coglie è quella di una comunità a carattere rurale, relativamente chiusa e in parte legata, almeno nella fase di uso iniziale della necropoli, vale a dire agli inizi del IV secolo a.C., ad un repertorio ceramico connesso alle tradizioni più an-tiche di questo territorio, rispondente a modelli culturali piuttosto conservativi. Il costume funerario che prevede la deposizione esterna del corredo è uno di quei caratteri di conservazione che viene mantenuto fino all’ultima fase d’uso della necropoli stessa e che costituisce un forte denominatore culturale di appartenenza29. Un quadro parzialmente mutato è quello che si evince dall’analisi delle sepolture della seconda metà del IV seco-lo a.C. La comunità che emerge dai contesti funerari presenta ancora carattere fortemente locale, ma manifesta con chiarezza l’acquisizione di modelli culturali nuovi, quali la conoscenza del simposio con il conseguente uso e consumo del vino, secondo un modello che si diffonde con una certa ampiezza nelle aree vicine30. L’acquisizio-ne di alcuni prodotti ceramici provenienti da officine campane particolarmente fiorenti a partire dalla seconda metà del IV secolo a.C., quali ad esempio quelle cumane, testimonia oltre che la diffusione di questi prodotti su larga scala territoriale, anche una certa floridezza di questa comunità ed una sua accresciuta capacità economica. Questa condizione tuttavia non produce un cambiamento decisivo nella scelta del corredo, che resta legato ad un repertorio di forme nel complesso piuttosto modesto e che si pone sostanzialmente in continuità con la fase precedente. L’arco cronologico di vita del sito, così come emerge da questa prima disamina, evidenzia un periodo d’uso della necropoli di circa un secolo. Siamo in un momento cruciale, come già detto, per la storia di questo territorio, segnato dalle vicende storiche che coinvolgono prima gli equilibri delle etnie stanziate tra Lazio meridionale e Campania Settentrionale e successivamente gli accadimenti connessi con l’avanzata romana. Le sepolture più
ESTRATTO
196 Angela De Filippis, Angelo Mazzocchi, Maria Grazia Ruggi d’Aragona
tarde si collocano cronologicamente proprio tra gli ultimi anni del IV e gli inizi del III secolo a.C., in quella fase nella quale, a seguito della disfatta degli Aurunci, si attua la confisca delle terre e la fondazione della colonia. L’u-so della necropoli fino ai primi anni del III secolo a.C. potrebbe essere messo in relazione con una preesistente organizzazione socio-territoriale, in forza della quale, pure a seguito delle tormentate vicende che segnarono il destino di queste popolazioni, piccoli gruppi fecero ritorno alle aree di origine. In questa ultima fase, queste pic-cole comunità non rinunciano tuttavia, almeno nel rituale funerario, all’affermazione della propria identità etnica e culturale, continuando ad adottare il costume funerario delle fasi precedenti ed utilizzando senza soluzione di continuità le stesse aree di sepoltura. Si potrebbe inoltre considerare una ulteriore e nuova affermazione identi-taria, intesa come acquisizione ed adozione di modelli culturali di tipo greco, anche l’utilizzo dell’anfora vinaria, del cratere e del servizio potorio all’interno dei corredi funerari di una comunità, che grazie al suo profondo legame con il territorio riesce a resistere ancora, almeno un ventennio, all’inesorabile riconfigurazione politica sociale ed economica prodotta dalla conquista romana.
ESTRATTO
Nota preliminare sulla necropoli di Località Piscinola a Lauro di Sessa Aurunca (CE) 197
NOTE
1 Un sentito ringraziamento va al Prof. Fausto Zevi ed alla Dott.ssa Valeria Sampaolo, che dal 2003 al 2005 si sono avvicendati alla Direzione della Soprintendenza ai Beni Archeologici della province di Napoli e Caserta. Un altrettanto sentito ringrazia-mento va alla Prof.ssa Gloria Olcese, che con cortesia ed entu-siasmo ci ha invitato a partecipare ai lavori ed ha incoraggiato questo contributo. 2 I lavori di indagine archeologica rientrano nel più ampio piano di interventi previsto per la realizzazione della rete di adduzione dell’impianto irriguo agricolo, ad opera del Consorzio Aurun-co di Bonifica. Le attività di controllo e assistenza archeologica, effettuate dal 2003 al 2006, hanno portato al rinvenimento non solo della necropoli oggetto di questo contributo, ma di altri im-portanti contesti distribuiti lungo un arco cronologico che va dal IV sec. a.C. fino ad epoca romana imperiale. Si tratta di scarichi di materiali ceramici per le fasi più antiche e di strutture relative a piccoli edifici rustici databili già a partire dal II sec. a.C. L’evi-denza più cospicua è sicuramente costituita da un lungo tratto di acquedotto rinvenuto in località Lauro di Sessa Aurunca, databi-le con tutta probabilità al I sec. d.C., al quale si sovrappone una necropoli costituita da 54 sepolture distribuite lungo un arco cronologico che va dalla fine del I al III sec. d.C. 3 L’uso di deporre il corredo ceramico all’esterno della cassa, lungo uno dei margini della fossa, sembra uno dei caratteri spe-cifici della necropoli.4 Lo studio dell’intero contesto di scavo è attualmente in corso; i dati qui forniti costituiscono una prima e generale sintesi delle caratteristiche della necropoli e delle indicazioni culturali in essa contenute. Il sito, del tutto ignoto prima del suo fortuito rinveni-mento, non è stato fortunatamente oggetto di scavi clandestini; ciò ha permesso di recuperare contesti integri, non manomessi nemmeno dai lavori agricoli, essendo buona parte dei terrazza-menti interessati dalla necropoli, del tutto incolti. Una notizia preliminare relativa al rinvenimento in Nava 2005, pp. 604-605, tav. IV.1. 5 Olle di questo tipo sono presenti, senza alcuna differenziazio-ne, in contesti di abitato, di necropoli e di santuari; esse fanno parte di un repertorio ceramico che conserva una straordinaria continuità, motivata probabilmente, oltre che dalla funzionalità della forma, anche e soprattutto dal valore culturale che questo tipo di vaso assume in questa area geografica. Essa rientra in quel repertorio di forme tipiche “della civiltà del Liri”, associate nelle fasi più antiche ai contesti contenenti vasi del cosiddetto buc-chero rosso, e poi variamente riproposta in associazione a classi ceramiche di epoche successive. Per le attestazioni in territorio aurunco e per un inquadramento della classe: Talamo 1987, pp. 115-116. L’“olla a bombarda” sembra assumere una connotazio-ne di appartenenza culturale e forse etnica, tanto da essere pre-sente in corredi funerari costituiti da oggetti di pregio, all’inter-no dei quali esse figurano come dei “markers” di identificazione anche da parte di individui che sembrano aver acquisito piena-mente modelli culturali di tipo greco, legati all’uso e al consumo del vino. Per le attestazioni a Teanum Sidicinum: cfr. Sirano 2008, p. 46; Sirano 2005, p. 432. Più di recente, per un contesto analo-go a quello della necropoli di Settequerce a Teano e proveniente da Riardo, loc. Palazzone: De Filippis, Passaro 2011, p. 523. Per la diffusione della classe nella Campania settentrionale tra il VII e il VI sec.a.C.: Sirano 2005a; De Filippis 2004; Johannowsky
2000; Renda 2004. Attestazioni anche in comparti più meridio-nali e da contesti rurali o di abitato in Mazzocchi 2011, p. 54, nota 13; Giampaola et al.1997, pp. 232-234.6 La tomba, rinvenuta nel settore Sud della necropoli, presenta-va una semplice fossa terragna coperta da due lastre di tufo gri-gio di spessore piuttosto ridotto, simulanti una copertura a dop-pio spiovente. Il corredo era posto in una piccola nicchia ricavata nell’angolo SW, all’esterno della fossa. 7 Agorà XII, pp. 107-108, tavv. 24,53, figg. 6,12; la forma rag-giunge la sua massima diffusione nel terzo quarto del V sec. a.C. in Attica e vive un notevole successo per tutto il secolo; diventa più rara nel IV, quando tuttavia la produzione continua in manie-ra più ridotta almeno fino alla fine del secolo. L’esemplare della tomba 73 sembra corrispondere alle elaborazioni realizzate dalla fine del V, con un piede che presenta una curva continua dalla parte inferiore a quella superiore, l’orlo lievemente estroflesso sul quale si impostano le anse, a ferro di cavallo, appena rivolte verso l’alto. Il tipo trova una elaborazione anche nelle produzio-ni a vernice nera dell’Italia meridionale, dove compare nella se-conda metà o alla fine del V secolo. Le attestazioni più numerose tuttavia si registrano nel corso del IV; cfr. Morel 1981, tipo 4122.8 Cfr. Agorà XII, pp. 126-127, tavv. 30-31, fig. 8; questa coppa monoansata a vernice nera si afferma nelle produzioni attiche, a partire dal secondo quarto del V secolo a.C. e perdura sino alla fine del IV. Le elaborazioni più tarde della forma presentano una vasca a profilo con doppia curva ed anse a ferro di cavallo, caratteri questi che compaiono nelle produzioni a vernice nera dell’Italia meridionale; Morel 1981, tipo 6213. Una coppetta monoansata dello stesso tipo di quella della Tomba 63 è presen-te all’interno della Tomba 5 di Teano, Settequerce, in un conte-sto datato tra la fine del V e gli inizi del IV sec. a.C.; Sirano 2005.9 Cfr. Agorà XII, pp. 130-131, tav. 32, fig. 8. L’esemplare della tomba 63 è confrontabile con la variante del tipo a vasca poco profonda. La forma, introdotta nel repertorio vascolare attico nel secondo quarto del V, conosce la massima diffusione alla fine del secolo, per scomparire prima della metà del IV, momento in cui diviene più larga, più bassa e con pareti più sottili. Il tipo compare fra i materiali ceramici del deposito del santuario della Marica di Minturnae; cfr. Mingazzini 1938, p. 895, tav. XXXVII, 6, dove sembra attestata tuttavia in pochi esemplari. La forma viene ripresa, con una certa semplificazione del profilo, anche nella produzione a vernice nera dell’Italia meridionale, nella se-conda metà del IV secolo a.C.; cfr. Morel 1981, tipo 2433. 10 L’anforisco costituisce un unicum all’interno della necropoli, la cui collocazione cronologica, tra la fine del V e il IV sec. a.C., non è evidentemente compatibile con la circolazione di prodotti di impasto attestati tra il VII e il VI sec.a.C. L’anfora analoga ad un altro esemplare proveniente da un corredo funerario della necro-poli in località Ponte Ronaco di Sessa Aurunca, corrispondente al tipo Talamo D, è del tutto caratteristica della cultura della me-dia valle del Liri. Essa è attestata, oltre che in siti del Lazio meri-dionale, anche in alcuni contesti della Campania settentrionale ma trova, al momento, solo sporadiche attestazioni nel territorio di Sessa Aurunca; Talamo 1987, p. 53, n. 3; p. 87, n. 61; p. 136, con un ampia bibliografia e siti di attestazione; lo stesso contesto anche in Villucci 1982. L’esemplare della Tomba 63 trova inoltre confronti tipologici stringenti con un’anfora dal deposito votivo del santuario della Marica a Minturnae, dove, all’interno della classe ceramica di “impasto marrone accuratamente ingubbiato di nero”, datata alla seconda metà VII-prima metà VI sec. a.C., viene segnalata tuttavia la sua possibile derivazione da una variante più
ESTRATTO
198 Angela De Filippis, Angelo Mazzocchi, Maria Grazia Ruggi d’Aragona
antica, con collo più sviluppato e corpo piuttosto schiacciato; cfr. Mingazzini 1938, p. 864, tav. XXX, 8.11 Questo settore della Campania settentrionale sembra conser-vare traccia profonda del più antico popolamento costituendo una zona marginale capace di conservare le più antiche tradi-zioni etniche e culturali; Lepore 1976-1977. In questa ottica è stata sottolineata inoltre l’azione unificatrice della valle del Liri, soprattutto nella sua parte inferiore, punto in cui essa svolge una funzione di polo di attrazione di popolazioni e costituisce l’ele-mento topografico portante del territorio degli Ausoni-Aurunci, che ne occupano le due sponde; Coarelli 1993.12 Per Teano si veda: Gabrici 1910, Tocco 1981, Sirano 2005. Per la necropoli di Cales: Passaro 2004, con bibliografia prece-dente. 13 Un altro piccolo gruppo di anfore greco italiche, del tipo II e IV, associate anche ad un esemplase di Corinzia A, è presente in corredi funerari provenienti dalla necropoli di Masseria Mona-ci a Presenzano (CE); il sepolcreto, databile tra la fine del VI e gli inizi del IV sec. a.C. è costituito da tombe scavate nel banco tufaceo disposte fittamente, secondo un unico orientamento ed insiste su un’area prossima ad un corso d’acqua stagionale, in una collocazione topografica che richiama quella della necropoli di Piscinola; Sirano 2005a, pp. 313-314. 14 Per la tipologia si fa riferimento allo studio di Vandermesch 1994. Recentissimo è lo studio di G. Olcese, di fondamentale importanza per l’inquadramento delle produzioni di anfore greco italiche in Campania, in particolare dei contenitori prove-nienti da Ischia e dal Golfo di Napoli; questo lavoro oltre che esaminare i prodotti di queste officine, con particolare attenzio-ne ai tipi IV e V, considera gli aspetti archeometrici per la com-parazione di reperti provenienti da diversi siti del Mediterraneo; Olcese 2010. La presenza dei tipi IV e V nella necropoli di Pisci-nola, in contesti coevi, sembra inoltre confermare quanto detto a proposito della comparsa e della circolazione dei due tipi, che appaiono contemporanei e coesistenti, in alcuni casi del tutto simili e associati in maniera piuttosto frequente con altre produ-zioni anforiche, quali le corinzie; Olcese 2010, p. 41. 15 Vandermesch 1994, pp. 73-76; Olcese 2010, con una analisi puntuale dei contenitori provenienti dal carico del relitto.16 Si tratta di un gruppo di vasi con figure rosse sovraddipinte, databili tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C., relativi ad una classe poco nota nella letteratura scientifica e con tutta pro-babilità riferibile ad un atelier nel territorio di Teanum Sidicinum o comunque nella Campania Settentrionale interna. Il reperto-rio vascolare si limita essenzialmente a due forme, il cratere a campana, con una vasca dalla caratteristica forma cilindrica, e lo skyphos, a profilo allungato; cfr. CVA Capua, IV Er, Vasi campani con figure rosse, p. 16, tav. 37,3 e p. 19, tav. 45, 1; Schauenburg 2002, p. 84 ss. Esemplari di crateri e skyphos attribuibili a questa produzione compaiono anche a Presenzano, Cales, Alife e più sporadicamente anche nell’entroterra di Neapolis; Sirano 2007, p. 38. 17 Questo gruppo di vasi è stato identificato per la prima volta dal Beazley e poi ripreso dal Trendall che lo ha inserito tra i pro-dotti dell’officina Cuma C; Beazley 1943, p. 104; Trendall 1967, pp. 571-572. Di recente è stata riconsiderata questa produzione all’interno del più generale quadro delle produzioni ceramiche figurate di Teano tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. Per una disamina dei vari contesti, funerari e cultuali, in cui sono sta-ti rinvenuti vasi e frammenti dell’officina del Pittore di Vitulazio
e degli elementi a sostegno dell’attribuzione di questi prodotti ad un atelier attivo nel territorio di Teanum verso la fine del IV e i gli inizi del III sec. a.C. cfr. De Filippis 2007, pp. 133-137.18 La cassa, con copertura a doppio spiovente, presenta all’in-terno una cornice su due registri e i timpani delle testate decorati da modanature. 19 Vandermersch 1994, pp. 76-78; Olcese 2010. 20 La Tomba 110 fa parte di un piccolo gruppo di sepolture, ben distinto dal punto di vista delle caratteristiche costruttive. Si tratta di tombe a fossa rettangolare, simulante la cassa, scavate nel banco tufaceo affiorante, che presentano sul lato N un ricet-tacolo a pianta quadrangolare, sulla cui fronte è posto in un caso una colonnina tuscanica priva di capitello (Tomba 109) nell’al-tro una colonnina dello stesso tipo ma con capitello a volute, estremamente stilizzato (Tomba 98). A questo piccolo insieme appartiene anche la tomba 110, che presenta un semplice ricet-tacolo rettangolare, all’interno del quale era deposto parte del corredo, mentre l’anfora era collocata ai piedi dell’inumato. Si tratta di una tipologia di tomba che, pur in una versione sempli-ficata, trova analogie piuttosto puntuali con monumenti simili di area sidicina; si veda per la necropoli di Torricelle, Tocco 1981; per località Gradavola, Gabrici 1910 e più di recente De Filip-pis, Svanera 1996; per le sepolture di località Settequerce, Sirano 2005, dove tuttavia l’elaborazione architettonica appare sicura-mente più accurata e spesso associata a decorazioni pittoriche. Se le elaborazioni di area aurunca si rifanno a modelli per così dire “architettonici” ben attestati a Teanum, se ne discostano tut-tavia, in maniera netta, nel rapporto funzionale che la struttura della tomba ha con il corredo funerario; nelle grandi necropoli sidicine il ricettacolo contiene sempre il corredo, mentre nelle tombe di Masseria Piscinola questo si presenta vuoto, con la sola eccezione della Tomba 110, e quindi defunzionalizzato rispetto ai modelli delle aree più a Sud. 21 Per la nascita e lo sviluppo della produzione: Koehler 1979; Koehler 1981; Koehler 1992. Si tratta di un esemplare ricon-ducibile alla elaborazione evoluta della forma avvenuta nel IV secolo a.C., con un largo orlo aggettante, molto inclinato e a con-tatto con la parte superiore delle anse, che sono maggiormente incurvate verso il basso, dove diminuiscono di spessore. Il cor-po evidenzia un profilo più slanciato e il piccolo puntale ha una forma chiaramente a tronco di cono. L’esemplare di Piscinola è realizzato in un’argilla di colore giallo, con la superficie esterna di colore rosaceo. La presenza dell’anfora corinzia A´ offre un ulteriore dato sulla circolazione di questi contenitori, spesso pre-senti negli stessi contesti delle greco italiche, come sottolineato nel recente studio di G. Olcese. Per la necropoli di Piscinola, questa resta l’unica attestazione, ma potrebbe essere utile richia-mare anche la necropoli di Masseria Monaci a Presenzano, dove un piccolo numero di corredi ha restituito anfore del tipo greco italica II e IV e una corinzia A; cfr. nota 13. 22 L’anfora potrebbe essere avvicinata ai prodotti della fiorente e prolifica officina cumana, riferibile al Gruppo Apulizzante, sia per la scelta iconografica con la scena funeraria e il naiskos, sia so-prattutto per la resa dell’architettura del sacello, completamente sovraddipinto in bianco così come la figura femminile al suo in-terno; cfr. Trendall 1967, p. 495 ss. 23 È alquanto probabile che, in questa area, fosse attivo un centro di produzione di anfore greco italiche, considerati anche i risul-tati delle analisi delle argille, che hanno evidenziato caratteristi-che mineralogiche del tutto specifiche; Olcese 2010, p. 277. La
ESTRATTO
Nota preliminare sulla necropoli di Località Piscinola a Lauro di Sessa Aurunca (CE) 199
vocazione produttiva di questo comparto geografico-culturale si coglie con notevole chiarezza in questa fase, pur mancando dati certi sui siti produttivi: sono abbastanza tipiche le ceramiche a vernice nera realizzate con un’argilla di colore chiaro, polverosa, utilizzata senza discrimine per la realizzazione di vasi a vernice nera e di forme di ceramica comune, rinvenute anche in altri contesti di scavo nel corso dei lavori promossi dal Consorzio di Bonifica Aurunca. Sembra del tutto verosimile l’esistenza di un centro di produzione di greco italiche tipo V e V/VI nel terri-torio di Mondragone (CE), dove è stata localizzata una fornace che ha continuato la sua attività anche successivamente, con la produzione di Dressel 1; Olcese 2010, p. 277. Sulla continuità di produzione: Hesnard et al. 1989. Risulta comunque necessaria l’individuazione di altri siti, nell’area compresa fra Capua e Ses-sa Aurunca, determinati anche dalle ricche produzioni vinicole ben note per questo territorio; Olcese 2010, p. 297. 24 Per un’accurata analisi delle notizie sugli Aurunci in Livio si veda Pagliara 2006. 25 Liv. II, 36, 4; Liv. II 37,1.26 Cfr. Arthur 1991, p. 26.27 Liv. VIII, 15,4; il passo di Livio parla della distruzione dell’op-pidum degli Aurunci, del suo abbandono e della fuga degli abi-tanti presso un altro sito fortificato, che più tardi sarà chiamato Suessa Aurunca. Il racconto di Livio contiene, secondo Salmon, un probabile anacronismo, poiché riporta fatti avvenuti solo nel 314, quando l’offensiva di Roma diede un duro colpo agli Aurun-ci e provocò molto probabilmente la distruzione dei loro centri fortificati. La notizia dell’intervento dei Sidicini può essere stata creata per giustificare in qualche modo la fondazione di Cales nel 334, proprio come punto di controllo dei Sidicini localizzati sulla riva opposta del Savone; Salmon 1967, p. 209. Il passo liviano è stato di recente riesaminato da A. Pagliara, il quale sottolinea la distinzione tra l’oppidum conquistato dai Sidicini e la città di Suessa, nella quale si rifugiano gli Aurunci sconfitti; Pagliara 2006. Quest’ultima potrebbe essere identificata con Ausona, una delle città aurunche menzionate dallo stesso Livio, alla cui fine nel 314, segue la deduzione della colonia di Suessa Aurunca: Liv. IX, 25, 4-5: “Ausona et Minturnae et Vescia urbes erant ex quibus principes iuventutis duodecim numero in proditionem urbium sua-rum coniurati ad consule venerunt”. Nessuna di queste città è stata identificata con certezza con un centro arcaico. Da ricerche sul territorio F. Coarelli identifica il sito di Minturnae aurunca con l’insediamento medievale di Traetto. La presenza di Vescia è, al momento, attestata solo da un’iscrizione rinvenuta a Castelforte, presso Suio, nella quale si ricorda un pagus vescinus; tale presen-za, associata al riscontro con la miniatura dei Gromatici Veteres, ha fatto ritenere che il centro aurunco potesse trovarsi sulla riva destra del Garigliano. Nulla si può ipotizzare invece sull’ubica-zione di Ausona, il centro eponimo, che tuttavia è posto, dallo stesso Coarelli, in prossimità del sito della futura colonia latina di Suessa Aurunca, in una posizione dominate rispetto alla pia-nura costiera; cfr. Coarelli 1993. Si è tentato più volte di mettere in relazione questi centri arcaici con le numerose cinte in opera poligonale presenti su tutto il territorio, anche se molte di queste hanno restituito pochi e sporadici resti riferibili essenzialmente al IV secolo a.C.; cfr. Arthur 1991, p. 30. La problematica relativa all’organizzazione del territorio e ai modelli di insediamento è stata ripresa di recente, in un’ottica che privilegia la centralità di alcuni luoghi di culto come poli di aggregazione di comunità or-ganizzate secondo un modello pagano-vicanico; Andreani 2003. 28 Per Sessa Aurunca, i dati, piuttosto frammentari, per l’età
arcaica fanno riferimento ai resti di un abitato in località Ponte Ronaco. I materiali recuperati testimoniano, oltre che l’esisten-za di un insediamento arcaico, il perdurare dello stesso almeno fino al III sec. a.C., in una fase sicuramente successiva la fonda-zione della colonia di Suessa; Talamo 1987, pp. 10-50. Nel resto del territorio dovevano insistere piccoli insediamenti, costituiti da capanne e da strutture realizzate in materiali deperibili, che proprio per le loro caratteristiche non monumentali risultano difficilmente leggibili e spesso suggeriti solo dalla presenza dei nuclei di necropoli, a partire da età arcaica fino a giungere, con tutta probabilità, al momento della conquista romana, che segna la svolta nel modello di occupazione e sfruttamento del territo-rio. Numerosi e frammentari sono i dati relativi alla più antica occupazione preromana, le cui testimonianze si distribuiscono in un’ampia porzione di territorio che va dal Lazio meridionale, con maggiore concentrazione nelle aree gravitanti intorno alla valle del Liri, fino al territorio di Cales e Sinuessa; per una sintesi dei rinvenimenti Gasperetti et al. 1999, pp. 152-158.29 Lo stesso costume è attestato nella necropoli di Lagoscello a Riardo (CE)dove già a partire dal VII secolo a.C., le sepoltu-re sono accompagnate da un corredo ceramico in parte posto all’esterno della fossa. Questo uso sembra rispondere al carat-tere culturale delle comunità ausoni-aurunche, e si manifesta, pur se in forma ridotta, anche in alcune tombe della necropoli di Cales, dove un solo vaso di grandi dimensioni è collocato fuori dalla fossa di deposizione; De Filippis, Passaro 2011, p. 521. 30 Il modello sembra essere diffuso in un ampio settore della Campania settentrionale interna; De Filippis, Passaro 2011, pp. 522-523; Sirano 2005.
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Agorà XII: B. Sparkes, L. Talcott, The Athenian Agorà, vol. XII, Black and Plain Pottery of the 6th, 5th, and 4th century BC, Princeton 1970.
Andreani 2003: M. Andreani, Sul santuario della Marica alla foce del Garigliano, in L. Quilici, S. Quilici Gigli (a cura di), Santuari e luoghi di culto nell’Italia Antica (Atlante Tematico di Topografia Antica 12), Roma, pp. 177-208.
Arthur 1991: P. Arthur, Romans in northern Campania: Settlements and land-use around the Massico and Garigliano basin (Archaeological Monographs of the British School at Rome 1), Rome.
Beazley 1943: J.D. Beazley, Group of Campanian red-figure, in Journal Hellenistic Studies 63, pp. 66-111.
Coarelli 1993: F. Coarelli, Roma, Gli Aurunci e la fondazione di Sinuessa, in L. Crimaco, G. Gasperetti (a cura di), Prospettive di memoria. Testimonianze archeologiche della città e del terri-torio di Sinuessa, Napoli, pp. 17-28.
De Filippis 2004: A. De Filippis, Sito 43. Via Vergini località Fabbrica, in F. Miele, F. Sirano (a cura di), Ager Allifanus. La piana alifana alla luce delle recenti ricerche archeologiche (Quaderni Campano Sannitici IV), Piedimonte Matese, pp. 133-137.
De Filippis 2007: A. De Filippis La ceramica figurata di Teanum Sidicinum tra IV e III sec.a.C., in F. Sirano (ed.), In itinere. Atti del I e II Ciclo di Conferenze, Capua, pp. 123-143.
De Filippis, Passaro 2011: A. De Filippis, C. Passaro, L’oc cu-pa zione sul territorio caleno e del Monte Maggiore. Stato de-
ESTRATTO
200 Angela De Filippis, Angelo Mazzocchi, Maria Grazia Ruggi d’Aragona
gli studi e prospettive di ricerca, in Gli Etruschi e la Campania Settentrionale. Atti del XXVI Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Caserta - Santa Maria Capua Vetere - Capua - Teano, 11-15 novembre 2007), Roma 2011, pp. 513-531.
De Filippis, Svanera 1996: A. De Filippis, S. Svanera, Di alcu-ni corredi della necropoli di Teano-Fondo Gradavola, in BA 37-38, pp. 127-144.
Gabrici 1910: E. Gabrici, Necropoli di età ellenistica a Teano dei Sidicini, in MonAL 20, pp. 7-52.
Gasperetti et al. 1999: G. Gasperetti, C. Passaro, S. De Caro, Novità dal territorio degli Ausoni, in M. Barra Bagnasco, E. De Miro, S. Pinzone (a cura di), Progetto strategico CNR, Origine e incontri di culture nell’antichità. Magna Grecia e Sicilia. Stato de-gli studi e prospettive di ricerca. Atti incontro di studi (Messina, 2-4 dicembre 1996), Messina 1999, pp. 145-158.
Giampaola et al. 1997: D. Giampaola, M. Sica, G. Ronga, Appunti per la storia del paesaggio agrario di Acerra, in L. Quilici, S. Quilici Gigli (a cura di), Uomo acqua e paesag-gio. Atti dell’incontro di studi: irreggimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico (S. Maria Capua Vetere, 22-26 novembre 1996) (Atlante Tematico di Topografia Antica Suppl. 2), Roma 1997, pp. 232-234.
Hesnard et al. 1989: A. Hesnard, M. Ricq, P. Arthur, M. Picon, A. Tchernia, Aires de production del gréco-italiques et des Dr.1, in M. Lenoir, D. Manacorda, C. Panella (a cura di), Amphores romaines et histoire économique: dix ans de recherche. Acte du colloque de Sienne (22-24 mai 1986) (Collection de l’Ecole Française de Rome 114), Roma 1989, pp. 21-65.
Johannowsky 2000: W. Johannowsky, Presenzano: necropoli in località Robbia, in Italia dei Sanniti, Roma, pp. 16-19.
Koehler 1979: C.G. Koehler, Corinth A and B transport am-phoras, Diss. Princeton University.
Koehler 1981: C.G. Koehler, Corinthian Developments in the Study of Trade in the Fifth Century, in Hesperia 50, pp. 449-458.
Koehler 1992: C.G. Koehler, A brief typology and chronology of Corinthian transports amphoras, Saratov.
Lepore 1976-1977: E. Lepore, Gli Ausoni: leggende delle ori-gini, tradizioni etniche e realtà culturali, in Archivio Storico di Terra di Lavoro 5, pp. 81-108.
Mazzocchi 2011: A. Mazzocchi, Gricignano d’Aversa (CE). Olle dipinte di età arcaica, note preliminari, in F. Roncalli (a cura di), Munuscula. Omaggio degli allievi napoletani a Mauro Cristofani (Quaderni del Centro Studi Magna Grecia 11), Pozzuoli, pp. 51-72.
Mingazzini 1938: P. Mingazzini, Il santuario della Dea Marica alle foci del Garigliano, in MonAL 37, 2, coll. 693-957.
Morel 1981: J.-P. Morel, Céramique campanienne: les formes (Bibliothéque des Ècoles françaises d’Athènes et de Rome 244), Rome.
Nava 2005: M.L. Nava, L’attività archeologica a Napoli e Caserta nel 2005, in Velia. Atti del Quarantacinquesimo Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto-Marina di Ascea, 21-25 settembre 2005), Taranto 2005, pp. 583-661.
Olcese 2010: G. Olcese, Le anfore greco italiche di Ischia: archeologia e archeometria. Artigianato ed economia nel
Golfo di Napoli (Immensa Aequora 1), Roma.Pagliara 2006: A. Pagliara, Gli Aurunci in Livio, in Oebalus 1,
pp. 11-19. Passaro 2004: C. Passaro, Tombe maschili da Cales, in D.
Caiazza (a cura di), Safinim. Studi in onore di Adriano La Regina per il premio I Sanniti, Piedimonte Matese, pp. 153-169.
Renda 2004: G. Renda, Il territorio di Caiatia, in L. Quilici, S. Quilici Gigli (a cura di), Carta archeologica e ricerche in Campania, Fasc. I, Comuni di Alvignano, Baia e Latina, Caiaz-zo, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Dragoni, Piana di Monte Verna, Ruviano (Atlante Tematico di Topografia Antica Suppl. 15.I), Roma, pp. 239-423.
Salmon 1967: E.T. Salmon, Samnium and the Samnites, Cambridge.
Sirano 2002: F. Sirano, Presenzano/Rufrae. Per una nuova im-magine della piana nell’antichità, in D. Caiazza (a cura di), Presenzano ed il Monte Cesima. Archeologia, storia e arte di una comunità (Quaderni Campano-Sannitici 3), Piedimonte Matese, pp. 61-97.
Sirano 2005: F. Sirano, Appunti su una tomba da Teanum Sidicinum con bronzi etruschi e un’anfora di mende, in D. Caiazza (a cura di), Italica Ars. Studi in onore di Giovanni Colonna per il premio i Sanniti (Libri Campano-Sannitici 4), Piedimonte Matese, pp. 413-448.
Sirano 2005a: F. Sirano, Presenzano-Rufrae. Nuovi dati per la storia del popolamento nella Campania Settentrionale tra età arcaica e classica sulle sfondo delle dinamiche di lungo periodo, in P. Attema, A. Nijboer, A. Zifferero (a cura di), Papers in Italian Archaeology VI, Communities and Settlements from the Neolithic to the Early Medieval Period. Proceedings of the 6th Confernce of Italian Archaeology, I (BAR International Series 1452 I), Oxford, pp. 302-316.
Sirano 2007: F. Sirano, Il museo di Teanum Sidicinum, Guida rapida, Napoli.
Sirano 2008: F. Sirano, Identità culturali nella Campania setten-trionale: un aggiornamento, in C. Corsi, E. Polito (a cura di), Dalle sorgenti alla foce. Il bacino del Liri-Garigliano nell’anti-chità, culture contatti scambi, Atti del Convegno (Frosinone-Formia, 10-12 novembre 2005), Roma 2008, pp. 37-59.
Schauenburg 2002: K. Schauenburg, Studien zur unteritali-schen Vasenmalerei, IV/V, Ludwig.
Talamo 1987: P. Talamo, L’area aurunca nel quadro dell’Italia centromeridionale. Testimonianze archeologiche d’età ar-caica (BAR International Series 384), Oxford.
Tocco 1981: G. Tocco, Teano (CE), Necropoli in località Torricelle, in SE 49, pp. 519-520.
Trendall 1967: A.D. Trendall, The red-figured vases of Lucania, Campania and Sicily, Oxford.
Vandermersch 1994: Ch. Vandermersch, Vins et amphores de Grande Grèce et de Sicile, IV-III s. avant J.C., Naples.
Villucci 1982: A.M. Villucci, Testimonianze del Gaudo nel ter-ritorio di Suessa Aurunca. Presenze orientalizzanti a Suessa Aurunca. Presenze romane nel territorio di Sinuessa e Suessa Aurunca, in I Convegno dei Gruppi Archeologici della Campania (Pozzuoli, 12-20 aprile 1980), Roma 1982, pp. 145-174.
ESTRATTO