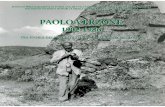RV Schofield, L'architettura temporanea costruita per il matrimonio di GGSforza e Isabella D'Aragona...
Transcript of RV Schofield, L'architettura temporanea costruita per il matrimonio di GGSforza e Isabella D'Aragona...
QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURADIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA
NUOVA SERIE, FASCICOLI 57-59 / 2011-2012
SAPIENZA- UNIVERSITÀ DI ROMA
GIORNATE DI STUDIOIN ONORE DI ARNALDO BRUSCHI
VOLUME IRoma, Facoltà di Architettura, 5, 6, 7 maggio 2011
A CURA DI
FLAVIA CANTATOREFRANCESCO PAOLO FIORE
MAURIZIO RICCIAUGUSTO ROCA DE AMICIS
PAOLA ZAMPA
BONSIGNORI EDITORE2013
Francesco Paolo FiorePRESENTAZIONESCRITTI DI ARNALDO BRUSCHIStefano PittaccioSANTA MARIA IN TRASTEVERE,ASPETTI INEDITI DI UN PROGETTO ALL’ANTICA.ORIGINI E FORMAZIONE Massimo BulgarelliLA SAGRESTIA DI SANTA TRINITA A FIRENZE.ARCHITETTURA, MEMORIA, RAPPRESENTAZIONEFlavia CantatoreIL TEMPIETTO DI SANT’ANDREA A PONTE MILVIOTRA ARCHITETTURA E SCULTURANELLA ROMA DEL SECONDO QUATTROCENTOFrancesco BenelliLA FACCIATA DELLA CHIESA DI SANT’AGOSTINO A ROMA:UNA NUOVA LETTURARenata SamperiIL GUSTO DELLA VARIETASNELL’ARCHITETTURA ROMANADEL SECONDO QUATTROCENTO: CAPITELLI COMPOSITI E MIXTA LINEAMENTISNELLA CHIESA DI SANT’AGOSTINOSimonetta ValtieriIL PALAZZO DI SANTE BENTIVOGLIO A BOLOGNARichard SchofieldL’ARCHITETTURA TEMPORANEACOSTRUITA PER IL MATRIMONIODI GIAN GALEAZZO SFORZA E ISABELLA D’ARAGONA (1489)Christof ThoenesPERSISTENZE, RICORRENZE E INNOVAZIONINELLA STORIA DELLA BASILICA VATICANAFrancesco P. Di TeodoroINEDITI RILIEVI DALL’ANTICOIN ALCUNI FOGLI DEL XVI SECOLOALLA BIBLIOTHÈQUE DE L’INSTITUT DE FRANCE«... DONT PLUSIEURS PARAISSENT ÊTRE DE LA MAINDE DONATO D’ANGELI LAZZARI, DIT BRAMANTE, D’URBINO»Marcello Fagiolo BRAMANTE E IL PALAZZO DELLA CANCELLERIA:LA PORTA-CITTÀ E LA LEZIONE DI GEOMETRIA
57
13
25
37
49
59
67
77
85
93
101
PAG
RIASSUNTI / ABSTRACT
113
121
129
143
151
155
167
173
183
191
199
209
223
231
SAPIENZA- UNIVERSITÀ DI ROMA
DirettoreFrancesco Paolo Fiore (responsabile)
Consiglio scientifico Daniela Esposito, Paolo Fancelli, Donatella Fiorani,Francesco Paolo Fiore, Antonella Greco, Giorgio Muratore,Augusto Roca De Amicis, Paolo Rocchi, Maria Piera Sette, Alessandro Viscogliosi.
Comitato direttivo Lia Barelli, Clementina Barucci, Calogero Bellanca, Simona Benedetti,Maurizio Caperna, Tancredi Carunchio, Annarosa Cerutti, Piero Cimbolli Spagnesi,Fabrizio De Cesaris, Daniela Esposito, Paolo Fancelli, Donatella Fiorani, Francesco Paolo Fiore,Daniela Fonti, Antonella Greco, Giorgio Muratore, Susanna Pasquali,Maurizio Ricci, Augusto Roca De Amicis, Paolo Rocchi, Maria Piera Sette,Maria Grazia Turco, Alessandro Viscogliosi, Paola Zampa.
Redazione Flavia Cantatore (coordinatore)
Ogni contributo viene sottoposto ad almeno due revisori scelti fra i membri del Dipartimentoin base alle loro specifiche competenze nel settore della Storia e Restauro dell’architettura;tali pareri sono integrati da pareri di studiosi italiani e stranieri esperti nei temi affrontati.
Traduzione in inglese Erika G. Young
Grafica e impaginazione Roberto steve Gobesso
Stampa CTS Grafica S.r.l., via Vito Vincenti 23, località Cerbara 06011 Città di Castello (PG) - telefono 075.8511555
Corrispondenza e norme editorialiDipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’ArchitetturaPiazza Borghese 9, 00186 Roma - telefono 06.49918825 - fax 06.6878169 - web w3.uniroma1.it/storiarch
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 131/87 del 06/03/1987
Il presente fascicolo è stampato con il parziale contributo di SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA
Abbonamenti e distribuzioneBonsignori Editore s.r.l., via Giuseppe Tornielli 16, 00153 Romatelefono 06.99709447 - [email protected] - www.bonsignori.it
PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
© 2013Bonsignori Editore s.r.l., via Giuseppe Tornielli 16, 00153 Roma© 2013Sapienza - Università di RomaDipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, piazza Borghese 9, 00186 Roma
ISBN 978-88-7597-433-6ISSN 0485-4152
NUOVA SERIE, FASCICOLI 57-59 / 2011-2012
PAG
QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURADIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA
Maurizio CapernaCONSIDERAZIONI SULLA LUNGARA DI GIULIO II E BRAMANTEBruno AdorniGIULIO ROMANO ARCHITETTO NEL PERIODO MANTOVANO:PRECISAZIONI SU QUALCHE RIPRESA DA RAFFAELLORossella OngarettoBALDASSARRE PERUZZI E I TEATINIFlaminia Bardati«DOMINICO CORTONENSI ARCHITECTANTE» A PARIGI (1530-1545):IL PROGETTO DELL’HÔTEL-DE-VILLEEnzo BentivoglioANTONIO DA SANGALLO IL GIOVANE E SIMONE MOSCA,PER LA PRIMA «INTRATA» DI PAOLO III A ORVIETOFlavia ColonnaIL FORTE SAN MICHELE A OSTIAUNA PICCOLA OPERA DI ARCHITETTURA MILITARENEL SISTEMA DIFENSIVO COSTIERO PONTIFICIOAugusto Roca De AmicisSUCCESSI E LIMITI DEGLI ‘ARCHITETTI-SCULTORI’NEL CINQUECENTO: IL CASO DI SIMONE MOSCAAmedeo BelluzziUN CASO STORIOGRAFICO:LA VILLA FIORENTINA DEI COLLAZZIAdriano Ghisetti GiavarinaQUALCHE CONSIDERAZIONE SU PALLADIO E ROMA:UNA VEDUTA TOPOGRAFICA E I DISEGNI DALL’ANTICOPaola ZampaLO IONICO MODERNOMaurizio RicciUN CARDINALE CERCA CASA. FILIPPO BONCOMPAGNIE OTTAVIANO MASCARINO TRA BOLOGNA E ROMABartolomeo AzzaroFACCIATE PULSANTI E SPAZIO URBANONELLA ROMA DEL CINQUECENTOMario CurtiNOTE SUI ‘TRACCIATI ARMONICI’NELLA STORIA DELLE TEORIE ARCHITETTONICHE
77QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 57-59/2011-2012
Gian Galeazzo Sforza e IsabellaD’Aragona si sposarono il 24 di-
cembre 1488 a Napoli1: purtroppo l’archi-tettura effimera costruita a Milano nel feb-braio 1489 per festeggiare il loro matrimo-nio rimane ancora oggi quasi ignota, nono-stante le copiose descrizioni di TristanoCalco e dell’Anonimo parigino (un testomolto vicino nel contenuto a quello di Cal-co) e nonostante i testimoni oculari, comeil poeta Gian Alberto Bossi, i fratelli Fos-sano e soprattutto Stefano Dulcino2.
Quella di Stefano Dulcino è una figuradi particolare interesse non solo per le sueattività letterarie (curò infatti un’edizionedel primo libro di Manilio, delle Epistolaedi S. Ambrogio e compose il Sirmio basatosul carme di Catullo n. 31), ma anche per ilsuo specifico interesse per l’architettura3.Per le sue Nuptiae illustrissimi ducis medio-lani pubblicate nel marzo del 1489 Dulci-no ricevette le lodi di Giacomo Gherardi,
nunzio pontificio a Firenze e a Milano, chenota soprattutto la sua competenza rispet-to al linguaggio di Vitruvio e Plinio4.
Nel suo piccolo volume, Dulcino pre-senta una descrizione approfondita delDuomo, puntando l’attenzione, inter mul-ta alia, sullo schema di Stornaloco per lasua costruzione e per la forma del tiburionel periodo del celebre concorso che coin-volse Bramante, Leonardo e molti altri, di-chiarando nel capitolo de templo mediola-nensi di aver desunto molte informazioni«ex adversariis architectorum et ex ephi-meridibus epistatarum»5.
Il suo interesse per l’architettura conti-nuò inoltre con la partecipazione alle com-missioni per il completamento della portadi Compedo nel 15036. È quindi certo cheDulcino doveva per lo meno conoscerepersonalmente sia Amadeo che AmbrogioFerrari, Bramante, Leonardo e altri archi-tetti e impresari impiegati in duomo o pres-
so il duca negli anni ‘80 del XV secolo. Per la cerimonia del febbraio 1489 una
serie di strutture lignee era stata sistemataper creare un percorso cerimoniale chepartiva dalla corte ducale del castello sfor-zesco giungendo fino all’altare maggioredel duomo. Nella corte un portico ligneodi sette colonne era stato posto in corri-spondenza del lato aperto della corte stes-sa, di fronte a quello realmente esistente sulfondo che presenta cinque colonne e duesemicolonne (fig. 1).
I muri della corte erano decorati concentauri e fauni, corone di edera, trecce dilauro, ghirlande di ginepro e stemmi duca-li. Le arcate erano realizzate con rami di gi-nepro e con capitelli di bacche; non sappia-mo, però, per quale motivo Calco dichiaraanche che l’architettura era «novi generis».
Il corteo di Isabella d’Aragona, con ilsuo entourage di sessanta donne sontuosa-mente vestite e seguita dal duca e dalla du-
L’ARCHITETTURA TEMPORANEA COSTRUITAPER IL MATRIMONIO DI GIAN GALEAZZO SFORZA
E ISABELLA D’ARAGONA (1489)
di RICHARD SCHOFIELD
Fig. 1 - Milano, castello sforzesco, corte ducale.
I.
quasi certamente di un ottagono regolarealmeno fino all’altezza della cornice16.
Secondo Dulcino, somigliava al Battiste-ro di Cremona e a San Lorenzo a Milano,edifici ai suoi occhi assai simili anche se laparte superiore di San Lorenzo era a sedicilati e presentava due gallerie (fig. 3), men-tre il battistero di Cremona aveva forma ot-
tagonale, con una galleria alla sommità, untetto a falde e una volta a padiglione su ba-se ottagonale con sezione semicircolare.
Ovviamente è più difficile ricostruire idettagli della struttura (fig. 2). Le columnaemenzionate da Dulcino sono in realtà pilo-ni e lui stesso aggiunge che erano di «formatriquetra» Calco parla di columnae triangu-lares. Per sostenere un edificio ottagonalesono necessari piloni poligonali con alme-no due facce verso l’esterno e due versol’interno, come sarebbero quelli della sa-crestia di Santa Maria presso San Satiro seconsiderati come fossero isolati (fig. 4).Forse le trentadue statue femminili, quat-tro per pilone, erano distribuite in corri-spondenza delle facce esterne e laterali deipiloni stessi, piuttosto che disposte a cop-pie solo sulle facce esterne, perché la deco-razione dell’edificio avrebbe dovuto esse-re visibile sia all’esterno che all’interno. Neipennacchi degli archi si trovano pueri ala-ti, forse un fraintendimento per vittorie.
Dulcino dice che archi potenti congiun-gevano gli epistyliadei piloni e che al di sot-to di questi si trovavano grandi ruote. Pro-babilmente gli epistylia erano trabeazioniinvece che semplici architravi, sulle qualipotevano essere appoggiati gli archi, con-sentendo così la formazione di spazi in cuiinserire le ruote e i fanciulli che si doveva-no occupare di girarle17. I vantaggi di que-sta interpretazione sono che fornisce unospazio plausibile per le rotae simile a quel-lo visibile a destra dell’incisione Prevedari(1481), dove una ruota fantastica si trovadentro un archivolto sopra una trabeazio-ne, anche se ilpuer inginocchiato dà le spal-le alla ruota (fig. 5).
La trabeazione completa aveva almenodue precedenti rispetto al tiburio: quelladel padiglione ligneo costruito prima del1480 nel parco del castello e disegnato daLeonardo in Ms B, fol. 12r (fig. 6), e quelladella loggetta realizzata nella corte ducaledello stesso castello (fig. 1 a sinistra). Piùtardi, quella della Ponticella di Ludovico ilMoro. Siamo di fronte però al solecismo ar-chitettonico di un archivolto sopra una tra-beazione completa.
La contraddizione contenuta nelle di-chiarazioni che il tiburio somigliasse con-temporaneamente al Panteon (Calco) e aSan Lorenzo (Calco e Dulcino) può esseretuttavia spiegata. Calco dice che la cupolasorge «hinc» – sopra i piloni del peristyliumo dell’ambulatio– passando probabilmen-te a parlare dell’interno dell’edificio; e, in-fatti, l’interno del tiburio somiglia sia alPanteon sia a San Lorenzo perché entram-bi avevano coperture grosso modo emisfe-riche all’interno ma diverse all’esterno;questa attenzione per l’interno può spiega-re perché Calco non menziona la galleriasuperiore descritta da Dulcino. Il risultatofinale è che il tiburio era una struttura lom-barda tipica, genericamente simile a SanLorenzo e Sant’Aquilino, alla sacrestia diSanta Maria presso Satiro, a Santa Mariadelle Grazie e altri esempi.
II. Qual era il significato della strutturaper gli spettatori? Arrivati all’arco trionfa-le, i neo-sposi passarono a cavallo per il va-no centrale, il loro retinue a piedi per i va-ni laterali; nel tiburio Isabella «fu ricoltadal clericato del domo quale gli fece basa-re una croce» (Anonimo), e da una folla dinobildonne milanesi, tra le quali Beatriced’Asti, figlia di Ludovico il Moro. Poi en-trambi entrarono in duomo dove il clero siera già radunato.
Le trentadue immagini di donne inclu-
79QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 57-59/2011-2012
chessa, usciva dal castello per arrivare a unarco a triplice fornice posto all’inizio dellapiazza del duomo e decorato con rappre-sentazioni delle gesta di Francesco Sforza.Dopo l’arco e grosso modo parallelo con ilCoperto dei Figini si estendeva un’altroportico costruito con mirtillo ed edera, de-scritto da Dulcino come un ambulatioo ge-statio e simile ad un xystuso paradromis. Fi-nalmente la processione giungeva quindi alpièce de résistance, il tiburio costruito da-vanti alla porta del duomo.
La descrizione di Calco dell’ultima se-rie di arcate, quella dentro il duomo, è lapiù particolareggiata: si tratta di un peristy-lium esteso dalla porta della chiesa al capo-croce, con diciassette coppie di colonnescanalate dotate di plinti, basi e capitelli aforma di testa di Giano con quattro facce,la cui iconografia è spiegata più tardi daBernardino Corio, che adulando Ludovi-co il Moro dice che «come arbitro d’Italiatanto tempo habbi saputo concordar Gia-no con Marte»7. La volta era composta dapiccoli tondi intrecciati («minusculis orbi-bus») forse ‘alla Mantegna’, decorati constemmi e rappresentazioni di centauri eninfe, come nella corte del castello.
Soffermiamoci però a studiare nel det-taglio il tiburio costruito davanti alla portadel duomo, descritto da Dulcino come se-gue (fig. 2): «Ante templi frontispicium am-phitheatrali orbe portam magnam vestienslignea testudo primum spectantibus mira-culum prebuit. Haec columnarum octosty-lio sustentata fastigiato fornice veteris tem-pli pinaculum adaequabat. Columnarumforma quasi triquetra exangularis firmissi-ma basi ex[s]urgens sex8 passuum latitudi-ne antiqua opera imitabatur. Testitudinishuius, quam modo prothyron9 modo pro-naon nonnumquam sphaeristerion10 diver-sis de causis nominabo, unaquaeque co-lumna quaternis loculamentis emula veri-tatis signa capiebat, quae sub nomine illu-strium foeminarum duo et triginta fuere,forma et habitu muliebri, cum peculiaribusarmis et eulogiis faberrime expolita; colum-narum epistylia quibus testudinea moles in-niteretur fortissimi arcus connectebant subquorum singulis ingentes rotae, binis iuve-nibus superliminari fultis versabantur, exvirenti hedera superficies et radii, modioliautem et tympanum ex auro refulgebant, inarcuum dorso secundum coronida deam-bulatorius tyrsis11 relinquitur, sexqui [sic:sexque] cubitalibus columnellis extrinse-cus quasi cancellis munitus. Supra hunc si-mile aliud procestrion12 per quod ad fasti-gium ascensus erat. Ex ambobus in forumprospectus et circum machinae coronamvia facilis. Ab hoc loco in metatam figuramapex fastigiari incipit usque adeo in altumprogrediens ut altitudine tempo par sit.Tholi rotundus vertex columnata triplicisordinis pyramide coronatur, totum aedifi-
cium iunipero tectum pumbleis [sic: plum-beis] siphonculis epluebat13. Sed ne dum inhoc nimium versor molestus tibi fiam, opu-sque explicare cupiens me totum impli-cem, exemplo agetur: delubrum divi Lau-rentii quod Mediolanenses tugurium ap-pellant fuit istius aedificii exceptis orna-mentis archetypon, ipsa testudo non mul-tum a vestro baptisterio absimilis»14.
Le fonti concordano su dimensioni, for-ma e materiali del tiburio: era costruito dilegno, con i condotti per l’acqua di piom-bo e il tetto coperto di ginepro; era «tuttocoperto de cartoni bianchi et morelli» e trai balaustri della prima galleria c’erano«imagini» dipinte su carta (l’Anonimo).
Le trentadeue rappresentazioni di don-ne illustri sono descritte come imagines(Calco e l’Anonimo) e signa (Dulcino); sitrovano in nicchie (loculamenta) e nei «ca-vati modice lateres» dei piloni (Dulcino eCalco), per cui sembrano essere state sta-tue lignee o di carta pesta.
Il tiburio era largo 30 braccia (Calco) e
alto 50 (l’Anonimo). L’altezza del tiburiodescritta dalle fonti potrebbe essere solouna congettura ma non sarebbe assurdaper una struttura effimera perché avrebbeun rapporto tra altezza e larghezza di 5 a 3ovvero 1.6 a 1.0, un po’ inferiore a quelloutilizzato per edifici poligonali e circolaricostruiti di mattoni e pietra nella Lombar-dia del Quattrocento15.
Le fonti sono chiare sulla forma dellastruttura: presentava un tetto a falde (meta-ta figura); l’archetipo era San Lorenzo (Dul -cino) e l’Anonimo lo descrive come un ti-burio. Quindi la parte superiore era emi-sferica oppure su base ottagonale con se-zione in alzato semicircolare e circondatada muri verticali reggenti un tetto a falde,secondo l’uso tradizionale lombardo. Dul-cino dice che il tiburio era costruito amphi-teatrali orbe, suggerendo forse una formaellittica, ma la frase sembra un espedienteretorico e questa forma non sarebbe credi-bile per il 1489; in ogni caso Calco dice cheera costruito in orbem. Quindi si trattava
78 Richard Schofield . L’ARCHITETTURA TEMPORANEA COSTRUITA PER IL MATRIMONIO DI GIAN GALEAZZO SFORZA E ISABELLA D’ARAGONA (1489)
Fig. 2 - Tiburio ligneo del 1489 (ricostruzione di R. Tavernor in R.V. Schofield,A Humanist Description of the Architecture for the Wedding of Gian Galeazzo Sforzaand Isabella D’Aragona, in «Papers of the British School at Rome», LVI, 1988, pp. 213-240).
Fig. 3 - Milano, San Lorenzo, spaccato del XVI secolo(Milano Castello sforzesco, Civico Gabinetto dei disegni, Scuola B56).
Fig. 4 - Milano, Santa Mariapresso San Satiro, sagrestia.
Fig. 5 - Bramante, stampa Prevedari,1481 (particolare).
0 1 5 10 braccia
stri testimoni oculari e lo stesso varrebbeper l’idea che il tiburio fosse un tempio diVesta, che, secondo Servio e Ovidio, fonticonosciutissime nel Quattrocento, era apianta centrale. Malgrado questo, non c’èragione particolare per collegare Vesta conil nostro ottagono del 1489: Vesta non ave-va molto che fare con i matrimoni nelQuattrocento28.
La decorazione dell’interno della cupo-la con la sua flora e fauna e i riferimenti aGian Galeazzo e i duchi raffiguravano unapergola deliziosa con iconografia non pre-cisabile, forse simile a quella della Sala del-le Asse, dove, però, sembra che il décor fa-cesse riferimento alla saggezza della fami-glia Sforza. Allo stesso tempo il tiburio eraun vestibolo come l’antiporta costruita peril matrimonio di Bianca Maria Sforza eMassimiliano a Milano nel 1493, nel qualeil clero riceveva gli ospiti illustri29.
Tuttavia la domanda di fondo, ovveroperché costruire un luogo d’incontro informa di cappella o chiesa, rimane ancorasenza risposta.
III. Leonardo era coinvolto nel progettodell’architettura temporanea? Abbiamovisto che i tre portici erano costruiti con co-lonne e volte di rami di ginepro, mirtillo ededera, i capitelli di bacche e teste di Giano.
Nella metà inferiore del f. 28v del Ms BLeonardo descrive nel dettaglio la costru-zione di colonne lunghe di ginepro con di-dascalie in forma di esortazione, «si deb-bono...», «sia...» e «si lega...» (fig. 9)30. Alf. 54v si trova poi un disegno piccolo e ra-pido con la didascalia «armadura da unotiburio da festa» (fig. 10), che illustra un si-stema per irrigidire un edificio ligneo concupola, forse circolare o poligonale.
Due considerazioni suggeriscono che,presi insieme, questi due disegni siano daconnettere in qualche modo con l’architet-tura effimera del 1489: 1) i disegni nel ma-noscritto B sono cronologicamente asse-gnabili a momenti precedenti o contempo-ranei o di poco successivi alla costruzionedell’architettura lignea in questione; 2) iltiburio ligneo è l’unico a essere stato co-struito nel periodo coperto dal manoscrit-to B e la compresenza di un’arcata di gine-pro e di un tiburio del genere suggerisceuna connessione tra i disegni e l’architet-tura effimera realizzata. Purtroppo, vistoche Leonardo dice che si devono costruiretali strutture in un certo modo, non è chia-ro se si tratti di un progetto per le architet-ture lignee (e se così la mancanza di speci-ficità del disegno del tiburio sarebbe mol-to sorprendente) o viceversa se, una voltavista l’architettura, Leonardo stia racco-mandando a se stesso come costruire altriesempi del genere, a imitazione di quellodel 1489. In assenza di qualsiasi documen-to in proposito non lo sapremo mai31.
Forse un candidato più promittente co-me disegnatore del tiburio potrebbe esse-re Bramante. In una lettera del 15 maggio1492 Bartolomeo Calco riferisce al duca di
aver convocato Bramante «per havere daluy qualche digna fantasia de mettere inspectaculo [un battesimo], lo quale [Bra-mante] ... dixi che per essere trovato più
81QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 57-59/2011-2012
devano le nove muse; l’identità delle altreventitre è sconosciuta ma presumibilmen-te includevano personalità come Giuditta,Lucrezia, Penelope, Porzia, Sulpicia e To-maride, che facevano parte di un «honesta-rum chorus» di good-girls («illustria sancti-tatis exempla») durante i festeggiamentidel matrimonio di Isabella a Tortona; ov-viamente evitando le bad-girls pur presen-ti a Tortona, come Semiramide, e le moglilascive come Cleopatra, Elena e Medea18.
All’interno degli archi alcuni giovani gi-ravano ruote coperte da edera (ruote dellafortuna?), vittorie (?) volavano nei pennac-chi al di sopra degli archi e figure dipintesu carta si presentavano tra le colonninedella prima balaustrata.
Secondo Bossi la decorazione dell’in-terno della cupola includeva insignia diGian Galeazzo, ritratti dei duchi, fiori,frutti pendenti da rami, erba con uccelli,serpenti e «parva bruta», nonché creaturedella terra e del mare. Curiosamente Cal-co descrive la pittura all’interno solo come«tota bicolori pictura alba et rosea» mariassume la decorazione dicendo che «sipuò credere che fosse una foresta o pergo-la naturale», certamente un precedente ge-nerico per la sala delle Asse (1498 circa),del quale però si può dedurre un’iconogra-fia più precisa19.
Uno dei problemi più spinosi è comespiegare il fatto che si tratti 1) di un edifi-cio centralizzato che subito richiama ai no-stri occhi la forma di una chiesa costruitoper festeggiare un matrimonio, e 2) chefunzionava come un luogo d’incontro do-ve la sposa baciava una croce, e 3) che fudecorato come una pergola all’interno,con 4) una sorta di elogio della sposa vir-tuosa all’esterno.
Un’ipotesi potrebbe essere che si trat-tasse di una cappella dedicata alla Vergine:nel Quattrocento ci sono parecchi esempidi cappelle ottagonali con tiburi e galleriededicate alla Vergine e il significato potreb-be essere che la purezza della sposa è simi-le a quella di Maria. Le statue ‘all'antica’delle Muse e «illustrium virginum» (Calco)sarebbero state in tal caso alla moda: Erco-le, antenato di Bartolomeo Colleoni, peresempio, è rappresentato sul basamentodella cappella Colleoni dedicata a San Gio-vanni Battista; alla Certosa di Pavia, dedi-cata a Santa Maria delle Grazie, il basa-mento presenta sessantuno teste imperialiantiche; nel duomo di Como, dedicato aSanta Maria Assunta, la Porta della Rana ele edicole dei Plini presentano moltepliciscene “all’antica”20.
La nostra struttura fu però usata, aquanto pare, solo come luogo di incontroe nessuna delle fonti suggerisce che essafosse una cappella consacrata.
Forse invece il tiburio poteva far riferi-mento alla tradizione di rappresentare il
Tempio di Salomone come poligonale ocircolare negli sfondi di scene con lo Spo-salizio della Vergine. Anche in questo caso,però, dobbiamo sospendere il giudizioperché non esistono altri esempi di rappre-sentazioni di matrimoni comuni che inclu-devano il tempio di Salomone; solo quellodella Vergine, infatti, poteva meritarlo, ol-tre al fatto che Isabella, essendo formal-mente già sposata, non poteva in ogni caso
più richiamare la verginità di Maria.Tentiamo dunque un’altra strada. Nel
Quattrocento e nel Cinquecento almenotre divinità antiche erano associate con edi-fici a pianta centrale: Diana, Giunone e Ve-sta21. Ovviamente Diana è spesso presentenelle celebrazioni di matrimoni nel Quat-trocento22 e alcuni disegni del Cinquecen-to illustrano templi di Diana, in particola-re un esempio a pianta quadrata comparenel cosiddetto taccuino di Bramantino delprimo Cinquecento23. Un esempio più si-gnificativo è quello di Bernardino Luiniche include nello sfondo della storia diProcris e Cephalo una versione ottago -nale del celebre tempio di Diana ad Aric - cia, mostrando l’iscrizione VIRGINITAS(1519-1521): (fig.7)24. Forse il tiburio otta-gonale voleva suggerire l’associazione trala purezza di Diana e quella di Isabella e lasua forma era una versione del celebre tem-plum nemorale 25. Le obiezioni a questa let-tura sono ovvie e seppure non decisive,non sono certo incoraggianti: infatti, nes-suno dei nostri testimoni menziona Dianae, per quanto noto, la decorazione esternanon includeva alcuna rappresentazionedella casta cacciatrice a grande scala.
Infine, ci si può chiedere se si trattassedel tempio di Giunone a Cartagine, rap-presentato qualche volta in forma poligo-nale nelle illustrazioni della scena descrit-ta nell’Eneide 26 quando Ilioneo incontraDidone e Enea e Acate rimangono mo-mentaneamente invisibili a causa di unanebbia magica (fig. 8)27. L’obiezione prin-cipale a quest’ultima lettura è comunque lastessa: non abbiamo alcun tipo di riferi-mento a Giunone nelle descrizioni dei no-
80
Fig. 6 - Leonardo da Vinci, Ms B, f. 12r padiglione nel parco del Castello di Milano.
Fig. 7 - Bernardino Luini, Cephalo e Procris(National Gallery of Art, Washington, DC)dettaglio con l’iscrizione VIRGINITASsul frontespizio del Tempio di Diana.
Fig. 8 - Firenze, Biblioteca Riccardiana, Cod. Virgilio, Ms 492, 711, f. 85r, il tempio di Giunone.
Fig. 9 - Leonardo da Vinci, Ms B, f. 28v.
Richard Schofield . L’ARCHITETTURA TEMPORANEA COSTRUITA PER IL MATRIMONIO DI GIAN GALEAZZO SFORZA E ISABELLA D’ARAGONA (1489)
i vestibula avevano le proporzioni di tem-pli circolari, anch’essi descritti da Alberti,e certamente per nulla somiglianti al no-stro tiburio39.
Prima di rinunciare a identificare concertezza il nostro disegnatore, torniamo aguardare le sue gallerie. Secondo Dulcinovi erano due loggiati, uno sopra l’altro, cheoffrivano un panorama sulla piazza per glispettatori e, dalla seconda, un accesso di-retto al tetto. La descrizione di Calco èmolto suggestiva: sopra gli archi si trovavaun piano con tre ordini di piloni (colum-nae) sullo stesso livello, di cui quelli ester-ni erano dotati di balaustri; le altre due filedi piloni formavano un «peristylium tran-scursoriamque ambulationem», cioè unagalleria doppia e Bossi precisa che si tratta-va di una «via facta duplex», certamente uncorridoio doppio (fig. 2)40. Nella ricostru-zione abbiamo provato a far combaciare
queste descrizioni con la presenza di una«via ... duplex» sotto e una «via simplex»sopra, in modo che la cupola si imposti so-pra la prima galleria, come nell’Incorona-ta a Lodi e nell’Oratorio del Cristo Risortoa San Luca a Cremona (1503).
Una galleria doppia di questo tipo nonha precedenti nell’architettura costruitanel Quattrocento in Lombardia per ovvieragioni strutturali: non sappiamo se la gal-leria interna della «via duplex» fosse con-tinua o bloccata da elementi lignei struttu-rali utilizzati per irrigidire l’insieme. Co-munque ci si potrebbe chiedere se la galle-ria doppia di questo tiburio “alla lombar-da” sostenuta da tre file di piloni di altezzauguale che permettevano così una visionesimultanea sia dell’esterno sia dell’internodell’edificio, non fosse un precedente perle gallerie interrotte da giganteschi muri disostegno che Bramante disegnò per il tho-
los ‘alla romana’ di San Pietro, anche se ledifferenze dei dettagli formali, materiali edi scala sono enormi (figg. 11, 12)41.
«Sed ne dum in hoc nimium versor mo-lestus tibi fiam», come dice Dulcino, tiria-mo le somme: le caratteristiche di routinedei portici e degli archi probabilmente im-pediscono un’attribuzione precisa; abbia-mo solo deboli indicazioni per dire cheBramante potrebbe aver disegnato l’arco atre fornici e indizi solo un po’ più robustiper il progetto del tiburio, ovvero la presen-za dei pueri con le rotae, come nell’incisio-ne Prevedari, più la «via duplex», forse unprecedente in miniatura per la cupola diSan Pietro. È ragionevole tuttavia pensareche dietro l’intero apparato effimero per lenozze vi sia stata la progettualità di un uni-co individuo, e non vi sarebbe ragione perpensare diversamente, salvo il piccolo in-conveniente di nessuna prova diretta.
83QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 57-59/2011-2012
volte in consultatione de simile pompe»,forse alludendo anche a quella del 148932.
Una serie di elementi della decorazionedell’architettura dimostra infatti i tipici gu-sti “all’antica” degli Sforza: le vittorie diFrancesco Sforza erano celebrate su un ar-co a tre fornici nella piazza del duomo e unagalleria di ritratti degli Sforza, forse profilientro tondi, adornava l’interno della cupo-la del tiburio; stemmi, ghirlande e tondi difogliame si trovavano dappertutto. Pocotempo dopo Bramante avrebbe inclusotondi con profili dinastici sopra le colonnenella piazza di Vigevano, più un arco tripli-ce “alla romana” decorato con stemmata etrofei collocati all’entrata della piazza do-ve confluivano almeno due strade33.
Quando nell’architettura tardo-quat-trocentesca a Milano si può identificarel’influenza di Vitruvio e di Alberti è ragio-nevole supporre il coinvolgimento di Bra-mante. Non è troppo ottimistico sperareche almeno alcune delle parole utilizzateda Dulcino per descrivere queste architet-ture garantiscano che il disegnatore o dise-gnatori avevano in mente gli stessi concet-ti. Per Dulcino il tiburio era un pronaos,prothyron e sphaeristerion e l’arcata davan-ti al tiburio somigliava a un xystus o para-dromis, gestatio e ambulatio. Dal punto divista squisitamente filologico questi voca-boli non sono sinonimi e Dulcino dice cheil portico sembrava un xystus o ambulatio,esprimendo forse solo un’opinione perso-nale non necessariamente basata su una co-noscenza delle intenzioni del disegnatore;tuttavia Dulcino conosceva quasi tutti iprotagonisti.
Possiamo dunque in questo caso direche le forme stesse dell’architettura riflet-tono le raccomandazioni di Alberti e chequindi suggeriscono il coinvolgimento diBramante.
La descrizione albertiana del triplice for-nice nel De re aedificatoria (8, 6), già pub -blicato nel 1485, è molto nota: l’arco si tro-vava nel foro, al punto di arrivo della stra-da regia e presentava tre aperture, di cuiquella centrale più grande, l’insieme arric-chito da iscrizioni, sculptae historiae, etc.34.
Nel caso di loggiati all’interno di giardiniantichi Alberti (9, 1) parla di «colonne fat-te ad imitazione di tronchi d’albero con lenodosità recise, o di fasci tenuti insieme dacinghie, o altre ancora tortili o palmate ocon la superficie ruvida di frasche o coper-ta di uccellini»35. Descrivendo la casa anti-ca Alberti osserva (9, 3) che «Nell’antichi-tà si annetteva alla casa un porticato (porti-cus) ovvero un locale per riunioni (sessio-nes); sia l’uno che l’altro non erano semprequadrati o rettangolari, ma anche a linee in-curvate alla maniera d’un teatro. Al porti-co si aggiungeva un vestibulum quasi sem-pre a pianta circolare»36. Tutto sommatol’arco a tre fornici realizzato in piazza delDuomo sembra ben corrispondere alle rac-comandazioni di Alberti; inoltre, questoarco ligneo con tre vani voltati, quello cen-trale più grande, fu costruito sulla stradaprincipale della città, quella che conduce-va dal castello sforzesco al duomo; l’arco siapriva sulla piazza ed era decorato con exu-viae, storiae e così via. I portici temporaneierano costruiti con colonne e volte di ede-ra, ginepro, mirtillo, con capitelli di bacchee cerchietti e semicerchi di edera e, quindi,tutti e tre sono genericamente simili ai por-tici nei giardini degli antichi secondo Al-berti (9, 1).
Almeno in teoria il tiburio ottagonalepotrebbe essere interpretato come un por-ticuso sessio albertiano, costruito in theatrimodum, e forse un vestibulum rotundum.
Teniamo presente però che, se l’archi-tettura temporanea, escludendo il tiburio,presentava forme o decorazioni tipichedella tradizione del Quattrocento, qualsia-si tentativo di stabilire l’autore di tutto l’ap-parato potrebbe essere compromesso.Emerge con chiarezza, infatti, che i porticitemporanei del 1489 erano interamentetradizionali nella forma e nelle decorazio-ni. Tutta la flora menzionata – bosso, ede-ra, ginepro, lauro, limoni e mirtillo – sim-boleggiava l’eternità della fedeltà deglisposi37. Quasi tutti i matrimoni del Quat-trocento o del primo Cinquecento include-vano archi trionfali e masse di ghirlande etondi “all’antica”, realizzate con fogliami
sempreverdi. Citiamo solo gli esempi me-glio documentati come gli ingressi trionfa-li di Eleonora d’Aragona e Ercole d’Este aFerrara nel 1473, di Roberto Malatesta eElisabetta Montefeltro a Rimini nel 1475 edi Costanzo Sforza e Camilla d’Aragona aPesaro nello stesso anno, o di Isabellad’Aragona a Genova38. Inoltre, mentre laprobabile conoscenza di Dulcino delle in-tenzioni dell’architetto non è sufficiente agarantire un’attribuzione a Bramante, lecaratteristiche ormai tradizionali di porti-ci e archi possono lasciare la porta apertaad altri tipi di attribuzione, per esempio alegnaioli o imprenditori, piuttosto che di-segnatori eruditi.
Tuttavia, d’altra parte abbiamo identifi-cato diverse somiglianze generiche tra lanostra architettura temporanea e strutturedescritte da Alberti, che potrebbero esse-re usate a supporto dell’ipotesi che Bra-mante avesse disegnato alcuni elementi, oaddirittura, la totalità delle architetture li-gnee. Rispetto all’arco di trionfo, anche senessuna fonte prima del nostro esempiodel 1489 dice specificamente che le variecelebrazioni quattrocentesche includeva-no un arco a tre fornici, ovviamente questopotrebbe semplicemente essere dovuto auna mancanza di precisione nelle fonti di-sponibili; in ogni caso l’archetipo, l’Arco diCostantino, era sempre visibile e semprepiù riprodotto in disegni, dipinti e altri me-dia nel Quattrocento. Considerando la da-ta, 1489, solo quattro anni dopo la pubbli-cazione del De re aedificatoria, la cui cono-scenza avrebbe dovuto essere essenzialeper tutti gli architetti, e il fatto che entro1492 Bramante stesso poteva dire di esse-re stato coinvolto in «pompe più volte», eche nello stesso anno egli stesso disegnò unarco a tre fornici a Vigevano con forma efunzioni simili, sembra almeno probabileche Bramante stesso fosse responsabile peril triplice arco del 1489.
Infine il tiburio sembra essere, a primavista, semplicemente una versione di unacappella squisitamente lombarda che po-teva essere disegnata da parecchi architet-ti attivi per Ludovico negli anni ‘80 – Bat-tagio, Amadeo o il suo misterioso collabo-ratore, Dolcebuono. Tuttavia la combina-zione di forma e funzione rimane impres-sionante. Alberti sembra essere il solo au-tore nel Quattrocento che sostiene che iportici e vestibuladegli antichi fossero ton-di e somigliassero ai templi. Il nostro tibu-rio è il solo esempio conosciuto di unastruttura che somigliava a un tempio ton-do e che fungeva da luogo di incontro, po-sto davanti a un grande edificio: è possibi-le che l’architetto del tiburio stesse pensan-do ad Alberti? Forse, ma gli elementi con-trari a questa lettura non mancano. Alber-ti infatti stava anzitutto descrivendo gli in-gressi delle case, non degli edifici religiosi;
82
Fig. 10 - Leonardo da Vinci, Ms B, f. 12r, f. 54v.
Fig. 11 - Sebastiano Serlio, Terzo Libro, c. XXXIXr, (Venezia 1540):progetto di Bramante per la cupola di San Pietro.
Fig. 12 - Ipotesi di ricostruzione della cupola di San Pietrosecondo il progetto di Bramante, (F. Krauss, C. Thoenes,Il progetto di Bramante per la cupola di S. Pietro, in San Pietroche non c’è, a cura di C. Tessari, Milano 1996, pp. 179-196).
Richard Schofield . L’ARCHITETTURA TEMPORANEA COSTRUITA PER IL MATRIMONIO DI GIAN GALEAZZO SFORZA E ISABELLA D’ARAGONA (1489)
NOTE
1. A. DINA, Isabella d’Aragona Duchessa di Mi-lano e di Bari, in «Archivio storico lombardo», se-rie 5, 8, 1921, pp. 269-457, in particolare pp. 269sg.; G. CALVI, I manoscritti di Leonardo da Vinci,Bologna 1925, pp. 81-83; K.T. STEINITZ, The Vo-yage of Isabella d’Aragona from Naples to Milan, Ja-nuary 1489, in «Bibliothéque d’Humanisme et Re-naissance», 23, 1961, pp. 17-33; U. ROZZO, La fe-sta di nozze sforzesche del gennaio 1489 a Tortona,in «Libri e documenti», 15, 1, 1989, pp. 9-23 e ID.,L’Ordine de le imbandisone per le nozze di Gian Ga-leazzo Sforza con Isabella d’Aragona, in «Libri e do-cumenti», 15, 2, 1989, pp. 1-14.
2. Tristani Chalci mediolanensis nuptiae medio-lanensium ducum, in Tristani Chalci,... Residua, e
bibliotheca Lucii Hadriani Cottae nunc primo pro-deunt in lucem, studio et opera Joannis Petri Puri-celli, Milano 1644, pp. 65-67; G. LOPEZ, Festa dinozze per Ludovico il Moro, Milano 1976; F. PE-TRUCCI, Calco, Tristano, in Dizionario Biografico de-gli Italiani, Roma 1973, XVI, pp. 537-541; ANONI-MO, Descriptione de l’ordine et feste celebrate in lenoze delo illustrissimo Zoanne Galeaz Duca de Mi-lano, Parigi, Bibliothéque Nationale de France,Ms. It., 1592; brani pubblicati da G. GIULINI, Me-morie spettanti alla storia... di Milano, 6, Milano1857, p. 649 sg. e in B. CORIO, Storia di Milano, 3,Milano 1857, p. 447 sgg.; G.A. BOSSI, Epithala-mium de Io. Galeazio sexto mediolanensium duceet Elisabella uxore (Milano, Biblioteca Ambrosia-
na, Cod. N 133 sup., cc. 139-143), trascritto da P.BONDIOLI, Un poeta bustese alle nozze di G.G. Sfor-za et Isabella d’Aragona, Monza 1927, pp. 44-45;G. IACOBO e G.P. FOSSANO, Memorie dall’anno1489 al 1559, (Milano, Biblioteca Ambrosiana,Fondo Trotti 422, c. 3rv). Cfr. F. MALAGUZZIVALE-RI, La Corte di Lodovico il Moro, 4 voll., Milano1913-1923, 1, p. 458.
3. U. ROZZO, Dolcino (Dulcino, Dulcinio, Dol-cin), Stefano, in Dizionario biografico degli italiani,Roma 1991, XL, pp. 444-447.
4. Dispacci e lettere di Giacomo Gherardi nunziopontificio a Firenze e Milano (11 settembre 1487-10ottobre 1490), a cura di E. Carusi, Roma 1909, pp.339-340, lettera 220 dell’agosto 1489.
5. R.V. SCHOFIELD, Amadeo, Bramante, Leonar-do and the tiburio of Milan Cathedral, in «Achade-mia Leonardi Vinci», 2, 1989, pp. 82-84.
6. R.V. SCHOFIELD, J. SHELL, G. SIRONI,Gio-vanni Antonio Amadeo: i documenti, Como 1989,documento n. 805.
7. B. CORIO, L’Historia di Milano, Padova 1646,p. 885. Una statua di Giano con quattro facce è sta-ta trovata a Faleri (SERVIO, Commentarii in Vergi-lii Aeneidos libros, 6, 607; MACROBIO, Saturnalia,1, 9) e un’altra si trovava nel foro di Nerva nel se-sto secolo (L. LYDUS, De mensibus, 4, 1).
8. Un passus = 6 piedi; per Dulcino un pes =braccia e quindi 6 x 5 braccia = 30 per la larghezzadel tiburio; concordano Calco e l’Anonimo.
9. VITRUVIO, De architectura, 6, 7, 5.10. Di solito vuol dire ‘ball-court’ (cfr. PLINIO,
Epistolae, 2, 17, 12 e SUETONIO, Vespasiano, 20):notiamo che nel 1490 Domenico Maccaneo usò laparola per descrivere le torri rettangolari della vil-la Sforzesca (R.V. SCHOFIELD,Ludovico il Moro andVigevano in «Arte Lombarda», 62, 1982, pp. 93-140, in particolare p. 138). Dulcino sembra pensa-re che nell’antichità la parola includa un riferimen-to alla forma, piuttosto che alla funzione, di tali edi-fici (C. DEBONDT, Royal Tennis in Renaissance Ita-ly, Turnhout 2006, pp. 14 sgg. per Plinio e il ‘sphae-risterium:’ pp. 40-46 per la sala della palla nel ca-stello sforzesco).
11. Non ho trovato altri casi in cui il termine siausato in questo senso.
12. Qui nel senso di corridoio o scala in un mu-ro: «procastria [o procestria] dicuntur, quo proce-ditur in muro» (FESTO, De verborum significatu);«loca extra civitatem degradata per quae murosascenditur» (Thesaurus linguae latinae, X, 2, fasc.X, Stuttgart-Leipzig 1998, col. 1527).
13. La lanterna nella ricostruzione si basa exem-pli gratia su quella di Santa Maria delle Grazie.
14. Il Nuptiae (cfr. nota 2.) è indirizzato a Nic-colò Lucaro di Cremona.
15. Si veda Santa Maria delle Grazie (altezza-larghezza circa 1 a 1.8), la sacristia di Santa Mariapresso San Satiro (circa 1 a 2.2), la cappella Porti-nari (circa 1 a 2) e Santa Maria della Croce a Cre-ma (circa 1 a 1.7).
16. Sembra che nessun edificio ovale sia statocostruito nel Quattrocento (ma la chiesa di SantaChiara in Urbino, disegnata da Francesco di Gior-gio, era ovale). Non sembra probabile che l’otta-gono fosse irregolare e quindi più ‘anfiteatrale’ co-me nel caso del tiburio dell’Ospedale maggiore odel duomo di Pavia.
17. Quindi epistyliumnel senso di ‘trabeazione’come in VITRUVIO, De architectura, 1, 2, 6, invecedel solito ‘architrave’.
18. Tristani Chalci mediolanensis..., cit., p. 77.19. Sensata l’interpretazione di P.L. MULAS, La
Sala della Asse: una allégorie de la prudence à la courde Ludovic le More?, in La Représentation de la Pru-dence La représentation de la Prudence, Actes ducolloque, Université de Haute Alsace, 5 mars 1999,117-128, Paris 1999, pp. 117-128.
20. R.V. SCHOFIELD, Avoiding Rome: Lombardsculptors and the Antique, in «Arte Lombarda»,100, 1992/2, pp. 29-44; R.V. SCHOFIELD, A. BUR-NETT, The Medallions of the basamento of the Cer-tosa di Pavia, in «Arte Lombarda», 120, 1997/2,pp. 5-28; R.V. SCHOFIELD, A. BURNETT, ‘The Deco-ration of the Colleoni Chapel’, in «Arte Lombar-da», 126, 1999/2, pp. 61-89; R.V. SCHOFIELD, TheCertosa Medallions: an Addendum, in «Arte Lom-barda», 127, 1999/3, pp. 74-85; ID., The ColleoniChapel and the Creation of a local all’antica archi-tectural style in Bramante milanese e l’architetturadel Rinascimento lombardo, a cura di C.L. From-mel, L. Giordano, R.V. Schofield, Venezia 2002,pp. 167-192.
21. Si veda il saggio incomparabile di S. SIN-DING-LARSEN, Some Functional and IconographicalAspects of the Centralized Church in the Italian Re-naissance, in «Acta ad archaeologiam et artium hi-storiam pertinentia», 2, 1965, pp. 203-252, in par-ticolare pp. 224 sgg.
22. Per esempio: 1) matrimonio di AnnibaleBentivoglio e Lucrezia D’Este a Bologna (J. BUR-CKHARD, The Architecture of the Italian Renaissan-ce, a cura di P. Murray, London 1985, p. 266 sgg.;2) Pesaro, 1475 (T. DEMARINIS, Le nozze di Costan-zo Sforza e Camilla d’Aragona celebrate a Pesaro nelmaggio 1475, Roma 1946, p. 26); 3) Rimini, 1475(L. TONINI, Storia di Rimini, 5, parte 1, Rimini1880, p. 360); 4) Ferrara, 1487 (I. LAVIN, Cephalusand Procris: Transformations of an Ovidian Myth,in «Journal of the Warburg and Courtauld Institu-tes», 17, 1954, pp. 260-286, in particolare p. 267).
23. C. FUMARCO, Un lombardo tra i sepolcri del-la campagna romana: nuove proposte per il codicedelle Rovine di Roma, in Tracce di letteratura arti-stica in Lombardia, a cura di A. Rovetta, Bari 2004,p. 12, fig. 2.
24. M.T. BINAGHI OLIVERI, Bernardino Luini,Milano 2007, pp. 35-36; un altro tempio di Diana,con cupola circolare sostenuta da sei colonne piùarchi su una base esagonale, si trova nella scena diCamilla al Tempio di Diana (C.L. BASKINS, Casso-ne. Painting, Humanism, and Gender in Early Mo-dern Italy, Cambridge 1998, p. 89, fig. 32): cfr. labella pergola esagonale sul cassone dipinto da Bia-gio d’Antonio (1486-1487 circa) per la storia di Me-dea e Giasone (Virtù d’amore: pittura nuziale nelQuattrocento fiorentino, a cura di C. Paolini, D. Pa-renti, L. Sebregondi, Firenze-Milano, 2010, p. 132).
25. Aricia: OVIDIO, Ars Amatoria, 1, 259;Meta-morfosi, 14, 331; Fasti, 3, 261 ff., VITRUVIO 4, 8, 4etc. Secondo la descrizione più ampia di STRABO-NE, Geografia, 5, 3, 12, il tempio si trovava in unbosco sacro con un lago davanti.
26. VIRGILIO, Eneide, 1, 520 sgg.27. E. CALLMANN, Apollonio di Giovanni, Ox-
ford 1974, 54, scheda 6, p. 54, scheda 7 p. 55, sche-da 35, p. 68; C.L. Baskins, Cassone, cit., pp. 65 sgg.
28. SERVIO, Commentarii, cit., 9, 406: «aedes au-tem rotundas tribus diis dicunt fieri debere, Vestae,Dianae vel Herculi vel Mercurio». OVIDIO, Fasti,6, 249 sg. secondo cui il tempio di Vesta era tondo,come la terra, e cupolato: ‘par facies templi [i.e. ro-tunda]: nullus procurrit in illo / angulus; a pluviovindicat imbre tholus’. ALBERTI seguiva Ovidioquando scrive che ‘aedem Vestae quam esse terramputarent rotundam ad pilae similitudinem facie-bant (LEONBATTISTAALBERTI, L’Architettura, edi-zione a cura di G. Orlandi e P. Portoghesi, Milano1966, 2 voll., 2, p. 547).
29. L’antiporta includeva bric-a-brac ‘all’anti-ca’ – fogliami, tondi, un arco trionfale, e una strut-tura eretta davanti al Duomo: «sopra la porta cheè in lo fronte de la fazada, gli era constructo un’an-tiporta cum le colonne da canto, sopra le quale erasustentato certo ornamento facto a forma de capo-celo [baldacchino] morello, tendente in alto, divi-sato de columbine» (A. LUZIO, R. RENIER, Delle re-lazioni di Isabella d’Este Gonzaga e Beatrice Sforza,in «Archivio storico lombardo», 1, 17, 1890, pp.346-390, in particolare p. 384).
30. Da sinistra a destra: «Modo come si debemettere le pertiche per legare i mazoli de’gineprisopra esse pertiche, le quali sono confitte sopral’armadura della volta; e lega essi mazoli con salci,e lle superfrue cime tosa colle forbici e lavorale co’-salci»; «modo come si fa l’armadure per fare orna-menti di edifizi»; «Sia da l’uno all’altro cierchio11/2 bracio, el ginepro si de’ vigiere cole cime ingiù cominciando di otto»; «a questa colona si legad’intorno 4 pertiche, d’intorno a le quali s’inchio-da vinchi grossi uno dito, e poi si fa da piè, e vassi
in alto legando mazoli di cime di ginepro colle ci-me in basso, cioè sotto sopra».
31. G. CALVI (I manoscritti, cit.) e K.T. STEINITZ
(The Voyage, cit.) elencano i disegni nel Ms B con-nessi con architettura temporanea. Nei casi dei fo-gli 4r, 29v e 78v non c’è ragione particolare perpensare che i disegni potrebbero essere connessicon le celebrazioni del 1489. Forse i due disegnisulla metà superiore del foglio 28v sono rilevantiperché si trovano sullo stesso foglio che le volte diginepro, ma le strutture disegnate, probabilmentesezioni di volte (anche sul f. 29v), non combacianocon nessuna parte della volta di ginepro illustratoin basso sul f. 28v e non possono essere connessicon il tiburio. Se sono infatti sezioni di volte lignee,l’ampiezza della curvatura e il grande dettaglio del-la loro struttura interna implicano strutture di lar-ghezza notevole.
32. Documento del 15 maggio 1492 (Archiviodi Stato di Milano, Autografi, Pittori, Bramante: ci-tato in parte da F. MALAGUZZIVALERI, La corte.,cit.,p. 132.
33. Da ultimo: L. GIORDANO, Costruire la città.La dinastia visconteo-sforzesca e Vigevano. La piaz-za, Vigevano 2011.
34. LEONBATTISTAALBERTI, L’Architettura, cit.,2, pp. 716-722.
35. Ivi, pp. 786-7 e pp. 806-807.36. Ivi, p. 795. Non si capisce perché Orlandi
abbia tradotto «non sempre lineis rectis» come«non erano sempre poligonali». Per gli equivoci ri-nascimentali rispetto ai termini atrium e vestibu-lum: L. PELLECCHIA, Architects read Vitruvius; Re-naissance Interpretations of the Atrium of the An-cient House, in «Journal of the Society of Architec-tural Historians», 51, 1992, pp. 377-416, in parti-colare pp. 382 sgg.
37. Spunti affascinanti in M.A. ALTIERI, Li nup-tiali di Marco Antonio Altieri, ed. a cura di E. Nar-ducci, Roma 1873; M. LEVI D’ANCONA, The Gar-den of the Renaissance: Botanical Symbolism in Ita-lian Painting, Florence 1977, è indispensabile.
38. B. CORIO, L’Historia di Milano, Padova1646, pp. 821-826; L. OLIVI, Delle nozze di ErcoleD’Este con Eleanora d’Aragona, in «Memorie del-la R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Mode-na», ser. 2, 5, 1887, pp. 15-68; G. CORVISIERI, Iltrionfo romano di Eleonora d’Aragona nel giugnodel 1473, in «Archivio della società romana di sto-ria patria», 1, 1878, pp. 475-491 e 10, 1887, pp.489-491, in particolare p. 643; T. DE MARINIS, Lenozze, cit.
39. Ma le fonti classiche non dicono mai che i ve-stibula erano ottagonali, anche se, come il tiburio,erano decorati con statue degli antenati, armi, tro-fei (TIBULLO, Elegiae, 1,1, 54; PLINIO, Naturalis hi-storia, 35, 2, 6; LIVIO, Ab urbe condita, 10, 7, 9; 22,57, 10; VIRGILIO, Eneide, 2, 504; CICERONE, Filip-picae, 2, 28, 68; GIOVENALE, Satire, 7, 126) e foglia-mi (CATULLO, Carmina, 44, 278 sgg.) e, ovviamen-te, potevano includere piloni o portici (SUETONIO,Nerone, 16; SERVIO, Commentarii, cit., 2, 469).
40. Teniamo presente che Calco non menzionauna galleria superiore e Dulcino non nota il fattoche la prima galleria fosse doppia.
41. F. KRAUSS, C. THOENES, Il progetto di Bra-mante per la cupola di S.Pietro, in San Pietro che nonc’è, a cura di C. Tessari, Milano 1996, pp. 179-196.
Offro questo contributo come una postilla al la-voro immenso del grande critico Arnaldo Bruschi.Ringrazio i curatori per avermi dato l’occasione dipresentare qui una versione revisionata di un sag-gio ormai dimenticato edito in R.V. SCHOFIELD, AHumanist Description of the Architecture for theWedding of Gian Galeazzo Sforza and IsabellaD’Aragona, in «Papers of the British School at Ro-me», LVI, 1988, pp. 213-240.
84 Richard Schofield . L’ARCHITETTURA TEMPORANEA COSTRUITA PER IL MATRIMONIO DI GIAN GALEAZZO SFORZA E ISABELLA D’ARAGONA (1489)
RIASSUNTO /ABSTRACT
L’ARCHITETTURA TEMPORANEA
COSTRUITA PER IL MATRIMONIO
DI GIAN GALEAZZO SFORZA
E ISABELLA D’ARAGONA (1489) L’architettura temporanea più spettaco-
lare del Quattrocento milanese è rappre-sentata da un tiburio costruito davanti alduomo di Milano nel febbraio 1489 per ri-cevere Gian Galeazzo Sforza e la sua sposaIsabella d’Aragona. Numerose fonti per-mettono di ricostruire l’edificio e le altredecorazioni temporanee nel cortile ducaledel castello sforzesco e nella piazza del duo-mo. Secondo la fonte più dettagliata, Stefa-no Dulcino, il tiburio doveva essere ottago-no con due piani coperti a cupola, costrui-to in legno e decorato con immagini di don-ne virtuose realizzate su carta. Si tratta, al-meno dal punto di vista della forma, di unaversione ridotta del grande ottagono di SanLorenzo a Milano, che trova riscontro an-che in altre chiese del tardo Quattrocentoa Milano. Nel saggio si discutono iconogra-fia e funzione della struttura: non era unacappella, né una versione del Tempio di Sa-lomone neanche, come sembra, un tempiodedicato a Diana o Giunone. Si può ipotiz-zare che Leonardo abbia forse partecipatoalla progettazione di alcuni elementi delladecorazione temporanea e che forse Bra-mante possa essere stato il progettista perla costruzione del tiburio visto che da unaparte, come è noto, era coinvolto spessonell’organizzazione di feste e dall’altra èpossibile riscontrare nell’architettura tem-poranea riflessi delle idee albertiane: man-cano tuttavia prove per affermare in via de-finitiva la partecipazione al progetto deidue personaggi.
TEMPORARYARCHITECTURE BUILTFOR THEMARRIAGE OFGIANGALEAZZOSFORZA TO ISABEL OF ARAGON (1489)The most spectacular fifteenth-century
temporary architecture in Milan was the pa-vilion built in front of the Cathedral in Fe-bruary 1489 where Gian Galeazzo Sforzawas to meet his bride Isabel of Aragon. Nu-merous sources provide information regar-ding the pavilion and other temporary set-tings and decorations in the courtyard of theDuke’s palace and in the square in front ofthe Cathedral. According to Stefano Dulci-no who provided the most detailed informa-tion the octagonal, two-floor pavilion, crow-ned by a dome, was built in wood and deco-rated with paper images of virtuous women.Its shape was a smaller version of the grandoctagon of St. Lawrence in Milan, replicatedin other late fifteenth-century churches inMilan. The paper discusses the pavilion’s ico-nography and function: it was neither a cha-pel, nor a version of the Temple of Solomon,or, it seems, a temple dedicated to Diana orJuno. Leonardo possibly designed some ofthe elements of the temporary decorations,while Bramante might have designed the pa-vilion because it is a well-known fact that hewas often tasked with organising festivities,and also because the temporary architecturereflects some of Alberti’s ideas. However,there is no definitive proof that either parti-cipated in the project.
Richard Schofield[[email protected]]
QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 57-59/2011-2012