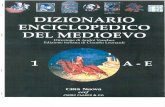Il Decameron letto dagli storici del Medioevo, "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per in...
Transcript of Il Decameron letto dagli storici del Medioevo, "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per in...
BullettinoDELL’ISTITUTO STORICO ITALIANO
PER IL MEDIO EVO
116
ROMANELLA SEDE DELL’ISTITUTO
PALAZZO BORROMINI___
2014
DELL’ISTITUTO STORICO ITALIANOPER IL MEDIO EVO
ISSN 1127 6096
Direzione: MASSIMO MIGLIO
Comitato scientifico: FRANÇOIS BOUGARD, TOMMASO DI CARPEGNA,ERRICO CUOZZO, MARIA CONSIGLIA DE MATTEIS, GIACOMO FERRAÙ,JAMES HANKINS, PAULINO IRADIEL, UMBERTO LONGO, ISA LORISANFILIPPO, WERNER MALECZEK, GHERARDO ORTALLI, GIUSEPPEPETRALIA, GABRIELLA PICCINNI, GIUSEPPE SERGI, SALVATORE SETTIS,MARINO ZABBIA - Segretario: ANNA MARIA OLIVA
A cura di ISA LORI SANFILIPPO - ANNAMARIAOLIVA - FULVIODELLEDONNE
Redattore capo: SALVATORE SANSONE
Redazione: ANTONELLA DEJURE
I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti alla lettura didue esperti anonimi.
Il Decameron letto dagli storici del Medioevo
Mi sia consentito, prima di entrare in argomento, di informare bre-vemente su come sono arrivato ad utilizzare il Decameron, e quanto poila raccolta di novelle sia diventata (anche per me) oggetto di studio1.Noto che ho sempre amato i novellatori, ma ho utilizzato esplicita-mente il Decameron soltanto per ultimo, quasi per un rispetto superiorea quello dovuto ad altri novellieri e comunque sempre nel contesto diuna ricerca mirata a tirare in campo le fonti più diverse – sottolineoquesto fatto come centrale problema di metodo e di attendibilità –onde cogliere gli aspetti più vari e più sicuri delle realtà che intendevovia via descrivere. La mia utilizzazione del Decameron è stata comunquepiù ampia di quanto potrebbe a prima vista apparire, perché presentein molti miei interventi particolari, il cui titolo non richiama esplicita-mente all’opera2. In ogni modo accanto alla novellistica mi piace alme-no indicare, fra le fonti diverse or ora richiamate, i catasti agrari (pensoin primo luogo alla Tavola delle possessioni di Siena), gli statuti urbani erurali, le deliberazioni dei Consigli, le imbreviature notarili, i «libri di
1 Sfogliando i miei ricordi, che un gruppo di alunni ormai docenti ha inserito allafine della raccolta di studi che mi ha voluto affettuosamente dedicare (Uomini, paesag-gi, storie. Studi di storia medievale per Giovanni Cherubini, cur. D. Balestracci - A. Barlucchi- F. Franceschi - P. Nanni - G. Piccinni - A. Zorzi, 2 voll., Siena 2012), trovo alle pp.1273-1308 anche la Bibliografia dei miei scritti, cur. F. Leoni. Con un po’ di impegno miè stato abbastanza facile risalire ai lavori in cui, nel corso degli anni, ho utilizzato inovellieri.
2 Ecco l’elenco (per l’opera ricorro sempre al Decameron ed. V. Branca, Milano1976, IV della raccolta di Tutte le opere). Di molti di questi miei interventi ricordo lanovella della Lisabetta (IV, 5) e quella di Salabaetto e Iancofiore (VIII, 10) (G.Cherubini, La Sicilia e la Sardegna viste dagli altri, ora in Cherubini, Scritti meridionali,Firenze 2011 [Quaderni della Rivista di Storia dell’Agricoltura, 7], pp. 68-69). Dallaseconda di queste novelle ho tratto altrove l’interessante descrizione della Dogana delporto di Palermo (VIII, 19), e ho parlato della malavita e della prostituzione che inquest’ultima città ed a Napoli popolavano le vie più anguste, soprattutto di notte (G.Cherubini, Impianto urbano e strutture architettoniche delle città portuali dell’Italia tirrenica, in
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
ricordanze». Il mio volume Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla societàitaliana del basso Medioevo3 contiene già al suo interno la documentazio-
Cherubini, Scritti meridionali cit., pp. 283, 285). Se pensiamo che il Boccaccio fece il suoapprendistato a Napoli presso la succursale della grande compagnia fiorentina deiBardi, non ci si può meravigliare se il Decameron allude a tutti i santi luoghi che nelregno erano meta di pellegrinaggio e principalmente a San Nicola di Bari e a SanMichele del Gargano (II, 2). Altrove, raccontando l’avventurosa vicenda di LandolfoRufolo, afferma essere opinione diffusa che «la marina da Reggio a Gaeta sia quasi lapiù dilettevole parte d’Italia». Allora l’età d’oro di Amalfi era passata da un pezzo, mail ravellese Landolfo vive una vicenda ricca di peripezie, tra terra e mare, quasi collo-cata a mezza strada tra la fiaba e le peripezie dei mercanti che avevano il mare in fronte(II, 4). L’Abruzzo che pure al tempo del Boccaccio era entrato con le sue lane, il suobestiame, il suo zafferano nella rete commerciale dei fiorentini viene significativa-mente evocato attraverso le sue montagne e la sua lontananza, che proprio per queicaratteri ambientali appare più remota di quanto in realtà non fosse (VI, 10 e VIII, 3).Ma non in un contesto burlesco vengono evocati gli umanizzatissimi paesaggi diCastellammare di Stabia se nelle loro dimore signorili della campagna evocarono peril Boccaccio, in qualche misura, le case padronali di cui i fiorentini del suo tempo ave-vano punteggiato le loro campagne, sovrapponendo al più fitto reticolo delleabitazioni dei loro contadini quel reticolo da padroni. In queste assolate terre cam-pane, con il mare in fronte o non lontano, i giardini, i campi, i boschetti gli apparivanoben più rigogliosi, l’aria e il clima ben più gradevoli. E proprio ad un tiro di balestradalla terra, «tra ulivi, nocciuoli e castagni, de’ quali la contrada è abondevole», un esulefiorentino acquista una proprietà, «sopra la quale un bel casamento e agiato fece e alla-to a quello un dilettevole giardino, nel mezzo del quale, a nostro modo, avendo d’ac-qua viva copia, fece un bel vivaio e chiaro e quello di molto pescie riempié leggier-mente» (X, 6). Il Boccaccio conosceva bene la stagionalità, la successione, i movimen-ti di merci e di uomini a cui esse davano luogo e non dimenticò di parlarne nelDecameron. «L’altranno fu a Barletta un prete, chiamato donno Gianni di Barolo, il qual,per ciò che povera chiesa aveva, per sostentar la vita sua con una cavalla cominciò aportar mercatantia in qua e in là per le fiere di Puglia e a comperare e a vendere» (IX,10). Tutte queste notizie che contribuiscono a caratterizzare ambienti naturali e sociali,sono utilizzate in G. Cherubini, Il Mezzogiorno normanno-svevo visto da Firenze, in Scrittimeridionali cit., pp. 41-58. Altre sono servite invece per la stesura di un saggio moltopiù ampio dedicato a I prodotti della terra: olio e vino, ibid., pp. 159-207, con citazioni checaratterizzano la spesso imponente montagna meridionale, dove la vite e soprattuttol’olivo appaiono lontani e di scorcio, evocati col sapore delle cose lontane (VI, 10, 40-42, VIII, 3, 14-16). Vini genericamente detti «di Calabria» vengono ricordati in unapratica di mercatura pisana del 1278 e più in particolare della Scalea, un porto nel golfodi Policastro di cui, più tardi, il Decameron sottolineerà l’animazione (V, 6, 11). Per laCampania il Decameron ricorda gli oliveti di Castellammare (X, 6, 6). Ma giova precisa -re, tuttavia, che le testimonianze del Boccaccio rimangono un contributo modestonelle amplissime testimonianze, narrative e documentarie che mi riuscì di mettereinsieme per quel lavoro sull’olio e sul vino.
3 Firenze 1974, 19772. Mi piace ora rinviare sul libro al giudizio di G. Piccinni,Signori, contadini, borghesi. Una recensione tardiva, in Uomini paesaggi storie cit., pp. 1193-1206.
172 GIOVANNI CHERUBINI
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
ne della mia utilizzazione della novellistica, con la ristampa di un brevearticolo, edito nel 1966, su La crisi della proprietà contadina in una novellalombarda del Cinquecento, che prende le mosse dal Trecentonovelle del Sac -chetti, ma utilizza poi, sull’argomento, una preziosa pagina de Le piace-voli notti dello Straparola. In apertura di Signori, contadini, borghesi com-pare anche la ristampa dell’ampio lavoro, da poco edito, su Vita trecen-tesca nelle novelle di Giovanni Sercambi, che utilizzava la recente edizione indue volumi di Giovanni Sinicropi4, senza ignorare le critiche che lefurono rivolte da Luciano Rossi, che ne aveva una propria in arrivo5.Ed infine in Signori, contadini, borghesi trovò posto, come appendice adun saggio sulla signoria di una famiglia senese in Maremma, un inedi-to lavoro intitolato Vita signorile a Montantico in una novella di GentileSermini, che dava per così dire il via al mio rapporto con questo novel-liere, indipendentemente da chi egli sia stato veramente6, ma che seguiipersino in una mia indagine testuale nella Biblioteca Estense diModena, dove si conserva il più importante dei due manoscritti del-l’opera7. E non abbandonai il Sermini. Pubblicando anzi nel volumeMedioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina, curato da Vito Fumagallie Gabriella Rossetti8, il saggio Il mondo contadino nella novellistica italianadei secoli XIV e XV. Una novella di Gentile Sermini (dodicesima della suaraccolta nella quale la novella è intitolata L’autore e ser Cecco da Perugia,e contiene anche il sonetto Se tu sapessi, Francio, com’io stò) lo feci prece-dere da alcune pagine in cui presentavo una sorta di teorizzazione
4 Bari 1972. Il Sinicropi ne pubblicò una seconda edizione (Novelle, Nuovo testocritico con studio introduttivo e note, 2 voll., Firenze 1995).
5 Giovanni Sercambi, Il Novelliere, ed. L. Rossi, 3 voll., Roma 1974.6 Vedi ora la proposta di Petra Pertici, Novelle senesi in cerca d’autore. L’attribuzione
ad Antonio Petrucci delle novelle conosciute sotto il nome di Gentile Sermini, «Archivio StoricoItaliano», 169 (2011), pp. 679-706. A proposito della sua identità io scrissi prudente-mente nel 1980, nel saggio di cui parlo poco sotto nel testo, alla p. 423: «GentileSemini, sul quale non si sa per la verità quasi nulla, era sicuramente un senese, comerisulta da un esame interno della sua raccolta di novelle. Nato verso la fine delTrecento, egli avrebbe cominciato a scrivere le sue novelle intorno al 1420-1430.Proprio la novella oggetto del nostro esame fa riferimento ad una “morìa”, cioè ad unaepidemia del 1424». Ho poi ripetuto queste righe nella ristampa di cui alla successivanota 9, alla p. 333.
7 Vedi la nota 2 di p. 417 del medesimo saggio. Nella ristampa del saggio nel volu-me di cui alla nota 9 (Scritti toscani. L’urbanesimo medievale e la mezzadria, Firenze 1991,pp. 327-346), il passo è alla nota 2 di pp. 327-328.
8 Bologna 1980, pp. 417-435, con altre indicazioni bibliografiche alle pp. 458-459.
IL DECAMERON LETTO DAGLI STORICI DEL MEDIOEVO 173
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
generale sul valore della novellistica come fonte storica, alla quale mipermetto di rinviare chi ne provi qualche desiderio9.Soltanto nel 1999 ho finalmente deciso, al Convegno del Centro
italiano di Studi di Storia e d’Arte di Pistoia, dedicato a Ceti, modelli, com-portamenti nella società medievale (Secoli XIII-metà XIV), i cui atti furonopubblicati nel 2001, di fare del Decameron l’oggetto principale del miointeresse con l’intervento Ceti, modelli, comportamenti nel «Decameron», dalmomento che, se centrale può dirsi ovviamente in questo capolavorodella letteratura universale la chiave di lettura dell’arte, il carattere con-creto dell’opera non impedisce che vi si cerchino gli spunti, diretti oindiretti, della società del tempo. E confesso che mi ha colpito legge-re nelle pagine di un amico, storico anch’egli, ma molto sensibile algusto della letteratura, che un tipografo tedesco, già a metà delCinquecento, definisse Giovanni Boccaccio «historiographus clarissi-mus». Non lo seguirò tuttavia su questa lunghissima strada, a me inprimo luogo vietata dall’incompetenza, ma che non nego di trovareaffascinante10. A Pistoia il mio intervento venne volutamente delimitato per moti-
vi di tempo. Non affrontai in effetti il tema che mi era stato assegnatoin relazione al sesso e all’età, o per quanto riguardava la vita di re o disignori cittadini, o per momenti centrali dell’esistenza quali la nascita, ilmatrimonio e la morte, e fatti importanti nella vita materiale e mentaledegli uomini, come il pasto e la tavola, il lavoro e la preghiera, il sonnoe la festa, e neppure sentimenti che come l’amore vi hanno un ruolocentrale. A meno che anche per tutti questi casi i sentimenti, i fatti, imomenti non risultassero strettamente collegati con i ceti, i mestieri, leprofessioni, le condizioni sociali ai quali fu dedicata la mia trattazione,tuttavia escludendone i religiosi, specie regolari, che mi sembravano datempo ampiamente studiati.Grande spazio, anzi lo spazio maggiore, occupa nelle novelle la
nobiltà, quasi che l’opera, destinata in primo luogo ad un pubblico bor-
GIOVANNI CHERUBINI
9 Ristampai il saggio nel mio volume Scritti toscani cit., pp. 327-351. La quarta partedel volume contiene, sotto il titolo Esame di fonti e di atteggiamenti mentali, sette saggi, frai quali, oltre a quello ricordato, compaiono Un diario fiorentino della fine del Trecento, I «libridi ricordanze» come fonte storica, L’immagine di Federico II nella cultura toscana del Trecento, Dantee le attività economiche del tempo suo, La campagna nel “Buon Governo” di Ambrogio Lorenzetti.Il paesaggio agrario medievale della Toscana, Rassegna di studi sui protocolli notarili toscani.
10 M. Miglio, Boccaccio biografo, in Boccaccio in Europe. Procedings of the BoccaccioConference, Louvain, December 1975, cur. G. Tournoy, Leuven 1977, p. 149.
174
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
ghese e mercantile e legittimamente definita da Vittore Branca come«epopea mercantile»11, poi come l’«epopea dei mercatanti»12, implichianche il sogno della vita nobile, non tanto e non soltanto nel suo signi-ficato di condizione sociale, ma anche e più nel significato di bei gestie di alti sentimenti. Questa nobiltà si presenta tuttavia nell’opera in tuttii suoi differenti aspetti, non foss’altro perché l’autore, nella sua stessavicenda biografica, con quegli aspetti diversi era venuto in contatto. Viincontriamo in effetti la nobiltà feudale e cavalleresca e la nobiltà citta-dina, i nobili ben fermi nella loro collocazione sociale e i nobili decadu-ti. E fra i nobili ben fermi sia quelli che si attengono alle norme conso-ne al loro status, sia i nobili che quelle norme tradiscono. Fra i nobilidecaduti incontriamo sia coloro che mantengono tutte le regole del lorostile di vita o almeno le sue apparenze, sia coloro che nel loro compor-tamento quelle regole rinnegano o sono costretti a rinnegare.Le divisioni di ceto e di classe vengono talvolta evidenziate nel-
l’opera dalla utilizzazione di coppie di opposti come «gentile uomo» e«villano», «povero» e «ricco», «mercatante» e «barattiere»13, e sindall’Introduzione risulta nel Decameron ben chiara la tremenda disugua-glianza di fronte alla peste14. Ben diversa da quella del popolo dellacittà e dei contadini è l’immagine che ci viene offerta dalla brigata deidieci giovani che trovano rifugio in campagna. Le sette donne, defini-te «di sangue nobile» – ma si tratta di una nobiltà cittadina – hannomolti beni terrieri e di non diversa condizione sociale sono evidente-mente i tre loro amici, dal momento che tutti risultano accompagnatida un “famiglio”. Una villa sontuosa, un maggiordomo, una servitù, unvivere raffinato quale risulta dai loro conviti fanno pensare ad unrango borghese non certo mediocre ed i nomi stessi dei servi, presi inprestito da Terenzio e Plauto, aggiungono un colorito fastoso, in
11 V. Branca, Boccaccio medievale, Firenze 1964, pp. 71-99.12 V. Branca, Boccaccio medievale e nuovi studi sul Decameron, quinta edizione accresciu-
ta, Firenze 1981, pp. 134-164.13 Decameron, I, 7, 23.14 «Della minuta gente e forse di gran parte della mezzana, era il riguardamento
di molto maggior miseria pieno: per ciò che essi, il più o da speranza o da libertà rite-nuti nelle lor case, nelle lor vicinanze standosi, a migliaia per giorno infermavano, enon essendo né serviti né aitati d’alcuna cosa, quasi senza alcuna redenzione, tuttimorivano. E assai n’erano che nella strada publica o di dì o di notte finivano, e molti,che ancora nelle lor case finissero, prima col puzzo de’ lor corpi corrotti che altramen-ti facevano a’ vicini sentire sé esser morti; e di questi e degli altri che per tutto mori-vano, tutto [era] pieno [...]. E acciò che dietro a ogni particularità le nostre passate
IL DECAMERON LETTO DAGLI STORICI DEL MEDIOEVO 175
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
mezzo a tocchi e particolari realistici15. Il Boccaccio impreziosiva senzadubbio i caratteri delle campagne fiorentine, ma non ne tradiva la real-tà come ben ci dimostra una famosa e notissima pagina di GiovanniVillani16. Proprio ai ceti contadini che popolavano quelle campagnesono dedicate alcune delle novelle più comiche e avvincenti delDecameron, quella di Masetto da Lamporecchio, quella di frate Cipolla,quella della Belcolore e del prete da Varlungo, quella di Ferondo. Glisfondi rusticani e di paesaggio non si limitano tuttavia al contado fio-rentino e spaziano, in Toscana, sino alla Lunigiana, e fuori dellaToscana sino alle zone alpine occidentali, alla pineta di Ravenna, alladesolata campagna romana, alla marina tirrenica dell’Italia meridiona-le, alle campagne siciliane. Contadini e campagnoli toscani offrono tut-tavia per noi gli spunti di maggiore interesse e mi dispiace non poter-ne qui trattare. Faccio solo una breve eccezione per la novella di frateCipolla, ma soltanto perché da un suo aspetto essenziale ha preso il viaun mio lavoretto dedicato a Certaldo e la borghesia castellana. Nota su untema di storia comunale toscana, che costituisce ovviamente uno specificointeresse di storico. Si tratta di uno studio di poche pagine, ma ampia-mente documentato, che ha poi avuto una qualche fortuna17.Al Decameron non sono del tutto ignoti i ceti cittadini più modesti,
artigiani o salariati, che hanno magari raggiunto la ricchezza nella loroattività e, come Cisti fornaio, aspirano ad un signorile comportamen-to, oppure come un poveruomo tedesco di Bolzano, di vita buona e
GIOVANNI CHERUBINI
miserie per la città avvenute più ricercando non vada, dico che così nimico tempo cor-rendo per quella, non per ciò meno d’alcuna cosa risparmiò il circustante contado. Nelquale, lasciando star le castella, che simili erano nella lor piccolezza alla città, per lesparte ville e per li campi i lavoratori miseri e poveri e le loro famiglie, senza alcunafatica di medico o aiuto di servidore, per le vie e per li loro colti e per le case, di dì edi notte indifferentemente, non come uomini, ma quasi come bestie morieno»(Decameron, Introduzione, pp. 16-38, 43-44).
15 C. Muscettta, Giovanni Boccaccio, Bari 1972 (estr. dal vol. III della Letteratura ita-liana Laterza, diretta dallo stesso Muscetta), p. 163.
16 G. Villani, Nuova Cronica, ed. G. Porta, 3 voll., Parma 1990-1991, XII, 94: III,pp. 201-202.
17 Ricordo, in particolare, il saggio di G. Pinto, che ne ha ripreso sostanzialmen-te il titolo (La “borghesia di castello” nell’Italia centro-settentrionale (secoli XII-XV). Alcune con-siderazioni, in Città e territori nell’Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti, cur.G. Chittolini - G. Petti Balbi - G. Vitolo, Napoli 2007, pp. 155-170), allargandolo atutta l’Italia superiore, che non mostrava tuttavia ovunque, al tempo in cui il Boccaccioscriveva, i caratteri delle campagne dominate dalla borghesia cittadina, come avvenivaa Firenze.
176
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
santa, che fa il facchino a Treviso, oppure come la coppia di coniuginapoletani, il marito muratore, la moglie filatrice che con il loro con-giunto operare «la lor vita reggevano come potevano il meglio»18.Naturalmente è dal mondo fiorentino segnato dall’alto livello qualita-tivo e quantitativo della produzione delle stoffe di lana che ci giungo-no gli accenni alla filatrice che lavora a domicilio per il lanaiolo, men-tre il lanino le distribuisce la lana e ritira il filato, oltre che descrizionirelative ai modi e ai luoghi di incontro segreti fra i giovani della lorocondizione19. Il Boccaccio non manca di accennare anche al mondodella servitù domestica, spesso segnata dalla «milensaggine» di moltesue appartenenti, che sembrano convinte dovere le donne evitar diparlare «co’ valenti uomini». Questa servitù femminile, che popola lecase dei ricchi, si dà piuttosto a favorire gli incontri segreti e gli amoridei padroni e soprattutto delle padrone con gli amanti. Al grandenovelliere non sfugge, tra l’altro, che i decessi per la peste ne hanno fal-cidiato le file e ne hanno innalzato sfacciatamente i salari20. Il Boccac -cio ricorda anche il mondo della mendicità e dell’accattonaggio, acominciare dai «paltoni franceschi», poveramente vestiti, che a Londravanno chiedendo la carità21, e continuando con «le due grandissimecaldaie di broda» quotidianamente distribuite dal convento francesca-no di Santa Croce «a molta povera gente»22. Ci vengono poi descrittigli «zoppi, attratti e ciechi e altri di qualunque infermità o difetto impe-diti» che nella cattedrale di Treviso si affollano intorno al corpo di undefunto ritenuto santo, nella speranza di riceverne la guarigione23. Néviene dimenticato il mondo della prostituzione cittadina – a Napoli, aPalermo, a Firenze –, con le sue figure di magnaccia, come, a Napoli,lo «scarabone» Buttafuoco, o, a Firenze, il «tristo» chiamato icastica-mente «il Mangione», che teneva «a sua posta» una ragazza nella zonapopolarissima di Camaldoli e «la prestava a vettura» ai giovani ricchiche avevano villa in contado. Lo scrittore non dimentica neppure gli«stracci d’un povero uomo» morto di peste pericolosamente abbando-nati su una via di Firenze24. Un quadro, in definitiva, quello che si rica-
18 Decameron, VII, 2, 7,19 Decameron, IV, 7, 6-11.20 Decameron, Introduzione, 28.21 Decameron, II, 8, 28.22 Decameron, I, 6, 19.23 Decameron, II, 1, 5.24 Decameron, Introduzione, 18.
IL DECAMERON LETTO DAGLI STORICI DEL MEDIOEVO 177
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
va dal Decameron, che difficilmente gli storici possono chiedere alle lorofonti più consuete. Un ampio spazio è riservato anche agli uomini dicorte, che sono protagonisti di più di una novella e rappresentano dueepoche diverse, la seconda delle quali contrassegnata dalla decadenzadei costumi cavallereschi e della vera nobiltà25.Categorie sociali che non sfuggono all’attenzione del Boccaccio
sono anche quelle di coloro che infrangono le leggi, come i briganti diterra, che agiscono attraverso canagliesche imboscate contro i viandan-ti, o i corsari che rendono insicura la navigazione, ma non godonodella trista fama dei primi, talvolta assumendo anzi un rispettabile pro-filo nel quadro di una forma di guerra quasi o del tutto lecita, talvoltarivolta contro gli infedeli e contrassegnata dal necessario coraggio26. AlDecameron non sfugge nemmeno l’albergo, per quanto non vi appaia innegativo o in positivo un vero modello dell’albergatore che pur gode-va in molte fonti diverse di un’immagine non limpida. In una novellaviene addirittura presentato con simpatia «uno alberghetto fiorentino»,«il quale una buona donna vedova tenea». Tuttavia, a conferma dellacattiva fama della categoria, che soltanto una scarsa pratica con lavarietà delle fonti potrebbe farci credere un topos letterario, ci vieneraccontato che due fratelli albergatori, che vivevano nella medesimacittà, ed il loro fante furono autori di un omicidio27. Alle descrizioni del novelliere non sono naturalmente estranee le
categorie dei professionisti, più o meno importanti, dal notaio al giu-dice e al medico, accompagnate da un prestigio diverso, ma comunquesenza che il Boccaccio esprima per loro una generale benevolenza,quasi a generale condanna di una sapienza che costoro mettono invendita o di una sapienza soltanto apparente, non mascherata dall’ap-parato e dalla solennità, anche di vestiario, con le quali si adornanoquando tornano dagli studi fatti a Bologna28. Il caso estremo, fra costo-ro, è rappresentato dal notaio ser Cepperello da Prato, tanto noto checredo non ci sia bisogno di una descrizione, canaglia a tal punto, ma amodo suo, che non teme di dannarsi aiutando chi nel difficile mondo
GIOVANNI CHERUBINI
25 Decameron, I, 8, 8-10.26 Decameron, II, 4, 6 e 10, V, 2 e 7.27 Decameron, III, 7, 77, 81.28 «Sì come noi veggiamo tutto il dì, i nostri cittadini da Bologna ci tornano qual
giudice qual medico e qual notaio co’ panni lunghi e larghi e con gli scarlatti e co’ vaie con altre assai apparenze grandissime, alle quali come gli effetti succedano ancheveggiamo tutto giorno» (Decameron, VIII, 9, 4).
178
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
fuori dai nostri confini lo accolse gravemente ammalato29. I medicifanno più di una volta la loro comparsa nell’opera, a cominciare dallaloro impotenza contro la peste e dai guaritori improvvisati, fra i qualicompaiono anche le donne. Una figura degna di scherno è il maestroSimone da Villa, «più degno di ben paterni che di scienza», giustamen-te domiciliato in via del Cocomero e con una bottega in MercatoVecchio «alla ’nsegna del mellone», contro il quale si dirigono le burledi Bruno e Buffalmacco30. Ma non mancano, tuttavia, figure positive,per sapienza e gentilezza d’animo, cioè capaci di ricevere le fiammed’amore a dispetto dell’età avanzata, come maestro Alberto da Bolo -gna31, o «un grandissimo medico in cirugia» di Salerno (significativo ilrichiamo alla locale e famosa scuola medica) che nella sua «ultima vec-chiezza si prende imprudentemente in moglie una bella gentildonna»32.Fra i giudici il pisano Riccardo da Chinzica commette la stessa impru-denza dell’illustre chirurgo salernitano33. La descrizione di un miserogiudice marchigiano giunto a Firenze nella «famiglia» di un altro pez-zente rettore consente al Boccaccio di informarci sulla grossolanità ela cattiva immagine di cui godevano nella grande città i marchigiani chevi erano stati chiamati con funzioni di governo34. Questo ci fa pensa-re che la loro immagine ideale per i fiorentini fosse invece costituitadalla dignità, anche esteriore, dall’istruzione e anche dalla signorilità ditratto.Nel Decameron occupano infine un posto centrale i mercanti, nel
senso complessivo di commercianti di merci e di commercianti didenaro. Ma non alle loro attività, ai loro ambienti, ai loro eroismi, ailoro successi, alle loro avventure, al loro girovagare tra Oltremonte eOltremare dedicherò la mia attenzione, ma soltanto ai modelli idealiche il Boccaccio ne delinea e ai comportamenti concreti che ci fa indo-
29 Decameron, I, 1, 10-14.30 Decameron, VIII, 9, 5-6, e IX, 3.31 Decameron, I, 10, 9-10.32 Decameron, IV, 10, 4.33 Decameron, II, 10, 5.34 «Nella nostra città vegnono molto spesso rettori marchigiani, li quali general-
mente sono uomini di povero cuore e di vita tanto strema e tanto misera, che altro nonpare ogni lor fatto che una pidocchieria: e per questa loro innata miseria e avariziamenan seco e giudici e notari, che paiono uomini levati più tosto dall’aratro o trattidalla calzoleria che delle scuole delle leggi». Il nostro giudice, vero e proprio «nuovouccellone» porta un «vaio tutto affumicato in capo e un pennaiuolo a cintola e piùlunga la gonnella che la guarnacca» (Decameron, VIII, 5, 4-5, 7).
IL DECAMERON LETTO DAGLI STORICI DEL MEDIOEVO 179
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
vinare. Un solo accenno ad un mercante provenzale ce ne dà subitoun’idea. «Marsilia, sì come voi sapete, è in Provenza sopra la marinaposta, antica e nobilissima città, e già fu di ricchi uomini e di gran mer-canti più copiosa che oggi non si vede; tra’ quali ne fu uno chiamatoN’Armad Civada, uomo di nazione infima, ma di chiara fede e lealmercatante, senza misura di possessioni e di denari ricco»35. Un belprototipo del retto uomo d’affari, ma «grosso» e semplice parlatoresulle questioni della fede, come era cosa normale per un mercante, èquello che ci viene presentato nella seconda novella della prima gior-nata. In un’altra un altro altrettanto significativamente dichiara: «io sonmercatante e non filosofo, e come mercatante risponderò»36. Un terzo,che operava a Parigi, chiamato Giannotto di Civignì, «lealissimo e dirit-to e di gran traffico d’opera di drapperia», «avea singulare amistà conuno ricchissimo uomo giudeo chiamato Abraam, il quale similmentemercatante era e leale uomo assai». «Giannotto non stette [di mostrar-gli] così grossamente come il più i mercanti sanno fare, per quali ragio-ni la nostra [fede] era migliore che la giudaica»37. Prototipi di giovaniuomini d’affari ancora inesperti ed ingenui, ma poi vittoriosi, per aguz-zato ingegno mercantile sollecitato dalla necessità contro l’ingannodelle belle ed esperte prostitute siciliane nelle affascinanti e pericolosecittà di Napoli e di Palermo, appaiono Andreuccio da Perugia38 eSalabaetto da Firenze39. Si può anche, più in generale, osservare che,quando un uomo d’affari era in viaggio, i malviventi che stavano all’er-ta lungo le strade, «veggendol mercatante e istimando lui dovere por-tar denari», erano pronti a saltargli addosso40.Il Decameron tratta anche del ceto dei nobili e cavalieri e dei loro
modelli di vita e di comportamento. Ne vengono evocati due apparte-nenti alla Provenza, che avevano castelli e vassalli, ed avevano l’abitu-dine di prender parte a tornei e giostre o ad altri fatti d’arme «insiemee vestiti d’una assisa», cioè di una stessa divisa41. Un magnifico conte-sto di vita feudale è quello che ci viene offerto dalla corte e dalla figu-ra del marchese di Monferrato, «uomo d’alto valore, gonfaloniere della
GIOVANNI CHERUBINI
35 Decameron, IV, 3, 8.36 Decameron, II, 9, 18.37 Decameron, I, 4-5, 8-9.38 Decameron, II, 5.39 Decameron, VIII, 10.40 Decameron, II, 2, 5.41 Decameron, IV, 9, 4-6.
180
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
Chiesa, oltremare passato in un general passaggio da’ cristiani fattocon armata mano»42. Un perfetto modello di gentiluomo è il conteGualtieri di Anversa, «del corpo bellissimo e d’età forse di quarantaanni, e tanto piacevole e costumato quanto alcuno altro gentile uomoil più esser potesse; e oltre a tutto questo, era il più leggiadro e il piùdilicato cavaliere che a quegli tempi si conoscesse e quegli che più dellapersona andava armato»43. Ricciardo Minutolo era invece un giovanenapoletano di nobile sangue, il cui corteggiamento a una donna consi-steva in «armeggiare» e «giostrare»44.Anche nelle città che come Firenze erano ormai percorse da forti
spiriti borghesi e da un profondo mutamento sociale, quelle consuetu-dini del corteggiamento non erano ignote, così come le «ragunate»conviviali, tra l’ammirazione, la meraviglia e il dissenso nei circoli dellanuova aristocrazia del denaro. Il Decameron ci racconta a questo propo-sito lo splendido comportamento di messer Filippo Alberighi cheinnamoratosi di una monna Giovanna, ritenuta una delle più belle diFirenze, per conquistarla consumò il suo patrimonio giostrando,armeggiando, organizzando feste e generosamente facendo doni45. El’autore non manca di ricordare le «assai belle e laudevoli usanze» pra-ticate in Firenze «ne’ tempi passati», ormai tutte scomparse a causa del-l’avarizia cresciuta insieme alle ricchezze. E una in particolare ne de -scrive46. Ma lo stile della vita nobile, tra la fine del XIII e i primi annidel XIV secolo poteva assumere anche aspetti diversi da quelli del cor-teggiamento amoroso, della larghezza nello spendere, dell’armeggiaree dei conviti. La caccia era uno di questi aspetti. «Currado Gianfigliazzi
42 Decameron, I, 5, 5.43 Decameron, II, 8, 6.44 Decameron, III, 6, 4 e 7.45 Decameron, V, 9, 5-6.46 «Ne’ tempi passati furono nella nostra città assai belle e laudevoli usanze, delle
quali oggi niuna n’è rimasa, mercè dell’avarizia che in quella con le ricchezze è cresciu-ta, la quale tutte l’ha discacciate. Tralle quali n’era una cotale, che in diversi luoghi perFirenze si ragunavano insieme i gentili uomini delle contrade e facevano lor brigate dicerto numero, guardando di mettervi tali che comportare potessono acconciamente lespese, e oggi l’uno, doman l’altro, e così per ordine tutti mettevan tavola, e ciascuno ilsuo dì, a tutta la brigata; e in quella spesse volte onoravano e gentili uomini forestieri,quando ne capitavano, e ancora de’ cittadini; e similmente si vestivano insieme alme-no una volta l’anno, e insieme i di più notabili cavalcavano per la città e talora armeg-giavano, e massimamente per le feste principali o quando alcuna lieta novella di vitto-ria o d’altro fosse venuta nella città» (Decameron, VI, 9, 4-6).
IL DECAMERON LETTO DAGLI STORICI DEL MEDIOEVO 181
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
[...] sempre nella nostra città è stato notabile cittadino, liberale e magni-fico, e vita cavalleresca tenendo, continuamente in cani e in uccelli s’èdilettato»47. Localmente, com’è naturale, la vita dei gentiluomini e delle gentil-
donne può presentare talvolta abitudini particolari. Gli indimenticabi-li ricordi della giovinezza ai quali dobbiamo anche il «movimento not-turno» della novella di Andreuccio da Perugia48, fanno apparire Napolial Boccaccio città «forse così dilettevole, o più, come ne sia alcuna altrain Italia». Là c’era l’abitudine, nelle calde giornate d’estate, «per moltebrigate di donne e di cavalieri», di andare «a diportarsi a’ liti del mare ea desinare e a cenarvi»49. Possiamo aggiungere, sul piano più generale,che la vita dei nobili comprendeva anche altre abitudini diffuse comeil pellegrinaggio in Terrasanta o ai santuari del Mezzogiorno d’Italia50.Non sempre tuttavia coloro che occupavano i piani alti della piramidesociale vivevano secondo le medesime regole. Non è un caso che pro-prio in due città segnate dall’espansione comunale, dai commerci, dallabattaglia quotidiana per il guadagno e per la ricchezza, cioè Pistoia eGenova, un cavaliere dei Vergiolesi fosse «uomo molto ricco, savio eavveduto», ma «avarissimo senza modo»51, un gentiluomo deiGrimaldi, che per la sua grande ricchezza si distingueva fra gli italiani,superava tutti per miseria e avarizia, teneva serrata la borsa, non spen-deva, in contrasto con le abitudini dei genovesi, nel vestirsi bene, nelmangiare e nel bere52.I cambiamenti di condizione sociale e di status non sono ignoti al
Decameron. Un bell’esempio di ascesa sociale fu quello di MusciattoFranzesi, «di grandissimo e gran mercatante in Francia cavalier divenu-to»53, un altro quello del ravellese Landolfo Rufolo, rovinato dal nau-fragio della sua nave, ma di nuovo arricchitosi con la guerra di corsasoprattutto contro i turchi54. La decadenza dei gentiluomini rappresen-ta tuttavia, come abbiamo già visto per Federigo degli Alberighi infeli-
GIOVANNI CHERUBINI
47 Decameron, VI, 4, 4.48 Si veda in proposito il bellissimo saggio di Benedetto Croce, ora in B. Croce,
Storie e leggende napoletane, cur. G. Galasso, Milano 1990, pp. 51-88. 49 Decameron, III, 6, 4 e 9.50 Decameron, II, 6, 18; III, 7, 9, e 9, 33.51 Decameron, III, 5, 4.52 Decameron, I, 8, 4-6.53 Decameron, I, 1, 7. 54 Decameron, II, 4, 3-10.
182
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
cemente innamorato, l’aspetto di questi mutamenti sociali, per un ec -cessivo ricorso alle spese. Non mancano tuttavia anche vicende diver-se e di differente conclusione. Una ne ricorda evidentemente il Boc -caccio, quella di messer Tebaldo dei Lamberti o degli Agolanti (l’incer-tezza era il frutto di due differenti versioni fra i fiorentini). Egli morìricchissimo di beni mobili e stabili, ma i tre figli, trovatisi fra le maniquel ben di Dio lo dilapidarono in breve senza pietà, «tenendo gran-dissima famiglia», cavalli, cani, uccelli, donando e armeggiando. Percostoro la riconquista della ricchezza e della dignità sociale avvieneattraverso il momentaneo abbassamento verso l’usura. Ma appenariconquistatele essi tornano di nuovo alla spesa e alla vita di gentiluo-mini55. In questo intreccio di storie complesse per le quali è difficiledire se si tratta sempre di vicende reali o almeno in parte immaginateo addirittura simboliche, non manca un ultimo riferimento ad un pro-blema effettivamente risultante da più di una testimonianza, vale a direil desiderio del ricco mercante di trovarsi una moglie nobile, magari diuna nobiltà non più solida. Così fece «scioccamente» il «ricchissimomercante» Arriguccio Berlinghieri, allo stesso modo che fanno ognigiorno i mercanti per «ingentilire», e prese per moglie «una giovanegentil donna male a lui convenientesi»56. Ma una seconda novella cimostra che cosa poteva succedere se la moglie era piena delle qualità edella convinzione sociale del suo status ed il marito lanaiolo sensibilesoltanto al suo lavoro. Essa poteva in effetti decidere di non negarsi aisuoi abbracci, ma «di volere a soddisfazione di sé medesima trovarealcuno il quale più di ciò che il lanaiuolo le paresse che fosse degno»57.La mobilità sociale, il passaggio dall’una all’altra condizione, dal-
l’alto verso il basso e dal basso verso l’alto, anche se fantasticamenteimmaginati, mi paiono ben documentati. Il Decameron riflette dunque,sia pure con alcune polarizzazioni, la reale articolazione dei ceti e delleclassi e i modelli della nobiltà, delle professioni liberali, dei mercanti,dei contadini e del vario mondo del lavoro che il Boccaccio aveva inmente.Se dovessi ora indicare, in generale, la suggestione del capolavoro
del Boccaccio, non avrei alcuna difficoltà, ricordando quanto me nepiacesse e me ne piaccia la lettura, ad indicarne per me la centrale rile-
55 Decameron, II, 3, 6-9 e 11-13.56 Decameron, VII, 8, 4-5.57 Decameron, III, 3, 5-7.
IL DECAMERON LETTO DAGLI STORICI DEL MEDIOEVO 183
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
vanza, e poi l’importanza avuta dal saggio, già ricordato, di VittoreBranca sull’epopea dei mercanti, accresciuto di «nuovi studi sulDecamerone» nella quinta edizione sansoniana, del 1981, e pubblicatoinfine dalla BUR nel 2010 con Introduzione di Franco Cardini58, oltreche dalla precedente sollecita comparsa, in modo molto accessibile, diuna correlata documentazione pittorica59. I miei prevalenti interessiandavano tuttavia, in quegli anni, soprattutto alla storia dei contadini edelle campagne60, e non mi giudicavo sufficientemente pronto ad esa-minare, sulla scia di un grande autore come Boccaccio, i cento aspettidel mondo cittadino.E la peste, alla quale il Boccaccio dedica l’introduzione del Deca -
meron? Essa comparve invece molto precocemente nei miei interessi difresco assistente universitario, quando ne feci, nelle vivaci vicende dellaprima contestazione studentesca, l’oggetto di un mio seminario (1969-1970) e ne pubblicai, sia pure riviste, le relazioni degli studenti61. Madella peste, sulla quale mi ero precocemente informato, soprattutto subibliografia non italiana dato che modesto ne era ancora da noi ilrichiamo scientifico, ho dato comunque più tardi una complessivavalutazione storiografica, non dimenticando di dedicare una pagina alcaso straordinario di Firenze che poteva offrire in proposito le paginedi un grande cronista come Matteo Villani, che vi perse il fratelloGiovanni, e di un grande narratore come Giovanni Boccaccio che creòanche, attraverso di essa, la condizione straordinaria perché i giovaninarratori dell’opera potessero isolarsi dal flagello nello straordinariopaesaggio delle colline fiesolane62. Ma dovrei anche accennare allatematica più generale, relativa alla crisi del XIV secolo, sulla quale ho
58 Ne ricordo anche la bella recensione di Cesare De Michelis, «Studi sulBoccaccio», 38 (2010), pp. 315-318.
59 Giovanni Boccaccio, Decameron, con introduzione di Vittore Branca, 3 voll.,Firenze 1966.
60 D. Balestracci, Giovanni Cherubini e la storia delle campagne: un tema démodé?, inUomini paesaggi storie cit., pp. 1115-1129.
61 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, La Peste Nera(1347-1350), Seminario di Storia medievale. Relazioni degli studenti, AnnoAccademico 1969-70, Firenze 1970.
62 G. Cherubini, La peste nera: l’accertamento storiografico, in La peste nera: dati di unarealtà ed elementi di una interpretazione. Atti del III Convegno storico internazionale, Todi10-13 ottobre 1993, Spoleto 1994, pp. 383-402. A p. 396 il riferimento a Matteo Villanie al Boccaccio.
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
184 GIOVANNI CHERUBINI
avuto modo di riflettere e di scrivere, ma in questo caso mi basta invia-re all’attento lavoro di un mio alunno, ormai studioso maturo, checonosce molto bene la problematica, le discussioni relative e chi se neè occupato63. Ritornando per un momento al mondo rurale devo essere, per la
verità, anche un po’ più preciso. Il mondo rurale, difficilmente docu-mentabile attraverso fonti dirette, aveva bisogno della ricerca di fontivariegate per riuscire ad emergere dal silenzio della storia. E confessoche neppure in anni recentissimi, se sollecitato da qualche amico, horinunciato, ad esempio, a descrivere il montanaro – potrei chiamarlo,date le mie origini appenniniche, quasi un mio antenato – ricorrendoalla mia ormai cara novellistica64, che si era sempre più allargata anchea fonti non toscane, che rimasero tuttavia sino alla fine del Quat -trocento quelle nettamente prevalenti, e a fonti particolari come I mottie facezie del Piovano Arlotto e le Facezie in latino di Poggio Bracciolini.Neppure ho rinunciato a sollecitare i miei alunni nella direzione dellostudio del mondo rurale nel Decameron. Ricordo, in particolare, checonseguì con me il dottorato una brava alunna argentina, FlorenciaMarcela Gallego, innamoratasi di questa tematica, pur venendo da unapreparazione prevalentemente letteraria. Sempre al mondo rurale miha, di tempo in tempo, richiamato anche la suggestione di ciò che misuggerì il mio indimenticato maestro Ernesto Sestan parlandomi dellaSatira del villano come di una mia possibile tesi. Fatto è che sia su que-st’ultima che su altre cose ritrovo fra le mie carte testi di lezioni o diconferenze, lavori talvolta abbozzati e mai completati dedicati alDecameron o a temi vicini.
Ma quanto questa documentazione delle belle o comunque affasci-nanti novelle possa essere citata non soltanto come una fonte di rile-vante interesse, almeno per me, ma anche come una fonte utilizzatadagli storici, se molto o se poco e se non fraintendendo i testi, ma tra-endone soltanto una utilizzazione diversa dai letterati non saprei direcon assoluta sicurezza. Ho letto a tal proposito per intero ciò che ho
63 F. Franceschi, Giovanni Cherubini e la crisi tardo-medievale, in Uomini, paesaggi, storiecit., pp. 1131-1149.
64 G. Cherubini, Il montanaro nella novellistica, in Homo appenninicus. Donne e uominidelle montagne. Atti della giornata di studio, Capugnano 8 settembre 2007, Pistoia 2008(Storia e Ricerca sul Campo in Emilia e Romagna, 18), pp. 7-15.
IL DECAMERON LETTO DAGLI STORICI DEL MEDIOEVO 185
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
trovato all’interno di quella vera miniera che sono gli «Studi sul Boc -caccio». E devo ricordare subito che vi ho incontrato l’amico e condi-scepolo Franco Cardini, come presentatore dell’ultima edizione delBoccaccio medievale di Branca e come autore del saggio Il Decameron:“alle radici” (o “nella preistoria”) dell’orientalismo?65. Ne conosco da semprele competenze e i gusti. Ricordo con piacere che quando scrissi il sag-gio, già ricordato, sulla Vita trecentesca nelle novelle di Giovanni Sercambi,egli trovò il modo di fargli seguire un suo lungo saggio dedicato alle«novelle di magia» del lucchese con l’amichevole accompagnamentoche io, della raccolta, avrei «dimostrato efficacemente l’importanzaquale fonte per la vita economico-sociale del suo tempo». Cardini con-tinuò poi a distribuire altri saggi su temi simili o vicini anche in altrilavori, o perché aperto a molte tematiche e curiosità, o perché non lon-tani da richiami latamente letterari. Vedo che egli ne ha pubblicato,sempre sulle pagine di «Studi sul Boccaccio»66, anche un altro ampiolavoro che meno mi convince, ma forse soltanto per la mia vena un po’plebea e materialista che egli bene conosce.Se nel caso di Cardini sono in grado di identificare il carattere degli
studi, in altri casi la cosa non risulta altrettanto agevole, o perché chiscrive sul Decameron con un taglio non lontano dallo storico figura inve-ce come professore di letteratura, o perché non è sempre facile defini-re la sua condizione professionale. Sfogliando tutte le pagine di «Studisul Boccaccio» e soprattutto le lunghissime bibliografie che vi sonocontenute si acquisiscono tuttavia molte informazioni che mi permet-to, in qualche misura, di comunicarvi, attingendo poi anche alle mieconoscenze dirette di autori e di autrici, che sono soltanto, ovviamen-te, il frutto di letture personali. Trovo, ad esempio, che nel 1953 e nel1955, Carmelo Trasselli, del quale più tardi acquisii conoscenze piùampie, scrisse dei saggi rispettivamente dedicati a Le novelle siciliane delDecameron67 e al Decameron come fonte storica68, oltre che un lavoro Sugli
GIOVANNI CHERUBINI
65 Vedi «Studi sul Boccaccio», 39 (2011), pp. 1-21 la relazione di Franco Cardini.Alla nota 13 di p. 8 egli cita il bel lavoro, che da qualche tempo ho avuto modo diapprezzare del suo alunno N. Budini Gattai, La percezione del mondo greco del XIV secolotra incomprensioni culturali e topoi letterari, in Boccaccio geografo. Un viaggio nel Mediterraneo trale città, i giardini e…Il mondo di Giovanni Boccaccio, cur. R. Morosini, coll. A. Gentile,Firenze 2010, pp. 103-131.
66 F. Cardini, Una novella mai scritta e una catarsi cavalleresca, «Studi sul Boccaccio»,33 (2005), pp. 17-54.
67 «Sicilia Regione», 25/I (1953). L’autore fa riferimento alle novelle V, 2 e 7 e X, 7.68 «Rassegna di cultura e di vita scolastica», 9 (1955). Per le novelle VIII, 10 e V, 7.
186
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
europei in Armenia: a proposito di un privilegio trecentesco e di una novella delBoccaccio69, mentre Paolo Gasparinetti, scrivendo su «La via degliAbruzzi» e l’attività commerciale di Aquila e Sulmona nei secoli XIII-XV,sostenne che il Boccaccio l’avrebbe percorsa nel 1324 e nel 1362 e chela diffusione del Decameron sarebbe proprio avvenuta verso il sud perquesta via, secondo le documentazioni raccolte dal Branca70. GiovanniCecchini, che aveva esperienze di archivista e di storico, dedicò aGhino di Tacco, protagonista della terza novella della decima giornatadel Decameron, un suo saggio71. Qualche decennio più tardi un protago-nista della vita politica italiana come Bettino Craxi, cui venne forse allemani, al momento della sconfitta, anche il prezioso volumetto diBruno Benti vogli, Ghino di Tacco nella tradizione letteraria del Medioevo72, neaveva utilizzato polemicamente lo pseudonimo sulle pagine dell’Avanti!e ne scrisse più tardi, ormai esule volontario, una appassionata biogra-fia di «brigante gentiluomo»73 . A tutti è nota la novella di Andreuccio da Perugia commentata
nelle belle pagine di Benedetto Croce74. Non è neppure mancato chiha scritto di Echi e reminiscenze di vita e storia napoletana nel «Decameron»75.Vittore Branca e la sua rivista furono anche sensibili nel comuni-
care ciò che si pensava intorno al Boccaccio nel mondo comunista. IlDecameron vi conquistava, comprensibilmente, una grande simpatia.Nel 1954 si dette notizia che nell’Unione Sovietica in un «Bollettinodelle relazioni culturali dell’Urss», una traduzione completa delDecameron era giunta alla settima edizione con 260.000 copie, e che vierano traduzioni in ucraino, armeno, georgiano, che erano state infinepresentate anche delle tesi all’Università di Mosca76. Nel 1964 si detteinvece notizia di un periodico ungherese di Arte e realtà storica nelle operedi Giovanni Boccaccio77, come nella Russia Sovietica o in Cina il Boccac -
69 «Archivio Storico Italiano», 122 (1964).70 P. Gasparinetti, «La via degli Abruzzi» e l’attività commerciale di Aquileia e Sulmona
nei secoli XIII-XV, «Bullettino Deputazione Abruzzese di Storia Patria», 54-56 (1964-1966).
71 G. Cecchini, Ghino di Tacco, «Archivio Storico Italiano», 115/3 (1957), pp. 263-298.
72 Roma 1992.73 B. Craxi, Gesta e amistà di un brigante gentiluomo, Roma 1999.74 Decameron, IV, 4,4.75 L. Gasparini, Napoli 1975.76 N. G. Yelina, Italian Literature in the Soviet Union, «Volks Bulletin», 3 (1954), n. 3 (86).77 Z. Rózsa, «Acta Licteraria Academiae Scientiarum Hungaricae», 6 (1964).
IL DECAMERON LETTO DAGLI STORICI DEL MEDIOEVO 187
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
cio conquistava agli inizi degli anni Cinquanta molte simpatie e venivatradotto e letto. Dalla Francia tra il 1975 e il 1976 giungeva, attraversola penna di P. Renucci, la sottolineatura del ruolo della città e dell’«irre-sistible essor» della civiltà urbana nel Decameron78. Un autore tedesco inun’opera collettiva dedicata al realismo nel Rinascimento e pubblicatanel 1977 a Berlino e Weimar, stese un saggio di orientamento marxi-sta, che richiamava alla ricchezza delle novelle del Decameron, ai proble-mi del feudalesimo e del comune, al ruolo della Fortuna analizzandoun gruppo di novelle (fra le quali I, 3; V, 9; VI, 10; VIII, 8)79. Del notis-simo studioso francese Michel Plaisance, col quale ebbi modo, in annilontani, di intrattenere dei rapporti amichevoli a Parigi anche parlandodi novelle, conosco abbastanza bene gli interessi per le istituzioni cul-turali nella Firenze del Cinquecento, per la letteratura, il teatro e lefeste, la cura prestata all’edizione di vari volumi. Ma lo potrei conside-rare uno storico nel senso in cui qui lo intendo? Forse no, se leggol’elenco della settantina di suoi lavori che conosco. Non posso tuttaviadimenticare che egli scrisse dei rapporti tra la città e la campagna in treimportanti novellieri italiani80, della funzione e tipologia della cornicenella novella italiana81, ed infine di città e campagna tra il XIII e il XVIIsecolo non tralasciando ovviamente il Boccaccio82.
Fra gli storici che conosco e che hanno utilizzato le novelle delDecameron ricordo le belle pagine scritte da Rosa Maria Dentici Buc -cellato sulla Sicilia. L’isola vi appare come un vero e proprio mito, unaterra affascinante e remota, l’«isola dalle molte avventure»: un’isola nel -la quale, probabilmente, il Boccaccio non mise mai piede, ma dellaquale sentì parlare dai mercanti nel porto di Napoli e alla corte degliAngiò, che ne sognavano la riconquista, e della quale lesse molte cosenegli amati scrittori dell’età classica83. Aggiungo anche il nome di Mas -
GIOVANNI CHERUBINI
78 P. Renucci, L’irresistible essor de la civilisation urbaine dans le «Decameron», «Revuedes Études Italiennes», n. ser., 21 (1975), e La ville dans le Décameron, «Bulletin duC.I.R.I.», 2 (1976).
79 H. Heintze, Das “Decamerone” und die Welt in die Novelle, in Realismus in derRenaissance, Berlin - Weimar 1977.
80 Les rapports ville campagne dans les nouvelles des Sacchetti, Sercambi et Sermini, in Cultureet société en Italie. Hommage à André Rochon, Paris 1985, pp. 61-73.
81 In La novella italiana, I, Roma 1989, pp. 103-118. 82 Nella Letteratura italiana, diretta da A. Asor Rosa, V, Le Questioni, Torino 1986,
pp. 583-634.83 R. M. Dentici Buccellato, L’isola dalle molte avventure. Il mito della Sicilia nelle novel-
le del Boccaccio, «Etruria Oggi», 8/21 (1989), pp. 52-56.
188
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
simo Montanari che in uno dei suoi fortunati ed apprezzati volumidedicati alla storia dell’alimentazione (La fame e l’abbondanza. Storia del-l’alimentazione in Europa)84, ha intitolato un paragrafo all’«abbondanzadei poveri», dove non si è dimenticato di Calandrino e dell’immaginefavolosa del Paese di Bengodi che gli fa balenare agli occhi Maso delSaggio che ben ne conosceva la semplicità. L’episodio ci illustra il desi-derio popolare del mangiar bene e molto, cioè dell’abitudine dei piùpoveri alla fame. Maso descrive dunque «una contrada che si chiamaBengodi, nella quale si legano le vigne con le salcicce e avevasi un’ocaa denaio e un papero giunta; e eravi una montagna tutta di formaggioparmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosafacevano che far maccheroni e raviuoli e cuocergli in brodo di cappo-ni, e poi gli gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se n’aveva; eivi presso correva un fiumicel di vernaccia, della migliore che mai sibevve, senza avervi dentro gocciola d’aqua»85. Con il nuovo secolo l’uso delle novelle da parte degli storici si è
ampliato. Chi, come Alberto Grohmann se n’è servito per dare un’ideadei mercanti e della morale cristiana, della fiera e del mercato comepossibili luoghi del raggiro e dell’inganno, per descrivere aspetti tecni-ci della mercatura, per mostrare l’aspirazione dei mercanti ad una sca-lata sociale, per descriverceli di fronte ai pericoli e agli imprevisti86.Paolo Nanni, fra le cui competenze figura anche la storia delle
campagne, mostra invece quale interesse abbia la Valle delle Donne, daalcuni identificata con la valletta presso villa Schifanoia a San Dome -nico di Fiesole. Si tratta di una descrizione del paesaggio agrario, inquesto caso fiesolano, molto precisa per alcuni aspetti, quali le sistema-zioni collinari a gradoni o il riferimento alle coltivazioni arboree, diffi-cilmente reperibili nelle fonti economiche e fiscali. Ma al tempo stes-so essa riflette una particolare percezione della campagna intorno aFirenze: la cura della sua rappresentazione ci mostra una campagnache partecipa alla bellezza della città e al suo decoro. «Le piagge dellequali montagnette così digradando giuso verso il pian discendevano,come ne’ teatri veggiamo dalla lor sommità i gradi infino all’infimovenire successivamente ordinati, sempre ristrignendo il cerchio loro. Eerano queste piagge, quante alla piaga del mezzogiorno ne riguardava-
84 Roma-Bari 1993.85 Decameron, VIII, 3, 9, 38.86 A. Grohmann, Fiere e mercati nell’Europa occidentale, Milano 2011, pp. 159-164.
IL DECAMERON LETTO DAGLI STORICI DEL MEDIOEVO 189
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
no, tutte di vigne, d’ulivi, di mandorli, di ciriegi, di fichi e d’altre manie-re assai d’albori fruttiferi piene senza spanna perdersene»87.Più di una volta è ricorsa alle novelle anche una studiosa come
Gabriella Piccinni, particolarmente versata nell’uso di testimonianzedifferenziate dalle quali ricavare il massimo possibile di informazioni,e spesso riguardanti soprattutto le donne, secondo una sensibilità del-l’autrice che l’accompagna si può dire da sempre con un femminismomai propagandistico. Fra le molte novelle citate (abbastanza frequentiquelle del Sermini) compaiono anche quelle del Decameron, protagoni-sta principe monna Belcolore da Varlungo. La prima comparsa mi parerisalga al saggio Le donne nella mezzadria toscana delle origini, riedito nel200688, ma che risale al 1985, con un’altra parte del titolo poi soppres-sa, che parla in modo chiarissimo sulle intenzioni dell’autrice (Materialiper la definizione del ruolo femminile nelle campagne). Vengo subito ad unsecondo volume nel quale l’autrice ha utilizzato di nuovo anche lenovelle del Decameron, ma non solo quelle, questa volta intelligente-mente sbilanciandosi a favore della capacità del novelliere di descrive-re i corpi di donne e di uomini in viaggio (la Piccinni ha suddiviso ilvolume con un’altra autrice, specialista di storia della moneta89, e chia-ra ne risulta subito la realtà del pellegrinaggio ed il passaggio per Sienadi molti pellegrini, che lasciavano loro monete in deposito all’Ospedaledi Santa Maria della Scala, con lo scopo di riprenderle tornando daRoma). L’autrice descrive, con larghezza, i segni particolari, la corpo-ratura e il volto che il frate incaricato registrava per lasciare un segnosicuro dell’identità delle persone. Trascrivo senza commento quelloche può servirci in questa occasione e concludo con queste righe dellaPiccinni questo mio studio. «Mi pare interessante segnalare [...] chesiamo di fronte a tecniche descrittive che, nella loro laconicità, appaio-no tuttavia abbastanza consonanti con quelle largamente utilizzateanche da Giovanni Boccaccio e, in minor misura, da Franco Sacchetti[...]. Non voglio operare disinvolti e semplicistici accostamenti insisten-do su questi dati dispersissimi, e tuttavia devo constatare che GiovanniBoccaccio, fine letterato ma anche uomo che proveniva dal mondo della
GIOVANNI CHERUBINI
87 Decameron, VI, Conclusione, 21-23.88 A. Cortonesi - A. Piccinni, Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agra-
ria, protesta contadina, Roma 2006.89 G. Piccinni - G. Travaini, Il Libro del pellegrino (Siena 1382-1446). Affari, uomini,
monete nell’Ospedale di S. Maria della Scala, Napoli 2003.
190
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione
mercatura e viaggiatore, utilizzava lo stesso codice di ri conoscimento diun padrone di schiavi, di un capitano militare che pagava il soldo o mul-tava i suoi soldati o di un frate addetto ad accogliere i pellegrini e adamministrare i loro denari, e che tutti, all’interno di un approccio all’in-dividuo che alla fine del Medioevo si era fatto più diretto, attingevanoad un bagaglio culturale comune, chiamando a testimoni strumenti diriconoscimento sicuramente diffusi e popolari»90.
(Univ. di Firenze) GIOVANNI CHERUBINI
90 Piccinni, ibid., pp. 79-80.
IL DECAMERON LETTO DAGLI STORICI DEL MEDIOEVO 191
© ISIME - Tutti i diritti sono riservatiÈ vietata la riproduzione