Fonti e paesaggio urbano nella Crocifissione di S. Pietro dal medioevo al primo Rinascimento in La...
-
Upload
unitusdistu -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Fonti e paesaggio urbano nella Crocifissione di S. Pietro dal medioevo al primo Rinascimento in La...
ENRICO PARLATO
FONTI E PAESAGGIO URBANO NELLA CROCIFISSIONE DI S. PIETRO
DAL MEDIOEVO AL PRIMO RINASCIMENTO
La Crocifissione di S. Pietro modellata dal Filarete poco prima • 1445 per la porta bronzea della basilica vaticana (fig.1-2) è un esem1 di singolare importanza nella storia di tale iconografia in amb quattrocentesco, il rilievo costituisce infatti lo snodo e il collegame1 tra l'antiquaria medievale e quella della nascente età moderna. discussione di questa singola scena non potrà prescindere dalla po nel suo insieme: dall'articolazione di immagini che la decorano, da interessi del pontefice che ne promosse la realizzazione, Eugenio ( 14 31-4 7), né - più in generale - dalle più antiche rappresentazioni • martirio dell'apostolo, immagini che Filarete di certo tenne considerazione I .
1 La porta bronzea del Filarete fu completata alla fine del luglio 1445 e colloc nell'ingresso principale della basilica di S. Pietro il mese successivo. Stando a qua scrive Vasari, l'esecuzione dei rilievi richiese 12 anni, ponendo così l'ini dell'opera nel 1433. Tali indicazion i cronologiche sono oggi generalmente accett: anche perché, come emerge dal Trattato, Filarete era certamente a Roma all'ini degli anni '30 del Quattrocento. Tuttavia non mancano elementi di incertezza, particolare, la fuga e poi il lungo esilio fiorentino di Eugenio IV fanno riten probabile una interruzione dei lavori. Meno credibile mi sembra, al momer l'ipotesi secondo la quale la porta possa essere stata eseguita a Firenze e da spedita a Roma, come avvenne nel caso ben noto della tomba di Martino V (Roma Giovanni in Laterano). Per quanto le argomentazioni e silen.tio siano sempre deb tuttavia è strano che un'opera del genere, che avrebbe rivaleggiato per dimensioni , la Porta del Paradiso del Ghìberti, sia del tutto ignorata dalle fonti fiorent contemporanee, ed è anche difficile immaginare lo stile antichizzante del Filarete un contesto fiorentino. La porta del Filarete si ispira nell'impaginazione a qu• romane del Pantheon, del Tempio di Romolo Augustolo e della Curia. Quest'ulti1 ricollocata nella basilica lateranense, costituisce un esempio particolarme significativo. L'esecuzione ebbe inizio dalle comici a girali, con i profili dei Ces ma anche di personaggi contemporanei. Come è emerso nel corso dei restauri
LE STORIE DI PIETRO NELL'ORATOR10 DI GIOVANNI VII 523
gli interventi decorativi che comportano il rifacimento del mosaico dell'abside e dell'arredo marmoreo del coro della basilica vaticana e il restauro del mosaico della facciata 81. La calotta absidale era occupata da una Maiestas con il Cristo in trono affiancato da San Pietro e San Paolo mentre sul fasciane inferiore erano raffigurate schiere di agnelli che uscivano dalle città di Gerusalemme e Betlemme e convergevano verso un trono con la Croce e l'Agnello, ai lati del quale erano poste le immagini di Innocenzo III e dell'Ecclesia Romana con il chiaro intento di sottolineare i pieni poteri del papato82 (fig.11 ).
Nell'ambito del progetto di riaggiornamento della decorazione della basilica vaticana, il mosaico con le storie di Pietro dell'oratorio di Giovanni VII, può essere stato introdotto con un intento simile. Le tre scene con la Predicazione dell'Apostolo, come abbiamo visto, costituiscono un unicum nel panorama figurativo dedicato a Pietro. Esse ricordano l'origine petriana delle tre sedi apostoliche e sono, quindi, una esplicita riaffermazione del primato di Pietro e di conseguenza del pontefice, non solo in occidente, ma anche sulla chiesa orientale. Si tratta, quindi, di uno scenario che ben si adatta alla personalità e al pensiero politico di un papa come Innocenzo lil che più di altri sostenne il ruolo del pontefice come vicarius Christi e riaffermò la sua supremazia sui patriarcati di Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme83.
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo
sociale: l'organization intérieure des grandes demeures à la fin du Moy1m Age età la Renaissance, Atti del Convegno di Tour 1988, Paris, 1988, p. 11-24.
81 Gesta lnnocentii /JI, in Patrologia Latina, 214, CIV-CV; A. lACOB1N1, ad vocem Innocenzo li!, in Enciclopedia dell'Arte Medievale, VII, Roma, 1996, p. 386-392; A. IACOS!N!, li mosaico absidale di San Pietro in Vaticano, in Fragmento Picta. Affreschi e mosaici staccati del Medioevo romano, catalogo della mostra (Roma, Castel Sant'Angelo, 15 dicembre 1989-18 febbraio 1990), Roma, 1989, p. 119-130; F. GANDOLFO, op. cit., p. 131-134.
~2 Del mosaico abs idale, distrutto nel 1592 durante i lavori di ampliamento della basilica vaticana rimangono tre frammenti, oggi conservati al Museo di Roma, con il volto di Innocenzo III , il volto del! ' Ecclesia e la Fenice. A. IACOBINI, op. cit., p. 119-130.
83 J. SA YER, op. cit., p. 156, 199-206.
FONTI E PAESAGGIO URBANO 525
1962, solo in una fase successiva furono inseriti all'interno delle cornici i 4 episodi
storici relativi al pontificato di Eugenio IV. Nella sequenza esecutiva, le scene di martirio si collocano nella fase conclusiva dell'opera, in quanto su di esse si trova la data 1445. Da un punto di vista tecnico le grandi lastre figurate rappresentano !a parte più impegnativa della porta e si può supporre che esse furono messe in opera quando il cantiere era ormai rodato, forse iniziando da quelle disposte in alto e terminando, come si è detto, con quelle del registro inferiore. La presenza di aiuti è documentata
dal rilievo posto sul retro del battente sinistro, nel quale la danza festosa del Filarete seguito dai discepoli registra la fine dell' opera. Sono ricordati i nomi di Agniolus, lacobus, Janne!lus, Pasquinus e Varro. Pasquino è Pasquino da Montepulciano, mentre Varro è stato identificato in Beltrame di Angelo Belfradelli . Quest'ultima lastra, il cui significato è stato ricostruito dalla King, si collega ed è molto vicina alla produzione di placchette bronzee da parte del Filarete, opere che l'artista realizzò
durante il soggiorno romano. a margine dell'impresa della porta, ponendosi così tra i fondatori di questo genere.
G. GRIMALDI, Descrizione della Basilìca antica di S. Pietro in Vaticano. Codice Barberini lat. 2733, ed. a cura di. R. NIGGL, Roma, 1972, p. 386-390; H. voN TSCflUDI.
Fìlaretes Milarbeiter an der Bronzetùren von St. Peter, in Repertorium jùr Kunstwissenschaft, VII ( 1884), p. 291-294 W. voN OErnNGEN, Der BildhauerArchiteckt Antonio Averlino, gennant Filarete, Marburg. 1888; A. Muiloz - M. LAZZARONI, Filarete scultore e architetto del secolo XV, Roma, 1908; D. RF.DIG DE
CAMPOS, Restaurate in San Pietro le porte di Bronzo del Filarete, in L'Osservatore Romano, 28 aprile 1962, 3; A.M. ROMAN!Nl, Averlino, A., in D.B.l., IV, Roma, 1962, p. 662-667; U. M1DDELDORF, Filarete?, in Mitteilungen des Kunsthistorischen lnslitutes in Florenz, XVII (1973), p. 75-86 C. S6VMOUR JR., Some Rejleclions on Filarete 's Use of Antique Visual Sources, in Arte lombarda, XVlll ( 1973), 38-39, p. 36-47; J.
SPENCER, Filarete 's Doors al Saint Peter. A Cooperative Project with Complication of Chronology and Technique, in Col/aboration in ltalian Art, a cura di W. SHEARD, New Haven, 1978, p. 37-57; E. PARLATO, li gusto a/l'antica di Filarete scu//ore, in Da Pisane/lo alla nascita dei Musei Capitolini. L'Antico a Roma alla vigilia del Rinascimento, a cura di A. CAVALLARO - E. PARLATO, Roma. 1988, p. I 14-123; P. CANNATA, Le placchette del Filarete, in Studies in the His1ory of Art XXII, ltalian Plaquettes, Atti del simposio, Washington, 1-22 marzo 1985 (Washington, 1989), a cura di A. LuCHS, p. 35-53; C. KING, Filarete 's Portrait Signature on the Bronze Doors of St. Peter 's and the Dance of Bathykles and his Assistants, in Journal of the Warburg and Courtauld lnstitutes, LIII ( 1990), p. 296-299; R. COCK.E, Filarete al St. Peter, Fra Angelico in the Valican: Art and a Sense of "Decorum" in the Service of the Church, in Decorum in Renaissance Decoralive Art. Atti della conferenza annuale del!a Association of Art Historians (1991 ), a cura di F. AMES LEwis, London, 1992, p. 44-51; I. BuONi>.ZlA, le porte, in la basilica di S. Pietro, a cura di A. PINELLI, Modena,
526 E. PARLATO
Si dovrà innanzi tutto avere in mente l'antica collocazione d ante bronzee; erano incardinate all'ingresso principale della vecchi Pietro, prospettavano sul portico, disposte nello stesso luogo di gra risalto dove si trovava la porta argentea donata da Leone IV (847-8 È una relazione questa, che viene ribadita in maniera insistente e q1 tediosa negli scritti di Flavio Biondo e di Maffeo Vegio, wnanisti • come è noto, furono al servizio di Eugenio IV. Biondo, che di e pontefice fu il segretario, in un passo molto citato della R< instaurata (terminata nel 1446), sottolinea lo strettissimo legame tr preziosa porta argentea di Leone IV e quella voluta dal Condulme: superiorità materica di quella più antica è ampiamente compensE scrive Biondo - dalla più sofisticata esecuzione della modema2. Il te è ripreso a quasi un decennio di distanza da Maffeo Vegio che, 1455, ricorda come Eugenio restituì alla porta all'originario splend facendola fare in bronzo con grande spesa e mirabile arte3.
2000, III, p. 325-332; M. BELrRAMIN1, scheda sulla porta, ibidem. IV, p. 480-487 ulteriore bibliografia).
2 F. Biondo, Roma instaurata, ed. in R. VALENTINI, G. ZUCCHETTI C( topografico della città di Roma (d'ora in poi citato come Cod. top.), IV, Roma, I p. 247-323, in part. p. 274: (<Sola re una videris a Leone superatus: quod valva argenteas, tu aeneas basilicae dedisti, nìsì par videatur magnificentia pro arge nullo exquisitiori artificio factis, aeneas posuisse inauratas, tantisque inscu historiis unionis Graecorum, Armeniorum, Aethiopum, lacobinorum et ali< populorum tua opera tuaque impensa ecclesiae conciliatorum, ut quadruplo aurique impendium merces opificis superaverit».
3 M. Vegio, De rebus antiquis memorabilibus basìlicae S. Petrì Romae, e Cod. top., cìt., IV, p. 375-398, in part., p. 379: «donec Eugenius quartus qu pontifex omni virtute excellens, cum nihil umquam nisi magnum et glorie aggressus fuerit, ita hanc portam pristino decori restituit, ductas ex aere, m sumptu, miro artificio, expressis ibi magnis ac praestantibus rebus gestis suis quidem ex argento, ne forte aliquando, quemadmodum superioribus tempor nefanda praedonum cupiditate violaretur; cui et impressa sunt epigramma testimonium gestorum eius, quae nos edidimus huismodi: I Haec sunt Eu monimenta illustria quarti, I Excelsa haec animi sunt monimenta sui./ Item aliud Graeci, Armeni, Aethiopes, hic aspice, ut ludii, I Romanam amplexi sint A fidem». La quartina riportata dal Vegio è leggermente diversa da quella che si nelle porte, fatto che lascia aperte diverse letture alla frase «quae nos edid huismodi», passo che non sembra necessariamente indicare, in Vegio - come prc Huskinson - l'autore dell'iscrizione. J.M. HUSKINSON, The CrucifJXion of Saint Pe
FONTI E PAESAGGIO URBANO 527
Il riferimento a Leone IV, indicato in maniera così palese dalle fonti quattrocentesche, è di grande interesse. Innanzi tutto quel pontefice aveva fondato la città leonina ed è presentato dalla storiografia pontificia come il restauratore della Sede romana: lepisodio celebre dell 'incendio di Borgo, ricordato nel Liber pontificalis all'inizio del pontificato leonino, offre un exemplum e una chiave di lettura per l'intera biografia4. In secondo luogo, la porta del IX secolo e quella ancora più antica fatta realizzare da Onorio I (625-638) sembrano avere lasciato un segno sulla loro erede quattrocentesca. Di quella onoriana è nota la grande iscrizione metrica nella quale si ricordavano nell'ordine i Ss. Pietro e Paolo, la Vergine e Cristo, figure che ritroviamo nella porta del Filarete. Quella di Leone IV è invece descritta da Pietro Mallio al tempo di Alessandro III ( 1159-1181) e, in maniera forse più analitica, nel Liber pontificalis. In quest'ultimo se ne ricorda l'inaugurazione che ebbe luogo il 27 giugno 847, due giorni prima della festa dei Ss. Pietro e Paolo: la porta, in legno di cipresso, era completamente rivestita da risplendenti larrùne d'argento sulle quali erano rappresentati episodi di storia sacra. La descrizione termina affermando che così si riparò "in meliorem speciem" quella di Onorio J5. Dalla sola lettura delle fonti non è evidentemente possibile stabilire né l'entità, né la fedeltà del restauro, tuttavia il testo è inequivocabile nell'indicare un legame e una continuità tra le due. Non è forse un azzardo pensare che sulle lamine argentate della porta leonina fossero raffigurate le storie dei Ss. Pietro e Paolo, della Vergine e di Cristo.
Nell'atrio della vecchia San Pietro e, in particolare presso le cinque porte della basilica, si esponevano i trofei delle vittorie cristiane - tradizione ancora in voga nel Quattrocento - e, inoltre, il portale maggiore era una stazione importante nel complesso cerimoniale delle
Fifteenth Century Topographica/ Prob/em, in Journal o/ Warburg and Courtauld lnstitutes, XXXII (1969), p. 135-161, in part. p. 156-157.
4 LP, 11, p. 110-111. 5 P. Ma Ilio. De script io basi/icae vaticanae ... in Cod. top., cit., lii, Roma, 1946, p.
382-442, in part. p. 429-430: «Quarum media et maior vocatur porta argentea, quoniam optimo argento tota deargentata fuit et variis picturis a sancto Leone pp 1111 depicta».
LP, Il, p. 127 «Portas infonda quas destruxerat progenies argentoque Saracena nudarat erexit, mu ltisq ue argenteis tabulis lucìfluis salutiferisque h istoriis sculptis decoravit et meliorem speciem quam pridem fuerat reparavit>>.
528 E.PARLATO
incoronazioni imperiali, elemento trionfale che va di certo tem.: considerazione anche nell'esaminare l'iconografia delle ante brc filaretiane6.
Il contesto fisico nel quale la porta del Filarete sì trova· origine, era, come sì è detto, diverso dall'attuale. Il portico e 1 dell'antica basilica petriana sono scomparsi nel primo decennic Seicento per fare posto alla navata e alla facciata del Maderno. L'2 documentazione grafica raccolta nell'album di Giacomo Grir consente tuttavia di ricostruire con un buon margin approssimazione la situazione quattrocentesca.
In origine, i rilievi filaretiani dialogavano visivamente e grande ciclo apostolico, dove in almeno 16 episodi si narrava Storie dei Ss. Pietro e Paolo, ciclo che terminava con le stoi Silvestro e Costantino, sottendo così un confronto non solo tra Pie Silvestro, ma anche l'antitesi tra Nerone e Costantino?. Le scene, t: figuravano il Martirio degli apostoli e la Morte di Nerone, e campite sulle pareti del portico e quindi affiancavano e ' circondavano i battenti bronzei. Quando questi ultimi erano ape porta era in diretto rapporto visivo con il mosaico abs commissionato da Innocenzo Ili (1198-1216). Qui, nel rei superiore, i Ss. Pietro e Paolo acclamavano Cristo in trono, men quello inferiore la personificazione della Chiesa roman qontrapponeva alla figura del pontefice. Il significato politic
6 Per la funzione dell'atrio cf. BuoNAZIA, Le porte, cìt. Nel gennaio del 1 catene del porto turco di Setalia, strappate dal cardinale Oliviero Carafa, esposte presso la porta ravenniana.
1 GRIMALDJ, Descrizione, cii., p. 167-179; P. o'ACHIARDJ, Gli affreschi di S. J Grado presso Pisa e quelli già esistenti nella basilica vaticana, in Atti del Cor. Internazionale di Scienze Storiche (1903), VII, Roma, 1905, p. 193 es.; A. Mu~
pitture del portico della vecchia basilica vaticana e la /oro datazione, in Bollettino di Archeologia Cristiana, XIX (1913), p. 175-180; S. WAETZOLC
Kopien des 17. Jahrhunderts nach Mosaiken und Wandmalereien in Roma, MUnchen, 1964, p. 66-67, fig. 863, 872; I. HUECK, Der Maler der Apostelsze Atrium von Alt St. Peter, in Mitteilungen des Kunsthistorischen lnstitutes in F XIV (1969-70), p. 115-144, in part. p. 131-133; A. TOME!, Le immagini di p Paolo dal ciclo apostolico del portico vaticano, in Fragmenta Pie/a. Affr. mosaici staccati del Medioevo romano, a cura di, M. ANDALORO, A. GHID
IACOBINI, s. ROMANO, A. TOMEI, Roma, 1989, p. 141-146.
FONTI E PA ESAGGIO URBANO 529
ecclesiologico del mosaico è stato lucidamente indagato da Paravicini Bagliani8. In entrambi - nel mosaico e nella porta * si ritrova la figurazione del Cristo benedicente in trono e l'analoga disposizione dei santi protettori di Roma; nel catino absidale Pietro era disposto a sinistra di Cristo e Paolo a destra, quindi rispettivamente a destra e sinistra di chi li osservava dalla navata, capovolgendo l'ordine gerarchico. Nell'abside il posto d'onore alla destra di Cristo era infatti attribuito a S. Paolo, posizione che si riflette nella porta, dove S. Pietro è effigiato sull'anta destra e S. Paolo sulla sinistra.
Le diverse raffigurazioni della porta erano pertanto viste e 'lette' in una visione sinottica che raccordava e aggiornava 1' insieme delle memorie petrine, figurate e scritte. Le immagini che vi sono modellate, il Salvatore e la Vergine, i Ss. Pietro e Paolo con le rispettive scene di martirio, le comici a girali abitati e con i profili dei Cesari hanno da tempo attratto l'attenzione degli studiosi e vorrei qui ricordare almeno le indagini iconografiche di Helen Roeder e di Ursula Nilgen, le prime incentrate sull'iconografia profana, le seconde su quella sacra9. Per il
8 A. PARA v1c1N1 BAGL!ANJ, le Chiavi e la Tiara, Roma, 1998, in part. p. 31; ID., San Pìetro e /'ideologia del papato duecentesco, intervento presentato nel corso di questo stesso convegno. Per il mosaico absidale di S. Pietro vedi anche GRIMALDT,
Descrizione, cir., p. 195-198; A. IACOBTNI, Il mosaico absidale di San Pietro in Vaticano, in Fragmento Picta, cit., p. 119-124 (con bibliogafia).
9 Per una lettura dell'iconografia della porta nel contesto politico religioso vedi C.W. W ESTFALL, In this Most Perfect Paradise, University Park, 1974, trad. it., Roma, 1984, p. 55-68; M. BRAY, La ''sovranità" del pontefice. le figure di Filarete nella porta di S. Pietro (Roma 1433-1445), in Nouve/les de la République des Lettres (1987), 2, p. 7-28; L. STOcKHERT, Die Petrus- und Pau/usmartyrien auf Fi/aretes Bronzetiir von St. Peter in Rom: eine Vorform des Panoramas als kirchenpoJitische Aussage, Frankfurt am Main, 1997; M. KAUFHOLD, Papst Eugen IV. (1431 - 1447) zwischen Rom und Florenz: stèìdtische Konkul"renz und gemeinsame Traditìon, in Florenz - Rom: zwìschen KontinuiUit und Konkurrenz; Atti del colloquio interdisciplinare (I O- t 1 aprile 1997, Fire.nze, Kunsthistorisches lnstitut), a cura di H. KEAZOR, Milnster, 1998, p. 21-45. Per l'iconografia profana della porta cf. B. SAUER, Die Randreliefe an Fifaretes Bronzetiir von St. Peter, in Repertorìum far Kunstwissenschaft, XX (l 897), p. 1-21.; H. ROEDER, The Borders of Filarete 's Bronze Doors to St. Peter, in Journa/ of 1he Wt. ... burg and Courtauld lnstitutes, X (1947), p. 150-153; C. LORD, Some Ovidian Themes in Jtalìan Renaissance, Ph. D. Diss.,
Columbia Univ., 1977; lo., Solar lmagery in Filarete's Doors to St. Peter's, Rome, in Gaze//e des Beaux-Arts, Ser. VI, LXXXV Il ( 1976), p. 143-15 O; KlNG, Filarete 's
530 E.PARLATO
momento, mi limiterei a sottolineare che attraverso le due cc appena citate, Cristo-Maria, Pietro-Paolo, viene messo in scena straordinario condensato di una lunghissima tradizione romar binomio figurativo Cristo-Maria si lega, nella Roma del Medioe temi ecclesiologici le cui manifestazioni più eclatanti furor processione dell'Acheropita, i mosaici absidali di S. Mari Trastevere e di S. Maria Maggiore. Nella porta bronzea - come è sottolineato dalla Nilgen - la figura di Maria "gratia piena" è irnm• della sponsa Christi, quindi della Chiesa. Tale elem iconograficamente portante è concluso dalla presenza dei fondat patroni della Roma cristiana: Pietro e Paolo. L'immagine di Pietr non a caso - immediatamente sottostante a quella della Vergine-Ci e nella valva bronzea affida le chiavi al committente, Eugeni (1431-47), rappresentandolo così il pontefice regnante come suo d: erede e legittima guida della Chiesa 10.
Accanto alle immagini sacre, quattro episodi storici che fu inseriti in una fase avanzata di esecuzione della porta suggellano i grande successo del tormentato pontificato Condulmer: I' effi: unione tra i cristiani d' oriente e d'occidente che fu subito utilizzat affermare l'egemonia papale nell'orbe cristiano, sia in ambito spiri a contrappeso delle spinte conciliari, sia in quello temporale; conferire autorevolezza al papato. L'iscrizione incisa sui battei sotto questo punto di vista, del tutto inequivocabile: "Ut Gr Armeni Aethiopes hic aspice ut ipsa romanam amplexa est
Porlrair, cit.; J. BLANSDORF, Petrus Berchorius und das Bi/dprogramn Bronzetiiren von St. Peter in Rom, in Die Rezeption der Metamorphosen des O der Neuzeit, a cura di H. WALTER. HJ. HORN, Berlin, 1995, p. 12-35; c. CIERI, L< del Sole. Fonti e modelli per un 'iconografia mitologica, in Le due Rom Quattrocento. Melozzo, Antoniazzo e la cultura artistica del Qualtrocento romc cura di S. Rossi e S. V ALERJ , Roma, 1997, p. 245-253. L'iconografia sacra t studiata da U. N!LGEN, Fi/aretes Bronzetiir von St.Peter. Zur lnterpretazion vo. und Rahmen, in Actas des XX/Il Congreso Internaciona/ de Historia del Granada, 1973 (1978), 3, p. 569-585; ID., Filare/es Bronzetiir von St. Peter in Ein p<ipstliches Bildprogramm des 15. Jahrhunderts, in Kirchen am Lebensw Jahrbuch des Vereinsjùr christliche Kunst in MUnchen, XVII (1988}, p. 351-357.
10 Naturalmente questa posizione discorda con quella del mosaico innocen dove, come è stato proposto da Paravicini Bagliani, il pontefice era rappres come vicarius Christi, facendo discendere la propria autorità direttamente da ql non attraverso la mediazione di S. Pietro.
FONTI E PAESAGGIO URBANO 531
iacobina fidem I Sunt haec Eugenii monimenta illustria quartii excelsii haec animi sunt monimenta sui"l 1.
Si può infine aggiungere che le immagini - così come sono orchestrate - sembrano indirizzare e visualizzare il percorso finale dei pellegrini giunti ad limina apostolorum, una attenzione che, come è stato osservato, scaturisce anche dal ruolo ora riservato alla basilica petriana, segnalando la centralità della sepoltura di S. Pietro, centralità che proprio a partire dalla metà del Quattrocento si manifestò in maniera non equivocabile, sia in imprese artistiche e architettoniche, sia nei diversi equilibri assunti dagli spazi urbani e nella topografia di Roma.
Nella Crocifissione di S. Pietro, l' immagine doppiamente petriana, per luogo e per soggetto , si connota per acribia topografica nell'ambientazione del martirio, per ricostruzione in dettaglio della antica Roma e perché offre una veduta e una rappresentazione della città. Dunque individuare e descrivere il luogo della crocifissione, ambientarlo attraverso la nascente scienza antiquaria, offrire un legame palpabile e concreto tra passato e presente. Attraverso questi tre livelli, così fortemente connessi e quasi sovrapponibili vorrei sviluppare la relazione odierna.
È noto che le notizie su s. Pietro a Roma - e quindi anche sul suo martirio - sono tramandate solo in maniera fuggevole dai testi canonici e che gli apocrifi, gli Acta Petri, risalenti alla fine del Il, la passio dello Pseudo Lino e la Passio apostolorum Petri et Pauli dello Pseudo Marcello, costituiscono il resoconto più dettagliato sulle vicende dell'apostolo a Roma12 . A questi scritti dobbiamo la memoria dei luoghi che furono teatro della persecuzione dell'apostolo e della sua crocifissione "capite deorsum". Tale evento e la sua popolarissima rappresentazione sottendono il capovolgimento di valori consustanziale al pensiero cristiano, un significato che espresso con grande chiarezza nel discorso che, nel testo apocrifo, Pietro pronunzia sulla croce 13.
1 l Vedi sopra n.3. 12 Acta Petri, acta Pauli, acta Petri et Pauli, a cura dì, R. L. LIPSIUS, Leipzig,
1891 , ed.cit Hildesheim, 1959. 13 lbi, p. 17.
532 E. PARLATO
È altrettanto noto che i primi cicli apostolici (e comprendevano la scena del martirio) furono realizzati in data piu alta nella basilica di S. Paolo f.1.m. e in quella di S. Pietro, dove ft poi replicati nel così detto transetto settentrionale. Quest'ultimo e stato distrutto senza essere docwnentato, tuttavia esso fu replicat volte. Gli affreschi di S. Pietro a Tuscania sono una delle ripres significative nell'età della Rifonna gregoriana 14. Per quanto rigua1 scena del martirio, si può aff ennare con buon margine approssima che l'iconografia non fosse molto diversa da quella degli affreschi Andrea in Catabarbara: qui la scena era dominata dalla croce cape di Pietro, affiancata da due soldati romani, i ss. Processo e Martir e da altre figure che assistono al martirio, l'ambientazione è del convenzionale e priva di qualsiasi riferimento alla topograf Roma15.
Nelle rappresentazioni finora considerate ci si attiene all'eler: più cospicuo indicato dalle fonti, la crocifissione capovolta, la pre: dei soldati romani e degli astanti che ascoltano I 'ultimo discor Pietro. Non vi è alcun tentativo di ambientare in modo preciso l'ai anche se le fonti scritte, a partire dal pseudo Lino, la collocavano i area circoscritta della città: «Ad locum qui vocatur Naumachiae, obeliscum Neronis, in montem. Illic enin crux posita erat»l6. indicazioni topografiche, che poi in ambito romano finirann1 diventare l'aspetto saliente della Crocifissione di S. Pietro, i: momento latitano. La loro entrata in scena risale ad un mon
14 Su questo tema H.L. KESSLER, "Caput et speculum omnium ecclesiarum St. Peter's and Chwch Decoration in Medieval Latium, in ltalian Church Deco of the Midd/e Ages and Ear/y Renaissance: Functions, Forms, and Rei Traditions, Atti del colloquio, Firenze, Villa Spelman, a cura di W. TI Baltimore, 1989, p. 119-146; lo., L'antica basi/;ca di San Pietro come ft ispirazione per la decorazione delle chiese medievali, in Fragme.nta picla, cit., llO.
15 Per una trattazione d' insieme dell' iconografia di S. Pietro cf. C.K. A.spects ofthe lconography o/ Saint Peter in Medieval Art of Western Europe, D1ss., Case Western Reserve Univ., 1978 e, in questo stesso convegno, agli intt di P. Poo1.1AN1, Le storie di Pietro nell 'Oratorio di Giovanni VII nella Be vaticana e di M. V!SCONTJNI, La figura di Pietro negli Atti degli Apostoli. Ui particolare: la cappella Palatina a Palermo.
16Acta Petri, cit., p. 11-12.
FONTl E PA ESAGGIO URBANO 533
preciso e circoscritto, al pontificato di Niccolò III Orsini ( 1277-80) sotto la cui egida furono realizzati gli affreschi della cappella del Sancta Sanctorum al Laterano e, con grande probabilità, i dipinti del portico di S. Pietro (citati in apertura) e quelli del transetto destro della basilica superiore di S. Francesco ad Assisi 17· Non possiamo qui approfondire questa, feconda, ossessione romana di Niccolò 11118,
avendo in mente che al suo pontificato risale la prima veduta di Roma, nell S. Marco - Ytalia di Assisi (fig.3)19. In queste immagini si fissa la dimensione romana del Martirio di S. Pietro, ripresa e ribadita qualche decennio dopo nel Polittico Stefaneschi (1315 ca., fig.4 ), che sanziona, per committenza e collocazione, lo status ormai del tutto ufficiale che a
17 J. GARDNER, Nicholas l/l's Oratory of the Sancta Sanctorum and its Decoration, in The Bur/ington Magazine, CXV (1973), 842, p. 283-294; J.T. WOLLESEN, Die Fresken in Sancta Sanctorum. Studien zur romischen Ma/erei zur Zeit Papst Nikolaus /li (1177-1280), in Rl>misches Jahrbuch fiir Kunstgeschichte, XIX (1981 ), p. 35-83; L. BELLOSI, La decorazione della b.1silica superiore di Assisi e la pittura romana di
fine Duecento, in Roma Anno 1300, Roma, 1983, p. 127-139; S. ROMANO, Il Sancta Sanctorum: gli affreschi, in Sancta Sanctorum, Milano, 1995, p. 38-125; I. HERKLOTZ,
Die Fresken von Sancta Sanctorum nach der Restaurierung: Oberlegungen zum Ursprung der Trecento Malerei, in Pratum Romanum, a cura di L. COLEI.LA, Roma, 1997, p. 149-180.
Per gli affreschi del transetto nord della basilica superiore di Assisi si rimanda alla recente monografia di L. BELLOSI, Cimabue, Milano, 1998, con amplia bibliografia. Bellosi, p. 88-90, attribuisce a Torriti il ciclo apostolico del transetto assisiate e ne propone una datazione posteriore di div~rsi anni rispetto al pontificato di Niccolò Ili e al ciclo del Sancta Sanctorum.
18 Su questo tema rimando al saggio di S. ROMANO, Cimabue e il ritratto di città, in la basilica di S. Francesco ad Assisi. Artisti, bolleghe, strategie narrative, in corso di pubblicazione. Ringrazio l'autrice per avere generosamente messo a mia disposizione il testo dattiloscritto.
l9 J. STRl.YGOWSKt, Cimabue und Rom, Wien, 1888, p. 84-130; E. BATTISTI,
Cimabue, Milano, 1963, p. 39-43; M. ANDALORO, Ancora una volta sull'Ytalia di Cimabue, in Arte Medievale, Il (1984), p. 143-181, con bibliografia precedente e con la messa a fuoco definitiva delle questioni topografiche inerenti la veduta di Roma. Interessa qui sottolineare che Anda!oro identifica la piramide che si intravede dietro Castel Sant' Angelo nella Meta Romuli , cf. p. 144,160.
La presenza di Roma, ne! S. Marco - Yta/ia, discende dalle testimonianze su S. Marco di Eusebio e di Girolamo. Quest'ultimo nel De viris illustribus (VIII, I) scrive: «Marcus discipulus et interpres Petri, iuxta quod Petrum referentem audierat rogatus Romae (il corsivo è mio) a fratribus breve scripsit Evangelium».
534 E.PARLATO
Roma si attribuisce a tale variante iconografica. V ari ante della abbiamo un solo documentato caso di esportazione fuori dai te romani: i dipinti di S. Piero a Grado a Pisa> datati 1300, che ripre1 quelli del portico di S. Pietro20. A controprova della spi congiuntura romana di fine Duecento, vanno citati gli affreschi • storie apostoliche della cappella Minutolo nel Duomo di Napoli, che per cronologia segue di un paio di decenni il pontificato C dove però nel Martìrio di s. Pietro i riferimenti topografici so1 tutto ignorati21. Considerando la formazione e il percorso e de autore, Montano d'Arezzo che di certo conosceva la basilica sup ad Assisi e la pittura romana della fine del Duecento, non abbi; che fare con una semplice omissione; si tratta piuttosto del rifi una variante iconografica della quale a Napoli non si stent riconoscere il carattere troppo romano ed una ostentazione di luc cui significato travalicava la storia sacra assumendo una connou di sapore quasi politico.
A Roma la Crocifissione di S. Pietro, nella sua versione duecentesca, ingloba così la rappresentazione di alcuni monumer fissano il luogo e la memoria del martirio dell'apostolo nelli: antica: la Meta Ramuli, il Terebinto e il mausoleo di Adriano. L inclusione e la loro importanza nella storia sacra non è certo ur estemporaneo, ma si congiunge ed integra la tradizione testuale apocrifi e dei Mirabilia. Dai primi, arricchiti da brani espunti da 1
20 In questo stesso convegno l'intervento di N . BER10u, Sainl Pierre, spécial de Pise au Xlii siècle par la volonté de l 'archèveque Federico Viscon; numerosi spunti di approfondimento per comprendere il significato del cult Pietro a Pisa.
Sugli affreschi di S. Piero a Grado vedi sopra n.7; J. T. WoLI.ESEN, Dfe Fresi San Piero a Grado bei Pisa, Bad Oeynhausen, 1977.
21 E. BOREA, I ritrovati affreschi medievali della cappella Minuto/o ne.I du Napoli, in Bollettino d'arte, XXXXVIJ (1962), p. 11-22; F. BOLOONA, I pitto. corle angioina di Napoli, Roma, 1969' p. 88-90; P.L. LEONE DE CASTRJS, Arte ' nella Napoli Angioina, Firenze, 1986, p. 198-199. Come è noto, la datazion affreschi di Montano d'Arezzo al 1285-90, proposta da Bologna, deve essere alla cronologia delle fasi architettoniche del duomo di Napoli, la cui costruz verosimilmente iniziata nel 1294. C.A. BRUZELIUS, The Churches of the Angevii of Naples, 1266 - 1343, in Center for Advanced Study in the VisuaJ Arts Bd . IX 1989), p. 45-46.
FONTI E PAESAGGIO URBANO 535
Girolamo e dal Liber Pontifìcalis, emergono i riferimenti all ' obelisco vaticano, alla naumachia, al terebinto, quest'ultimo citato per la prima volta dallo pseudo-Marcello in riferimento alla sepoltura di Pietro22; nei secondi invece, si cerca di collocare questi nomi nella realtà della Roma medievale23. A questo punto ha luogo la 'migrazione' di terebinto e naumachia verso est, dalla zona prossima al fianco meridionale della basilica essi vengono ricollocati - stando a quando si legge nei Mirabilia - in prossimità del mausoleo di Adriano, nel lembo orientale di Borgo. Il toponimo naumachia viene ora riferito alla chiesa di S. Pellegrino che sorge a notevole distanza dal circo di Nerone e circoscrive la fascia a nord della porticus s. Petri; il terebinto, l'arbusto che per lo pseudo Marcello segnalava la sepoltura dell'apostolo, viene adesso collocato in prossimità di S. Maria in Traspontina, chiesa che nel Medioevo era molto vicina al ponte e al castello; l'albero, da vegetale che era, è diventato una torre lapidea, che per altezza rivaleggia con la mole Adriana, un cambiamento di natura che sembra indicato anche dalla trasformazione del nome in tiburtinus Neronis, associandolo così non alla figura di Pietro, bensl a quella del suo carnefice e ali' obelisco che ne portava il nome.
Il fenomeno è stato studiato con grande finezza da Msg. Duchesne24, si può solo aggiungere che tale spostamento si adeguò alla
22 Acta Petri, cit., p. 173. «Sub therebìntum iuxta Naumachiam in locum qui
appellatur Vaticanus». 23 C. FRUGONI, l'antichità dai «Mirabilia» alla propaganda politica, in Memoria
dell'antico nell'arte italiana, a cura di S. SEITIS, I, Torino, 1984, p. 3-72, in part. p. 71-72; M. ACCAME LANZILLOTTA, Contributi sui Mirabilia urbis Romae, Genova, 1996; C. NARDELl-A, li fascino di Roma nel Medioevo, Roma, 1997; A. BARTOLOME! - U. V1GNVW, S. Pielro e il san/orale romano nella letteratura volgare romanesca sino al 1450, relazione presentata nel corso di questo stesso convegno.
24 L. DOCHESNE, Vaticana. Notes sur la topographie de Rome au Moyen Àge, in
Mélanges de l'écolefrançaise de Rome, XXII (1902), p. 3-22; Naumachie, Obélisque, Térébinthe, in Atti della Pontificia Accademia romana di archeologia. Dissertazioni, 1903, p. 137-148; entrambi rist. in lo., Scripta minora. Études de topographie romaine et de géographie ecclésiastique, Roma, 1973, p. 181 -200; 315-328: M. GUARDUCCI, la tradizione di Pietro in Vaticano, Roma, 1963; F. CASTAGNOLI, //
Vaticano nell'antichità classica, Roma, 1992 (dove alle p. 26-27 si dissente da quanto afferma Duchesne); L. BIANCHI, Ad limina Petri. Spazio e memoria nella Roma cristiana, Roma, 1999, p. 7-30, 45-53 (con bibliografia).
536 E. PARLATO
forma della città medievale (condizionata dalla presenza di ur ponte a collegare Roma e Borgo), e seguì i percorsi cerimon liturgici che si arricchirono così di stazioni cariche di memoria: il Politicus ricorda che nelle incoronazioni imperiali l'eletto incontr clero presso il terebinto e da lì si avviava in corteo a S. Pietro~ scenario urbano nel quale i Mirabilia ambientano la crocifissione Pietro non è più ancorato alla basilica petriana e alle sue imm< propaggini, ma è dominato dalla mole incombente del mausol Adriano e da quella minore, ma cospicua della Meta Romuli, che fama di essere il sepolcro del primo re di Roma. Accanto ques1 monumenti, molto ben documentati, i testi citano in modo sisten l'evanescente terebinto.
Durante il pontificato di Niccolò III si operò una scelta delibe forte: innestare nella tradizione figurativa altomedievale le r antiquarie maturate alla metà del XII secolo. Le immagini duecent messe a punto durante il breve regno di Niccolò Ili hanno codific Crocifissione di S. Pietro "inter duas metas", in un nuovo coi urbano, e hanno dato corso ad una lunga e fortunata tradì iconografica. A partire dallo Strzygowski per arrivare ad Huskins ricostruzione della topografia del Martirio è stata dibattuta in m< ampia ed articolata, si può tuttavia cercare di mettere a fuoco al l'identificazione dei monumenti chiave che vi compaiono26. La Adriana così come appare nell' Ytalia di Cimabue (fig.3) - il r€ quadrato, il cilindro merlato sul quale svetta la torre quadrangol<: una rappresentazione documentata e coerente, che regge allo scr di successivi confronti. Per quanto riguarda la Meta Romuli, e demolita nel 1499, non vi sono dubbi né sulla sua posizione, a distanza da Castel Sant' Angelo in direzione di S. Pietro, né sul che fosse una piramide tronca, le immagini quattrocentesche e ritraggono sono quasi del tutto univoche. Questa partic conformazione del Meta è attestata all'inizio del Quattrocento Processione di S. Gregorio Magno, affrescata da Spinello Aretine
25 Die dominico summo mane descendit electus cum coniuge sua ad s. r Transpadinam, que est iuxta Terebinthum. Cit. da DUCHESNE, Vaticana, cit. (190).
26 J. STRZYGOWSKI, Cimabue, cit., p. 76-83; HUSKINSON, The Crucifixion, DEMUS QUATEMBER, Et est alia pyramis, Roma - Wien, 1974; cf recensione HuSKINSON, in Art Bulfelin, L Vlll (1976), p. 618-621.
FONTI E PAESAGGIO URBANO 537
cappella Guasconi a S. Francesco ad Arezzo (fig.5)27. Diverso e più complicato il discorso sul Terebinto. Nei Mirabilia è descritto come un edificio circolare di grande altezza; si trovava in prossimità di S. Maria in Traspontina tra la Meta Romuli e Castel Sant' Angelo, si aggiunge infine che il rivestimento lapideo che lo ricopriva era stato adoperato per costruire la scalinata e lastricare il Paradiso della basilica petriana, spoglio che, del resto aveva subito la stessa Meta Romuli. Le moderne indagini archeologiche confermano almeno in parte quanto riportano le fonti: a pochissima distanza dalla Meta Romuli, ma in direzione nordovest, quindi lungo il tracciato della via Trionfale, è stata individuata la base circolare di un monwnento funebre romano che va identificato nel terebinto medievale28. È chiaro tuttavia che l'altezza che gli attribuiscono i Mirabilia - «tantae altitudinis quantum Castellum <H>adriani» - è un'iperbole e nasce, forse, dalla necessità di ricostruire e integrare con le parole ciò che con non era più possibile vedere. La lettura delle fonti offre qualche indizio in questa direzione. È vero che Benedetto Canonico nell'Ordo ricorda in sequenza il tempio di Adriano, "l 'obeliscum Neronis" e la memoria Romuli e quindi attesta la presenza di due piramidi. Tuttavia l'Ordo è ancorato ontologicamente alla tradizione e quindi 'trascina' notizie e informazioni accumulatesi nel passato. Lo stesso Benedetto Canonico nei Mirabilia, quindi in un testo di natura diversa, ricorda così i due monumenti: «In Naumachia est sepulchrum Romuli ( ... ) Circa se habuit tiburtinum Neronis». Si enumerano i due monumenti, ma, come era stato già osservato da Strzygowsky, per la Meta Romuli si adopera il presente est, mentre per il terebinto il perfetto habuit: Tale alternanza di tempi si ripete nei Miracole «L'Naumachia ène lo sepolcro de Romulo ( ... ) Ad lato ad
27 B.M. PEEBLES, La Meta Romuli e una lettera di Michele Ferno, in Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, Xli (1936), p. 21-63; G. GArn. Fasti archaeologìci, IV (1949), n.3771, p. 360; E. NASH, Pictorial Dictìonary of Ancient Rome, Il, New York, 1962, p. 59-60 CASTAGNOU, op. cìt., p. 28, 83.
Peebles dà il quadro più esauriente sulle vicende della Meta Romuli nel Medioevo insieme ad un utilissimo repertorio iconografico. Ricorda che questa denominazione risale al I 053 e che nel 1413 era anche chiamata "meta Sancti Petri".
28 GATTI, ibidem; F. Totorn Dov'era il Terebinto del Vaticano?, in Mélanges de l'écolefrançaise de Rome, LXXXXI (1979), p. 491 es.; CASTAGNOLt, op. cii., p. 20-2 1, 27.
538 E. PARLATO
essa fo lo Terrebinto de Nero»29. Al momento questo è solo un i1 che andrebbe verificato, vagliando in maniera sistematica l 'u! tempi all'interno del testo in esame, ma sembra molto probabile e al tempo dì Benedetto Canonico ai piedi di Castel Sant' A sorgesse una sola piramide.
Mi pare che, a questo punto, i dipinti possano offrire ult spunti per tentare di dirimere una questione certamente intricata.
Nel Martirio di S. Pietro del Sancta Sanctorum, la se inquadrata dalla Meta Romuli, a sinistra, e da Castel Sant' An! destra (fig.6)30. La prima è la piramide tronca dalle propo1 svettanti. Michele da Ferno, che la descrive alla vigilia dell distruzione, la ricorda più alta che larga con un'ampia camera fun che si apriva al suo interno31. Un margine di incertezza pot scaturire dalle comici marcapiano che scandiscono l'edificio effetti, evocano i gocciolatoi marmorei - «labia cooperta tE lapideis pro stillicidis» - che, secondo i Mirabilia, caratterizz~ l'edificio. Tale difficoltà potrebbe essere superata ricordando, in tutto, che nella medesima fonte si legge che i marmi della Meta R e del Terebinto erano stati asportati e supponendo, come se probabile, che la Meta Romuli fosse una struttura a gradoni, fatt ne spiegherebbe anche il profilo tronco32.
Neppure sull' identificazione del monumento di destra po sussistere dubbi: il bugnato isodomo dell'ordine inferiore, la mu cilindrica e la torre quadrata che sorge al centro restituisco fattezze del mausoleo ormai trasformato in fortezza, è una ve1 semplificata, soprattutto dal punto di vista spaziale, ma cht contrasta con le vedute del sepolcro di Adriano, a partire da que Cimabue (fig.3). La presenza del castello nel Martirio di S. Pietr solo è una palese contraddizione storica, ma soprattutto è del inconsueta in tale iconografia, come risulta dal confronto degl esempi vicini nel tempo e nello spazio. Nel contesto del S
29 Cod. top., cit., lii, p. 45, p. 117. 30 L'identificazione dell'edificio sulla destra in Castel Sant'Angelo si de·
GRlSAR, Die rom/sche Kapelle Sancta Sanctorum und ihr Schatz, Freiburg, \ • 37, ed è1Jniversalmente accettata.
31 B.M. PEEBLES, La Meta, cii., p. 39-40. 32 Cod. top., cit., ITI, p. 45.
FONTI E PAESAGGIO URBANO 539
Sanctorum, il controllo degli Orsini sulla fortezza e le opere che Niccolò III vi fece realizzare sono di per sé ragioni sufficienti a giustificarne la presenza e una simile scelta iconografica. Si è comunque colpiti dal tentativo di restituire un'immagine della zona, dove, secondo i Mirabilia, era avvenuta la crocifissione di Pietro, rispettosa delle effettive emergenze monumentali, attenta a suggerire una schematica, ma conforme ambientazione paesistica di Roma ai tempi Pietro (forse non è casuale l'assenza degli stemmi Orsini su Castel Sant' Angelo )33. Va infine osservato che nella base della Meta Ramuli si apre una porta cui viene data grande evidenza creando, al tempo stesso, uno stretto legame visivo con la figura di S. Pietro sulla croce; è un dettaglio reale - lo descrive lo stesso Magister Gregorius -che non solo ricorda ed evidenzia il carattere funerario del monumento, ma sembra anche indicare che proprio li sarebbe stato sepolto l'apostolo, costruendo attraverso le immagini quel parallelismo tra Romolo e Pietro34.
Almeno da un punto di vista iconografico, le due versioni del Martirio di S. Pietro - Roma, portico di S. Pietro, Assisi, basilica di S. Francesco (figg.7, 8) - sono tra loro strettamente connesse: in entrambe la crocifissione è ambientata "inter duas metas" in maniera meno equivoca di quanto apparisse nell' esempio del Sancta Sanctorum, in entrambe l 'edificio disposto sul lato sinistro della scena è una vera piramide rivestita da una cortina lapidea, mentre quello che appare nel settore opposto è identificabile nella Meta Romuli. li profilo tronco individua la peculiare fisionomia del monumento funebre romano, l' alberello che cresce alla sommità conferisce loro, per metonimia, il nome di terebinto.
Tale assimilazione è molto importante. Il terebinto che nella passio di S. Pietro gioca un ruolo fondamentale, nelle immagini si appropria delle fattezze dell'unica piramide superstite, della Meta Ramuli, il confronto tra la scena del Sancta Sanctorum e quelle di Roma e Assisi mi sembra, sotto questo aspetto, molto significativa. Ricordo che nelle fonti il terebinto è descritto come una struttura circolare, simile ad un
33 BEt..LOSI, Cimabue, cit., p. 89, sottolinea la riconoscibilità di tale rappresentazione «simile all' aspetto con cui Castel Sant' Angelo si mostrava>>.
34 Magister Gregorius, in Cod top., cit. , III, p. 164. La presenza di tale particolare è attestata, come si è detto, anche da Michele da Ferno, PEEBLES, la Meta, cit., ibidem.
540 E.PARLATO
castello, molto diversa dalla costruzione a base quadrata, rivestita regolare bugnato liscio che ricorre nelle scene del portico petrian Assisi. Quest'ultima ricorda la più grande piramide che fu mai sul suolo di Roma, forse in questo modo la tomba di Caio Cestio a fare parte dell'iconografia del Martirio di S. Pietro35. Naturalm€ sua posizione molto lontana da San Pietro e da Borgo costi l'ostacolo più arduo. Un'altra difficoltà è posta dagli affreschi pis notissimo ciclo apostolico di S. Piero a Grado (fig.9). Qui rie1 l'obelisco neroniano, che in seguito alla 'migrazione' della naun era quasi caduto in oblio ed era sempre più di rado conness vicende petriane. I due leoni disposti presso la base, la sfera 1
sormonta, dove, stando alla leggenda, erano raccolte le cen Cesare, lo individuano in modo certo e quasi ripropongono quel circuito tra storia e monumento che scaturisce dall'impianto nar dei Mirabilia. La sostituzione del terebinto-Meta Romuli ' terebinto-obelisco di Nerone è indizio di incertezza nell'identifi diversi monumenti e risponde ad una logica: il terebinto, com detto, era anche il tiburtinus Neronis, quindi di pietra, torna in e caso ad essere l'obelisco, originario riferimento per indie• sepoltura dell 'apostolo. Tuttavia la presenza della guglia vaticanl; affreschi pisani potrebbe forse riferirsi ad un episodio leggend~ cui dà conto un'iscrizione apocrifa segnalata da Castagnoli. L'ob romano - stando all'epigrafe - sarebbe crollato e poi di nuovo inn da "Buzeto", cioè da Buscheto, architetto del duomo di Pisa36.
Il paliotto della Vergine di Anagni (ante 1298, fig.10) rifle1 iconografia e stile - come scrive Bertelli - le decorazioni monurr delle basiliche romane. Solo nel Martirio di S. Pietro si riscont
35 A N 1CHOLSON, Cimabue. A Critica} Study, Princeton, 1932, p. 17, ha sug1 ricorso alla piramide Cestia per supplire alla seconda meta. Al contrario Snu.v Cimabue, cii. , p. 80 seguito da PEE.BLES, La Meta, cit., p. 53-54, da M. Bo! Cimabue e i precursori dì Giotto, Firenze, 1976, n.39, riconosce nel Martir Pietro del transetto assisiate la Meta Romuli, nell'edificio piramidale dis sinistra e il Terebinto in quello visibile a destra.
36 M. SQUARCIAPl'NO, L'obelisco di S. Pietro e una pittura dì S. Pietro in Gi Studi romani, X (1967), p. 166-170; HuSKINSON, The Crucifixion, cii., WOLLESEN, Die Fresken, cit., p. 60-72; lo studioso (p. 68) identifica l'obe quello che un tempo sorgeva sul Campidoglio; CASTAONOLI, op. cit., p. 43, I bibliografia).
FONTI E PAESAGGIO URBANO 541
non perfetta aderenza con gli affreschi del portico vaticano e con quelli assisiati. La crocifissione a testa in giù è ambientata tra una struttura aguzza e piramidale (a destra) da identificarsi verosimilmente nella Meta Romuli. Più complicata la questione del ciborio con la 'torre' sul fianco che si intravede sul lato sinistro della scena. Per Bertelli potrebbe trattarsi del palazzo vaticano. Se però la 'torre' fosse l 'obelisco, il ciborio potrebbe essere identificato nella tomba di Pietro, vicina alla guglia vaticana37. È interessante osservare che nel paliotto di Anagni si rappresenta wia sola piramide, forse restituendo l'effettiva situazione topografica della Roma tardo-duecentesca, così nell'affresco pisano solo la guglia vaticana sembra avere un concreto riscontro, sottolineando che la simmetria tra le due piramidi o le due moli non era così facilmente riconoscibile.
Alla fortunata sequela iconografica della Crocifissione "inter duas metas", appartiene non solo il polittico Stefaneschi (fig.4), ma anche la predella del polittico di Pisa di Masaccio (1426) e la scena filaretiana (fig.2) da cui si è partiti. In quest'ultimo caso la presenza delle due piramidi, a sinistra la Meta Remi (o Cestia) a destra la Meta Romuli, si attiene a quella tradizione di cui si sono visti gli esordi38. L'impianto generale del rilievo non solo offre, per i chiari riferimenti topografici e monumentali, quella ambientazione puntuale e archeologica ormai radicata nella tradizione figurativa romana, mal 'immagine del Martirio è dilatata e si trasforma in una veduta di Roma nella ricostruzione della città al tempo dì Nerone e di Pietro. Per fare questa operazione, Filarete contrae un debito con Masolìno da Panìcale, con il ciclo degli Uomini
37 L. MORTARJ, //tesoro della caltedrale di Anagni, Roma, 1963; C. BERTEL.1.1 , Opus romanum, in Kunsthistorische Forschungen Otto Pachi zu seinem 70. Geburtstag, a cura di A. ROSENAUER - G. WEBER, Salzburg, 1973, p. 99-117, in part. p. 104-108; A.
ToMEt, Jacobus Torriti Plctor. Una vicenda figurativa del tardo Duecento romano, Roma, 1990, p. 150 n.59, seguito da BELL.OSr, Cimabue, cit., p. 90, 224, ritengono che l'autore del cartone per il paliotto vada individuato in un maestro romano «della stretta cerchia del Torriti». Da un punto di vista iconografico è interessante osservare la posizione attribuita ai Ss. Pietro e Paolo all'intemo del paliotto. Come nel caso del mosaico absidale di S. Pietro (e poi nella porta bronz.ea) a S. Paolo viene dato il posto d'onore, a destra della Vergine.
38 La presenza della piramide Cestia nella lastra filaretiana è negata da PEEBLES,
La Meta, cit., p. 55-56, e da Demus~ Quatember, Et est, cii. Contra HUSKINSON, in Art Bulletin, LVIII (1976), p. 618-621.
542 E. PARLATO
famosi dipinto nel 1432 nel palazzo del cardinale Giordano Or ciclo che ebbe breve vita - andò distrutto nel 1485 - ma che fu m ammirato e copiato. La nota trascrizione miniata di Leonardc Besozzo consente ancora oggi di verificare l'indubitabile, dipendi dal modello messo a punto dal pittore toscano che fu un gn specialista di paesaggi urbani (fig.11 )39. La posizione del Ca; Marzio - individuato nel rilievo dalla dea Roma che regge il simul di Marte e dalla panoplia d'armi distesa ai suoi piedi - quella mausoleo di Adriano e della Meta Romuli, sottolineano anche la s' di un circoscritto punto di osservazione. La città è vista da m Mario, riproponendo così il primo colpo d'occhio che si offriva~ vi giungeva seguendo la via Trionfale, percorso tradizional• visitatori e pellegrini provenienti da settentrione, veduta di R assurta a dignità letteraria grazie ad un passo celebre di Mag Gregorius40. Una scelta che nella basilica di San Pietro, sede della I bronzea, fa sì che la scena non sia solo rappresentazione di un epis di storia sacra, ma susciti in chi l'osserva un contesto fortem evocativo, lo stesso che forse era ricercato negli affreschi di Nic III. Alla città consumata dal tempo di Masolino si sostituisce ricreata antichità che cancella la decadenza dei tempi presenti : citando Biondo - una Roma instaurata che, nel contesto della vec
39 W. A. SIMPSON, Cardinal Giordano Orsini (+ 1438) as a Prince of the CJ and as Patron of the Arts. A Contemporary Panegiric and two Descriptions <
Lost Frescoes in Monte Giordano, in Journaf o/ the Warburg and Cour Institutes, XXIX (1966). p. 135-159; R.L. MooE, Masolino, Uccello, and the "V• famosi", in The Burlington Magazine, 114 (1972), p. 369-378; A. M1GNos1 TAN"
"Uomini famosi" committenze Orsini nel Lazio durante il Q11attrocento, in Brac.
e gli Orsini: tramonto di un progetto feudale, cat. della mostra, Bracciano 19 cura di A. CAVALLARO, A. M!CNOSI TANrcu.o, R. SlUOATO, Roma, 1981 , p. 14 e SCAl.ABROMJ. Masolino a Montegiordano: un ciclo perduto di "uomini illustri", i Pisanelto alla fondazione ... , cii., p. 63-72; P.I.,. ROBERTS, Maso/ino da Pan Oxford, 1993, p. 207-208; P. JOANNJDE.S, Masolino and Masaccio, London, 19~ 452-455 (con amplia bibliografia).
Per le origine delle vedute dì Roma, oltre a STRZYOOWSKI, Cimabue, cit.; FRUTAZ, Le piante di Roma, l, Roma, 1962, p. 19-20; M. ME1ss, French Painting Time of Jean de Berry: the Limbourg and their Contemporaries, London, 19' 209-214; S. MADDALO, In figura Romae. Immagini di Roma nel libro medil Roma, 1990, p. 107-134, 170-183 (con bibliografia).
40 Magister Gregorius, cii., in Cod. top., cit., Ili, p. 143.
FONTI E PAESAGGIO URBANO 543
S. Pietro, evocava il continuo e ininterrotto dipanarsi della storia, il legame stretto e provvidenziale tra la città pagana e quella cristiana. Per fare tutto ciò era necessaria una discreta dottrina archeologica e, sembra molto probabile, che Filarete fosse assistito da qualche umanista, forse proprio da Flavio Biondo ritornato a Roma nel settembre 1443 al seguito di Eugenio IV. Mi limiterò a segnalare qui solo alcuni esempi: il terebinto è tornato ad essere un albero, fatto che implica familiarità con le fonti latine e con quanto si legge nella Roma instaurata, albero che viene disposto presso il luogo del martirio di Pietro - quindi "inter duas metas" - che qui sono la Meta Romuli e il Castello, vicino al Tevere e a S. Maria in Traspontina41. Continuando la discussione sul luogo del martirio di Pietro, Biondo parla della mole Adriana affermando che, da una parte, deve essere identificata come una delle due piramidi tra le quali, secondo la tradizione, ebbe luogo la crocifissione dell'apostolo, dall'altra sottolinea l'evidente incongruenza storica di una simile ricostruzione: «Hadriani moles temporibus Petri et Neronis non fuerit». Tuttavia - prosegue il segretario papale - riteniamo che coloro i quali molto tempo la morte di Pietro hanno voluto mettere per iscritto o rappresentare con figure per gli illetterati quel fatto, abbiano accettato quell'immagine perché la vedevano42. Biondo, infine, ricorda la presenza di una "altera moles", di cui, con forte senso storico, dichiara di ignorare se esisteva al tempo di Nerone.
Per Biondo (e per Filarete) le due mete facevano parte del paesaggio romano ed erano il riferimento tangibile per individuare il luogo del martirio dell'apostolo, una tradizione che non poteva essere abbandonata. Nel rilievo bronzeo non si ricostruisce solo il recinto quadrato del mausoleo di Adriano, di cui nel Quattrocento erano visibili ampi frammenti, ma se ne integra anche la tholos e la parte sommitale (dominata dalla figuretta dell'arcangelo Michele) di cui era molto più difficile farsi un'idea partendo solo dall'esame del monumento. Fu una ricostruzione fortunata - la ritroviamo nella veduta di Roma di Giacomo da Fabriano del 1456 e nel tabernacolo marmoreo di S. Gregorio al Celio, datato 1469 ~ che nacque dagli studi di un altro
41 Biondo, Roma, cìt. in Cod. top., cit. IV, p. 272. 42 Jbidem.
544 E. PARLATO
umanista archeologo, Ciriaco d' Ancona43. La fantasia architettoni< integra al motivo della porta semi-aperta, evidentemente ispirato; sarcofago, sottolineando così l •antica funzione funeraria del maus1 imperiale e della Meta Romuli.
Di quest'ultima Filarete rispetta il caratteristico profilo tra (anche se lo deforma trasformando la cuspide in un capitello quasi f scala), ripropone il sistema di cornici orizzontali e sopratt suggerisce attraverso gli smalti la presenza di una decorazione ester tarsie marmoree. L'effetto che ne deriva potrebbe appa particolarmente convincente. Tuttavia altre immagini quattrocente~ ignorano questo particolare decorativo e Poggio, Biondo e poi Miei da Ferno, nel descrivere la piramide la ricordano spogliata dei : marmi44• Molto stretto è invece il legame con i dipinti assisiati e ar con quelli del portico di S. Pietro che fornirono spunti che lo scul fiorentino integrò forse con l'osservazione in situ. Come nel caso mausoleo di Adriano, Filarete ha ricostruito un modello che verrà ripreso dall'autore del così detto ciborio di Sisto IV.
La crocifissione filaretiana si mantiene in equilibrio tra no archeologiche e tradizione. È una posizione che non è troppo lontan; quella di Biondo. Questi come è noto collocava la crocifissioni Pietro in naumachia, non troppo lontano dalla mole Adriana e ne~ con energia che il supplizio potesse avere avuto luogo al Gianic Anche se ha dei seri dubbi sulla posizione delle piramidi - ricord averne vista s9lo una -, accetta comunque quanto si legge nei testi vede nelle antiche immagini del Martirio di S. Pietro. Nonostant non totale coincidenza di vedute tra Filarete e Biondo, ad esempio n collocazione del Palatium Neronis, l'approccio non è troppo dive Lo schema tradiz ionale viene mantenuto, solo la sua trasfonnazion una veduta urbana, il rapporto visivo e quasi prospettico tra la piran
43 Oxford, Bodleian Library, Ms. Ashmole f. 63r. F. SAXL, The C/as. lmcriplion in Renaìssance Art and Politics, in Journal of lhe Warburg and Cour1 Jnstitutes, IV (1940), p. 19-46, in part. p. 42; B. AsHMOL6, Cyriac of Ancona. Proceedings of the British Acadenry, XIV (1959), p. 25-41 ; FRUTAZ, le piante, 140, HUSKJNSON, The Crucifixion, cii., p. 147.
44 P. BRACCIOl.INT, De varietatefortwiae, ed. in Cod. top .• cit., IV, p. 240: «Pyr est praeterea in Vaticano grandis operis, instar molis, omni ornatu ablato». PEE
La Meta, cit., p. 39-40.
FONTI E PAESAGGlO URBANO 545
di Caio Cestio e la Meta Romuli e la croce che si trova al vertice della composizione possono suggerire che la crocifissione ebbe luogo sul Gianicolo. Questa fu la lettura che ne diedero, prima, Maffeo Vegio e Nicolaus Muffel e, molto più tardi, il Torrigio, quando la fortuna di S. Pietro in Montorio si era rafforzata; solo la nascita delle piante prospettiche, di cui il rilievo filaretiano può essere considerato un incunabolo permise di visualizzare il possibile rapporto tra la Meta Romuli e la Meta Remi45.
All'inizio degli anni '70 del Quattrocento, nel grande rilievo disposto sulla fronte del ciborio collocato a protezione della confessio della basilica vaticana, la Crocifissione dell'apostolo è fissata di nuovo rigidamente "inter duas metas" con l'unica variante che l'albero di terebinto (trasformato nella quercia araldica dei Della Rovere) è ora affiancato e non più sovrapposto alla Meta Romuli ( fig.12 ). Ali' inizio del pontificato di Sisto IV si accettano alcune delle varianti introdotte nella porta bronzea, ma la tradizione iconografica tardo-duecentesca è ancora del tutto accreditata46.
Solo a fine secolo, tra il 1489 e il 1492, nel cantiere pinturicchiesco della cappella Basso Della Rovere a S. Maria del Popolo, tale convenzione pare definitivamente abbandonata. La Crocifissione di S. Pietro dipinta a monocromo, è di nuovo ambientata
45 N. MurFEL, Beschreibung der Stadi Rom. ed. in Cod. top., cii., IV, p. 359; ora anche nell'edizione a cura di G. WIEDMANN, Bologna, 1999, p. 91-93. L'ubicazione del luogo del martirio di Pietro, così come è indicata da Muffel, potrebbe discendere dall'avere visto la porta del Filarete. F.M. TORRJGIO, le Sacre Groue Vaticane, Roma 1635 (I ed. 1618), p. 155-156: «In esse (le porte) vi è scolpito il martirio dei Ss. Pietro e Paolo, di quello nel Gianicolo tra le due Mete, cioè una alla porta di S. Paolo e !"altra vicino a Castello S. Angelo e di questo altro alle Tre Fontane». Su questa questione cf. P. FEHL, Michelangelo's Crucifixion os St.Peter. Notes on the Jdentification of the locale of the Aclion, in Art Bulletin, Llll (1971 ), p. 327-340; 342-343, in part. p. 334, n.50.
46 GRlMALDI, Descrizione, cii., p. 198-203; P. SILVAN, Il ciborio di Sisto IV nell'antica basilica di S. Pietro in Vaticano: ipotesi per un 'ideale ricomposizione. in Bollettino d'arte, S. VI, LXIX (1984), 26, p. 87-98; F. CAGLIOTI, in la basilica di S. Pietro, cit., IV, p. 811-821, attribuisce il ciborio a Paolo Romano (e bottega e ne colloca l'esecuzione durante il pontificato di Paolo Il. Tuttavia la presenza di elementi araldici rovereschi è perlomeno testimonianza del protrarsi dei lavori nella fase iniziale del pontificato di Sisto IV.
546 E. PARLATO
«iuxta obeliscum Neronis», come scriveva lo pseudo Lino; trovié l'obelisco del circo neroniano, quello che sorgeva sul lato meridio1 della basilica presso la rotonda di S. Andrea, riconoscibile per la 1 marmorea e gli astragali. L'esplorazione di luoghi e monumenti, qu che già Poggio aveva compiuto a metà del secolo, distinguendc enumerando gli obelischi di Roma, comincia a dare i suoi frutti taccuini di anticaglie che la documentano. Anche a Roma la contin antiquaria medievale deve cedere il passo alla distanza oggettivi della moderna archeologia.
ADDENDA ICONOGRAFICA
Contaminazioni dalla Caduta di Simon Mago
La discussione sull'iconografia petriana ha messo in evide l'importanza, davvero cruciale, della tradizione figurativa romé Vorrei qui segnalare in forma sintetica un caso di contaminazione spostamento di un episodio delle storie apostoliche in un cont• narrativo apparentemente molto diverso. La Caduta di Simon Mc così come è stata formulata negli affreschi del portico della basi vaticana, nel transetto nord della basilica superiore di Assisi (fig.13~ S. Pietro a Grado, costituisce un precedente per una delle storie d leggenda francescana nella stessa basilica assisiate.
La tradizione romana tardo-duecentesca, ispirandosi al raccc degli Atti apocrifi, organizza la scena attorno a tre distinti nucle immagini: Nerone in trono (a destra), la torre a traliccio (al centro) due figure dei Ss. Pietro e Paolo (a sinistra)47. In quest'ultimo gru1 Pietro sta in piedi e ordina ai demoni di abbandonare Simon Mago il gesto del braccio destro proteso in obliquo; Paolo è inginocchiat preghiera al limite sinistro del campo figurativo . Così, partendo d figura inginocchiata di Paolo, passando per il braccio dispc obliquamente di Pietro si arriva fino all'apice della torre, le div•
47 Ringrazio Chiara Frugoni per la discussione su questo argomento. Il confi tra la Caduta di Simon Mago e la Cacciata dei demoni da Arezzo è stato propost J.T. WOLLESEN, Pictures and Reality, New York, 1998, p. 176, fig. 116, 123, 124.
Acta, cìt., p. I 53-167; CARR, Aspects, cii., p. I S 1-158; WOLLESEN, Die Fresken. p. 55-57. La posizione di S. Paolo, "positis genibus" è desunta in maniera diretta Passio Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, in Acta, cit. p. 163, 18-19.
FONTI E PAESAGGIO URBANO 547
figure sono ordinate attorno ad un asse compositivo diagonale che indirizz.a la lettura della scena.
L'orchestrazione dell'immagine nel suo insieme e le due figure raggruppate, una stante l'altra inginocchiata, sembrano essere la fonte per la messa a punto della Cacciata dei demoni da Arezzo (fig.14 ), il decimo episodio della leggenda francescana, affrescato sulla parete destra della prima campata della chiesa superiore48. L' idea compositiva basata sulla diagonale ascendente, che visualizza il passaggio dalla preghiera all'azione, semplifica e chiarifica il modello della scena apostolica. S. Francesco in preghiera è quasi un calco del S. Paolo orante, così frate Silvestro che indica con il braccio destro la città sullo sfondo, è molto vicino alla figura di S. Pietro. Infine la stessa posizione dei demoni che svolazzano sui tetti di Arezzo ha un rapporto - questa volta meno stringente - con quelli che nell'episodio apostolico volteggiano sopra la torre. La relazione tra le due immagini, tra Ja Caduta e la Cacciata si rileva anche dalla lettura della Legenda maior. Qui non si fa cenno alla preghiera di S. Francesco, ma si ricorda solo l'ordine impartito dal santo al suo compagno: «Vai, grida davanti alla porta e per volere di Dio caccia via i demoni». Quindi l'idea del S. Francesco orante nasce da una idea figurativa e non testuale.
Può sorprendere invece il parallelismo e il confronto tra S. Francesco e S. Paolo. Nella Cacciata, come osserva Chiara Frugoni e come è indicato in modo esplicito nel passo della Legenda maior appena citato, l'esorcismo è operato da Silvestro che, al contrario di S. Francesco, era stato ordinato sacerdote. Da qui scaturisce la necessità di ispirarsi per questo ruolo alla figura di S. Pietro. Il confronto può anche aiutare a comprendere meglio la Caduta nel transetto, nella quale la funzione sacerdotale e quindi dì maggiore prestigio spetta,
48 G. RUF, Francesco e Bonaventura. Un 'interpretazione s1orìco-salvifica degli affreschi della navata nella chiesa superiore di S. Francesco in Assisi alla luce della teologia dì S. Bonavent1Jra, Assisi, 1974, p. 160-162. C. F RUGONI, Le storie di S. Francesco ad Assisi, in B. Z ANARDI, Il cantiere di Giotto. Le storie di san Francesco ad Assisi, Milano, 1996, p. 160. «Cum beatus Franciscus vidit supra civitatem Aretii daemones exultantes et ait socio: "Vade et in virtute Dei daemones expelle, sicut in Domino ipsi tibi praescriptum est, clamans in porta". Ut autem ille oboediens clamavit, daemones aufugierunt, et pax illico facta est» Legenda maior VI, 9, cit. da FRUGO!>il, ibidem, da cui si è anche ripresa la traduzione italiana.
548 E. PARLATO
evidentemente, a S. Pietro, in un gioco di rimandi voluti e ce: all'interno della basilica assisiate. Rimandi che sembrano presupp l'esistenza di un progetto iconografico predisposto, almeno nelle linee generali, nel momento in cui si diede avvio alla sua decoraz pittorica.
Non si può dubitare che il 'prestito' sia avvenuto proprio 1
chiesa superiore di Assisi; qui, del resto, la committenza ha ser incoraggiato la sovrapposizione di immagini vetero e neo-testarnen per formulare le storie del santo fondatore, conscia che questo fos modo più semplice dì costruire una nuova tradizione che si present sotto le spoglie rassicuranti di quella antica. Rimane da stabilire parallelismo tra la Caduta di Simon Mago e la Cacciata dei demor Arezzo, abbia una valenza solo compositiva o implichi invece un n iconografico. Di certo si può affermare che i grandi cicli romani loro derivazioni si dimostrarono, ancora una volta, straordir deposito di invenzioni, immagini e soluzioni compositive.
Università della Tuscia, Viterbo
E. PARLATO
Fig. l - Filarete, Porta bronzea di S. Pietro, insieme, Roma, basilica di San Pietro (foto Musei Vaticani).
...
E.PARLATO
Fig. 2 - Filarete, Martirio di S. Pietro, particolare della porta bronzea vaticana (foto Musei Vaticani).
Fig. 3 - Cimabue, S. Marco particolare con Ytalia -Roma Assisi, S. Francesco, basilica Superiore volto della crociera.
E. PARLATO
Fig. 4 - Giotto e bottega, Martirio di S. Pietro, anta del Politico Stefaneschi, Roma, Pinacoteca Vaticana (foto Musei Vaticani).
E.PARLATO
Fig. S • Spinello Aretino, Processione di S. Gregorio Magno, Arezzo, San Francesco, cappella Guasconi.
Fig. 6 - Pittore romano di fine del Duecento, Martirio di S. Pietro, Roma, cappella del Sancta Sanctorum (foto Musei Vaticani).
Fig. 8 - Bottega cimabuesca, Martirio di S. Pietro, Assisi, San Francesco, basilica superiore, transetto nord.
E.PARLATO
Fig. 7 - Martirio dì S. Pietro, già nel portico della vecchia basilica petriana (da Grimaldi, foto Bibliotheca Hertziana}.
Fig. IO - Maestranza romana, Martirio di S. Pietro, particolare del paliotto della Vergine, Anagni cattedrale, museo (foto Bibliotheca Hertziana).
E. PARLATO
Fig. 9 - Deodato Orlandi, Martirio di S. Pietro, Pisa, San Piero a Grado (foto reco).
E.PARLATO
Fig. 11 - Leonardo da Besozzo, Roma, nel Codice Morbiano, Milano coli. Crespi.
I Fig. 12 - Paolo Romano, Martirio di S. Pietro, Roma, basilica di San Pietro.





































![[Salis M.] Ittiri, chiesa di San Pietro](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63235bf65f71497ea9044b23/salis-m-ittiri-chiesa-di-san-pietro.jpg)




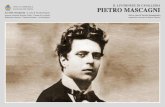



![[2. versione provvisoria: 31.12.2021] 1/113 PIETRO ZAPPALÀ ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63287da5051fac18490ec024/2-versione-provvisoria-31122021-1113-pietro-zappala-.jpg)








