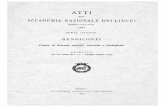12. Appunti sull'alto Medioevo nel territorio agrigentino
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of 12. Appunti sull'alto Medioevo nel territorio agrigentino
353
XL, 2013, pp. 353-366
Luca Zambito
Appunti sull’alto Medioevo nel territorio agrigentino
1 Rassegna bibliografica fino agli anni ’90 in FIORILLA 1991; una recente messa a punto in ARCIFA, BAGNERA, NEF 2012. Ricordo i recenti convegni: From Polis to Madina. La trasformazione delle città siciliane tra tardoantico e altomedioevo (Siracusa, 21-23 giugno 2012); La Villa restaurata e i nuovi studi sull’edilizia resi-denziale tardoantica (Piazza Armerina, 7-10 novembre 2012); Il processo di islamiz-zazione in Sicilia e nel Mediterraneo centrale (Palermo, 8-10 novembre 2012).
2 RIZZO 2004; MOLINARI, NERI 2004; WICKHAM 2005; CORRETTI et al. 2006; PRIGENT, NEF 2006; ARDIZZONE 2010a; CORRETTI, GARGINI, VAGGIOLI 2010; KISLINGER 2010; RIZZO 2010; CACCIAGUERRA 2011 con bibliografia pre-cedente; ARCIFA, BAGNERA, NEF 2012. Non vidi VACCARO 2013.
3 Sulle fornaci di S. Lucia, scoperte casualmente agli inizi degli anni ’60: RAGONA 1966; FIORILLA, CILIA PLATAMONE 2005 e 2007; CILIA PLATAMONE, FIORILLA 2009; D’ANGELO 2010, p. 114. Alcuni di questi materiali sono ora visibili nel nuovo allestimento del Museo Civico di Agrigento presso i locali dell’abbazia di S. Spirito.
4 Vari settori della città classica e romana sono interessati dalla presenza di officine ceramiche tra il X e il XIV secolo d.C.: oltre al quartiere di Santa Lucia, l’area del Bouleuterion, il Ginnasio (FIORENTINI 1996) e un settore a nord del tempio della Concordia occupato, in epoca tardoantica, da una vasta necropoli (BONACASA CARRA, ARDIZZONE 2007; ARDIZZONE 2010b).
5 A proposito di questo sito, e della nota pubblicata dal Bonfiglio, si veda la correzione di P. Orsi a quanti ne sostenevano una datazione ad età preistorica («non è che un complesso di abitazioni trogloditiche dell’alto Medioevo ana-logo a quelli che si trovano in moltissimi altri siti dell’isola»), P. Orsi, Rettifiche archeologiche, «BPI», XXVII, 1901, p. 206.
1. INTRODUZIONE
Negli ultimi anni si assiste ad un fervore e ad una forte ripresa di interesse per la storia dell’alto Medioevo siciliano, in partico-lare per l’indagine del momento di passaggio fra Vandali, Goti e Bizantini e fra questi e l’arrivo delle popolazioni musulmane1. Nuovi dati, relazioni di sintesi, indagini prosopografiche hanno consentito di testare modelli interpretativi per cui si erano già avanzate, nei decenni passati, interessanti ipotesi di lavoro2.
Di contro, però, tacciono e mancano i dati provenienti dal centro urbano di Agrigento per cui non conosciamo, per questa città, le fasi precedenti l’impianto delle fornaci ‘sveve’ e ‘chia-ramontane’ a S. Lucia3 e di un organico quadro interpretativo che, per esempio, consenta di raccordare topograficamente il quartiere del Balatizzo, a sud ovest del centro normanno (fig. 1), con l’area del pianoro occupato dal cosiddetto ‘Quartiere Ellenistico-Romano’4 che parrebbe frequentata in età post-clas-sica (WILSON 1990, pp. 114-115; DE MIRO 2009 e BELVEDERE, BURGIO 2012) (fig. 2).
È difficile immaginare un completo abbandono di questo settore dell’abitato tanto più in favore di un sito, quello del Balatizzo appunto, che non doveva fornire nessuna alternativa difensiva o migliori possibilità di rifugio rispetto al primo (BONFIGLIO 1900)5. In altre parole occorre chiedersi se ad Agrigento dopo il V secolo d.C. e fino alla conquista islamica, avvenuta nell’828 d.C., non sia intervenuto un processo di ‘ru-ralizzazione’ per chomas con più nuclei insediativi (addensatisi attorno ad edifici religiosi?) separati da superfici non urbanizzate, magari dedicate all’agricoltura di sussistenza; ovvero se, data la presenza delle autorità civili e religiose (anche con la funzione
di grandi possidenti terriere), il centro non abbia mantenuto una sua più ampia e complessa unitarietà topografica e la capa-cità di catalizzare e razionalizzare le attività economiche della prima cintura periurbana e del territorio agricolo circostante (SAMI 2011, pp. 226-227 e SAMI 2013, pp. 30-31 su Agrigento. CACCIAGUERRA 2011, p. 269).
Di certo, forse, un elemento che sembra spingere verso la se-conda ipotesi è dato dalla presenza a sud della città del porto che sembra vivace almeno fino alla prima epoca bizantina, verso il quale potevano confluire i beni derivanti dal surplus produttivo6 (GABRICI 1925 e CAMINNECI 2012, p. 265 e nota 32).
Ma qual è la cultura materiale fra VIII e almeno la prima metà del X secolo d.C. quando le prime produzioni invetriate (D’ANGELO 2010) hanno consentito di trovare griglie cronolo-giche affidabili?
In questa sede intendiamo presentare i materiali provenienti da ricognizioni mirate e rinvenuti in alcuni siti nelle campagne ad est di Agrigento che hanno caratteristiche simili tanto da un punto di vista topografico quanto per la cultura materiale documentata.
2. CANICATTÌ, C.DA CAIZZA-GIUMMELLO
Il primo sito (fig. 3) è ubicato nel territorio comunale di Canicattì (AG) a nord ovest di un imponente deposito calcareo del Messiniano, noto come “Pizzi di Giummello” (fig. 4), a est del quale si estende un’ampia dorsale gessosa con evidenti tracce di attività estrattiva (probabilmente postmedievale) protrattesi fino ad età contemporanea. L’idrografia è segnata dal passaggio dell’alto corso del fiume Naro (le cui sorgenti distano circa 5 km) e da alcuni stretti valloni che, incidendo fortemente le dorsali collinari in ripidi calanchi, vi confluiscono.
I frammenti ceramici (fig. 5) si rinvengono su un piccolo areale (600 m² circa) e si addensano in particolar modo in corrispondenza di alcune strutture murarie a secco addossate ed ortogonali ad alcuni tagli nel banco calcareo all’interno dei quali, fra l’altro, si annota la presenza di uno spesso deposito stratigrafico, particolarmente evidente ai margini di una stradella privata di accesso al fondo e in prossimità di uno sbancamento per il posizionamento di un palo della rete elettrica.
6 Nel 1903 fu rinvenuto un ripostiglio di monete di IX d.C. alle foci del fiume Akragas, LAGUMINA 1904, pp. 80-90. È forse da riconsiderare alla luce delle recenti scoperte sulla topografia del porto di Agrigento in età altomedievale l’ipotesi del Mons. Lagumina che proponeva di collegare l’occultamento del tesoretto ad uno degli episodi legati alla conquista islamica della Sicilia: «in quell’anno (215) gli Spagnuoli, distrutta Mineo, occupano G.ewaliah (presso Caltanissetta). Qui furono presi da una pestilenza … Gli avanzi dell’esercito spagnuolo giunsero alla Marina; Amari [BAS III, p. 5] dice fosse di Mazara io credo più probabile di Girgenti apparendomi difficile che le forze bizantine allontanandosi di molto da Castrogiovanni inseguissero gli Spagnuoli fino a Mazzara. Così io mi spiego come gli Spagnuoli, inseguiti dai Bizantini avessero nascoste nella spiaggia di S. Leone le monete delle quali siegue il notamento». Al di là delle ipotesi pare fuor di dubbio che lo scalo agrigentino fosse ancora vitale almeno fino alla prima metà del IX secolo d.C.
354
NOTE E DISCUSSIONI
fig. 1 – Agrigento. Pianta di una casa del Balatizzo (da BONFIGLIO 1900).
I materiali1. Orlo ingrossato e introflesso di olla modellata a mano, su-perficie esterna rifinita a stecca. Impasto grigio con numerosi inclusi calcitici e gessosi, caratterizzato da ampi vacuoli.2. Orlo di olla introflesso e ingrossato.3. Ansa frammentaria a sezione ellittica schiacciata e rastremata da un lato. Leggera solcatura longitudinale sull’asse mediana. Impasto giallo con minuti inclusi calcitici.4. Ansa con profonda solcatura mediana a margini irregolari.5. Grosso piede con due profonde incisioni concentriche.6. Orlo ingrossato e leggermente pendulo di brocca. Impasto con rari inclusi calcitici, bordo marcato da tre incisioni concen-triche poco profonde.7. Fondo di catino in due frammenti ricomponibili.8. Orlo bifido e parete verticale di forma aperta. Impasto con media quantità di calcite e superficie esterna con abbondanti vacuoli.
Fra i laterizi raccolti e campionati si annota la presenza di coppi sub-piani di forma pressoché quadrangolare, molto leggeri, per la presenza di elementi vegetali nell’impasto caratterizzati sulla superficie esterna da ampie striature a onde che segnano tutta la superficie del pezzo. Si tratta delle cosiddette tegole vacuolate e striate che si distinguono nettamente per tipologia ed impasto dai coppi “tipo C” di Wilson (WILSON 1979)7 (fig. 6).
Del contesto ceramico fanno parte anche alcuni esemplari di olle ad orlo rientrante e ingrossato8 caratterizzate anche dalla presenza di una decorazione a strie oblique, cosiddetta “a stuoia”, forse residuo, appunto, di un sostegno stramineo in fase di modellazione, da un impasto scuro risultato di cottura a basse temperature e in condizioni riducenti, e con abbondanti elementi di degrassante calcitico.
3. CAMPOBELLO DI LICATA (AG), C.DA CICCOBRIGLIO
Il secondo sito (fig. 7) si trova a circa 5 Km a sud del moder-no centro di Campobello di Licata (AG). L’area di dispersione dei frammenti ceramici è subito a sud di una dorsale calcarea (fig. 8), che si allunga da est a ovest, nella quale sono evidenti le tracce di uno sfruttamento prolungato nel tempo: ai suoi margini occidentali sono stati accumulati materiali di risulta da attività agricole ed edilizie mentre sulle pendici nord si è documentata una tomba a grotticella parzialmente crollata. Fra queste, che possono essere considerate, rispettivamente, la più recente e la più antica attività nell’area, si interpone una fase in cui ebbe luogo una intensa attività di cava che ha parzialmente modificato la conformazione del rilievo (e forse distrutto altre sepolture, infatti più a valle si rinvengono sporadici frammenti preistorici ipoteticamente riconducibili all’Eneolitico ma che meritano, forse, uno studio più approfondito).
L’area del sito altomedievale si sviluppa, per circa 400 m², a sud di questo rilievo collinare. La concentrazione del materiale ceramico è buona nonostante le cattive condizioni di visibilità e si annota la presenza di abbondante pietrame calcareo di piccole e medie dimensioni che è visibile sul terreno.
7 Sull’ormai annosa questione dei coppi striati/pettinati, “vacuolati” e striati e semplicemente vacuolati si veda RIZZO 2004, pp. 13-13 e 147; ARCIFA 2010b, p. 108, EAD. 2010c, pp. 26-27; ROTOLO, MARTÍN CIVANTOS 2012, p. 414; RIZZO, DANILE, ZAMBITO c.s.
8 ARCIFA 2004; EAD. 2010a, p. 71 fig. 3 con carta di distribuzione; FIORILLA 2010a, pp. 96-99.
Fra i materiali (figg. 9-10) è notevole il gruppo di pentole a orlo ingrossato, aggettante e con parete carenata che conserva una decorazione a strisce incise9. Si evidenzia, inoltre, assieme alla presenza di sporadico materiale chiaramente residuale di età ellenistica, la totale mancanza di reperti ceramici di importazione africana, eccezion fatta per un unico orlo di anfora tipo Keay 61, con il tipico impasto giallo chiaro delle produzioni tarde10, che potrebbe essere un indizio di un reimpiego, in contesto rurale, di un contenitore da trasporto chiaramente riconducibile ad una fase cronologica precedente. Fra la ceramica comune rinvenuta, si annota come il catino a orlo indistinto e a tesa e parete verticale (fig. 10.10), che all’analisi macroscopica della sezione pare abbia lo stesso impasto delle pentole ‘tipo Rocchicella’, documenti la coesistenza di forme in ceramica comune assieme a ceramiche da fuoco prodotte nella stessa officina.I materiali1-5. Bordi ingrossati e rientranti di casseruole ‘tipo Roc- chicella’.6. Ansa con solcatura mediana.7-8. Pareti di casseruole “Tipo Rocchicella” con segni lasciati dalla stuoia.9. Orlo leggermente ingrossato e estroflesso di catino.10. Orlo indistinto e leggermente estroflesso di catino. Impasto calcitico.11. Orlo frammentario e attacco di parete di anfora.12. Orlo di anfora africana. Keay 61.13. Orlo ingrossato di brocca.14-15. Anse con solcatura mediana.
9 Cfr. ora un frammento rinvenuto a Gerace (EN), BONANNO, CABELLA, CAPELLI 2010, figg. 12-13 e uno da Delia (CL) FIORILLA 2010b, p. 79, fig. 1. Un commento su presenze/assenze di tali reperti ceramici in contesti altomedievali in RIZZO 2010 e ARCIFA 2010a.
10 Ad una cronologia successiva alla metà del VII d.C. pensa M. Bonifay. BONIFAY 2004, p. 140.
355
NOTE E DISCUSSIONI
fig. 2 – Agrigento. Ortofoto del “Quartiere Ellenistico Romano”. In evidenza le aree con fornaci (rielabo-rato da Google Earth).
fig. 3 – Canicattì (AG). Contrada Giummello. Stralcio CTR 637070 1:10000.
fig. 4 – I “Pizzi” di Giummello da nord.
356
NOTE E DISCUSSIONI
11 Appunti inediti su taccuino di scavo. Archivio Soprintendenza di Agrigento.
12 Progettata a fine ’800 per servire il bacino solfifero agrigentino, la linea ferroviaria a scartamento ridotto Agrigento-Naro-Licata fu completata con circa trenta anni di ritardo e inaugurata proprio in uno dei momenti peggiori per il commercio del minerale. Non fu sostanzialmente mai ammodernata e, dopo poco più di cinquanta anni, nel 1958 fu dismessa. Rimangono nelle campagne le rare ma imponenti opere ingegneristiche per il superamento di fiumi e rilievi collinari oltre alla traccia delle cremagliere per il valico di alcuni importanti dislivelli. MOLINO 1985 sulla rete ferroviaria siciliana a scartamento ridotto.
13 Sull’epistolario e sui dati prosopografici ricavabili, oltre al classico RECCHIA 1978, cfr. RIZZO 2008 e 2009. Sulla grande proprietà agraria in età tardoantica VERA 1999; BELVEDERE 2004, pp. 3-5; CALIRI 2006.
fig. 5 – Materiali Giummello. Ceramica da fuoco e comune.
fig. 6 – Coppi da Giummello. A sinistra coppo vacuolato e striato, a destra coppo vacuolato.
4. NARO, C.DA CANGIANA/S. GREGORIO
Più complesso ed articolato è lo sviluppo del sito di c.da S. Gregorio/Cangiana nel territorio di Naro (fig. 11). A NW rispetto al centro attuale di Naro e a est rispetto al sito di C.da Saraceno di Favara, AG (CASTELLANA, MCCONNELL 1990; CASTELLANA 1998). L’insediamento si estende alle pendici di un basso rilievo collinare che si allunga da est ad ovest e separa il bacino idrografico del fiume Naro da quello di un suo affluente, il torrente Iacono (fig. 12). Quest’ultimo è caratterizzato da un flusso torrentizio che comporta una maggiore aggressività verso i suoi argini che appaiono anche oggi molto irregolari, con nume-rosi episodi franosi e formazioni calancoidi. Dal sito si controlla l’ampia vallata, i rilievi dell’entroterra agrigentino e, allo stesso tempo, si controlla verso SW il mare con la foce del fiume Naro e, soprattutto, il tratto pianeggiante da cui doveva passare la direttrice stradale E-W verso Siracusa. Circa 300 m a NE del sito, si conservano i resti di un imponente insediamento la cui vita sembra cessare entro il I secolo d.C. L’areale di dispersione dei frammenti ceramici supera ampiamente i 10 ettari mentre all’interno del sito sono nettamente percepibili i limiti, per fasi cronologiche, delle diverse facies ceramiche e culture che vi si sono succedute. Noi, in questa sede, ci occuperemo strettamente dell’abitato di età altomedievale. Pare però importante aggiun-gere come la cresta calcarea che protegge l’insediamento da
sud sia interamente occupata da una vasta area di necropoli ad arcosoli, ipogei e fosse sub divo, parecchie delle quali violate in antico (fig. 13). Si tratta con ogni probabilità delle tombe viste da P. Griffo nel 194511 passando lungo la ferrovia a scartamento ridotto il cui vecchio tracciato è ancora vitale come tratturo interpoderale12. La particolare topografia, la fertilità del suolo e l’abbondanza di acqua hanno consentito che nei secoli la vita dell’abitato, probabilmente strettamente legato ad un generale surplus da dedicare ai mercati, sia continuata almeno fino ad età altomedievale epoca in cui, in prossimità del rilievo roccioso e a nord di esso, si installò un piccolo insediamento. I materiali riconducibili a questa fase (figg. 14), infatti, si rinvengono su un areale abbastanza ristretto (non superiore ai 1000 m²) e, in alcuni settori, chiaramente associato con frammenti diagnostici riconducibili ad un orizzonte tardoantico.
A proposito di questa “facies” tardoantica (fig. 15), che sarà più ampiamente trattata in altra sede, chi scrive non riesce a sfuggire alla tentazione di collegare il toponimo Cangiana (ma dialetto locale Cianciana), cui si associa l’agiotoponimo S. Gregorio, con la Massa Cinciana di cui è menzione in una famosa lettera di Gregorio Magno (I, 42) indirizzata a Petrus rector Patrimoni Sancti Petri 13.I Materiali1. Orlo rientrante e ingrossato e attacco di parete carenata di casseruola.2. Orlo frammentario a tesa complanare di olla a pareti verti-cali.3. Orlo indistinto con leggera risega per il coperchio, ansa a bugna. Impasto calcitico.
357
NOTE E DISCUSSIONI
fig. 7 – Campobello di Licata (AG). Contrada Ciccobriglio, CTR 637150 1:10000.
fig. 8 – Panoramica Ciccobriglio da Est.
4. Orlo ingrossato di forma da fuoco.5. Orlo estroflesso di catino. Impasto con biscotto grigio.6. Orlo di anforaceo. Impasto giallastro, depurato.7. Orlo rientrante e ingrossato di casseruola.8. Orlo estroflesso e ingrossato e parete verticale di catino.9. Orlo estroflesso di catino.10. Presa di coperchio appiattita, spesso attacco di parete.
5. CANICATTÌ (AG), CONTRADA CAZZOLA
Il sito di contrada Cazzola (fig. 16), 4 km ad ovest del moder-no centro di Canicattì (AG), si sviluppa su un rilievo calcareo in posizione strategica all’incrocio fra una direttrice stradale
e almeno un asse viario N-S che collega l’entroterra collinare con il fondovalle. Nonostante una strada interpoderale moder-na abbia pesantemente danneggiato il deposito stratigrafico, sopravvivono in alzato alcuni edifici di cui si possono scorgere i livelli di crollo, inoltre sono leggibili numerosi ambienti in fondazione collegati ad alcune fosse tagliate nella roccia (figg. 18-19). A ovest, invece, si conserva un imponente sistema idraulico costituito da un canale di immissione e da una monumentale vasca quadrangolare alla quale se ne addossa una seconda, più piccola, rettangolare (fig. 20). La presenza di un fitto e com-patto strato di rivestimento in cocciopesto, assieme a sporadici frammenti di sigillata e anfore africane, sono gli unici, vaghi, elementi datanti per queste strutture. A NW del sito medievale una strada lastricata, in parte intagliata nella roccia calcarea e con una carreggiata di oltre 8 m, è delimitata, nel punto in cui
358
NOTE E DISCUSSIONI
fig. 11 – Naro (AG). Contrada Cangiana/S. Gregorio. CTR 637059 1:10000.
fig. 9 – Ciccobriglio. Ceramica da fuoco e comune. fig. 10 – Ciccobriglio. Ceramica comune e anfore.
359
NOTE E DISCUSSIONI
fig. 12 – Panoramica Cangiana.
fig. 13 – Necropoli di S. Gregorio.
valica il rilievo collinare, da due grandi strutture a base circolare, profonde circa 15 m e con un diametro di 8, per 2/3 scavate nella roccia e per la restante parte costruite con pietre informi calcaree di medie e piccole dimensioni, forse interpretabili come siloi granari (fig. 17).I Materiali (figg. 21-22)1. Orlo e attacco di parete di anfora (Keay 61)2. Orlo estroflesso di olla.3. Orlo estroflesso e ingrossato di olla, risega per il coperchio.4.-6. Orli a collarino di anfore. Impasto con rari elementi calcitici.7. Orlo ingrossato e a tesa di catino. Impasto giallo, depurato.8. Orlo ingrossato e rientrante di casseruola. Impasto con calcite.9. Orlo a tesa di catino.10-11. Anse con solcatura mediana.12. Orlo ingrossato e rientrante e parete carenata di casseruola.13. Orlo rientrante e ansa a bugna frammentaria di olla, impasto con media quantità di calcite.14. Orlo bifido e ansa a bugna frammentaria. Impasto con abbondante calcite.15. Orlo ingrossato e rientrante di casseruola.16. Orlo di brocchetta.
6. CANICATTÌ (AG), VITO SOLDANO
Due piccole (6×20 m) concentrazioni di materiale ceramico altomedievale sono state rinvenute a sud del sito di Contrada Cazzola e subito a est dell’impianto termale di Vito Soldano (fig. 16, 1-2). L’area è probabilmente da identificare come la statio di Corconiana14 la prima lungo la direttrice Agrigento-Catania (GIACCONE 2012). Dopo il primo intervento di scavo, condotto su sollecitazione di urgenti interventi di tutela, che ha consentito di portare alla luce alcuni vani delle terme e un fugace scavo, ancora purtroppo inedito condotto agli inizi degli anni ’70 e che ha interessato una porzione del villaggio tardoantico, tra il 2004 e il 2005 sono state condotte, nel sito di Vito Soldano, indagini stratigrafiche che hanno individuato oltre ad altri settori delle terme (fig. 23) anche una grande strada lastricata su cui viene costruito, probabilmente dopo il VII d.C., un impianto artigianale15. Alcuni saggi, inoltre, hanno portato all’identifica-zione di un precedente complesso termale, interpretato come un piccolo balneum privato, anteriore alla edificazione, datata al IV secolo d.C., della terma confermando e precisando, seppur
14 Su alcune ceramiche da fuoco rinvenute in un contesto databile proba-bilmente all’VIII si veda RIZZO, ZAMBITO 2012.
15 Il panorama insediativo di Vito Soldano è del tutto analogo a quello, meglio conosciuto, di Sofiana (Mazzarino, CL). FIORILLA 2009 e BOWES et al. 2011 con bibliografia precedente.
360
NOTE E DISCUSSIONI
fig. 16 – Canicattì (AG). Contrada Vito Soldano e Cazzola. Stralcio CTR 637020 1:10000.
fig. 14 – Materiali Cangiana. Ceramica da fuoco e comune. fig. 15 – Materiali Cangiana. Anfore tardoantiche.
in via preliminare e parziale, il dato di una diffusa e costante presenza su gran parte dell’area di reperti ceramici della prima età imperiale. Numerose fosse circolari, all’interno degli spazi termali, con abbondanti tracce di bruciato e di argilla concotta,
documentano probabilmente una attività di spoliazione, cottura e riutilizzo dei rivestimenti pavimentali e dei blocchi di calcare delle strutture, in una fase cronologica purtroppo, ancora, non meglio precisabile.
361
NOTE E DISCUSSIONI
fig. 17 – Cazzola. Siloi.
fig. 18 – Cazzola. Strutture medievali. fig. 19 – Cazzola. Pozzo.
fig. 20 – Cazzola. Vasca romana.
A ovest del sito di Vito Soldano, sopralluoghi mirati hanno consentito di individuare altre tre piccole unità topografiche con scarsissimo materiale altomedievale (RIZZO, DANILE, ZAMBITO c.s.) dalle caratteristiche simili ai due siti che qui si presentano.I Materiali16 (figg. 24-25)1. Orlo rientrante di casseruola. Impasto grigio con abbon-dante calcite.2. Orlo a tesa pendula di olla. Impasto grigio con frequenti inclusi calcitici e chamotte.3. Orlo a sezione triangolare, estroflesso e con risega per il coperchio di olla. Impasto grigio con numerosi vacuoli e sporadici elementi degrassanti.4. Orlo ingrossato e pendulo di olla.5. Orlo e attacco d’ansa a nastro di brocca.
16 I numeri 2, 4, 5, 6, 9, 10, dal sito 1; 1, 3, 7, 8, 11 dal sito 2.
362
NOTE E DISCUSSIONI
fig. 21 – Materiali Cazzola. Ceramica da fuoco, comune e anfore. fig. 22 – Materiali Cazzola. Ceramica comune e da fuoco.
6. Orlo estroflesso di catino. Decorazione con rotellatura sul bordo.7. Ansa con solcatura mediana.8. Orlo estroflesso e ingrossato di olla. Risega per il coperchio.9. Orlo di olla. Superficie esterna lisciata a stecca.10. Orlo di vaso con corto listello.11. Orlo e parete con listello di anforaceo.
7. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Pare di poter cogliere, soprattutto nelle forme ceramiche di c.da Cangiana, la coesistenza per un periodo della produzione nelle stesse officine, o all’interno di strutture produttive più semplici, quali i singoli nuclei familiari, tanto di olle con orlo a tesa quanto delle pentole con orlo ingrossato e rientrante. Gli esemplari 2 e 3 di Cangiana hanno infatti stesso impasto, caratterizzato soprattutto da abbondanti inclusi calcitici di medie dimensioni e da nucleo scuro indizio della cottura in atmosfera riducente. La superficie esterna invece è lisciata a stecca e rifinita con un ingobbio fine color camoscio. Al repertorio tipologico abbastanza scarno di questi contesti altomedievali si può ag-giungere una forma (figg. 14.3 e 22.14) bassa (per la cottura dei cibi?), con orlo bifido per l’alloggiamento del coperchio e impasto calcitico. E un catino (fig. 10.10) a orlo indistinto ed
estroflesso il cui impasto è simile a quello delle casseruole a bordo rientrante.
Sembra di poter dire che una vera e propria cesura nel reper-torio morfologico delle forme da fuoco si possa riscontrare solo dopo la fine delle importazioni pantesche (comunque prevalenti, nei contesti agrigentini, almeno fino agli inizi del VII d.C. con punte di attestazioni vicine al 100% in alcuni contesti di V secolo d.C.) quando la ceramica da cucina è rappresentata dalle olle con impasto riducente e calcitico e orlo estroflesso e a tesa che ci sembrano innovare decisamente il repertorio formale e tipologi-co, contemporaneamente riducendolo e standardizzandolo.
Recenti scavi e revisioni di dati hanno consentito di associare le olle con orlo a tesa ed impasto riducente con abbondante calcite da un lato a grandi coperchi con spesso pomolo per la presa e con pareti caratterizzate da fori-sfiatatoio a circa un terzo della parete dall’altro con reperti anforici databili all’VIII secolo d.C.17 (RIZZO, ZAMBITO 2012, p. 296 e fig. 3).
Una ulteriore novità nella tipologia della ceramica da fuo-co si ha, invece, proprio con le pentole a bordo ingrossato e rientrante. Secondo Lucia Arcifa la ceramica da fuoco isolata a Mineo, proprio per una sua distribuzione attorno al centro di
17 Precisi confronti con questi esemplari in GUTIERREZ LLORET, GRAU MIRA 2012, p. 183, fig. 7; ARDIZZONE 2004, p. 377, fig. 1; CIAMPOLTRINI 2001, p. 463, fig. 4 e BORTOLETTO 1995.
363
NOTE E DISCUSSIONI
fig. 23 – Vito Soldano. Im-pianto termale.
fig. 24 – Materiali Vito Soldano. Ceramica da fuoco e comune. fig. 25 –Materriali Vito Soldano. Ceramica da fuoco e comune.
364
NOTE E DISCUSSIONI
fig. 26 – Coppi striati, striati e vacuolati, solo vacuolati.
viarie e dalla assenza, nei contesti in esame, di qualsiasi traccia di importazioni. E la contestuale assenza nei siti di altura, come Entella e Jato che sono interessati tanto dalla conquista islamica quanto dalle rivolte in età normanna e sveva (MOLINARI 2010a, 2010b, 2010c).
Si può inoltre ampliare la carta delle attestazioni di queste pentole a profilo ingrossato e rientrante ‘tipo Rocchicella’ almeno a tutta la porzione orientale della provincia di Agrigento, con una diffusione puntiforme. Si spiegherebbero, dunque, due fenomeni: l’assenza di tracce di casseruole ‘tipo Rocchicella’, con caratteristiche tettoniche peculiari, dai contesti bizantini calabresi, pugliesi e campani, oltre che dai siti di altura del-l’entroterra siciliano come Entella e Jato occupati da fortezze bizantine conquistate dalle truppe islamiche e l’innovazione, risultato della conquista normanna, epoca in cui sembrano scomparire le casseruole a bordo rientrante e si afferma, invece, la grande olla a orlo indistinto, prese ad orecchia e pareti verticali documentata in contesti di XI-XII d.C.
È probabile che le pentole “islamiche”, fabbricate al tornio, con bordo indistinto e rientrante e ampie prese ad orecchia (ARDIZZONE 2004, p. 384, fig. 4), rappresentino una tappa intermedia.
Fra le anfore documentate mi sembra che un confronto tipologico sia da rintracciare nelle anfore tunisine edite da E. Cirelli (CIRELLI 2002, p. 440, fig. 2.4).
Un cenno, ancora, merita l’attestazione dei laterizi nei nostri siti: nei primi due (Giummello e Ciccobriglio) non sono presenti tegole striate/pettinate a impasto pieno mentre compaiono indi-stintamente tegole vacuolate (per la presenza di paglia ed elementi vegetali nell’impasto) e con striature sulla superficie esterna e tegole con vacuoli ma prive di striature. Nei siti di Vito Soldano e Cangiana sono presenti tegole vacuolate e vacuolate e striate mentre nell’area in cui si sviluppa il sito tardoantico e bizantino si annota una grande presenza di tegole pettinate/striate ma con impasto ‘pieno’ privo di vacuoli (fig. 26). Notiamo come oltre a queste due tipologie di laterizi, in contesti tardo-bizantini22, ne compaia una terza con impasto ‘pieno’ ma con la superficie non pettinata ma caratterizzata da decorazioni digitali.
Condivido la constatazione di L. Arcifa secondo la quale l’editto di Al Mu’izz del 967 «fotografa una situazione già in atto» (ARCIFA, BAGNERA, NEF 2012, p. 267) per cui le campagne risultano occupate da insediamenti piccoli, medi e di grandi dimensioni (e proprio verso questi ultimi l’editto fa confluire la popolazione dei primi due); propongo di vedere nei siti che do-cumentano la presenza di ceramiche da fuoco ‘tipo Rocchicella’ i principali indiziati per questo pattern insediativo a partire alme-no dalla prima metà del IX secolo d.C. (WICKHAM 2010).
Se le sovrastrutture religiose sono i colori che variano la società umana l’archeologia della cultura materiale è ovviamente dalto-nica, ragion per cui non saprei indicare quale fosse l’’identikit’ antropologico e culturale di questi nuovi arrivati ma è più che evidente come i loro gusti e abitudini alimentari fossero radical-mente diversi da quelli fino ad allora predominanti propendendo, forse, per la cottura per brasatura piuttosto che per bollitura23 (ARTHUR 2007, pp. 18-19). Mi chiedo, infine, se la diffusa presen-za di ceramica ‘tipo Rocchicella’ non sia da mettere in relazione
18 Per attestazioni in siti nisseni, oltre a FIORILLA 2010a; BERGEMANN 2011, pp. 87, fig. 9 e BOWES et al. 2011, p. 433.
19 Osserviamo, fra l’altro, che nei siti con olle con bordo a tesa sono attestati altri indicatori archeologici come vetrina pesante, sigilli bizantini e reperti anforici orientali.
20 Questa analogia tipologica è già stata posta in evidenza da ARCIFA 2010a, p. 76.
21 Sulla situazione dell’isola allo scorcio dell’VIII secolo KISLINGER 2010, p. 147. Sull’incastellamento su impulso statale che sarebbe stato avviato già nell’VIII d.C. MAURICI 1992, pp. 42-47 e ID. 1995, pp. 490-494.
Siracusa (e dunque con un areale di diffusione che da Siracusa andrebbe verso ovest) e per una connessione con la presenza bizantina sul territorio potrebbe essere l’indicatore di presenze allogene forse proprio in funzione del clima di insicurezza re-lativo alle incursioni islamiche18 (ARCIFA 2004, 2010a). Come ipotesi di lavoro propongo che la comparsa delle casseruole ‘tipo Rocchicella’ sia legata all’arrivo in Sicilia di usi alimentari e culturali legati alle popolazioni dell’Africa settentrionale forse immigrate nell’isola su pressione della conquista islamica. E di vedere nelle olle con orlo a tesa uno dei markers della presenza tardo-bizantina sul territorio19.
Nei contesti cartaginesi, d’altro canto, sono presenti alcune forme da fuoco, purtroppo non ben databili (si tratta delle forme 32.1 e 32.220 prodotte nel fabric 1.9 di Peacock) che hanno l’orlo ingrossato e rientrante (Carthage 1984, p. 164, fig. 59). Cartagine è già sotto il controllo islamico nel 698 d.C. ma, probabilmente assieme ad altri centri produttivi, dai suoi ateliers continuano a uscire prodotti quali anfore e ceramica per la preparazione dei cibi che si diffondono ancora sui mercati siciliani21 (RIZZO 2010, p. 284, fig. 8). È ben inquadrabile, così, la presenza di questi manufatti in piccoli siti, aperti, la cui vocazione tendenzialmente autarchica e finalizzata allo sfruttamento agricolo è resa palese dalla loro ubicazione lontano dal mare e dalle grandi direttrici
22 A margine di queste note si ricorda che il crollo dell’edificio 2/06 a Cignana, costruito nella seconda metà del V, frequentato fino al primo trenten-nio del VI d.C. e il cui crollo e databile a inizi VII d.C. (RIZZO, ZAMBITO 2010), non sono presenti affatto tegole pettinate ma coppi con bordo ingrossato.
23 Sarebbe interessante sottoporre ad analisi archeometriche alcuni reperti di scavo (come quelli rinvenuti a Colmitella, Racalmuto, AG). Sulle potenzialità di queste analisi cfr. PECCI 2009, pp. 32-33.
365
NOTE E DISCUSSIONI
con un interessante gruppo di sigilli in piombo con iscrizione, datati dalla Prof.ssa M.A. De Luca al IX secolo (DE LUCA 2003, pp. 252-256; ARCIFA 2010b, p. 124 e n. 84 e ARCIFA, BAGNERA, NEF 2012, p. 256 e n. 117), e rinvenuti nell’area di Monte Conca, Rocca Aquilia e Serra del Palco nel territorio di Milena (CL) e a breve distanza dai siti oggetto di questa comunicazione.
BIBLIOGRAFIA
ARCIFA L., 2004, Nuovi dati riguardanti la ceramica di età islamica nella Sicilia Orientale, «MEFRM», 116 (2004), 1, pp. 205-230.
ARCIFA L., 2010a, Indicatori archeologici e dinamiche insediative nella Sicilia tardo bizantina, in CONGIU, MODEO, ARNONE 2010, pp. 67-89.
ARCIFA L., 2010b, Indicatori archeologici per l’altomedioevo nella Sicilia orientale, in P. PENSABENE (a cura di), Piazza Armerina. Villa del Casale e la Sicilia tra tardo antico e medioevo, Roma, pp. 105-128.
ARCIFA L., 2010c, Nuove ipotesi a partire dalla rilettura dei dati archeo-logici: la Sicilia orientale, in A. NEF, V. PRIGENT (eds.), La Sicile de Bysance à l’Islam, Paris, pp. 15-49.
ARCIFA L., BAGNERA A., NEF A., 2012, Archeologia della Sicilia islamica: nuove proposte di riflessione, in P. SÉNAC (ed.), Histoire et archéologie de l’Occident musulman (VII-XV siécle). El Andalus, Maghreb, Sicile, Toulouse, pp. 241-274.
ARDIZZONE F., 2004, La ceramica da fuoco altomedievale della Sicilia occidentale (secc. VIII-XI), in S. PATITUCCI UGGERI, La ceramica altomedievale in Italia. Bilanci e aggiornamenti, Atti del V Congresso di Archeologia Medievale (Roma, 26-27 novembre 2001), Quaderni di Archeologia Medievale, VI, Firenze, pp. 375-386.
ARDIZZONE F., 2010a, Nuove ipotesi a partire dalla rilettura dei dati archeologici: la Sicilia occidentale, in NEF, PRIGENT 2010, pp. 51-76.
ARDIZZONE F., 2010b, Le produzioni medievali di Agrigento alla luce delle recenti indagini nella valle dei Templi, «Albisola» XLII (2009), pp. 275-285.
ARTHUR P., 2007, Pots and boundaries. On cultural and economics areas between late antiquity and the early middle ages, in J.CH. TREGLIA, M. BONIFAY (eds.), LRCW2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, Oxford, pp. 15-27.
BELVEDERE O., 2004, Dal Medioevo alla tarda antichità: gli esiti di una ricerca, in RIZZO 2004, pp. 1-12.
BELVEDERE O., BURGIO A., 2012, Carta archeologia e sistema informativo territoriale del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, Palermo.
BERGEMANN J., 2011, Il Gela survey: 3000 anni d insediamenti e storia nella Sicilia centro meridionale, «Sicilia Antiqua», 8 (2011), pp. 63-100.
BONACASA CARRA R.M., ARDIZZONE F., 2007, Agrigento dal Tardo Antico al Medioevo. Campagne di scavo nell’area della necropoli paleocristiana. Anni 1986-1999, Todi.
BONANNO C., CABELLA R., CAPELLI C., 2010, Nuove esplorazioni in località Gerace, in S. MENCHELLI, S. SANTORO, M. PASQUINUCCI, G. GUIDUCCI (eds.), LRCW3. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean Archaeology and archaeo-metry. Comparison between western and eastern Mediterranean, BAR International Series, 2185 (I) (2010), pp. 261-272.
BONFIGLIO S., 1900, Villaggio bizantino del Balatizzo, «Notizie degli scavi di Antichità», CCXCVII (1900), pp. 511-520.
BONIFAY M., 2004, Etudes sur la céramiques romaine tardive d’Afrique, BAR International Series, Oxford.
BORTOLETTO M., 1995, La ceramica grezza di San Lorenzo di Ammia-na tra tardoantico e altomedioevo, «Archeologia medievale», XXII (1995), pp. 467-474.
BOWES et al. 2011 = BOWES K., GHISLENI M.E., LA TORRE F., VAC-CARO E., Preliminary report on Sofiana/mansio Philosophiana in the hinterland of Piazza Armerina, «JRA» ,24, pp. 423-449.
CACCIAGUERRA G., 2011, Archeologia medievale, proprietà fondiaria e paesaggi: i casali di Aguglia e Bigeni, in D. MALFITANA, G. CAC-CIAGUERRA (a cura di), Priolo Romana, Tardo romana e medievale. Documenti, paesaggi, cultura materiale, Catania, pp. 261-272.
CALIRI E., 2006, Città e campagna nella Sicilia tardoantica: massa fun-dorum e istituto civico, Mediterraneo Antico, IX, 1, Pisa-Roma.
CAMINNECI V., 2012, “Animam in sepulchro condimus”: sepolcreto tar-doantico in anfore presso l’Emporion di Agrigento (Sicilia-Italia), «Rei Cretariae Fautorum Acta», 42, Bonn, pp. 259-266.
Carthage 1984 = FULFORD M.G., PEACOCK D.P.S. (eds.), Excavations at Carthage: The British Mission, Vol. I, 2. The Avenue du Président Habib Bourguiba, Salambo. The Pottery and other Ceramic Objects from the Site, Sheffield 1984.
CASTELLANA G., 1998, I livelli medievali del Saraceno di Favara presso Agrigento ed il commercio granario dai caricatori agrigentini, in S. GELICHI (a cura di), Ceramiche, città e commerci nell’Italia tardo-medievale (Ravello, 3-4 maggio 1993), Mantova, pp. 127-141.
CASTELLANA G., MCCONNELL B., 1990, A rural settlement of Imperial Roman and Byzantine date in Contrada Saraceno near Agrigento, Sicily, «AJA», 94 (1990), pp. 25-44.
CIAMPOLTRINI G., 2001, Vetroniano e Vico Leoniano. Insediamenti “protetti” e vici nel Valdarno, «Archeologia Medievale» XXVIII, pp. 457-496.
CILIA PLATAMONE E., FIORILLA S., 2009, Nuovi dati sulle produzioni ceramiche delle fornaci medievali di Agrigento, in Actas del VIII Congreso Internacional de Céramica Medieval (Ciudad Real 2009), pp. 907-916.
CIRELLI E., 2002, La circolazione delle giare gerbine nel Mediterraneo occidentale: continuità e discontinuità nel commercio di derrate ali-mentari africane in età tardoromana e islamica, in L’Africa romana XIV (Sassari 2002), Roma, pp. 437-450.
CONGIU M., MODEO S., ARNONE M. (a cura di), 2010, La Sicilia bizantina: storia, città territorio. Atti VI Convegno di Studi, Cal-tanissetta.
CORRETTI A., GARGINI M., VAGGIOLI M.A., 2010, Frammenti di me-dioevo siciliano: Entella e il suo territorio dall’alto medioevo a Federico II, in P. PENSABENE (a cura di), Piazza Armerina. Villa del Casale e la Sicilia tra tardo antico e medioevo, Roma, pp. 147-196.
CORRETTI et al. 2006 = CORRETTI A., FACELLA A., GARGINI M., VAG-GIOLI M.A., Per una carta storico-archeologica del Comune di Contessa Entellina dati archeologici preliminari (1998-2002), in Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VIII-III sec. a.C.), Atti delle Quinte Giornate Internazionali di studio sull’area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo (Erice, 12-15 ottobre 2003), Pisa 2006, pp. 561-593.
D’ANGELO F., 2010, Le produzioni di ceramiche invetriate dipinte in Sicilia nei secoli X-XII, «Mediaevalsophia». Studi e ricerche sui saperi medievali, 8 (luglio-dicembre 2010), pp. 108-140.
DE LUCA M.A., 2003, Reperti inediti con iscrizioni in arabo rinvenuti nel sito archeologico di Milena: i sigilli e le monete, in M.V. FONTANA, B. GENITO (a cura di), Studi in onore di U. Scerrato, I, Napoli, pp. 231-258.
DE MIRO E., 2009, Il quartiere ellenistico romano di Agrigento, Roma.FIORENTINI G., 1996, Il Ginnasio di Agrigento, «Kokalos», XLII (1996),
pp. 5-14.FIORILLA S., 1991, Ceramiche medievali e postmedievali. Bibliografia
e rassegna degli studi, «Archivio storico messinese», 58 (1991), pp. 13-46.
FIORILLA S., 2009, Sofiana medievale: un abitato siciliano sull’itinerario antonino Catania-Agrigento. Nuove acquisizioni dallo studio dei ritrovamenti ceramici, in G. VOLPE, P. FAVIA (a cura di), Atti del V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Manfredonia-Foggia 2009), Firenze, p. 336-340.
FIORILLA S., 2010a, Santo Spirito tra latifondo e abbazia, in CONGIU, MODEO, ARNONE 2010, pp. 91-111.
FIORILLA S., 2010b, I rinvenimenti, in S. SCUTO, S. FIORILLA (a cura di), Delia. Il Castellazzo. Scavi e restauri (1987-1995), pp. 77-174, Caltanissetta 2010.
FIORILLA S., CILIA PLATAMONE E., 2005, Dalle collezioni del Museo regionale della ceramica di Caltagirone; nuove acquisizioni sulle ceramiche delle fornaci medievali di Agrigento, «Albisola», XXXVI (2003), pp. 161-168.
FIORILLA S., CILIA PLATAMONE E., 2007, Ceramiche da fuoco e da dispen-sa della fornace tarda di Contrada S. Lucia ad Agrigento, «Albisola», XXXIX (2006), pp. 141-151.
366
NOTE E DISCUSSIONI
GABRICI E., 1925, Scavi e scoperte archeologiche dal 1916 al 1924, «NSA» (1925), pp. 423-425.
GIACCONE N., 2012, sub voce Vito Soldano, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, XXI (2012), Pisa-Roma-Napoli, pp. 999-1001.
GUTIERREZ LLORET, GRAU MIRA I., 2012, El territorio tardoantiguo y altomedieval en el sureste de Hispania: Eio-Iyyuh como caso de estudio, in L. CABALLERO ZOREDA, P. MATEO CRUZ, T. CORDERO RUIZ (eds.), Visigodos y Omeyas el teritorio, Merida, pp. 171-198.
KISLINGER E., 2010, La città bizantina in Sicilia come centro ammini-strativo, in CONGIU, MODEO, ARNONE 2010, pp. 147-167.
LAGUMINA B., 1904, Ripostiglio di monete arabe rinvenuto a Girgenti, «Archivio Storico Siciliano», n.s. XXIX (1904), pp. 80-90.
MAURICI F., 1992, Castelli medievali in Sicilia. Dai bizantini ai nor-manni, Palermo.
MAURICI F., 1995, L’insediamento medievale in Sicilia: problemi e prospet-tive di ricerca, «Archeologia Medievale», XXII (1995) pp. 487-500.
MOLINARI A., 2010a, La ceramica siciliana di età islamica tra interpre-tazione etnica e socioeconomica, in P. PENSABENE (a cura di), Piazza Armerina. Villa del Casale e la Sicilia tra tardoantico e medioevo, Roma, pp. 196-228.
MOLINARI A., 2010b, La ceramica siciliana di X e XI secolo tra circolazione interregionale e mercato interno, in S. GELICHI, M. BALDASSARRI (a cura di), Pensare classificare: studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti, Firenze, pp. 159-170.
MOLINARI A., 2010c, Paesaggi rurali e formazioni sociali nella Sicilia islamica, normanna e sveva (secoli X-XIII), «Archeologia Medievale», 37, 2010, pp. 229-245.
MOLINARI A., NERI I., 2004, Dall’età tardoimperiale al XIII secolo. I risultati delle ricognizioni di superficie nel territorio di Calatafimi/Se-gesta (1995-1999), «MEFRM» 116, 1, 2004, pp. 109-127.
MOLINO N., 1985, La rete FS a scartamento ridotto della Sicilia, Torino.NEF A., PRIGENT V., 2010, La Sicile de Byzance à l’Islam, Paris.PECCI A., 2009, Analisi funzionale della ceramica e alimentazione medie-
vale, «Archeologia medievale», XXXVI (2009), pp. 21-42.PRIGENT V., NEF A. 2006, Per una nuova storia dell’altomedioevo sici-
liano, «Storica», 35-36, XII (2006), pp. 9-63.RAGONA A., 1996, Le fornaci medievali scoperte in Agrigento e l’origine
della maiolica in Sicilia, «Faenza», LII (1966), pp. 83-89.RECCHIA V., 1978, Gregorio Magno e la società agricola, Roma.RIZZO M.S., 2004, L’insediamento medievale nella valle del Platani,
Roma.RIZZO R., 2008, Papa Gregorio Magno e la nobiltà in Sicilia, Palermo.RIZZO R., 2009, Prosopografia siciliana nell’epistolario di Gregorio
Magno, Roma.RIZZO M.S., 2010, L’abitato rurale nell’agrigentino nella prima età
bizantina, in CONGIU, MODEO, ARNONE 2010, pp. 277-296.RIZZO M.S., DANILE L., ZAMBITO L., c.s., L’insediamento rurale nel
territorio di Agrigento: nuovi dati da prospezioni e scavi, in Atti Convegno Islamizzazione (Palermo 2012).
RIZZO M.S., ZAMBITO L., 2010, Ceramiche comuni e anfore dal villaggio tardoantico di Cignana, in S. MENCHELLI, S. SANTORO, M. PASQUI-NUCCI, G. GUIDUCCI (eds.), LRCW3. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean Archaeology and archaeometry. Comparison between western and eastern Mediterra-nean, BAR International Series, 2185 (I) (2010), pp. 293-300.
RIZZO M.S., ZAMBITO L., 2012, Ceramiche da fuoco di età tardo-antica e della prima età bizantina dal territorio agrigentino: nuovi dati da Cignana e Vito Soldano, «Rei Cretariae Fautorum Act»a 42, Berlin 2012, pp. 289-298.
ROTOLO A., MARTÍN CIVANTOS J.M., 2012, Il territorio dei monti di Trapani in epoca islamica. Primi risultati dall’Idrisi Project ARPITRA, in F. REDI, A. FORGIONE (a cura di), VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (L’Aquila 2012), Firenze, pp. 413-418.
SAMI D., 2011, From Theodosius to Constans II: Church, Settlement and Economy in Late Roman and Byzantine Sicily (AD 378-668),
Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History University of Leicester.
SAMI D., 2013, Sicilian cities between the fourth and the fifth centuries AD, in R. GARCÌA-GASCO, S. GONZÀLEZ SÀNCHEZ, D. HERNÀNDEZ DE LA FUENTE (eds.)The Theodosian Age (A.D. 379-455). Power, place, belief and learning at the End of the Western Empire, Bar I.S. 2039, pp. 27-36.
VACCARO E., 2013, Sicily in the Eighth and Ninth Centuries AD: A Case of Peersisting Enonomic Complexity?, «Al Masaq», 58, pp. 34-69.
VERA D., 1999, Massa fundorum, Forme della grande proprietà e poteri della città in Italia fra Costantino e Gregorio Magno, «MEFRA» (1999), 111, pp. 991-1025.
WILSON R.J.A., 1979, Brick and tiles in Roman Sicily, in A. MCWHIRR (ed.), Roman brick and tiles, London.
WICKHAM C., 2005, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean 400-800, Oxford.
WICKHAM C., 2010, Archeologia e mondi rurali: quadri di insediamento e di sviluppo economico, «Archeologia Medievale», XXXVII, pp. 277-284.
SummaryNotes on the Early Middle Ages in the territory of Agrigento.The aim of this paper is to illustrate the material culture of some
sites located east of the centre of Agrigento which offer new data for the revision and modification of the concept of settlement in the Early Middle Ages in Sicily and of the sequence of the types and shapes of cooking pottery which, in our opinion, was indicative of a shift in the tastes and customs which in turn was directly related to a change in the ethnic and anthropological composition of the rural settlements. The smallest sites, in fact, which seem to have been involved in the primary exploitation of the agricultural resources, appear in the 9th century AD and were no longer frequented by the middle of the 10th century AD when the arrival of glazed pottery makes it possible to determine the chronology with greater precision. Besides this ex-silentio proof of the chronology of the sites, one must consider the fact that the aban-donment of the minor settlements is related to what we know of the legislation made after the Aglabidi rose to power, and in particular, the often cited edict of Al Mu’izz which determined the redistribution of settlements in favour of those that were easy to defend and to control. The larger settlements and those for which earlier settlement phases have been documented, not only survive beyond the mid-10th century but are probably identifiable as farmhouses (rihal) in the settlement structure of the following period.
RiassuntoObiettivo di questo contributo è illustrare la cultura materiale di
alcuni siti ubicati ad est del centro di Agrigento che offrono alcuni spunti per una revisione e una messa a punto circa le modalità inse-diative nell’alto Medioevo siciliano e sulla successione di tipi e forme di ceramica da fuoco indicativi, riteniamo, di una mutazione di gusti e costumi direttamente correlata alla mutata composizione etnica e antropologica degli abitati rurali. I siti più piccoli, infatti, che sembrano vocati allo sfruttamento primario delle risorse agricole, sembrano sor-gere nel IX e cessare di essere frequentati prima della metà del X secolo d.C. quando l’arrivo delle produzioni invetriate consente di precisare meglio le cronologie. A questa prova ex silentio circa la cronologia dei siti, si aggiunga come il quadro di un abbandono dei centri minori possa collimare con quanto conosciamo della legislazione successiva all’ascesa al potere degli Aglabidi e, in particolare, con il più volte citato editto di Al Mu’izz che dovette determinare una redistribuzione dei centri abitati in favore di quelli meglio difendibili e controllabili. Quelli di maggiori dimensioni, invece, e in cui sono documentabili fasi insediative precedenti, non solo sopravvivono alla metà del X ma con ogni evidenza sono identificabili come casali (rihal) nella struttura insediativa di età successiva.