I Templari a Bologna e frate Pietro
-
Upload
nottinghamtrent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of I Templari a Bologna e frate Pietro
7
Giampiero Bagni
I Templari a Bologna e frate Pietro
Il presente lavoro riguarda la mia ricerca sui Templari a Bolo-gna, con una particolare attenzione rivolta al famoso fratello Pietro da Bologna, procuratore generale nella Curia Romana, con lo sco-po di scoprire la sua vera identità e alla ricerca di una comprensio-ne più dettagliata della sua vita. Quest’articolo fa parte del mio progetto di ricerca di dottorato sulla casa templare di Bologna per identificarne nel dettaglio i beni, i personaggi principali e il ruolo politico svolto.1
Il potere economico dei Templari alla fine del XIII secolo era cresciuto notevolmente attraverso le numerose donazioni di beni e d’immobili compiute da pellegrini, re e nobili. Tutte queste pro-prietà erano state ben gestite dall’Ordine e utilizzate per costruire un significativo reddito utile per sostenere l’azione dell’Ordine in Terrasanta.
Alla fine del XIII secolo inoltre, il regno di re Filippo il Bello di Francia si trovava in una situazione economica disperata per dover sostenere tutte le guerre e le campagne che il re stava con-ducendo. Grazie alla sua influenza sul papa, Clemente V, il re fu quindi in grado di sfruttare a suo favore le critiche mosse ai Tem-plari relativamente all’efficacia e alla moralità dell’Ordine dopo la caduta di Acri nel 1291.2 Così l’Ordine apparve al re come un’altra facile possibile fonte di denaro, ottenibile attraverso un’accusa di
1 Le immagini di questo articolo sono tratte dal mio libro G. Bagni, Templari a Bologna, Tuscania 2012. Per l’utilizzo delle immagini si ringraziano le E-dizioni Penne e Papiri di Tuscania. 2 Per una discussione scientifica sulla questione vedi H.Nicholson, Templars, Hospitallers and Teutonic Knights: Images of the Military Orders, Leicester 1993.
8
eresia, oltre a ciò che aveva già ottenuto con la forza, dagli ebrei, dai banchieri fiorentini e altri.
Per conseguire questo risultato il re diede inizio al processo ai Templari, nell’Ottobre del 1307, con l’arresto dei Templari pre-senti in Francia. Nel primo periodo del processo il papa non fu in grado di agire, in qualsiasi modo, per tutelare l’Ordine e solo nel-l’estate del 1308 papa Clemente V scrisse la bolla Faciens miseri-cordiam che avocava a sé tutti i processi intentati relativi ai Tem-plari, sottraendoli al controllo laico, in modo da garantire la giuri-sdizione di tutti i processi locali alle autorità ecclesiastiche. Da questo punto, molti processi locali si svolsero in tutta Europa, ma l’attenzione rimase focalizzata su Parigi, dove l’Ordine ebbe una delle sue principali basi.
Questa relazione vuole analizzare una tappa cruciale nel pro-cesso dei Templari, che si tenne a Parigi nella primavera del 1310, quando all’Ordine fu finalmente consentito di difendersi adegua-tamente nominando quattro avvocati guidati da Pietro da Bologna, il procuratore generale dei Templari presso la Curia Romana.3 Questo processo francese è stato uno dei più importanti perché là erano detenuti il maestro generale dei Templari, Jacques de Molay, e molti altri cavalieri-chiave.
Il Templare Pietro da Bologna È noto da tempo che Pietro difese l’Ordine dal marzo 1310 al
18 maggio 1310 e che poi scomparve. Molti storici importanti co-me Michelet, Lizerand, Oursel e Partner hanno concluso che egli possa essere morto in prigione a Parigi. Lo hanno identificato co-me il principale difensore dell’Ordine in questo processo e come colui che svanì nel nulla nel momento in cui il vescovo di Sens, che aveva giurisdizione sulla città di Parigi, iniziò a giustiziare i Templari che erano sotto la sua custodia. 3 R. Oursel, Le procès, Paris 1955, p. 81; J. Michelet, Procès des Templiers, vol. II, Paris 1841, p. 398; G. Lizerand, Le dossier de l’affaire des Tem-pliers, Paris 1923, p. 156; P. Partner, I Templari, Torino 1987, p. 88.
9
Gli storici moderni della Massoneria invece ipotizzarono che Pietro scappò da Parigi per raggiungere La Rochelle e poi la Sco-zia, dove agì come tramite per collegare la “conoscenza” dei Tem-plari alla Massoneria, con la creazione del grado scozzese templa-re.4
Dal mio studio delle fonti locali a Bologna, posso fornire un re-soconto molto diverso del suo destino, attraverso nuove fonti che descrivono i suoi movimenti dopo il processo. Sappiamo dagli stessi storici di cui sopra, che egli è descritto come: un esperto le-gale, prete, bolognese e che era il procuratore generale dell’Ordine presso la Curia Romana. Tuttavia non abbiamo il suo nome com-pleto o ulteriori informazioni sulla sua vita.
Ci sono diverse fonti locali, sia contemporanee sia successive, negli archivi emiliano-romagnoli, che menzionano Pietro durante gli anni del processo ed in seguito.
Analizzeremo questi materiali in ordine cronologico: le prime fonti trattate sono i documenti originali prodotti dalla Cancelleria dell’arcivescovo di Ravenna, Rinaldo da Concorezzo, che fu no-minato dal papa giudice principale nei processi locali nel nord-est d’Italia che si svolsero tra il 1309 e il 1311. Nel settembre 1309 Rinaldo fu, infatti, finalmente in grado di prendere il posto dell’In-quisizione nella gestione dei beni templari a Bologna. Tra questi documenti prodotti dalla Cancelleria, vi è un inventario dei beni dei Templari, in cui sono menzionati alcuni Templari nominati per gestire le aziende agricole templari nel territorio di Bologna. Que-sto inventario è stato redatto dall’Inquisizione nel marzo 1309, prima quindi che l’arcivescovo sostituisse l’Inquisizione nella loro gestione: è stato però utilizzato successivamente da Rinaldo e ac-quisito dalla sua Cancelleria e tuttora è conservato nell’Archivio Arcivescovile di Ravenna. In un passo all’interno di queste otto pagine di pergamena dell’inventario è citato un Petrum de Rotis, che è posto a capo di un’importante fattoria nella prima periferia di Bologna, dopo l’agosto 1308, quando l’inquisitore ha preso pos-
4 A. Ramsay . M., Discours, 1741, p. 22.
10
sesso dei beni dei Templari e prima del marzo 1309, quando l’in-ventario è stato completato come da datazione del notaio alla fine del documento.5 Questa è la prova che, in questa data, questo Tem-plare era a Bologna. La mia ipotesi, come vedremo nel dettaglio in seguito, è che Pietro Rota sia il nome completo del fratello Pietro da Bologna, il famoso difensore al processo di Parigi.
Un altro documento interessante sempre conservato all’Archi-vio Arcivescovile di Ravenna e datato 13 ottobre 1309, è quello in cui l’arcivescovo fornisce «vitto e alloggio» ai Templari bolognesi che erano sotto la sua custodia durante il processo locale, insieme ai vestiti e denaro.6 Si parla, in questo documento, di un Pietro co-me precettore della casa di Bologna. Se Pietro Rota fu precettore della casa di Bologna, in questo periodo, sembra probabile che o-gni volta che venga menzionato un Pietro precettore bolognese, in qualsiasi documento locale, ci si riferisca a lui.
Abbiamo inoltre la registrazione di un atto giuridico, fatta da un notaio nell’ufficio comunale di Bologna, ora nel fondo Memoriali dell’Archivio di Stato di Bologna,e datato 8 ottobre 1313, in cui è citato un Petrus de Monte Achuto (Monte Acuto è un piccolo vil-laggio nel territorio montano controllato da Bologna), che fu il precettore della casa templare di Bologna.7 Dopo il concilio di Vienne del 1312 il papa decise, con la bolla papale Ad providam Christi vicarii di destinare i beni templari agli Ospitalieri: dal do-cumento, un arbitrato, si evince che questo Pietro era un esperto di diritto, rappresentando localmente l’Ordine del Tempio nell’appli-cazione locale della bolla papale sopra menzionata, relativa al pas-saggio delle proprietà templari agli Ospitalieri. Questa persona è menzionata anche come camerario dell’arcivescovo di Ravenna Rinaldo.
Dato che quest’uomo è documentato come essere a Bologna in questa data e che Pietro Rota fu precettore di Bologna in questo periodo e in precedenza, è necessario verificare se fossero questi 5 AARa 12575. 6 AARa 9688. 7 ASBo, Ufficio dei Memoriali, Reg. 127 (1313), c.110r.
11
due Pietri siano la stessa persona. Nella relativamente piccola casa templare di Bologna sembra molto improbabile che vi fossero due Templari chiamati Pietro, entrambi esperti legali, ed entrambi pre-cettori nello stesso periodo. Una seria indagine storica dell’identità di Pietro da Bologna necessita di un ampio lavoro di confronto delle diverse fonti: quest’articolo deve essere considerato solo un primo passo in questa ricerca.
Un altro testo importante, in questa verifica dell’ipotesi formu-lata, è il libro scritto da Nicolò Pasquali Alidosi, uno storico loca-le, in merito all’identità dei cavalieri bolognesi di tutti gli Ordini, che erano presenti a Bologna dal XIII secolo al 1616.8 Non cono-sciamo tutte le fonti utilizzate da quest’autore, ma i nomi dei cava-lieri templari segnalati dall’Alidosi sono in parte confermati in di-versi documenti medievali relativi al processo locale ai Templari. Il libro è stato dedicato inoltre ad un importante cavaliere di Malta: ciò può rafforzare la credibilità dell’autore perché avrebbe potuto avere accesso all’archivio locale dell’Ordine di San Giovanni. Egli elenca i Templari bolognesi e mostra che nel 1304 ci fu un cava-liere chiamato Pietro Rota che era procuratore generale dei Tem-plari presso la Curia Romana (fig. 1). Questo libro fornisce anche una lista di Ospitalieri, che comprende lo stesso Pietro Rota che è elencato come divenuto cavaliere di San Giovanni nel 1315, in-sieme con la trascrizione dell’iscrizione sulla sua tomba che fu vi-sta da Alidosi nella chiesa di Santa Maria del Tempio (fig. 2), in Strada Maggiore, a Bologna. Dobbiamo notare che numerose fonti medievali confermano le varie informazioni fornite da Alidosi in questi elenchi di cavalieri bolognesi.
Analizzando questi tipi di fonti sepolcrali locali, possiamo con-centrarci su due iscrizioni rinvenute sulle tombe segnalate da un altro storico locale, Marcello Oretti, nel XVIII secolo.9 Queste se-polture erano all’interno della stessa chiesa, Santa Maria del Tem-pio. 8 N. Pasquali Alidosi, Tutti li Cavalieri bolognesi di tutte le religioni et ordi-ni, Bologna 1616, pp. 9-10. 9 BCB, Ms Oretti, B 114, cc. 205r-v.
12
Figg. 1-2: quattro pagine del testo di N. Pasquali Alidosi, Tutti li Cavalieri bolognesi di tutte le religioni et ordini, Bologna 1616.
13
La prima è l’iscrizione sulla tomba di frate Bartolomeo Tenca-rari, riportato come segretario di fra’Pietro, che in precedenza era stato procuratore generale dei Templari presso la Curia Romana. Questa persona è anch’egli nella lista di Alidosi dei Templari bo-lognesi nel 1304-1314 ed è confermata la sua presenza anche dai documenti d’inizio trecento riguardanti il processo locale all’Ordi-ne.
La figura 3 mostra il disegno della possibile tomba di Pietro, come riportato da Oretti stesso,che la vide nella medesima chiesa al centro del pavimento.
Fig. 3: riproduzione della tomba di Pietro de Rotis, come pubblicata nel testo di N. Pasquali Alidosi.
14
L’iscrizione, che ha esattamente lo stesso testo di quello ripor-tato in precedenza da Alidosi, può essere tradotta come segue:
(Qui giace) Pietro della famiglia Rota, illustre in grazia della <sua> virtù. Qui riposa l’intrepido difensore legale di Cristo, amato in seno all’Ordine. Sulla tunica portando lo spirito <i valori morali>, che cui era dotato, e la croce. Ora scala le vette supreme e ci offre l’esempio di uno sguardo che contempla le cose del cielo nell’anno 1329, alla sesta ora, nel quarto <giorno> di maggio, la luce ha attraversato gli organi della mente . Nella figura 3, inoltre,il soggetto è rappresentato in abito litur-
gico, com’era prevedibile che fosse se questa persona è stata cor-rettamente identificata come il sacerdote Pietro da Bologna.
Il nome della famiglia Rota (o Roda) viene registrato nella città di Bologna, e nella zona montana dove si trova il Monte Acuto, come una famiglia ragionevolmente importante proveniente dalla Lombardia fin dal XII secolo. Tuttavia, Roda non è un nome di fa-miglia comune di Bologna, ma è attestata comunque con certezza, nel XIII secolo, la sua presenza, già in una buona posizione nella società locale.
Un’altra fonte interessante è l’antica campana della locale ma-gione in cui è inscritto il nome di Pietro da Bologna, come colui che ebbe l’autorità per far fare per primo la campana nel 1303, di-mostrando quindi che egli era a Bologna nel 1303 e in una posi-zione di alto livello nella locale magione. Durante il periodo napo-leonico, il governo locale ha acquisito le proprietà degli Ospitalieri e alcuni oggetti sono stati venduti, come questa campana, che ora è in un campanile nella campagna bolognese a Montebudello. La sua iscrizione, infatti, recita:
Frate Pietro da Bologna fece nel 1303, Cesare Lambertini, commendatario di S. Maria del Tempio rifece nel 1779...
Era pratica comune, quando le campane di una chiesa venivano
rifuse, citare l’iscrizione originale per esprimere la continuità della
15
devozione. Può essere il caso che Lambertini, ogni mattina, andan-do nella sua chiesa, abbia visto la tomba del suo predecessore Pie-tro, che sembra quindi debba essere morto necessariamente come un fratello ospedaliero.
Ci sono anche documenti legali relativi ai Templari a Bologna nel 1313, come accennato prima, sotto forma di registrazioni fatte dai notai nell’ufficio comunale preposto di Bologna nei primi anni del XIV secolo, in cui Pietro è menzionato: la ricerca su questo materiale d’archivio specifico, identificato come fondo Ufficio dei Memoriali, è lontana dall’essere completata per la presenza di cir-ca 20.000 registrazioni fatte per ogni anno dopo il 1265. In effetti, per tutti i notai bolognesi era necessario registrare presso il Comu-ne, dopo al massimo due giorni, tutti gli atti redatti con un valore superiore alle 20 lire. Confrontando queste registrazioni con i do-cumenti già presentati, è possibile verificare quindi se Pietro Rota sia la stessa persona di Pietro da Bologna, mettendo a confronto tutti i diversi tipi di fonti locali in sequenza cronologica.
Analizzando quindi l’insieme di questi elementi di prova pos-siamo notare che l’iscrizione della campana riferisce che nel 1303 “Pietro da Bologna” era a Bologna come precettore, e lo storico locale Alidosi, ha riferito che nel 1304 Pietro Rota era procuratore generale dei Templari presso la Curia Romana. Seguendo l’ordine cronologico, possiamo osservare che l’inventario delle proprietà templari riferisce che marzo 1309 Pietro de Rotis era un importan-te templare presente a Bologna.
Per quanto riguarda i legami tra “de Rotis”, “Rota” o “Roda”, è importante notare che, in quegli anni, latino e volgare italiano coe-sistevano in scritti letterari o giuridici, come esemplificato nella Divina Commedia di Dante Alighieri. Il poeta, per inciso, ha vissu-to a Bologna e Ravenna in quel periodo ed è possibile che lui a-vesse conosciuto tutti i protagonisti di questa vicenda: il papa, Pie-tro e l’arcivescovo Rinaldo. Essi, infatti, avevano probabilmente studiando legge tutti insieme a Bologna intorno al 1280. Queste conoscenze inoltre potrebbero aver influenzato Dante, anche in se-guito, nel prendere la parte dei Templari, quando stava scrivendo il
16
Purgatorio a Ravenna nel 1313, due anni dopo l’assoluzione loca-le dei Templari da parte dell’arcivescovo Rinaldo sempre a Raven-na. Dante ha, infatti, scritto nel XX Canto del Purgatorio:
Veggio il novo Pilato sì crudele, che ciò nol sazia, ma sanza decreto portar nel Tempio le cupide vele. O Segnor mio, quando sarò io lieto a veder la vendetta che, nascosa, fa dolce l’ira tua nel tuo secreto?10
Il novo Pilato è il re di Francia Filippo il Bello che senza l’auto-
rizzazione papale si appropriò dei beni del Tempio. Dante si chie-deva quando avrebbe potuto vedere la vendetta che, al momento della stesura di questi versi, infatti, non si era ancora consumata con la morte, solo nel 1314, sia del papa che di Filippo il Bello.
Possiamo ora proseguire la sequenza cronologica ricostruttiva basata sulle fonti con il documento datato ottobre 1309 in cui ve-niva fornito vitto e alloggio ai Templari bolognesi in custodia al-l’arcivescovo Rinaldo, in cui si segnala la presenza di un Pietro precettore della Magione.
Proseguendo con quest’analisi, abbiamo un documento datato giugno 131111 che riporta che Pietro fu precettore della Magione di Bologna e fu giudicato innocente nel processo a Ravenna dall’arci-vescovo Rinaldo. Purtroppo questo documento è danneggiato e abbiamo solo brevi riferimenti a Pietro da parte dello storico locale Rossi che hanno provocato varie perplessità sulla correttezza della trascrizione dei nomi riportati e sulle fonti realmente consultate.12
Dopo due anni di silenzio nelle fonti locali, vi è la registrazio-ne, del 1313, in cui si menziona un Pietro da Monte Acuto come già precettore della magione bolognese, e, al momento, anche ca-
10 Dante Alighieri, Purgatorio, XX, 91-96. 11 AARa 8011. 12 H. Rubei, Historiarum Ravennatum libri decem, Venezia 1589.
17
merario dell’arcivescovo di Ravenna Rinaldo. L’informazione più importante è stata riferita dallo storico loca-
le Alidosi riguardo al fatto che nel 1315 Pietro Rota, in precedenza un fratello del Tempio, divenne un Ospedaliero ed è ricordato co-me «pugil», vale a dire come un difensore nel processo giudizia-rio. Infatti anche nella lapide disegnata da Oretti, e mostrata in fi-gura 3, Pietro Rotis, Stirpe roti petrus, è ricordato come «pugil» vale a dire di nuovo come difensore legale.
L’ultima fonte posta in sequenza è l’iscrizione sulla tomba di frate Bartolomeo, morto nel 1323, in cui è citato come egli fosse stato segretario di frate Pietro, già procuratore generale dell’Or-dine nella Curia Romana.
Questa raccolta diversificata di fonti dipinge un quadro piutto-sto diverso della vita di Pietro. Basandosi su ciò possiamo così i-potizzare la ricostruzione della sua vita: egli nacque probabilmente sulle colline bolognesi a Monte Acuto, infatti il nome di Pietro da Bologna usato a Parigi, così lontano da Bologna, non è indicativo di una specifica località bolognese di nascita. Il suo cognome era Rota (Rotis), nome di famiglia attestata a Monte Acuto e a Bolo-gna a quel tempo; era procuratore generale dell’Ordine presso la Curia Romana e probabilmente anche precettore della magione templare bolognese. Nel 1309 è attestato a Bologna nell’inventario dei beni dei Templari, nel 1311 fu giudicato innocente nel proces-so di Ravenna, nel 1313 è stato identificato a Bologna probabil-mente come camerario dell’arcivescovo di Ravenna, nel 1315 di-venne cavaliere di San Giovanni, e, infine, nel 1329 fu sepolto, come rappresentato in figura 3, in Santa Maria del Tempio, lungo la via Emilia, vicino alle mura della città di Bologna, chiesa di-strutta durante l’ultima guerra mondiale. Nessuna informazione lo-cale su di lui è disponibile per il 1310, l’anno del processo a Pari-gi.
Se questa identificazione è corretta, c’è la possibilità che Pietro sia sopravvissuto al processo a Parigi nel 1310 e che, più tardi, sia divenuto un cavaliere di San Giovanni e come tale la sua tomba sia stata rispettata e venerata fino alle soppressioni napoleoniche.
18
Quest’articolo rappresenta solo il primo passo in questa ricerca e un confronto più ampio delle fonti, collegate a lui, dovrebbe rive-lare le conferme più esplicite della sua identità e maggiori dettagli sulla sua vita e carriera nell’Ordine dei Templari.
I luoghi templari bolognesi La Magione templare bolognese era nota come una delle più
ricche della provincia ecclesiastica ravennate per i possedimenti annessi e per il numero di frati templari che vi risiedevano, oltre che per la sua posizione geografica strategica. Il mio progetto di ricerca, per la Nottingham Trent University, è volto ad approfondi-re ogni aspetto della vita della casa templare bolognese: luoghi, manufatti, personaggi coinvolti, connessioni politiche, rilevanza economica.
I Templari bolognesi dimorarono nella Magione di Santa Maria del Tempio, ove alla magione stessa era annessa la chiesa di Santa Maria Maddalena, situata in Strada Maggiore, tra via Torleone e vicolo Malgrado. In passato questo luogo era contrassegnato con i civici 214 e 21513 all’angolo con via Torleone, e 213 e 213/1 al-l’angolo con vicolo Malgrado, ora con i civici 80-82-84 di Strada Maggiore nel centro storico di Bologna. La Magione fu, come d’a-bitudine, costruita fuori dalle mura cittadine della penultima cer-chia, lungo la Via Emilia verso est.
Sempre fuori le mura, lungo la Via Emilia, l’Ordine possedeva anche la piccola chiesetta di Sant’Homobono.
Le fonti più importanti per la ricostruzione dei beni templari a Bologna sono in primis l’Inventario fatto redigere dall’Inquisi-zione nel 1309 e ora conservato presso l’Archivio Arcivescovile di Ravenna, gli atti dell’Ufficio dei Memoriali, che raccoglieva le re-gistrazioni degli atti stipulati dai notai bolognesi, e da qualche raro atto ritrovato in fondi diversi. Nel fondo Santa Maria del Tempio 13 G. Guidicini, Cose notabili della città di Bologna ossia Storia cronologica de’ suoi stabili sacri, pubblici e privati, Bologna 1868 (rist. anast. Bologna 1972), vol. III, pp. 13 ss.
19
all’interno delle Corporazioni Religiose Soppresse (Fondo Dema-niale), conservato all’Archivio di Stato di Bologna, vi sono docu-menti datati a partire dai primi decenni del XV secolo di carattere eminentemente tecnico-giuridico e di rendiconto. Non vi erano perciò documenti coevi disponibili in modo sistematico e rilevanti ai fini di questa ricerca, anche se molto utili sono stati i cabrei, cioè le mappe settecentesche delle proprietà della commenda di Santa Maria del Tempio all’epoca di proprietà dei cavalieri di Malta. Interessante è la notizia riportata dal Pini,14 che cita una let-tera inviata da papa Innocenzo III, il 30 ottobre 1213, a Bologna indirizzata agli abati dei monasteri di Santo Stefano, San Procolo, al priore di San Giovanni in Monte, alla Domus Hospitalarii Gero-solimitani e al maestro della Domus Militiae Templi perché venis-sero consegnate al suo inviato le somme di denaro depositate pres-so di loro. Ciò a dimostrazione del fatto che la Magione già esiste-va ed era ben conosciuta.
Grazie a uno dei cabrei conservati all’Archivio di Stato di Bo-logna,15 datato 1741, si è presentata poi la possibilità di visionare le immagini della Magione e delle sue dipendenze con una descri-zione dei vari piani in cui era suddiviso il palazzo e la sua facciata (fig. 4). La posizione dell’edificio e parte della forma originaria, compreso il “chiostro” e una sala, risalente alla fine del Duecento, denominata ancora oggi “Sala dei Cavalieri”, da allora paiono ri-maste inalterate. Chiaramente ci sono stati molti rifacimenti nel corso dei secoli che hanno alterato la struttura originaria, senza contare i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale che han-no infine distrutto quasi completamente la chiesa annessa. Que-st’ultima, dedicata a Santa Maria Maddalena, era lunga 60 piedi (quasi 23 metri) e larga 25 (9 metri e mezzo), ed era a una sola na-
14 A.I. Pini, Gli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme a Bologna nel XII-XIII secolo: prime ricerche, in Riviera di Levante tra Emilia e Toscana: un crocevia per l’Ordine di San Giovanni, Atti del Convegno (Genova-Chiavari-Rapallo, 9-12 settembre 1999), Genova 2001, pp. 389 ss. 15 ASBo, Corporazioni religiose soppresse (Demaniale), Santa Maria del Tempio, b. 19/2098.
20
vata con l’abside quadrata liturgicamente orientata, cioè rivolta verso via Malgrado col fianco su Strada Maggiore.16
Da documenti registrati presso l’Ufficio dei Memoriali, nel Re-gistro 133 del 1317 e nel Registro 165 del 1329, si ha la conferma della dedicazione della chiesa a Santa Maria Maddalena.17
Fig. 4: il prospetto della Magione di Santa Maria del Tempio in un cabreo del 1741, conservato presso l’Archivio di Stato di Bologna.
16 Opera Pia Poveri Vergognosi ed aziende riunite (a cura di), Palazzo Sala-roli, Strada Maggiore 80, Bologna. Lavori di ristrutturazione: relazione sto-rica dell’Edificio, Bologna 2007. 17 ASBo, Ufficio dei Memoriali, Reg. 133 (1317), c. 120v; Reg. 165 (1329), c. 1v.
21
In definitiva, ciò che rimane dell’antica Magione e che oggi può essere osservato è la forma, seppur rimodernata, del palazzo e la sala interna (fig. 5), che viene utilizzata per le esigenze parroc-chiali, ma che fortunatamente conserva il soffitto in travi di legno e le spesse mura intervallate da finestre ad arco acuto, che ho potu-to datare scientificamente attraverso lo studio dei carotaggi fatti nelle antiche travi, utilizzando la dendrocronologia e il C14, al 1294 con un’incertezza di sette anni quindi nell’ultima fase del possesso da parte dei Templari.
Fig. 5: le travi del soffitto della Sala dei Cavalieri, risalenti all’epoca templare.
Le mappe (cabrei) del Settecento, conservate all’Archivio di
Stato di Bologna, pur essendo riferite ai beni attribuiti alla com-menda settecentesca oramai dei cavalieri di Malta, hanno comun-que permesso una prima ricostruzione dei luoghi templari trecen-teschi, che trova riscontro in vari documenti medievali, spesso contratti di compravendita o arbitrati. Solo con il reperimento di diciotto pergamene trecentesche, in particolare lo straordinario in-ventario dei beni templari del 1309, custodite all’archivio Arcive-
22
scovile di Ravenna, il quadro si fa più completo e riferito nello specifico all’inizio del XIV secolo.
Per quanto riguarda la commenda dei Cavalieri di Malta, biso-gna osservare come da questa sia stata staccata, nel tempo, una parte, eretta a commenda indipendente nella zona di Castel San Pietro Terme nel 1693 con il nome di “San Giovanni Battista”. U-na commenda con denominazione analoga era inoltre la commen-da già presente a Bologna città e appartenente, fin dall’origine, ai cavalieri ospitalieri.
Dall’inventario si desume la proprietà dell’Ordine sulla Magio-ne di Santa Maria del Tempio, con annessa chiesa di Santa Maria Maddalena, sulla piccola chiesa di Sant’Homobono, nella parroc-chia degli Alemanni, oltre a un numero considerevole di terreni e case in città e nel contado.
Il Guidicini ci dà notizia del fatto che, con i beni dei Templari, i cavalieri gerosolimitani eressero nel 1315 un ospedale detto di San Giovanni Battista, che poi nel 1390 fu innalzato a commenda dell’Ordine di Rodi, poi di Malta. Nel secolo XVIII la facciata del-la Magione, che risultava antica e rozza per il gusto del tempo, fu rimodernata abbattendone il portico di legno come si evince dal documento del 1705 conservato nel fondo dell’Assunteria di Or-nato.18 La chiesa comunque nella sua lunga esistenza ebbe l’onore di ospitare papa Clemente VII quando venne a Bologna nel 1530 per l’incoronazione dell’imperatore Carlo V.
La commenda venne soppressa dai Francesi il 12 giugno 1798 e il governo di allora s’impossessò di tutti i suoi beni, allora goduti dal commendatario, don Cesare di Egano Lambertini, ultimo della sua famiglia e pronipote di Benedetto XIV. La parrocchia di Santa Maria del Tempio fu soppressa nel 1807 e il 16 agosto 1808 la chiesa fu chiusa e annessa alla chiesa di Santa Maria dei Servi, il palazzo della Magione venduto a privati dopo la requisizione del governo filo-francese. Ne venne, infatti, in possesso Luigi Aldini, al tempo segretario dell’Agenzia dei Beni Nazionali dal 1796 al
18 ASBo, Assunteria di Ornato, filza 15, 1705.
23
1811, che provvide a vendere molti dei beni ivi contenuti, come abbiamo già visto.
Dopo vari passaggi durante i quali la proprietà fu anche della Cassa di Risparmio di Bologna e del cav. Enrico Pietro Salaroli, l’edificio della Magione è attualmente di proprietà dell’Opera Pia dei Poveri Vergognosi, a cui è stato donato nel 1942. La suddetta proprietà l’ha ora concesso in affitto alla Polizia Giudiziaria, alla Polizia di Stato e alla Provincia di Bologna. La Sala dei Cavalieri è di proprietà della parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire mentre la chiesa di Santa Maria Maddalena, come già accennato, è andata quasi totalmente distrutta dopo la Seconda Guerra Mondia-le e sulle sue fondamenta è stato costruito un brutto edificio mo-derno.
Fig. 6: particolare della mappa di Bologna del 1575, presente nell’appartamento pontificio in Vaticano, in cui è ben visibile il
complesso ex-templare della Magione di Santa Maria del Tempio. Ma forse qualche manufatto è sopravvissuto: negli anni scorsi
sono stato interpellato da un collezionista relativamente ad una
24
pietra di volta con simboli interessanti, che è stata acquistata ora dalla Fondazione Carisbo per arricchire il Museo della Storia della Città in Palazzo Pepoli, del circuito di Genus Bononiae, recente-mente inaugurato in cui è anche presente un’interessante riprodu-zione della mappa di Bologna del 1575 presente nell’appartamento privato del papa in Vaticano, che ci fornisce un fantastico dettaglio della Magione bolognese (fig. 6).
Il manufatto in pietra presenta un’aquila, che si presume bicefa-la (abrasa nella parte superiore), con al centro una croce patente all’interno di uno scudo. Dalle dimensioni e dalla forma s’ipotizza potesse essere una pietra di volta di un portone.
La sua origine non è nota ma si possono fare alcune ipotesi sul-la sua provenienza: 1) Santa Maria del Tempio a Bologna (fig. 4). Grazie al cabreo già
citato del 1741 vi è la possibilità, come detto, di vedere le im-magini della Magione e delle sue dipendenze completate da una descrizione dei vari piani in cui era suddiviso il palazzo. Queste immagini però restituiscono la Magione com’era nel Settecento quando apparteneva all’Ordine gerosolimitano di San Giovanni. Si può comunque notare, che, sull’arco del portone d’ingresso dell’edificio, al centro, vi era lo scudo con la croce gerosolimi-tana: posizione e simbologia che potrebbero essere state mutua-te da una precedente pietra di volta risalente all’epoca in cui il palazzo apparteneva all’Ordine templare. Ciò potrebbe avvalo-rare l’ipotesi che la pietra sia quella originaria della magione medievale. È possibile inoltre un confronto iconografico delle immagini scolpite sulla pietra con la simbologia templare di fine XIII se-colo: infatti è stato possibile reperire due sigilli templari france-si appartenuti a due maestri d’importanti precettorie, con im-magini che presentano molteplici punti in comune con l’oggetto di quest’analisi: lo scudo con iscritta la croce templare e l’a-quila bicefala.19
19 L. Imperio, Sigilli templari, Tuscania 20063, pp. 57, 66.
25
2) Altro luogo di possibile provenienza della pietra è la sede dei cavalieri teutonici a Bologna ora conosciuta come “Alemanni”, nell’attuale via Mazzini. Ogni ricerca storica seria deve basarsi possibilmente su fonti
vicine ai fatti e personaggi indagati. Le fonti più importanti risul-tano quindi quelle coeve agli avvenimenti e in particolare quelle conservate presso l’Archivio Arcivescovile di Ravenna in cui sono conservati tutti gli atti e le lettere prodotte dalla cancelleria dell’ar-civescovo di Ravenna, Rinaldo da Concorezzo, al quale era stata affidata la conduzione del locale processo all’Ordine.
Questo straordinario materiale è stato parzialmente pubblicato negli ultimi due secoli, ma senza la finalità specifica di studiare i luoghi e i personaggi templari bolognesi e senza un’individuazione topografica dei siti indicati.20 Si possono poi comparare queste in-dicazioni topografiche ottenute con i cabrei settecenteschi dei beni dei cavalieri di Malta, che in parte mantengono la persistenza dei possedimenti ereditati dai Templari.
Ritengo quindi necessario uno studio diretto delle fonti origina-li -le pergamene ancora consultabili conservate nell’Archivio- e non la sola lettura delle stesse, per quanto possibile, nelle trascri-zioni ottocentesche o in altre fonti storiche moderne. Questo può permettere di fugare dubbi su eventuali interpretazioni problemati-che di luoghi e personaggi.
Un paio di esempi: in un passaggio di una pergamena, che for-nisce l’elenco dettagliato dei beni templari a Bologna e circonda-rio, compare un luogo che Caravita21 interpreta come Russi (Ra-venna) e non come l’esistente e più probabile località Russo, fra-zione di San Lazzaro di Savena, nel contado bolognese. O ancora: il templare Pietro da Bologna è citato da vari autori come Pietro da Montecucco. Ma se si vanno a leggere le pergamene dell’Archivio ravennate a cui si riferisce Caravita, si può rilevare come in realtà 20 R. Caravita, Rinaldo da Concorezzo, Firenze 1964; A. Tarlazzi, Appendice ai monumenti ravennati dei secoli di mezzo del conte Marco Fantuzzi, Ra-venna 1869-84. 21 R. Caravita, cit..
26
nel documento AARa 8011 manchi fisicamente la parte di perga-mena dopo il nome “Pietro”. Nell’altra fonte utilizzata invece, AARa 9688, lo stesso è citato come «Pietro precettore di detta ca-sa». Quindi senza “cognome”. Questi sono due esempi che mi hanno convinto ancor più, ove possibile, a verificare ogni afferma-zione già pubblicata in passato sulle fonti primarie coeve. Il nume-ro progressivo delle pergamene in archivio corrisponde alla segna-tura moderna, ma questa è solo parzialmente corrispondente alla segnatura ottocentesca utilizzata dal Tarlazzi, che invece suddivide le pergamene in scatole.22
Vediamo quindi analiticamente di cosa trattano queste primarie fonti su pergamena custodite nell’Archivio Arcivescovile di Ra-venna: 1) AARa 12575. Inventario dei beni dei Templari bolognesi redat-
to tra il 19 e il 27 marzo 1309 che contiene un allegato del 24 agosto 1308 in cui l’inquisitore di Bologna, Nicolò Tascherio, riceve le bolle papali per l’arresto dei Templari e per il seque-stro dei loro beni e delega, per l’inventario e l’amministrazione dei medesimi, Guidone Bontalenti e Francesco de’ Mussoni che poi saranno i compilatori del suddetto elenco.
2) AARa 7461 (13 settembre 1309). Invito da parte dell’arci-vescovo Rinaldo da Concorezzo al vescovo di Bologna Uberto, a lui sottoposto, per raccogliere testimoni relativi ai Templari di Bologna.
3) AARa 6807 (22 settembre 1309). Comunicazione di Rinaldo a tutti i vescovi a lui sottoposti della bolla di papa Clemente V, datata 30 dicembre 1308 da pubblicare nelle varie diocesi. Ve-dremo di che bolla si tratta.
4) AARa 9686. Pergamena che contiene due diversi documenti: a) il primo del 23 settembre 1309: presa possesso da parte dei
Vicari arcivescovili dei beni templari fino a quel momento gestiti dall’inquisitore per Bologna, Nicolò Tascherio;23
22 A. Tarlazzi, cit.. 23 Nella vecchia segnatura del Tarlazzi corrisponde a: Caps S. litt. E n. 6.
27
b) il secondo del 29 settembre 1309: bando per la locazione dei beni templari bolognesi.
5) AARa 6977 (9 ottobre 1309). L’arcivescovo Rinaldo costituisce il canonico Tederico suo procuratore in Romagna e nella Marca Anconetana scrivendo, in prima persona, dalla Magione tem-plare di Bologna.
6) AARa 9687. Pergamena sulla quale sono redatti due documenti: a) il primo dell’11 ottobre 1309: locazione di un anno, rinnova-
bile, dei beni templari bolognesi al rettore della chiesa di San Michele de’ Leprosetti di Bologna;
b) il secondo del 12 ottobre 1309: deposito di libri e oggetti templari a Dondidio, cappellano di Santa Maria Maddalena, da parte dei vicari arcivescovili.
7) AARa 9688. Pergamena composta da quattro diversi atti regi-strati: a) il primo (dall’alto) è datato 13 ottobre 1309: ricevuta da parte
dell’arcivescovo Rinaldo di 100 lire ricevute come acconto per la locazione dei beni fatta a Bologna e registrata nella pergamena precedente;
b) il secondo (dall’alto) dell’8 ottobre 1309: quietanza dell’arcivescovo di Pisa sui versamenti avuti dall’arcivesco-vo Rinaldo per la gestione dei beni templari e riscossi dal-l’economo, della casa di Bologna. L’atto è registrato come successivo nella sequenza, anche se con data antecedente al precedente, perché è prodotto da un altro arcivescovo ed e-videntemente giunge al notaio dell’arcivescovo Rinaldo qualche giorno dopo;
c) il terzo del 14 ottobre 1309: l’arcivescovo Rinaldo stabilisce vitto e vestiario per i Templari in custodia a Bologna con e-lenco dei medesimi;
d) il quarto e ultimo (registrato a partire dal margine in alto), del 16 ottobre 1309: quietanza per la consegna di 317 corbe di vino fatta dai vicari dell’Arcivescovo a Bologna.
8) AARa 3932. Pergamena composta da tre differenti documenti registrati:
28
a) il primo (dall’alto) del 21 ottobre 1310: il clero bolognese nomina una commissione per eleggere i procuratori per il concilio provinciale;
b) il secondo del 2 giugno 1311: nomina dei procuratori bolo-gnesi al Concilio di Ravenna;
c) il terzo dell’11 giugno 1311: frate Bono, maestro ospitaliero, ratifica l’atto di procura del 2 giugno 1311.
9) AARa 8011 (26 giugno 1311): purgazione di frate Alberto da Brenzano davanti al vescovo di Bologna Uberto, contenente all’interno anche la lettera, datata 21 giugno 1311, dell’arcive-scovo Rinaldo al suddetto Vescovo perché purghi il Templare, ritenuto innocente nel Concilio ravennate appena conclusosi.
10) ASBo, Ufficio dei Memoriali, Reg. 124, p. 44v: registrazione di un atto datato 21 aprile 1312, con cui Lambertino, presbitero della chiesa di San Michele de’ Leprosetti, divenuto nel frat-tempo conduttore ed esattore generale dei beni della Magione dei Templari di Bologna, pone la questione della riscossione delle rendite fondiarie. Inoltre un’altra fonte storica importante, anche se successiva in
quanto scritta nel 1589, è la Historia di Ravenna dello storico ra-vennate Geronimo Rossi, in cui si parla anche del Concilio di Ra-venna del 1311 e degli atti relativi.
Le molte informazioni sui Templari della nostra regione stanno portando alla creazione di un quadro articolato che vede al centro Pietro da Bologna, il famoso difensore dell’Ordine al processo di Parigi del 1310, quando venne processato anche il maestro genera-le dei Templari Jacques de Molay. Secondo gli storici più presti-giosi, Pietro probabilmente morì in carcere a Parigi, mentre gli sto-rici della Massoneria lo hanno ritenuto il tramite del passaggio del-le conoscenze templari alle logge massoniche scozzesi attraverso la sua fuga dalla Francia verso Edimburgo. La mia ricerca vorrà in futuro verificare se vi sia traccia di questo viaggio di Pietro in Gran Bretagna, almeno negli anni successivi al processo in cui non è testimoniato a Bologna dalle fonti locali, e prima della sua pos-sibile morte: quindi tra il 1314 e il 1329.




























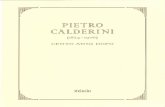











![[2. versione provvisoria: 31.12.2021] 1/113 PIETRO ZAPPALÀ ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63287da5051fac18490ec024/2-versione-provvisoria-31122021-1113-pietro-zappala-.jpg)


