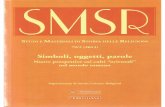Il Palazzo del Podesta' di Bologna
Transcript of Il Palazzo del Podesta' di Bologna
documenti di architettura
NUOVI ANTICHI committenti, cantieri, architetti 1400-1600 chiara baglione, francesco benelli, maria teresa sambin de noreen a cura di richard schofield
Electa
II palazzo del Podesta di Bologna nel Quattrocento. Storia e architettura Francesco Benelli
II primo studio scientifico sull'architettura del rinascimento bolognese risale a11899, risultato di un'approfondita ricerca eseguita da Francesco Malaguzzi Valeri che tuttora rimane fondamentale per la comprensione di questo periodo dell'architettura cittadina da sempre sottovalutata al di fuori di Bologna l
. Lo studioso reggiano nel1895 aveva tuttavia gia pubblicato un primo saggio sulla fase rinascimentale del palazzo del Podesta, fondato non solo su dati riportati dalle numerose cronache bolognesi dei secoli XV, XVI e XVII, rna anche e soprattutto su documenti inediti rinvenuti presso I'Archivio di Stato di Bologna2
•
Alia fine del XIX seCOrD il palazzo del Podesta aveva perso, gia da pill di trecentocinquant'anni, la funzione per la quale era stato costruito, trasformandosi dapprima in teatro, poi in granaio e in seguito in un'inutile semirovina prospiciente una delle piazze pill famose d'Italia3
• I..:interesse degli storici si riaccese nel primo decennio del XX secolo quando il Comune di Bologna decise di restituirgli una nuova e consona funzione. II progetto di restauro affidato ad Alfonso Rubbiani suscita un vivace dibattito all'interno della citta, che spinse alcuni esponenti della cultura bolognese a intraprendere ricerche sui palazzo allo scopo di ricostruire il pill possibile fedelrnente iJ suo aspetto originario, obiettivo prioritario da perseguire secondo la prassi del restauro dell'epoca4 I..:interesse per la storia del palazzo e il suo signifi•
cato nacquero dunque da motivi puramente ft,mzionali agli scopi del restauros (figg. 1,2). Fra il 1906 e il1912 vennero pubblicate quattro ricerche essenziali a opera di Pio Carlo
Falletti, Lino Sighinolfi e Guido Zucchini6• Un accuratissimo lavoro, svolto soprattutto pres
so l'Archivio di Stato di Bologna, mise in luce un gran numero di documenti riguardanti il complesso che servirono a chiarire, se non altro, una cronologia parziale delle fasi di costruzione. Se questi studi furono molto utili nello scoprire e ordinare i nuovi documenti, lasciarono tuttavia inesplorati gli aspetti estranei alla controversia suI restauro del Rubbiani e non misero a confronto i documenti con il costruito. Ecco perche non fu mai esarninato l'aspetto stilistico dell'architettura e la ricerca docurnentaria si orienta solo in minima parte verso il problema dell'attribuzione. Un'approfondita ricerca di storia dell'arte "intrinseca" al palazzo, che tuttavia non affronta i problemi di contesrualizzazione della sua architettura, ne si preoccupa di capirne la provenienza, la qualita e la portata, evitando considerazioni di ca
67
rattere strutturale e tecnologico. Ultimato I'intervento di Rubbiani, iI palazzo non suscito pili l'interesse degli storici dell'architettura fino a tempi molto recenti.
Nel 1989 Richard Tuttle mise in evidenza come I'imporranza dell'edificio fosse sempre stata sottovalutata dagli storici dell'architettura auspicando nuove ricerche7 Nel•
1994 10 stesso Tuttle affronto il problema dell'attribuzione avviando una sintetica rna corretta analisi stilistica8
• In questa occasione, anche se a margine del tema, "il Podesta" fu esaminato per la prima volta da un punto di vista "esterno" all'ottica locale.
L'analisi che qui si propone nasce proprio dall'intento di osservare I'edificio quattrocentesco con occhi da storico forestiero e contestualizzarlo nel profilo dell'architettura coeva, solo dopo aver ricostruito I'aspetto del primitivo palazzo comunale fondato insieme a piazza Maggiore a partire dal 12009
• Estato possibile in questo modo verificare come I'edificio medievale abbia influito sulle scelte architettoniche del progettista. Affronteremo poi in breve, alia luce di nuovi dati stilistici e costruttivi, la questione dell'attribuzione ad Aristotele Fioravanti. Strumento essenziale per questa ricerca estato il rilievo architettonico che, confrontato con i documenti, ha messo in luce aspetti costruttivi e compositivi finora sconosciuti e utili per nuove considerazioni sulla questione attributiva '0.
L'aspetto del palatium vetus II palazzo del Comune bolognese, fondato nel 1200 e completato gia nel 1203, rappresenta solo parte di un'idea urbana pili ampia e complessa che comprese I'apertura contestuale di una nuova grande piazza antistante di forma regolare ll Per rintracciare, se •
non altro in Italia, un edificio non sacro concepito e realizzato insieme al suo contesto urbano di forma regolare enecessario risalire almena all'eta tardoimperiale 12
•
L'operazione, eseguita in tempi mol to ristretti, ebbe inizio il28 aprile 1200 e si concluse il20 febbraio 1203 13
, date entro Ie quali il Comune, tramite i suoi procuratori l" acquisto
e demon all'interno di un'insula del tessuto romano case private e chiese di modeste dimensioni e COStrul il palazzo sullato nordlS, con la facciata principale orientata in direzione opposta all'area in cui in passato erano concentrati i poteri cittadini precomunalil6. Una parte consistente del palazzo doveva essere gia stata completata entro il20 marzo del 1201, quando alcuni documenti furono emessi «sub voltis palatium comunis" 17. Nel novembre dello stesso anno si trova notizia della scala palatii e della curia communis 18
• Appena un anna dopo I'inizio delle acquisizioni, i pilastri e Ie volte del portico, forse non tutte, erano gia stati eretti, COSI come una grande scala che avrebbe creato il collegamento con la sala consiliare, la sala grande del primo piano, e almeno una parte dell'invaso pubblico era fruibile 19
• Nel1203 infine si tenne consilium all'interno del palazzo; la stessa sala grande al primo piano doveva essere di conseguenza quantomeno agibile e usata anche come tribunale20
•
L'estensione orizzontale, i portici sulla piazza, la scala esterna, la sala grande al primo piano e la torre civica sono tutti elementi tipici dei palazzi comunali dell'Italia centro-settentrionale ereditati direttamente dai pili antichi palazzi vescovili della stessa area 21
• Tali palazzi a loro volta ebbero il mer!to, anche se in seguito accolsero e1ementi longobardi come la laubia22
, di avere trasmesso al medioevo alcune caratteristiche del palatium antico con funzione civica, che quindi non ando del tutto perso con la fine dell'Impero roman023
•
Fino al 1200 anche a Bologna I'unico "palazzo" cittadino col quale il nuovo palatium poteva rivaleggiare ed essere comparato era quello vescovile, a fianco della cattedrale di San Pietro, del quale si hanno poche notizie; doveva comunque essere sufficientemente grande e decoroso se nel 1184 vi soggiorno papa Lucio lIp4. I palazzi signori Ii bolognesi, infatti, in quel tempo e per tutto il XIII secolo, erano di dimensioni ridotte, con portici lignei e distinguibili solo per la torre pertinente25
•
69
1 Bologna, palazzo del Podesla, veduta anteriore al 1879, prima dei restauri di Achille Rubbiani. Si noti sulla parte sinislra il palazzo della Rota ora disIrullo.
2 Veduta del 1909 con prove di restauro "in stiler
•
3
1 2 45 I .
I
mmm ····6 'U'--==-E- -7
m 8 9
1012
-t1--=-ir--""'HJ-+-+~=4l=JJ
3 Pianta schemalica di Bologna all'inizio del XIII secolo; in evidenza il traccialo romano e in nero Ie mura dl Selenite. Legenda: 1 Foro romano 2 area della rocca imperiale 3 battistero 4 platea maior 5 cattedrale di San Pietro 6 palazzo vescovile 7 decumanus maior 8 palazzo del Podesta 9 piazza Maggiore 10 cone del Bulgaro 11 domus comunis 1'2 antico carda romano (disegno F. Benelh).
Fra i palazzi comunali dell'ltalia settentrionale sono rari i casi precedenti a quello bolognese e non tutti pienamente comparabili ne ricostruibili: fra questi si ricordano i casi del palazzo di Padova, gia costruito nel116626
, Verona nel119Y7, Modena, cominciato nel119428,
Bergamo e Pavia nel 119829 e il palatium vetus di Vicenza30; tutte citta, tranne la penultima,
che in un recente passato avevano aderito alia prima Lega lombarda. Non sorprende quindi che dal1198 al1205 i podesta in carica a Bologna, di norma chiamati da citta non ostili, provenissero da Milano, Parma e Modena3!; eanche risaputo che illoro costante spostarsi soprattutto fra i comuni dell'Italia centro-settentrionale, assieme allo stuolo di dipendenti, la cosiddetta familia potestatis, creo una certa omogeneita non solo tra i sistemi amministrativi cittadini e territoriali rna anche di una ben precisa tipologia di palazzo comunale.
L'asse del nuovo edificio fu individuato su un cardine minore del sistema viario romano che, a costruzione ultimata, avrebbe collegato la via Emilia al centro della nuova Platea Comunis, attraversando in profondita iI palazzo comunale in corrispondenza delIa campata centrale32 (fig. 3).
II palazzo affacciato sulla parte nord del nuovo invaso era separato su tre lati dagli edifici circostanti in una collocazione che ne aumentava quindi il carattere monumentale; la sua volumetria doveva essere molto simile a quella attuale, con un portico al piano terreno composto, come quello quattrocentesco, da nove arcate33
• I restauri del Rubbiani conc1usi negli anni dieci del secolo scorso, anche se con qualche errore filologico, hanno riportato alia luce, sullato posteriore nord, importanti tracce della facciata duecentesca utili a svelare alcune caratteristiche del palazzo medievale: una serie di finestre, poste a un livello fra la quota del portico e il pavimento della sala grande, testimoniano I'esistenza di un piano ammezzato a uso delle botteghe con copertura a volta34
• L'illuminazione della sala grande al primo piano era consentita da ampie finestre trifore incorniciate da un arco a tutto sesto di circa due metri di diametro e divise da colonnine in pietra, comuni in quegli anni a molti edifici omologhi35
• In alto concludeva la facciata una merlatura, anticipata da una serie di archetti di mattoni aggettanti sostenuti da mensole in pietra di selenite con un ritmo indipendente dagli e1ementi soprastanti. Pro~abilmente, come avverra nel re
70
-----1'101 !'OM i'1ff3rv M W1 rv Mcr1 MMJ fV] II FO IV] M 01 IV r1~
~
rv ~ ~
/
/?, ~ ~
~
y-.:::. r ~
~
R
1 1 ~ -~ ~ ~- '/ ~
-~ ~ ;L.-::::\ -~
~ .~ ~ ~ '~ I~ ~ -~ ~ I J
4 Palazzo del Podesta, sovrapposizione della facciata duecentesca con quella quattocentesca (disegno F. Benelli).
trostante palazzo di Re Enzo, detto anche palatium novum, i merli concludevano la facciata anche sui lati corti, impostati in corrispondenza della quota della cornice del futuro attico quattrocentesco di cui ricalcavano anche l'altezza (fig, 4).
La posizione delle grandi finestre sullato nord del palazzo relative alia sala, rinvenute nei restauri rubbianeschi, puo fornire alcuni indizi sui sistema di illuminazione: su questa lato esse sono a distanza diversa dagli spigoli della facciata e quella a est evisibilmente pili vicina allo spigolo di via Orefici. Ma nel nostro caso epili prudente considerare solo quella a ovest, in quanto la prima potrebbe essere stata spostata con la costruzione del palazzo del Capitano del POpOlOJ6 (figg. 5, 6).
Sulla facciata principale dovevano esserci probabilmente tre finestre di cui quelle laterali non allineate con il ritmo delle arcate inferiore. In quella centrale, in asse con la quinta campata, fu aggiunta intorno al1256 la ringhiera larga quanto la finestra 3S
•
La sala grande era a una quota inferiore a quella attuale. A conferma di cio, nella parte occidentale del lata nord eancora visibile una porta arcuata (ora murata) posta a una quota piu bassa di 100 cm rispetta all'attuale livello del salone39
• Tale dettaglio suggerisce gJi ingombri degli archi del portico della facciata principale, i quali potevano essere a sesto ribassato considerando che la luce delle arcate era all'incirca la stessa di quella quattrocentesca40
• Dei pilastri si conosee parte della forma della pianta, costituita da un elemento quadrangolare di circa un metro di lata affiancato da due semicolonne. L'attacco a terra ein pietra come pure la solida base rettangolare sottostante4J (fig. 7). Emeno probabile, anche se non da escludere, che una terza semicolonna sporgesse sullato frontale formando COS! un pilastro trilobat04l
• Parte della base del pilastro polilobata eoccultata da quello quattrocentesco, it che evidenzia come la facciata medievale fosse leggermente piu arretrata di quella esistente43
: 10 spessore del muro della parete duecentesca corrispondeva, infatti, alla distanza fra il filo esterno della cornice destra della attuale finestra ad arco verso la piazza (corrispondente alia campata [12]) (fig. 18) e il filo della parasta angolare del primo piano; Ie due murature quindi si sovrappongono solo per meno di una trentina di centimetri, all'incirca la lunghezza di un matton~ pieno bolognese (28,5 em).
71
5 6 Palazzo del Podesta, lato posleriore nord verso il Neltuno e verso via Orefici.
7 Fondazione del pilastro duecenlesco.
Dalla immagine si nota anche un leggero disassamento fra iI pilastro medievale e quello rinascimentale; si tratta tuttavia di uno scarto esiguo, tale quindi da non dover modificare il numero delle campate dell'edificio duecentesco che rimarrebbe COSl pari a nove.
La sala grande era accessibile tramite due scale poste sui lati corti dell'edificio, disposizione tipica nei palazzi comunali medievali italiani, nei quali la rampa poteva servire anche come podio durante Ie adunate, similmente a quanto avveml in quella del palazzo di Parma44
• La scala sui lato est era presumibilmente quella principale perche I'unica documentata nel LibeT TenninoTum nella descrizione del termine 13: «.. juxta plateam ante fatiem scalarum pallacii veteris que est a latere... »4S. La seconda scala sui lato opposto ovest, costruita in legno, doveva essere di minore importanza46.
Non einvece nota la posizione precisa della residenza del podesta, ne se egli vi risiedesse assieme alia sua familia di impiegati47. Sarebbe questo un dato utile da analizzare in quanto, se COSl fosse, bisognerebbe ipotizzare un numero cospicuo di camere e annessi, necessari a ospitare alcune decine di persone. Gia Zucchini ne indica una presenza a «settentrione del palazzo iUTidicum», individuandoli in quelle stanze che circondano la torre dell'Arengo al primo piano48 .
II cantiere quattrocentesco Durante iI XIV secolo iI palazzo del Podesta non fu soggetto a significative modifiche. Piazza Maggiore, al contrario, diventa il centro indiscusso delle attivita politiche, finanziarie e commerciali della citta49. In meno di un secolo gli edifici affaccianti sulla piazza si trasformarono da piccole case private a grandi volumi che ospitavano funzioni pubbliche e religiose: fra il1293 e iI 1295, sullato ovest della piazza venne eretto il palazzo della Biada nel quale nel 1336 si trasferi iI Consiglio degli Anziani dal palazzo del Podesta, diventando la vera sede del governo e del potere cittadino. Nel 1365 tale palazzo aveva occupato tutto illato della piazzaso • Nel 1328, rna forse gia da prima, comincia la costruzione del palazzo della sede dei Notai sullato sudS) e nel 1388 dell'enorme cantiere di San Petronio al suo fiancoS2 . L'unica modifica consistente al palatium vetus
73
L
2 .. . ,
3_m __n_
8
avvenne nel 1314 quando «fu finito di fabricare un portico a questo Palazzo verso la Piazza Maggiore nuova»53. Questo portico doveva consistere in una tettoia sporgente dalla facciata e sostenuta da colonne 0 pilastri di piccole dimensioni, che riparava Ie numerose botteghe poste al di fuori del portico duecentesco dando all'edificio bolognese l'aspetto molto simile a un palazzo pubblico, non troppo di fantasia, dipinto dal Sassetta54 .
II complesso del Podesta rimase con queste sembianze, almeno all'esterno, fino al 143855 . Edi quell'anno, coincidente con la definitiva presa di potere della citta da parte dei Bentivoglio (che durera fino aI1506)56, un pagamento per la costruzione di un percorso di due piani con portico e loggia detto iter in valtis con funzione di collegamento fra il palazzo di Re Enzo, il palatium vetus e quello del Capitano del POpOl057 (figg. 8, 9).
Con la realizzazione dell' iter in valtis si raggiunsero due scopi diversi: istituire un sistema di percorsi piu efficiente e dotare la curia di una quinta ordinata e imponente costituita da arcate sovrapposte che avrebbe unito anche visivamente i grandi volumi dei due palazzi di aspetto equivalente e dato molta piu unita e funzionalita a tutto il complesso del Podesta. II nuovo corpo di fabbrica venne pensato come una maschera-filtro profonda sei metri, coincidente con la distanza che separa la cappella di Santa Maria dei Carcerati con la testata dell'edificio adiacen~e alia torre58 . L'aggiunta del doppio ordine di arcate conferiva un prospetto unitario aile due testate del volume a "C" senza ostacolare tuttavia l'irraggiamento di luce all'interno della semicorte (fig. 10).
L'ingresso principale alia grande sala del palatium vetus venne quindi spostato sui retro, protetto e filtrato dalla cinta muraria ancora oggi visibile e raggiungibile dalla nuova loggia. Per salire at primo livello, dove si trovava il nuovo ingresso, fu eretta una grande rampa adiacente allato sud del palazzo di Re Enzo59. Nel 1442 venne anche demolita la scala medievale sullato orientale del palatium vetus che dava accesso alia sala grande dal fronte di piazza Maggiore, diventata inutile con il nuovo ingresso posto suI retro60
• II prospetto della loggia in mattoni, affidandoci alia ricostruzione di Alfonso Rubbiani, era costiruito da due serie di quattro grandi arcate sovrapposte con centro ribassato di uguale larghezza e con una merlarura superiore61 . Le decorazioni erano qua
74
8 Planimetria del piano terreno del complesso podestarile. Legenda: 1 palazzo di Re Enzo 2 curia poleslatis 3 Iter in vallis 4 vallone del Podesta 5 palazzo del Podesta 6 torre del Podesta 7 palazzo del Capitano del Popolo 8 torre dei Lambertini (disegno F. Benelli).
o o1 o
o9 Planimetria del primo o o piano del complesso podestarile. Legenda: 1 palazzo di Re Enzo, sala dell'archivio '2 iter In vol/is 3 torre del Podesta 4 palazzo del Capitano del Popolo 5 loggia duecentesca 6 corlile pensile (disegno F. Benelli).
E:.tW:lII ,= """" JI
9
si assenti; solo una sottile cornice in pietra separava i pilastri dagli arcru in entrambi i livelli. L'architetto dell'opera fu Bartolomeo Fioravanti che nel 1442 rilascia quietanza per illavoro svolto, segnando il primo di una serie di interventi architettonici da parte dei membri della sua famiglia all'interno del complesso podestarile62 .
Fin da prima degli anni cinquanta del XV secolo il palatium vetus doveva essere in condizioni strutturali alquanto precarie e di misero aspetto. Gia nel1447 il Comune stipulo una convenzione con Pietro Garganello, Tomaso di Pietro dalle Rode e Tomaso Cavichioli per «fare la Sala grande a tutte loro spese per lire due milia ducento»63. Tuttavia, nonostante l'intenzione, nulla avvenne, rna il fatto in se chiarifica 10 stato miserevole dell'edificio. Forse per questa ragione Niccolo V con un Breve del 12 settembre 1449 nomina Sante Bentivoglio, Signore di Bologna, e Nicolo Sanuti respol1sabili di liberare il palazzo dalle botteghe che 10 circondavano sui tre lati «tanquam difformes ac inepte» e che probabilmente invadevano gran parte della piazza e il portico del Podesta64
• Sarebbe stato compito dei due responsabili anche quello di accertarsi della rapida conclusione del cantiere.
Le botteghe che circondavano i pilastri del portico del palazzo non solo rovinavano la veduta di uno degli edifici piu rappresentativi della citta, rna dovevano avere anche minato la statica dell'edificio stesso in quanto Ie estremita degli elementi portanti in legno, per trovare sostegno, venivano inserite in alloggiamenti ricavati asportando parte del materiale della struttura65
•
Sotto il governo di Sante, gli interventi sui decrepito edificio furono tuttavia occasionali e dovuti aile necessita contingenti di riparazioni 0 cambiamenti d'uso delle stanze. Del 1456 e infatti un pagamento ad Aristotele Fioravanti «pro recoperiendo turim palatii», anna in cui venne eletto massaro dell'arte dei Muratori (carica che ricoprl anche neI1472)66. Aristotele, l'anno precedente67
, aveva trasferito l'intera torre della chiesa di Santa Maria del Tempio, detta anche della Magione, per circa tredici metri da un lato all'altro di Strada Maggiore68
, e si era gia distinto a Roma per opere di ingegneria fra il novembre 1451 e l'aprile 1452 e in seguito nel145669
•
Quando Giovanni Bentivoglio, nel 1463, prese il comando della citta non si impegno su
75
10
bito in dispendiosi lavori di committenza70; per interventi al palazzo del Podesta dobbiamo a
spettare fino al 1468, anna in cui Aristotele, di nuovo, lavof() intensamente all'interno delI'edificio adattando vari locali a uso di cancelleria7t
• A partire dal1471, proprio l'anno in cui, il1° marzo, Giovanni diventa capitano dell'esercito milanese72 aumentando coslle proprie entrate economiche, si registra un maggiore interesse verso Ie precarie condizioni del palazzo73
:
Battista Malvezzi, gonfaloniere di Giustizia, venne nominato a presiedere la costruzione delIa nuova grande sala74 e nello stesso anna il Senato gli confed, assieme alluogotenente del legato pontificio, il potere di riscuotere e usare tutti i beni e il denaro ricavato dai condannati e banditi a favore della ricostruzione del palazzo del Podestil7S
• Ancora ilB agosto 1472 il Senato versa ai due nuovi soprastanti alia fabbrica del palazzo, Giovanni Dell'Armi e Battista Malvezzi, in quel periodo prior del Consiglio dei Sedici, 1000 lire di bolognini con I'impegno di e1argire la stessa cifra ogni anno per 10 stesso motiv076
• Evidentemente la quantitil di denaro disponibile non fu sufficiente per cominciare delle vere e proprie opere di demolizione e ricostruzione, rna basta per i lavori di manutenzione e restauro dell'esistente.
Finalmente dopo pochi mesi, it 9 novembre, il Senato delibera la realizzazione di un modello, modulus, del palazzo e la spesa di 1000 lire ogni anna per la sua realizzazione, senza purtroppo specificare chi fosse incarica~o di questo compito. La forma del modello non avrebbe potuto essere modificata previa l'approvazione di undici senarod7 Inoltre era im•
posto il diviero di utilizzare il denaro ricavaro dai condannati e banditi se prima non fosse stata sottratta la somma di 1000 lire per i lavori del palazzo7s • In questa maniera il Senato rese chiare due volonta: avere un preciso obiettivo formale da perseguire e incassare delle somme minime annuali. Come si edeno i restauri eseguiti fino a quel momento derivarono da ragioni di necessita di riparazioni e modifiche ad hoc. Queste evidentemente divennero cosl numerose e capillari che dagli anni sessama del XV secolo, unite aile precarie condizioni statiche dei pilastri del portico, indussero il Senato alia decisione di intervenire radicalmente.
Tali motivi tuttavia non sono sufficienti per giustificare il rifacimento integrate del palazzo con una nuova e grandiosa facciata. La sala magna era illuogo in cui il podesta e i giudici svolgevano quotidianameme i processi penali e civili e nella sala di Re Enzo,
76
10 Complesso del Podesta. ~ iter in vollis.
11 Palazzo del Podesta, sovrapposizione delle sezioni trasversali del palazzo duecentesco e quattrocentesco. In trattegglo il solaio medievale (dlsegno F. Benelli).
~
~ ~
~ A ~
1=j
'-
11
il6 dicembre di ogni anno, nel giorno di san Nicolo, aIle ore ventuno si teneva il grande Consiglio dei Quattromila, I'unico rimasto a rappresentare i cittadini dopo l'abolizione di quelli della Massa del Popolo e della Credenza 79 La sala doveva rimanere (e•
rimarra) piG 0 meno delle stesse misure e al di sotto, nel portico, erano previste nuovamente, anche se meglio disposte, Ie botteghe.
Cera quindi dell'altro a muovere la decisione? r.;esistenza del Consiglio dei Quattromila molto probabilmente assicurava una relativa parvenza di liberra e giustizia sociale al di fuori della citta e serviva sia da calmiere nei confronti dei cittadini all'interno di Bologna sia soprattutto come organa di credito per il Comune; come si vedra pochi anni dopo, ne11487, il Comune affittera al Consiglio Ie tasse dette « brevetti d'eletta grazia»80.
II palazzo, in una cerra misura, doveva essere un luogo caro ai cittadini, che qui mantenevano illoro organo collegiale rappresentativo e forse non avevano ancora dimenticato, soprattutto quando il governo di Giovanni si stava facendo progressivamente sempre piG autoritario, che all'interno del palazzo aveva risieduto per lungo tempo il capitano del popolo, il magistrato che li aveva rappresentati e difesi81
• Inoltre non si deve dimenticare che piazza Maggiore, la piG importante della citta, era circondata a sud dal grande cantiere attivo di San Petronio, a ovest dal palazzo degli {\nziani (che pero era integrato in quello del Legato pontificio) e a est da abitazioni private' e spazi commerciali8z: il palatium vetus era quindi I'unico palazzo pubblico interamente di proprieta del Comune che affacciava sulla piazza e, in quanto sede di tribunale, simbolo e strumento della giustizia e dell'indipendenza della Signoria bolognese. Ricostruendo il palazzo del Podesta Giovanni avrebbe dotato Bologna di uno dei piG moderni palazzi di questo tipo in Italia, dando sfoggio di potenza, indipendenza e risorse tecniche cittadine molto qualificate sia davanti al papa che aile altre Signorie, ricordando cosl come Bologna fosse pur sempre la seconda citta piG importante dello Stato pontificio. Allo stesso tempo egli avrebbe accontentato il popolo dotandolo di una sede altamente rappresentativa dove svolgere Ie proprie adunate.
r.;abilira di Giovanni e del Senato fu quella di aver saputo cogliere tutti quei significati che confluivano nel palazzo del Podesta - favorevoli ai diversi livelli sociali (anche se in
77
maniera demagogica verso il popolo) - nonche il potere cittadino e la risonanza che tale impresa avrebbe avuto sulle altre Signorie.
Per la seconda volta nella sua storia il Comune di Bologna attribul nuovamente allo stesso palazzo, dopo piu di due secoli e mezzo, la responsabilita dell'immagine politica e sociale della citta. Non e possibile sapere se i bolognesi fossero stati a conoscenza delle ragioni della fondazione duecentesca dell'edificio e della piazza, rna se cosl fosse avrebbero aggiunto all'operazione anche una solida componente di tradizione e coscienza storica cittadina.
I lavori tuttavia non cominciarono subito, forse per la difficolta di convincere tutti i proprietari delle botteghe a spostarsi da quelluogo, soprattutto quando tra di essi vi era no persone di primo piano dell'aristocrazia cittadina come Nicolo Sanuti83
•
L'll febbraio 1474 il Comune ordinava la diffida, minacciandoli di esproprio, a tutti i proprietari di botteghe nel portico sotto il palazzo se, entro I'ottobre successivo, non avessero fatto costruire quella parte di volta a loro spettante per una quantita dimensionata in rapporto all'ingombro delle proprie botteghe84 Da questo documento traspare la •
novid di coinvolgere i privati, proprietari delle botteghe nel portico piu importante (e difeso) della citta, a contribuire aile spese della costruzione. Evidentemente il Comune ebbe notevoli difficolta a eseguire I'ordine in quanto nulla avvenne al riguardo fino a11483.
Solo quando, il 22 aprile 1483, i Sedici nominarono Giovanni Bentivoglio, Bernardo da Sassuno e Pirro Malvezzi85 soprastanti plenipotenziari alia fabbrica del palazzo con la liberta e discrezione di dare, assegnare e cedere Ie botteghe in questione, si manifestarono conseguenze concrete86
•
II 1483 fu anche l'anno in cui Giovanni e papa Sisto IV ricostruirono, per breve tempo, buoni rapporti dopo cinque anni di tensioni87 Nel dicembre, in sostituzione del •
defunto legato pontificio, Francesco Gonzaga, Sisto IV nomino al suo posto il giovanissimo nipote Giuliano della Rovere88
•
Nel frattempo, secondo la cronaca Ghirardacci, «II Senato fa rovinare Ie botteghe de' merzari che erano sotto il Palaggio del Podesta verso la piazza, e fu adl 6 maggio [1483], il martedl, delle quali parte ne furono pagate, e parte no, e questo per ampliare la Piazza, e far fabbricare il Palaggio per il Podesta a cui si die principio e si finl con superbo ed artifiziato modello all'antica»89. Gaspare Nadi90 nel suo diario conferma: «Rechordo come nel messe de luio 1483 se comenzo aprire la via sota el palazo del podesta e butare zosso Ie botege per fare una loza chome iera antigamente e per voltare la sala del dito palazo fo imbianchida de l'ano 1497»91. Senza dubbio la tarda primavera del 1483 rappresento quindi una svolta per I'inizio della ricostruzione del palazzo, e la siruazione descritta da Nadi e un partito del 22 aprile fanno intendere che tutto il portico era invaso da botteghe che non permettevano piu neanche la circolazione. Inoltre si evince dalle fonti che Ie volte del portico, che avrebbero dovuto essere finanziate dai proprietari delle botteghe, non erano state neppure cominciate.,
Pirro Malvezzi tuttavia si ritrovo da solo a sovrintendere I'inizio dei lavori, in quanto Bernardo da Sassuno mOrl il2 agosto 1483, pochi mesi dopo la nomina, e Giovanni il 10 settembre part! per aiutare il duca di Milano nella battaglia bresciana contro i veneziani da dove ritorno, mala to, solo il 22 ottobre92
•
II 9 gennaio del 1484, i Sedici di Reggimento, alia presenza delluogotenente del legato, emanarono un partito che stabill che dalle somme ricavate da "Bandi" e "Condanne" il Comune avrebbe dovuto sottrarre 4000 lire di bolognini per riedificare e riparare Ie botteghe dei merciai, privilegiando coloro cheavevano subito un danno dalle demoliziorll dell'anno precedente. Inoltre a Giovanni Bentivoglio e Pirro Malvezzi venne concessa la facold di decisione sui banditi e condannati senza I'assenso delluogotenente o dei Sedici di Reggiment093 Pochi giorni piu tardi, il 13 gennaio, un altro partito dei•
78
Sedici afferma che la «sala magna [... ] esset per magna parte desolata, et in ipso solario dirupta»9'; si poneva quindi la necessita di provvedere a lavori di riparazione e di rifacimento, motivo per cui, non potendo pill il podesta e i giudici esercitare Ie lora funzioni al suo interno, venne stabilito il trasferimento delle loro attivita nella vicina sala di Re Enzo. Si evince dunque che anche la grande sala del piano superiore era in pessime condizioni, desolata, senza quindi gran parte del solaio e con il solaria (tetto) pericolante9S
•
II 10 marzo Giovanni e Pirro ebbero anche it potere di assegnare ai padroni delle botteghe 10 spazio occupato dalla Tesoreria comunale posta al piano terreno del palazzo sotto la sala96
• Evidentemente gli influenti padroni delle botteghe reclamavano uno spazio sostitutivo al portico e neJJa stessa zona dove poter continuare il lora esercizio.
In una cronaca anonima troviamo scritto: «Del mese de mazo [1484] se cominzo a fondare la fazada e Ie volte de verso piaza del palazo del podesta de bologna»97. Nello stesso anna si legge nel diario di Gaspare Nadi: «messe di novembre e de dessembre 1484 se buto zosso la faza del palazo de la resedienza del Podesta per volerla refare; Regiva M. Zoane de Ii Bentivoli e chomenzose a fare adl 4 de feberaro 1485 de volonta del detto messer Zoane, perche iera el tuto de bolognia»98. Anche se Ie due fonti discordano di circa nove mesi sull'inizio dei lavori, risulta chiaro come comunque nel 1484, dopo Ie demolizioni delluglio dell'anno precedente, il cantiere ebbe inizio. La discordanza si estende anche sui procedimento dei lavori: la cronaca anonima afferma che per prima cosa si comincio a fondare, cioe a costruire direttamente la facciata e Ie volte, mentre Nadi scrive che in primo luogo venne abbattuta la facciata preesistente. La fotografia del 1990 evidenzia il nuovo pilastro quattrocentesco costruito in posizione pill avanzata verso la piazza rispetto a quello medievale e, supponendo verosimilmente che la facciata duecentesca gli fosse stata a piombo, eevidente che essa venne abbattuta (fig. 7). La facciata vecchia, come risulta visibile nel disegno di sezione, corrisponderebbe solo in minima parte con quella nuova pill arretrata del primo piano, non giustificando coslla convenienza a essere preservata (fig. 11). Si risolve in questo modo ogni dubbio circa il suo abbattimento e la totale sostituzione con quella quattrocentesca, almeno per il lato sulla piazza, a conferma quindi delle notizie riportate da Nadi. In pill, a suo favore, troviamo in un'altra cronaca all'anno 1485: «quando chavavano Ii fundamenti de detti pilastri in alchuni quando sono in zoxo una pertega atrovono una salegada de musaicha che era una bela cosa»99.
II contributo economico di alcuni proprietari delle botteghe risulto fondamentale per continuare i lavori del palazzo, superando d'importanza quello ricavato dai banditi e condannati. Alcuni di essi finanziarono la costruzione delle volte 0 dei pilastri del panico relativi alia posizione della lora bottega 100, evidenziando come un proprietario fosse disposto a notevoli investimenti di denaro pur di avere un luogo di lavoro all'interno del palazzo, ubicazione che evidentemepte incrementava di molto gli affari.
Nel 1487, come gia ricordato, i Sedici rif~rmatori coinvolsero nei finanziamenti per la costruzione anche i cittadini attraverso illoro Consiglio. II 28 aprile infatti deliberarono di affittare per i prossimi quattro anni, a cominciare dal gennaio del 1489, tutte Ie eleete lOI di pertinenza al Consiglio dei Quattromila. Questo avrebbe avuto quattro giorni di tempo per decidere se accettare I'offerta del Comune, di valore pari a 3500 bolognini d'argento, e, nel caso affermativo, avrebbe dovuto pagare 2000 lire entro il prossimo novembre e dilazionare la parte residua per tutto l'anno successivo. Nel caso che il Consiglio dei Quattromila avesse rifiutato I'offerta, il luogotenente e Pirro Malvezzi avrebbero potuto decidere, in piena liberta, a chi vendere e in quale modo Ie eleete. II Consiglio impiego due giorni ad accettare l'offerta I02
• Al pari dei proprietari delle botteghe, anche i cittadini dunque non esitarono a essere coinvolti nelle spese di ricostruzione del palazzo, segno di una
79
12 Palazzo del Podesta, dettaglio della facciata principale, architrave alia sommita del primo livello.
12
80
certa stabilita sociale interna - imposta comunque da un governo autoritario - di una fiorente econorrua e della condivisa opinione circa l'importanza dell'impresa edilizia.
IJ 1488 fu l'anno che segno una svolta decisiva nella signoria bentivolesca. Giovanni, partecipando alia Dieta di Parma, si pose definitivamente allo stesso livello delle maggiori Signorie italiane ,03 e nel novembre, sventata in maniera cruenta la congiura dei Malvezzi, trasformo il governo di Bologna in una esplicita tirannia dominata saldamente assieme ai suoi figli 104
•
Nel frattempo il cantiere doveva essere in pieno svolgimento, almeno per Ie parti murarie. In un atto notarile rogato dal notaio Bartolomeo Zani il 16 aprile 1488, Marsilio Infrangipani fondo una societa di scalpellini assieme a Leonardo quondam Petri de Filippis e Lazzaro quondam Pauli Ugolini 105. La parte del contratto significativa per la nostra trattazione equella in cui si stabilisce che la societa durera per tutto il tempo necessario per conc1udere ogni residuo lavoro gia stabilito tempo addietro dagli stessi soci e dai maestri Battista Zarbi e Matteo di Marco da Ragusa e sottoscritto da Giovanni Bentivoglio e Pirro Malvezzi'06. Da questa documenta risalta il ruolo importante svolto nelle decorazioni lapidee da Marsilio Infrangipani, capo di questo gruppo di scalpellini. La societii tuttavia venne sciolta pochi mesi dopo, il 7 luglio 1488, per motivi ignoti. Nell'accordo si conveniva, tra l'altro, che «a fare a Marsilio architravo e la cornis del palazo de la facada de Podesta da Bologna» 107. Non edel tutta chiaro a cosa si riferiscano i termini cornis e architravo se non si tiene conto dell' ultima parte del contratto in cui si stabilisce che «se bisognasi a Marsilio de la preda de Verignana de la prediva de Lazaro per la fabricha del palazo de Podesta pro architravo e la chornis de architravo el friso e si Ie pride mancasi cavando che sono de Marsilio che dito Lazaro sia hobligata a darli de la dita prida»108. Quindi i due termini si riferiscono entrambi a un architrave sia nella sua parte strutturale che decorativa, quella fra il portico e il primo piano. Il termine (riso dovrebbe quindi riferirsi al segmento di fregio che forma il davanzale del primo piano. Questa elemento infatti, quando si trova in asse verticale con la semicolonna e con la chiave d'arco, ecostituita da un tratto di trabeazione completa, composta da un architrave a doppia fascia intervallata da fusaroli e perline, un fregio (ora in mattoni a vista), e una cornice molto decorata (fig. 12). II documento fornisce la notizia del tipo di pietra impiegata, quella di Varignana, un tipo di arenaria di scarsa qualira, facilmente deperibile rna abbondante nel bolognese'09. Tutto cio testimonia come nel1488 si stesse ancora lavorando al primo Iivello del palazzo. Mentre la facciata verso la piazza, come detto, era stata abbattuta e cosl anche il solaio della sala grande medievale, almeno illata corto ovest della fabbrica duecentesca era ancora esistente: un memoriale del tempo riporta infatti che il 28 novembre 1488, Giovanni, figlio di Battista Malvezzi, a seguito della congiura, venne impiccato per la gola «ali merli del palazo del podesta arimpeto del Palazo de Ii Signori dove era la fontana»'IO. La presenza dei merli, coperti dall'interventa quattrocentesco, testimonia che la facciata medievale era ancora in piedi, corrispondente all'attuale parete del primo piano. La scelta di usare illato! ovest del palazzo per I'impiccagione dimostra che evidentemente il prospetta principale, suI quale di solito avvenivano Ie esecuzioni, non era disponibile in quanto ancora in fase di costruzione ed everosimile pensare che proprio I'esecuzione di un componente di rilievo della congiura avrebbe dovuta svolgersi suI lato verso la piazza'11 • Probabilmente quindi anche illato duecentesco est del palazzo venne conservato, mentre si puo stabilire con certezza che tutta la parete posteriore verso il voltone del Podesta sia rimasta intatta, in quanto i restauri rubbianeschi riportarono alia luce la merlatura e Ie ampie finestre medievali ad arco relative alia sala grandell2 (fig. 14).
Nel1489 presero forma Ie decorazioni lapidee dei pilastri, mai nominate prima. De Bursellis riporta a tale proposito: «Palatium pretoris, sive potesta tis, ex latere pia tee iam vetustate ruinosurn, lapidibus massicinis ac in modum rosa rum sculptis restaurari cep
81
13 Palazzo del Podesta, lalo ovest verso il Nettuno.
14 Schema assonometrico di aggregazione dell'inlervento quattrocentesco con Ie preesislenze duecenlesche (disegno F. Benelli).
14
tum est, domino Iohanne Bentivolo secundo principante» 113. In seguito, nel mese di febbraio 1491 per volere del Senato, venne rifatto in poco tempo il pavimento del portico in mattoni, essendo quello vecchio molto rovinato '14 .
Fra il 1492 e il1494 enotificato un pagamento del Comune di lire 258.9.0 di bolognini a Marsilio di Antonio Infrangipani per Ie opere in pietra dellato verso il palazzo dei Signori" 5
, che contribl1isce a chiarire la sequenza delle fasi di costruzione del piano terreno: cominciato sullato est dalla parte di via Orefici con i due pilastri finanziati nel1485 da Andrea Cenni ll6, il cantiere si espande verso ovest e nel1492 vennero realizzati i pilastri sullato opposto; in quello stesso anna e testimoniata inoltre la costruzione e pavimentazione del solaio della sala grande l17
,
II pagamento effettuato il 19 marzo 1492, in particolare, eutile per ricostruire all'incirca la data di completamento del volume dell'edificio. Antonio InfrangipaniJ18 realizza elementi lapidei dellato corto ovest, identificabili con certezza soltanto individuandone la corretta posizione nella facciata e confrontando Ie misure indicate nel documento con quelIe reali1l9
• I..:elenco parte dai pezzi piu vicini alia quota della piazza (figg. 13, 19): il piedistallo sotto la base (del pilastro), il pilastro con i roxuni, che si identifica con quello di imposta delFarco [12] per Ie sue dimensioni di 8 piedi e lq once (3,356 m) uguali a quello ora esistenteo Altre parti riconoscibili sono il primo concio d'arco di 2 piedi sopra l'imposta messo in opera verso la porta del Podesta, illavora di roxuni che concludeva il fregio verso 10 spigo10 nord dellato, la cornice di raxuni al di sopra, adiacente alia parasta, e l'architrave sopra il capitello, lungo all'incirca la meta del lato. Tutti gli altri elementi non sono collocabili con precisione in quanto la facciata presenta piu elementi della stessa tipologia e il documento non specifica esattamente di ql1ale si tratti. Queste pani sono: il pilastro mezo tondo, il capitello relativo, due triangoli che riquadrano un arco120
, un arco grande con chiave trionfale, due piedritti di imposta dell'arco, due cornici di una finestraal primo piano '2' e l'arco sopra di esse. Una parasta, un basamento (zoccolo) sotto Ie cornici della finestra, un capitello relativo alia parasta e un occhio al di sopra dell'architrave. Gli elementi lineari come il basamento al di sotto del fregio (7,53 m), la cornice al di sopra di esso (7,98 m) e I'architrave
83
15
' .... VI.
",";<',>-;
"'/'Ir:J.' 6 be»,' n'6~;
_1__
su cui si imposta l'attico (7,82 m), hanno quasi la stessa lunghezza pari a circa la meta di quella totale dell'intero lato. II fregio, al contrario, ha una lunghezza di 22,95 m, pari a circa tre campate. Gli elementi singoli come capitelli, mensole e il piede d'arco, rna anche quelIi di forma circolare come i due grandi archi del portico e della finestra e l'occhio dell'attico, sono pagati a forfait, indipendentemente dalle lora dimensioni 122
• Risulta anche come il capitella del piano terreno sia molto pill costoso (16 lire) di quello piatto della parasta al piano superiore (6 lire), e come il pilastro angolare con i motivi a rosoni, la semicolonna, il basamento sotto il fregio e quello sotta Ie cornici delle finestre del primo piano nonche la cornice decorata a rosoni sullo spigolo nord della facciata abbiano tutti 10 stesso costa di lavorazione, 8 scudi e 6 denari. La lavorazione pill costosa calcolata per lunghezza equella delle paraste, 20 scudi per piede123
• Ne11493, quando vennero stabiliti nuovi banchi, occupati ciascuno da due notai, il portico doveva comunque essere agibile 124.
Il9 dicembre 1494 iI Comune paga Alessandro Della Volta e i suoi fratelli 125 per il ferro lavorato messo in opera nella ringhiera terminata l'anno successivo 126
• Tale ringhiera, oltre agli elementi in pietra e muratura corrispondenti in verticale aile semicolonne e aile chiavi d'arco dellivello inferiore, era costituita da un davanzale in barre di ferro incrociate, montate a 45 gradi, che rendevflno l'intera composizione molto pill "trasparente" di quella attuale composta da massicci balaustri in pietra realizzati nel1603 da Pietro Fiorini, allora ingegnere del ComuneJ27
• Alcuni disegni della fine degli anni cinquanta del XVI secolo a opera del medico Stefano de' Corvi rendono un'idea, da prendere can Ie dovute ca utele, dell'aspetto originario della ringhiera 128 (fig. 15); Stefano disegno, anche se con una grafica incerta rna ricca di particolari, alcuni degli impiccati al balcone del Podesta. A parte Ie interessanti rappresenrazioni dei vestiti, dell'aspetto fisico dei condannati e delle lora espressioni del viso, risultano significativi alcuni dettagli del balcone, in particolare il davanzale costituito da una trama di ferri che farmano un sistema a rombi - a eccezione di una campata in cui il motivo diventa a quadranti con Ie diagonali - riempiendo gli spazi esistenti fra gli elementi in pietra verticali che proseguono sull'asse dei pilastri e delle chiavi d'arco. Acroteri di vario tipo, a palle e leoncini, posti sopra la cornice superiore
84
15 Impiccati alia ringhiera del Podesta in un dlsegno di Stefano de' Corvi. Biblioleca comunale dell'Archiginnasio di Bologna, Sala Manoscritti, Fondo Archivio Ospedale della morte, ms. 71.
16 Palazzo del Podesla, sezione nord-sud, quinta campata, orientamento oves!. Biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna, Sala Manoscritti, ms. B. 2044.
16
del davanzale in corrispondenza dei supporti in pietra, accentuano la vertical ita del sistema strutturale del portico129
• Un altro e1emento importante ela presenza, in ogni disegno, di mensole che sorreggono 10 sbalzo della balconata mettendo in evidenza come almeno una sua parte doveva essere aggettante rispetto al piano inferiore130
•
Si registrano infa tti diverse testimonianze del fa tto che il balcone, dal quale iI podesta leggeva Ie sentenze, fosse a sbalzo verso la piazza in corrispondenza della campata centrale 'JI • La testimonianza pili evidente emerge da un accurato rilievo eseguito nel 1742 da «periti architetti»l12, che mostra il balcone sostenuto da due mensole impostate sui lati dei pilastri verso I'interno della campata centrale, in corrispondenza dell'undicesimo filare di bugne JJJ (fig. 16). Lo sporto causato dal1e mensole provocava I'aumento dello spessore del1'arco che, verso I'esterno, terminava contro due pilastrini decorati e dotati di capitello che sorreggevano il balcone. Tali e1ementi, visti in prospetto, sovrapponendosi aile reni dell'arco, nascondevano Ie imposte, motivo giii abbastanza diffuso a partire almeno dal medioevo l34 Giii nelle stampe ottocentesche della fac•
ciata del palazzo il balcone sporgente non esisteva pili e non epossibile trovarne traccia alcuna tramite un'attenta analisi delle murature in quella parte di facciata.
Alia fine del XV secolo il palazzo qel Podestii doveva essere quasi terminato e comunque agibile. I documenti reperiti indicano soprattutto lavori di rifinitura e manutenzione. A partire dal 1496 si registrano regolari esecuzioni dei condannati svolte dalla ringhiera della facciata sulla piazza 135 e I'anno seguente venne «imbiancata» la sala grande JJ6
• Nel 1503, come si legge nell'iscrizione suI fregio, il podesta in carica, Giorgio Arnolfo da Fano, fece realizzare il portale d'accesso in marmo, situato in asse con l'iter in va/tis, dotando il palazzo di una entrata monumentale.
Dopo il 1488 Giovanni II, sebbene avesse consolidato iI potere all'interno di Bologna attraverso una pili spiccata tirannia, perse il prestigio che si era costruito al di fuori della citta, soprattutto a causa della protezione che godeva da parte di Luigi XII, la quale gli era fra I'altro costata ingenti somme di denaro. Con I'inizio del XVI secolo Ie fortune della famiglia cominciarono a diminuire drasticamente assieme all'appoggio
85
-UO'--r:-h
17 Pala2zo del Podesta, tacciata principale, stato attuale.
18 Elaborazione grafica di F. Benelli da un rilievo ottocentesco della Blblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna. In nero Ie fondazioni medievali, in tratteggio I'intenvento quattrocentesco. In evidenza I'asse di rotazlone della parete nord.
18
delle famiglie alleate bolognesi 137• Anche il popolo, soggetto a forti tassazioni pretese dal
duca Valentino, al fine di tenerlo lontano dalla citta, comincio dal 1501 a perdere la fiducia nei confronti del Signore; I'insieme di queste circostanze coincided. con il progetto di ristrutturazione della Stato pontificio da parte di Giulio II che conquisted. Bologna, cacciando i Bentivoglio, I'll novembre 1506138
•
Giovanni II mOrl il 14 febbraio 1508 in esilio a Milano139 e, dopo un breve periodo (da120 maggio 1511 alia fine di giugno 1512) nel quale il figlio Annibale tomo in citra e riprese il comando, i Bentivoglio abbandonarono definitivamente Bologna. Con Bolla papale del 29 luglio 1513 Giulio II abrogo I'istituto dei Quaranta consiglieri e nomina un Senato Formato da trentanove membri che venne investito delle stesse funzioni del Consiglio dei Sedici. Bologna a questo punto perse per sempre la sua autonomia e divento una citta completamente assuefatta allo Stato pontificio fino al 1796 14 °. Come conseguenza anche il palazzo del Podesta, simbolo dell'indipendenza di Bologna, segul la stessa sorre, perdendo da subito la sua funzione e decadendo progressivamentel41
•
L'aspetto compositivo e formale La facciata quattrocentesca del palazzo del Podesra Jesprime un'idea grandiosa dell'architettura che si impone in maniera prorompente sulla piazza piu importante della citta con un aspetto assolutamente sorprendente per la Bologna di quegli anni, che sfida Ie dimensioni del San Petronio ancora in costruzione e quelle del palazzo del Legato di forme ormai arcaiche l42
(fig. 17). Compaiono per la prima volta in citta portici con pilastri e semicolonne addossate, archi con chiave di volta, grandi capitelli corinzi143
, una "trabeazione triumphalis" e una facciata organizzata con una prevalenza eli vuoti rispetto ai pieni puramente "all'antica". Enuova anche l'idea di un prospetto esterno costituito da uno pseudo doppio loggiato continuo, anticipato nel XV secoJo solo da architetture romane, se si escJudono i cortili dei palazzi privati. Un'idea che, come afferma Christoph Frommel riferendosi alla loggia delle Benedizioni in Vaticano, permette di ricostruire «un'architettura forense in senso vitruviano»144.
II primo obiettivo del progetto esecutivo dovette essere quel!o di ottenere una serie di
87
19
20
E ~ o ~
(Q) (Q)
/~ ~
~~
~ ~--"-~
;
(CV @
~ ~
",,§!
~ '~
,
, ,
+-13 ----+-12 ~~2---->;--1~
i~B---':! : A : . , .' .:,-r------:
.:e--11 --'-10 --'-9-+---8~7 -+-----6 -+-----5--+--4------':'-3--'
~ ::~ .'
".: (6) CC» CC» (Q) (Q) (Q) (Q) (Q) :,@::
"
~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ :v---; :
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'r~'
-, '
Misure espresse in em
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A 734 707 681 681 680 680 673,5 673 682 680 682 702 701
B 525 514 480 483 480 486 476 475 482 481 481 507 495
C 320,5 304 282,5 295 300 304 292,5 299,5 300 300 307 307 312
0 736 706 671 681 698,25 684 668,5 677,5 677,25 680 687,5 703,5 728,5
115 114 104,5 99 102,5 102 97,5 93 98 94 101 lOS,S 111
d 114,5 101 97 100,5 101 91 93 99 94 99,5 94,25 105,5 119
21
88
campate il pill possibile simi Ii tra loro con un alzato ritmico, proporzionale e modulare, pur tenendo conto dei vincoli imposti dalla preesistenza 145 (fig. 18): i due grandi muri estovest paralleli che contenevano Ie botteghe, i due lati perpendicolari alia piazza, il passaggio in asse con la campata centrale e Ie quote dei solai adiacenti alia sala grande, soprattutto quello dell'iter in voltis. Dal rilievo appare subito evidente come Ie campate non presentino dimensioni uguali fra loro, il che entro certi limiti potrebbe essere normale (figg. 19-21); tuttavia, quando si riscontrano differenze che raggiungono i 61 em, poco meno di due piedi bolognesi, elecito considerarle anomale. Va inoltre precisato che Ie misure delle campate dei lati corti appartengono a una diversa categoria dimensionale rispetto a quelle della facciata. Le due testate, est e ovest, hanno ciascuna una misura differente, dovuta alia leggera rotazione dell'asse di meta della parete preesistente nord che, a partire dalla crux viarum verso est, piega di 1,5 gradi a nord (fig. 18). Questa anomalia provoca un incremento dimensionale dellato est pari a 60 em che viene compensato aumentando l'interasse [1], con la relativa luce dell'arco, di 33 em rispetto al suo corrispondente [13] sulla testata opposta, rispettando cosila perfetta linearita del muro sotto il portico. Le altre campate [2] e [12] in prossimita degli angoli verso la piazza differiscono fra loro di 5 em e quindi si possono ritenere uguali. La misura minima dei quattro interassi laterali risulta essere quella della campata [13] pari a 701 em, che comunque risulta sempre pill ampia di 19 em rispetto ai maggiori interasse della facciata principale [11] e [9]'46. Ne consegue che l'arco della campata (1], dovendo rispettare i vincoli fissi delle altezze delle imposte e dell'architrave-ringhiera al di sopra, ein reaIta una semicirconferenza schiacciata. L'altezza del solaio della sala grande non poteva inoltre essere spostata di molto perche avrebbe procurato notevoli difficolta nel raccordare il livello della sala con quello dell'iteT in voltis, dal quale si accedeva alia sala stessa - e non sono esclusi ulteriori collegamenti diretti fra essa e altre stanze del complesso147 Delle campate laterali solo la [1] e•
quindi sensibilmente maggiore, mentre Ie altre tre si attestano su una differenza reciproca massima di 6 em. II modulo scelto per i lati corti equindi quello della campata [13].
Come si edimostrato, gli interassi [1] e [13] sono fissati dalle distanze delle estremita dei muri 0 fondamenta dell'edificio medievale. Possiamo anche stabilire che Ie semicolonne che definiscono Ie due campate laterali corrispondono con esattezza aile testate delle pareti. La soluzione che viene adottata per risolvere tutte Ie difficolta planimetriche derivanti dalla preesistenza equella che riconosce anomala la campata [1], la cui misura deriva dalla rotazione della parete nord del palazzo rispetto alia maglia ortogonale romana, che organizza la forma della piazza, e Ie direzioni delle strade limitrofe. Risulta che la profondita del portico e quella del corpo delle botteghe ela stessa, almeno nella meta ovest dell'edificio, e Ie dimensioni degli interassi delle due coppie di campate laterali - esclusa ovviamente la [1] - diventano pill vicine a quelle della facciata pri,ncipale. Questa soluzione logica ed economica consente inoltre di attuare Ie correzioni manipolando i "vuoti" e lasciando uguali fra loro il pill possibile gli elementi lapidei. L'unica differenza sensibile di misura fra arcate adiacenti, [1] e [2], viene efficacemente localizzata nel punto in cui epill facile nasconderla: la campata [2] (A= 707 em, B=514 em) pili stretta della [1] (A=734 em, B=525 em), si trova infatti in testata al portico e puo essere percepita pill larga a causa del noto effetto ottico del vuoto retrostante148
• Questo primo, sottile elemento di qualita del progetto permette in conclusione di risolvere I'incompatibilita delle misure dei due lati corti, grazie alia felice scelta di usare i "vuoti" come elemento di compensazione. Ulteriori imprecisioni vengono assorbite dal diverso dimensionamento dei lati dei pilastri bugnati angolari e dal variare, a "soffietto", dell'angolo dellato corto diagonale che si raccorda alia semicolonna J49
•
L'imponente pilastro angolare divenne soluzione obbligata ed efficace per poter in
89
19 Palazzo del Podesta, schema delle due facciate laterali. A sinistra lato est su via Orefici (E), a destra lato ovest sui Nettuno (0) (disegno F. Benelli).
20 Schema della facciata principale (disegno F. Benelli).
21 Abaco delle dimensioni degli assi delle campate e luci delle arcafe del plano terreno e delle finestre del primo piano (rilievo eseguito da F. Benelli).
22 Palazzo del Podesta, soluzione angolare al primo livello, la10 verso via Orefici.
23 Soluzione angolare al secondo livello, lato verso il Nel1uno.
24 Vedu1a dall'alto del pilastro angolare verso il Nettuno.
24
quadrare e "contenere", soprattutto al piano terreno, un prospetto con un cos1 marcato e ripetuto ritmo, e costituito esclusivamente da grandi elementi strutturaJi alternati a una prevalenza di vuoti l50
• Al primo piano I'angolo avrebbe dovuto inoltre prevedere, per motivi cerimoniali, la presenza della ringhiera e del ballatoio, con il conseguente arretramento dei tre lati, rispettando il piu possibile la corrispondenza verticale degli elementi strutturali in entrambi i livelli151
• Probabilmente questo specifico problema non era finora mai apparso in edifici quattrocenteschi italiani. L'esempio piu simile, il palazzo della Loggia a Brescia, einfani posteriore al palazzo del Podesta di Bologna l52 e anche nell'architettura antica eraro; 10 si trova, semplificato, nel terzo livello dell'esedra del foro di Traiano'53 •
Usare un solo elemento angolare, colonna 0 pilastro, come avviene nel quasi contemporaneo palazzo Riario a Imola, non sarebbe stato sufficiente ne appropriato per coprire l'intera sporgenza laterale. L'elemento in questione infatti avrebbe richiesto una larghezza pari alia somma della semicolonna e del pilastro, risultando di proporzioni estremamente tozze e inadeguate. La scelta di accoppiare un pilastro angolare e una semicolonna comportava invece due vantaggi allo stesso tempo (figg. 22, 24): il pilastro, assumendo sui fianchi dimensioni leggermente diverse, avrebbe permesso i necessari aggiustamenti delle lunghezze al fine di dare ai )ati misure scomponibili in moduli, contenendo al contempo 10 spessore della ringhiera. Lo spazio totale della facciata da dividere per nove campate, tra gli interassi delle due semicolonne angolari, risulta infatti scomponibile per un modulo di diciotto piedi bolognesi, misura intera, multipla di tre e quindi facilmente divisibile '54
• II pilastro inferiore, privo di elementi corrispondenti al secondo livello, avrebbe oltretutto acquisito un valore di eccezione coerentemente estraniata dal sistema di archi e semicolonne che ritmano il prospetto. La semicolonna invece avrebbe introdotto, e concluso, il motivo strutturale ricorrente in tutta la facciata 155.
L'assenza di un piedistallo sotto gli elementi angolari risponde a ragioni di carattere proporzionale: se fosse stato introdotto, tali pilastri, anche se privi di capitello, sarebbero risultati di dimensioni troppo ridotte e tozze rispetto alia facciata e all'altezza totale dell'edificio. Un eventuale piedistallo avrebbe ridotto drasticamente anche Ie di
91
25
25 Palazzo del Podesta, pianta del pilastro angolare (disegno F. Benelli).
26 Particolare della base del pilastro della facciata.
mensioni delle semicolonne, indebolendo I'aspetto strutturale di tutto il prospettol56 •
Soluzioni angolari precedenti di questo tipo si ritrovano con sostanziali differenze nella facciata del duomo di Pienza e, con molti punti in comune, in quella albertiana di Santa Maria Novella a Firenze1S7
• Quest'ultima trova il suo riferimento antico nella facciata della cosiddetta basilica Emilia al Foro romano in Roma, compresa sia nell'aspetto formale che in quello strutturale, se ci fidiamo dei disegni di Giuliano da Sangallo L58
• In questa edificio, di pianta quadrangolare, il pilastro laterale doveva avere funzione di rinforzo strutturale per reggere il peso delle strutture del tetto che si scaricavano maggiormente negli spigoli, mentre Ie semicolonne avrebbero scandito il ritmo della facciata, in modo analogo alia soluzione adottata nella chiesa fiorentina e nel palazzo del Podesta L59
• Tuttavia sia nella chiesa fiorentina che nel palazzo bolognese, rna non nella basilica Emilia, una trabeazione completa aggetta in corrispondenza degli elementi strutturali, riproponendo la soluzione tipica degli archi trionfali, motivo comunque obbligato in presenza di elementi verticali come Ie semicolonne sporgenti dalla facciata l60. II modello del pilastro angolare della basilica Emilia a Bologna venne reinterpretato, probabilmente dagli scalpellini stessi, aggiungendovi elementi tardogotici, contraddicendo la modernid del sistema riscoperto da AJberti. A differenza del prototipo antico e della riproposta!fiorentina, il pilastro si congiunge alia semicolonna tramite un lata posta in diagonale (fig. 25): certamente un retaggio gotico ancora vivo e presente in citta a poca distanza dal palazzo del Podesta, nell'esterno del cora di San Petronio, rna impiegato gia a Firenze al piano terreno della loggia di OrsanmicheleJ61
•
Risolto il problema angolare dal quale anche cronoJogicamente ebbe inizio il cantiere, si passo al dimensionamento e alia posa dei pilastri di facciata.
La semicolonna venne idealmente, e con efficacia, collegata aJ pilastro tramite il ta
ro superiore della base, il quale, al contrario delle altre modanature e in maniera inedita per il Quattrocento, continua su tutto il perimetro del nodo strutturale e separa la base dal paramento soprastante, trovando un simile prototipo antico nel cosiddetta frontespizio di Nerone al Quirinale J62 (fig. 26).
Le uniche misure intere in piedi bolognesi (38 em) rilev~bili nella base del pilastro sono
92
26
illata lungo del dado della base delle semicolonne pari a 3 piedi e il diametro delle semicolonne che si riduce a 2 piedi. Le restanti misure non sono multiple dell'unira metrica bolognese, rna sembrano calibrate secondo proporzioni che rispettino quelle della base della semicolonna. La profondita dei piloni di facciata venne invece stabilita in base a quella dell'elemento angolare, il quale a sua volta doveva tenere conto delle larghezze dei muri preesistenti 163
• II risultato eche i pilastri diventano alquanta sovradimensionati rispetto a cia che devono reggere. Va tuttavia considerato che Ie pareti della sala grande al primo piano, pur essendo alleggerite da grandi finestre ad arco, sono gravate dalle forti spinte provocate dai puntoni delle capriate del tetto 164 Non sembra essere casuale che Ie semicolonne siano di•
mensionate in base a misure intere: essendo infatti gli interassi delle campate di dimensione non modificabile, ottenuta dividendo I'intera facciata per nove, la semicolonna venne proporzionata in funzione della misura del vuoto, con un diametro netto che avrebbe facilitato il processo realizzativo. II rapporto fra il diametro della semicolonna e la luce dell'arco risulta essere esattamente di 1:8, mentre I'altezza del fusto edieci volte il suo diametro, proporzione per un ordine corinzio abbastanza slanciata. Si ricorda tuttavia che I'altezza dell'ordine e dovuta al vincolo imposto dalla necessita di rispettare Ia quota dei solai delle parti medievaIi e dell'iter in voltis aile quali il palazzo dovev;a collegarsi, un vincolo molto simile a quello che Alberti dovette affrontare per la facciata di Santa Maria Novella165
•
La ringhiera puo essere considerata come una trabeazione corinzia quasi completa: nell'ottavo e nona decennio del Quattrocento sembra non esserci distinzione nell'architettura italiana fra un architrave a due 0 tre fasce 166 (fig. 27). Quello bolognese ea due sole fasee separate da perline e fusaroli e concluso da una gola rovescia. L:altezza del fregio venne dimensionata per fungere da parapetto suI quale potessero appoggiarsi Ie persone che assistevano aile feste, e per questo risulta leggermente schiacciata. Visivamente l~ ringhiera appartiene quindi allivello sottostante a conclusione dell'ordine corinzio, rna in rea Ita si trova al di sopra del solaio del primo piano. Equesto il primo caso conosciuto di "ringhiera" a forma di trabeazione staccata dalla parete retrostante, rna che conclude I'ordine del livello inferiorel67
• La ringhiera, rimanendo a filo della facciata sottostante, puo essere con
93
27
siderata parte e conclusione di essa; i suoi aggetti, che citano quelli tipici dell'arco trionfaIe, hanno anche la funzione di far proseguire visualmente l'asse verticale della semicolonna e di creare un migliore collegamento ottico con Ie paraste del secondo livello'68
•
Efrequente in molte facciate fiorentine, precedenti al caso bolognese, che la trabeazione si trovi tutta al di sopra del solaio e simuli il parapetto delle finestre fino ad arrivare al marcadavanzale, rimanendo comunque una decorazione parietale'69 • ARoma invece, con Ie prime facciate a "loggia" derivanti dal modello del Colosseo, essa assume un significato strutturale e funzionale pili determinato. Nella loggia delle Benedizioni 10 spazio residuo fra Ie semicolonne eriempito da una fascia liscia, che non si puc definire una vera e propria trabeazione, sopra la quale sono disposti balaustri che formano una ringhiera, tale da far supporre che il solaio del primo piano coincida con la base delle colonne come nel CQlosseo l7o.
Nel cortile incompiuto di palazzo Venezia Ie semicolonne reggono invece una vera trabeazione completa. Sopra di essa, come nella loggia delle Benedizioni, giace una fascia in pietra con cornice alta quanto i piedistalli, non assimilabile a una trabeazione rna che riempie i vuoti fra i piedistalli delle colonne I71 Nel cortile del palazzetto Venezia infine questo ele•
mento assume per la prima volta la duplice funzione di trabeazione-ringhiera, sintetizzando felicemente il rapporto formale e funzionaleJ72 (fig. 28). Equesto il precedente pili simile al palazzo del Podesta, con la differenza che in quest'ultimo la trabeazione, segmentata in relazione agli elementi strutturali sottostanti, non regge nulla e costituisce illimite fisico superiore del primo livello. La trabeazione aumenta quindi I'altezza del primo ordine evitando che appaia schiacciato dallivello superiore, oltretutto di aspetto pili" leggero".
Anche i prospetti del secondo livello rispettano regole proporzionali ben precise, frutto di un'impostazione molto chiara rna realizzate con meno cura rispetto al piano terreno, e presentano numerose irregolarit3., non giustificate questa volta da preesistenze a esclusione delle due testate. L'uso della parasta - con decorazioni a candelabra l73
- e non della semicolonna eobbligato dalla necessita di evitare sporgenze eccessive dalla parete per non rendere il balcone troppo stretto l74 (fig. 29). L'altezza della parasta, che ha un rapporto fra base e altezza di 7,5 moduli, euguale all'in~erasse della campata che COSl ri
94
27 Palazzo del Podesta, facciata pnncipale. Dettaglio della ringhiera di facciata al dl sopra del capitello.
28 Roma, palazzetto San Marco, vlridar/urn, particolare della ringhiera al secondo livello.
28
sulta un quadrato (fig. 30). Pure nelle finestre I'altezza degli elementi verticali che reggono il piedritto euguale alia larghezza totale della finestra includendo Ie cornici. La distanza fra la parasta e Ie cornici inoltre epari a un quarto dell'altezza degli elementi verticali della finestra. Emerge quindi una composizione basata su rapporti proporzionali molto semplici, 1/1e 1/4. L'esecuzione al secondo livello etuttavia molto approssimativa e in molte campate si creano degli scarti dimensionali che comunque non contraddicono il senso della geometria, evidenziando tuttavia una bassa qualita realizzativa.
Nella parte superiore dellato est Ie paraste sono posizionate in asse con Ie semicolonne e vengono rispettati i sottili criteri adottati per la parte sottostante - dove I'interasse [1] e sensibilmente piu largo del [2]- e di conseguenza I'apertura delle finestre (fig. 19). Anche Ie porzioni dei muri comprese fra Ie cornici delle finestre e Ie paraste variano consistentemente e con un senso preciso: mentre nella campata [1] sono uguali, nella [2] I'apertura e nettamente slittata verso sinistra. Tuttavia la distanza fra il muro di destra e iI suo simmetrico sulla campata [1] rimane uguale, e di conseguenza I'irregolarita si concentra sia sull'ampiezza della finestra sia soprattutto verso 10 spigolo sulla piazza. In questa maniera la parasta centrale diventa asse di simmetria fra Ie due finestre mentre I'irregolarita viene scaricata verso iI pilastro angolare dove, in mancanp di un riferimento simmetrico, epiu difficile notarla. La scansione dei partiti architettonici della facciata del secondo livello, soprattutto sui lato est, etalmente imprecisa da essere registrabile a occhio nudo. Anche Ie soluzioni angolari in questo livello hanno un pregio minore rispetto a quelle sottostanti. Le paraste, che presentano la stessa larghezza delle semicolonne, per rispettare illoro asse verticale non si attestano sullo spigolo, la cui posizione efissata dalla preesistenza. Anche in questa caso sarebbe stato opportuno l'uso di due elementi accoppiati l75
; in alternativa, si sarebbe potuto seguire l'esempio dell'arco di Costantino aRoma 0 di quello di Augusto a Rimini - ripreso da Alberti nel tempio Malatestiano -Iasciando la muratura a vista 0 comunque trattata a parete. Nel palazzo del Podesta, invece, I'angolo erivestito con un motivo bugnato che al pari del pilastrosottostante eprivo di capitello (figg. 13,23). Risentendo delle assialita provenienti dal piano inferiore anche in questo livello I'elemento angolare sui
95
29 30
lato della piazza risulta pili largo, il doppio di quello suI fianco. Diventa superfluo ai fini di una correttezza formale-strutturale attribuire un valore portante all'angolo, il quale risulta fra I'altro di larghezza minore della parasta, quindi troppo debole e in parte nascosto dallo stemma bentivolesco che si ripete nella facciata ogni tre campate. Inoltre il brusco accostamento tra parasta e bugnato, senza alcuna mediazione, crea una fastidiosa commistione che rende difficilmente distinguibili i due e!ementi e indebolisce cosl anche la parasta de! suo significato strutturale '76. Solo illeggero aggetto dal fregio del piedistallo della parasta ricorda I'originale funzione di struttura, anche se questo particolare viene nascosto dalla balaustra. Per concludere, il pilastro superiore, proiettando al di sotto il suo spigolo in un punto non significativo, preclude una armonica unitarieta verticale fra i due livelli contraddicendo e mortificando i sofisticati accorgimenti adottati al piano inferiore.
L'attico eritmato da oculi che allo stesso tempo 10 alleggeriscono, illuminano ulteriormente la sala - soprattutto ipotizzando la presenza di soffitti decorati - e concludono la successione verticale dei vuoti del portico e finestra ad arco (fig. 31). II motivo dell'attico ritmato da oculi a Bologna non enuovo e ha dei precedenti precisi: probabilmente eimpiegato per la prima volta nel distrutto palazzo Bentivoglio e riproposto ne! palazzo degli Strazzaroli, contemporaneo al PodestaI7~. Come precedente in una palazzo pubblico 10 si ritrova ne! palazzo Ducale di Venezia, inquello quattrocentesco della Ragione di Vicenza e forse nel trecentesco palazzo della Ragione di Ferrara l78 . Pili vicino ne! tempo, e anch'esso probabilmente noto al Bentivoglio, eil fiorentino palazzo di Parte Gue!fa 179
• Nel trattato filaretiano il motivo della finestra ad arco a tutto sesto sormontata da oculi appare molte volte; tuttavia in questi casi la sequenza verticale, incorniciata da paraste, non einterrotta da cornici e quindi non sarebbe corretto parlare di un vero e proprio attico dotato di oculi 180.
Dall'analisi della facciata del palazzo de! Podesta, e dallo studio delle modalita di realizzazione, si comprende che il progetto presenta una irhpostazione planimetrica di qualita elevata e risolve in maniera raffinata i problemi causati dalla preesistenza. Ne! piano terreno, inoltre, gli e!ementi tratti dall'antico 0 gia riproposti pochi anni prima - fra i quali I'angolo della basilica Emilia, la sezione dei pilastri, la architravis triumphalis - vengono usati
96
31
29 Palazzo del Podesta, veduta laterale della ringhiera
30 Finestra al secondo livello.
31 Veduta dell'attico.
non solo come pure soluzioni formali rna, con I'eccezione dei piedritti di imposta degli archi, compresi nelloro pieno significato strutturale, sintattico e funzionale. Questa alto livello qualitativo viene a mancare tuttavia nel piano superiore, come evidenziano I'infelice soluzione angolare e la scarsa precisione dimostrata dai muratori e dagli scalpellini. Inoltre gli elementi estratti dall'antico vengono rifiniti con motivi alquanto superati per I'ultimo ventennio del XV secolo, Ie cui origini affondano almeno nel tardogotico.
E importante tuttavia stabilire che questi dettagli sono indipendenti dalle scelte compositive-strutturali effettuate in precedenza e stabiliti a posteriori quasi come "incrostazioni" affisse sugli elementi architettonici.
Partiamo ancora una volta dal pilastro angolare; esso ericoperto di bugne molto lavorate, diverse tra loro e con una ricca varietas di fiori, foglie e altri motivi vegetali 'SI (fig. 32). Sui pilastri che affiancano la semicolonna, la bugna ha invece una forma di piramide tranca schiacciata, con motivo floreale al centro1S2 (fig. 33). Entrambe Ie decorazioni non hanno precedenti in altre architetture italiane di questo tipo e non sarebbe corretto considerarle di starnpo militare 0 come opera rustica 1S3 Le bugne lavorate non rappresentaro•
no una novita, anche se fino a quel momento non erano eccessivamente diffuse: in particolare quelle a "punta di diamante" erano da poco apparse a Bologna nella facciata del palazzo di Nicolo Sanuti lS4 Escorretta definire Ie bugne del palazzo del Podesta a "pun•
ta di diamante" 0 una lora variazione; esse infatti sono molto pill arrotandate e appiattiteo Siano completamente ricoperte da motivi vegetali 0 a piramide tronca con una rosa, fanno parte di una antica tradizione decorativa cittadina eseguita in terracotta, non necessariamente legata all'architettura; decorazioni analoghe sono presenti sullo sfondo di diverse miniature di scuola bolognese come decorazione di pareti interne, in una vetrata duecentesca in origine nella chiesa di San Domenico e motivi simili in terracotta decorano una fascia nella parte superiore dellato di San Giacomo su via Zamboni J85
• Si cerca quindi di qualificare ancora di pill gli elementi architettonici, in una sorta di orror vacui, con il meglio che la tradizione dell'arte ornamentale cittadina poteva proporre l86
• Tali bugne tuttavia non avranno fortuna in citta e rimarranno un esempio molto poco imitata 'S7 •
97
32 Palazzo del Podesta, bugne decorate di un pilastro al primo livello. Foto anteriore al 1888, prima dei restauri.
33 Bugne piramidali con rosa del fianco di un pilastro at primo livello.
33
Anche il "bastone" che configura 10 spigolo dei pilastri ha un'origine quanto meno tardogotica toscana che sopravvive comunque per tutto it XV secolo, fino ad arrivare almeno al 1503 nell'angolo del palazzo fiorentino Guadagni del Cronaca 188 (fig. 22). Lo troviamo presente in moire architetture fiorentine, a cominciare dalla loggia dei Lanzi, nella quale il bastone eancora molto evidente e dotato di un capitello a foglie, e piu sottile, rna senza capitello, in Orsanmichele e nellivello inferiore del palazzo di Parte Guelfa l89
• A Bologna I'eccezione edata dal fatto che il bastone estato applicato a una soluzione angolare d'avanguardia che non richiedeva un dettaglio COS! tradizionale. Un altro particolare proveniente dal tardogotico si trova nelle cornici delle finestre del secondo livello, formate da una gola e un listeJlo che circonda una colonna di bugne solo sui lati orizzontali e su quello verticale esterno (fig. 30). Questo elemento a "C" era gia stato utilizzato da Francesco di Giorgio Martini, rna in elementi realmente strutturali: compare nei pilastri all'interno della chiesa del Calcinaio a Cortona e in quelli del portico della contemporanea villa Chigi aile Volte a Siena ed ecomunque facilmente rintracciabile in elementi del tardogotico toscano190
•
I piedritti su cui si impostano gli archi del portico e quelli delle finestre al primo piano rappresentano un dettaglio significativo (fi~. 34). Essi sono costituiti da un segmento di trabeazione completa, con architrave a due fasce, fregio scanalato e baccellato di chiara origine fiorentina e una cornice a doppia gola (senza gocciolatoio) i quali, senza I'ausilio del capitello, appoggiano direttamente sui pilastro. L'uso di una trabeazione completa a mo' di piedritto eestremamente raro nell'architettura costruita quattrocentesca 191 in quanto raggiunge un doppio livello di ridondanza: se si considera la ghiera dell'arco come un architrave curvo, si ottiene un inutile sistema strutturale di architrave su trabeazione, mentre eallo stesso modo superfluo utilizzare un architrave su un elemento pieno quale il pilastro 192 Eun motivo quindi strutturalmente scorretto e lontano dai tentativi critici •
di sintesi degli elementi dell'ordine architettonico, soprattutto urbinati e a opera di Francesco di Giorgio '93 , da non attribuire a chi ha progettato I'edificio rna a quelle maestranze, anche se tecnicamente dotate, prive di una cultura architettonica aggiornata.
99
34 35
Non solo nella scelta dei motivi formali delle decorazioni, rna anche nella lora esecuzione si registra un certo scadimento, evidente ad esempio nell'architrave superiore dove e impiegata una tecnica esecutiva mol to rara 0 addirittura unica (figg. 35, 36): i vari conci sono di lunghezza diversa, rna i fusaroli e Ie perline che separano Ie due fasce inferiori si allungano 0 si restringono a seconda della lunghezza del blocco, evidenziando notevoli differenze dimensionali fra gli stessi e1ementi. In questa maniera ogni concio presenta tali e1ementi interi, diversamente da quanto avviene in tutti gli altri casi simili, per esempio nella facciata di Santa Maria Novella 0 negli archi trionfali romani '94 •
L'apparecchio della parete muraria einvece molto raffinato, frutto di una lunga e sperimentata esperienza dei maestri muratori cittadini195
• La differenza qualitativa fra il piano superiore e inferiore aggiunge un interrogativo alIa questione attributiva: chi diede il progetto del palazzo partecipo, almeno in parte, anche alia sua realizzazione?
Note suI problema dell'attribuzione II partito dei Sedici del 1472 che, nell'affidare I'incarico dell'esecuzione del modello del palazzo poteva costituire iI documento probante I'attribuzione, non specifica iI destinatario dell'incarico. II nome di Donato BramC/-nte, autore di un disegno del palazzo del Podesta compare solo nel1600 196
• La disputa sull'autore l97 nasce pero da una fonte del 1621 estratta dai memoriali dell'Alidosi nella quale vengono nominati assieme sia Aristotele Fioravanti che Bramante l98 e ribadita, pressappoco nello stesso periodo, negli Annali del Negri 199
•
Se ipotizziamo I'esistenza di un disegno di mana bramantesca, comunque scornparso, la sua data di stesura non potrebbe risultare antecedente al 1506, anna in cui Bramante arrivo a Bologna per la prima volta assieme a Giulio II e I'esercito papale travando il palazzo del Podesta gia ultimato200
, cosa che rende quindi impossibile un'attribuzione bramantesca del progetto. Ecomunque vera, come asserisce Richard Schofield, che iI palazzo bolognese, al pari delle architetture milanesi bramantesche, presenta elementi antichi stranieri alla grande scala e dettagli decorativi di origine locale non dovuti al progettista, rna affidati a maestranze in questo caso non molto aggiornate20I
•
100
34 Palazzo del Podesta, piedritto d'imposta dell'arco al primo livello.
35 Architrave alia sommita del secondo livello.
36 Dettaglio del capitello alia sommita del secondo livello e piedritti d'imposta dell'arco della fineslra.
36
Probabilmente quando Bramante vide per la prima volta il palazzo del Podesta ebbe una vaga sensazione di dejavau 0 quantomeno "senti" un'eco del suo passato milanese, proprio come accadde a Francesco di Giorgio nel 1491 quando visito la cappella Corner ai Santi Apostoli a Venezia con Ie quattro colonne libere agli angoli della spazio centrale202
•
Epoi altrettanto vero che negli anni ottanta i rapporti fra Giovanni Bentivoglio e gli Sforza, da sempre molto stretti, si infittirono ancora di pili, favorendo presumibilmente I'arrivo a Bologna di echi sulle novira architettoniche lombarde203
•
Epossibile datare e attribuire con certezza alia mana di Marsilio Infrangipani e degli scalpellini del suo gruppo Ie parti lapidee che, come si ecercato di dimostrare, potrebbero in larga parte derivare da un disegno della stesso Infrangipani 0 di quaicuno ancora immerso nella tradizione tardogotica di area padana rna con conoscenze fiorentine. Per ['impianto architettonico l'unica certezza equella di un modello, pili 0 menD definito, realizzato nel1472 e, stando ai documenti disponibili, mai modificato fino all'inizio dei lavori ne11484. L'architettura va quindi attribuita all'autore del madelIa e datata al 1472, quando l'attivira e la vita di Bramante non eancora documentata204
• Einvece verosimile che la cronaca del Negri del 1600 confonda il palazzo del Podesra con quello adiacente del Comune dove invece l'intervent<i> bramantesco sembra cert020S
•
Diverrebbe a questo punto mol to utile, per Ie numerose caratteristiche comuni, un confronro stilistico col palazzo della loggia di Brescia, il cui vocabolario architettonico e decorativo - quest'ultimo molto pili aggiornato di quello bolognese - unito alle proporzioni impiegate, spinge David Hemsoll e Giulio Lupo a una attribuzione a Bramante su basi stilistiche206 (fig. 37). Ma anche in questo caso I'incertezza attributiva non rende il palazzo bresciano un sicuro elemenro di paragone. In definitiva la totalita degli indizi compositivi e di contesto storico che inducono a ipotizzare un intervento di Bramante nel palazzo del Podesra di Bologna sono tutti troppo deboli 0 generali.
Bologna era una citra dove l'edilizia dipendeva ancora da pratiche di cantiere medievali, senza una chiara gerarchia e distinzione fra Ie maestranze, come attesta la stessa indifferenza con cui un muratore veniva definito architetto e viceversa. L'unico bologne
37 Brescia, palazzo della Loggia.
se nota in tutta Italia e aJl'estero fino alia meta degli anni settanta era Aristotele Fioravanti, anche se dai documenti disponibili risulta che egli non si cimento in incarichi di architettura, se non in Russia alia fine della carriera. La sua fama era dovuta prima di allora solo a imprese, anche se numerose e spettacolari, di ingegneria.
Aristotele, nato attorno al 1420 da una famiglia di noti ingegneri e architetti bolognesi, dal novembre 1451 all'aprile del 1452, quando Bessarione era legato a Bologna, lavoro aRoma sotto Nicolo V207. Gia in questa occasione potrebbe avere avuto stretti contatti con Leon Battista Alberti208
, Bernardo Rossellin020
9 e Francesco di Borgo, in quel periodo tutti documentati in Vaticano quando il Commissarius generalis delle opere nicoline era proprio un bolognese, Nello da Boiogna210 e quando in Campidoglio si stava approntando il restauro del palazzo dei Conservatori (1451-1453) e l'estensione di quel10 dei Senatori, con funzioni omologhe a quello del Podesta di Bologna2ll
•
Aristotele lavoro presso numerose corti in Italia quali Firenze, Napoli, Venezia, Mantova; a Milano fu attivo per almeno cinque anni e nel 1461 collaboro con Filarete alia costruzione delle coperture deJl'ospedale Maggiore2l2
• Venne chiamato aRoma da ben tre papi, Nicolo V, Paolo II e Sisto IV e si reco per due volte in Ungheria presso Mattia Corvino. La permanenza di Aristotele a Bologna ecerta fino al febbraio 1474 prima del suo trasferimento a Venezia e poi a Mosca chiamato da Ivan III, dove realizzera l'unica opera di architettura documentata, la cattedrale dell'Assunzione all'interno del Cremlino. Aristotele non tomo piu in Italia e morl forse a Mosca nel 1486.
Egli dunque god eva di una posizione piu elevata rispetto ai vari scalpellini e muratori bolognesi, ed era I'unica persona di origine e formazione cittadina che avesse avuto fama e rapporti con i pill importanti architetti e signori italiani. Inoltre aRoma aveva avuto modo di osservare direttamente i modelli dell'antico, e probabilmente di frequentare artisti che Ii avevano studiati e applicati. II fatto che abbia prestato la sua abilita di ingegnere a Nicolo V, Paolo II e Sisto IV, in un arco di tempo molto lungo (dal 1451 aI1473), dimostra che Ie sue doti erano apprezzate da persone diverse in tempi diversi. Aristotele, oltre aile capacita tecniche applicate ai vari campi dell'ingegneria e ri
102
37
conosciute ovunque, perfino all'estero, appariva una figura adatta a rappresentare I'ingegno cittadino.
II palazzo del Podesta venne rifondato da Giovanni Bentivoglio per dimostrare il valore, l'importanza e l'indipendenza di Bologna: affidare un tale progetto a un bolognese, definito magnificus eques, che proprio nel 1472, al suo ritorno in citta, era stato rieletto massaro dell'arte dei Muratori e da anni ricopriva il ruolo di ingegnere del Comune di Bologna213
, avrebbe accentuato ulteriormente questi significati. Riconsideriamo nell'insieme, per concludere, la presenza dei membri della famiglia Fioravanti nelle vicende di piazza Maggiore. Fieravante realizza tra il 1425 e i11430 i1 palazzo degli Anziani214
•
Bartolomeo lavora nel palatium vetus nel 1430 ed eresponsabile della costruzione dell'iter in voltis ultimato nel 1442. Aristotele infine e presente nel palazzo del Podesta gia nel1453, 1456 e 1468. In qualita di ingegneri del Comune, i Fioravanti sembrano in sostanza detenere con continuira una sorta di monopolio sulle fabbriche pubbliche bolognesi: una continuira che porta un'ulteriore prova, se pur indiretta, dell'ipotesi che ad Aristotele possa essere attribuito il modello del 1472.
II progetto del palazzo del Podesta, come si evisto, mostra molteplici elementi di inaspettata qualita, fra cui quello di scegliere oppqrtuni modelli presi dall'antico e comprenderne il significato non solo formale rna anche strutturale, uniti tuttavia ad alcune grossolane ingenuita - realizzative e stilistiche - riscontrabili soprattutto al piano superiore. Aristotele, anche se realizza il modello, non riuscl a seguire la costruzione del palazzo, avendo lasciato Bologna ne11475. Le grosse difficolra riscontrate da11472 al1483 che impedirono l'inizio del cantiere potrebbero aver contribuito ai motivi della sua partenza da Bologna. Solo dopo dodici anni, quando finalmente i lavori nel1484 ebbero inizio, it Comune decise di affidarIi a un "cartello" di scalpellini bolognesi guidato da Marsilio Infrangipani, che proprio nel 1488 fonda una societa con altri muratori per dividersi la maggioranza delle imprese edilizie cittadine. In questa maniera il cantiere del palazzo del Podesta si trova in mani affidabili ed esperte delle tecniche e della stile bolognese, tuttavia ancora provinciale e non aggiornato, che eclissa parzialmente Ie brillanti scelte architettoniche di Aristotele.
103
I
Questo saggio e una sintesi e1aboraea della mia tesi di dottorato discussa nel gennaio 2001 presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia. Desidero ringraziare Francesco Dal Co per I'ideazione di questo progetto editoriale e Ie persone che di seguito vado a elencare per aver discusso alcuni argomenti qui trattati e per i numerosi ed essenziali consigli e aiuti di ogni tipo senza i quali questo lavoro avrebbe avuto risultati ben diversi: Howard Burns, Paola Foschi, Manuela Morresi, Maurizio Ricci e Vitale Zanchettin. Massimo Bulgarelli, Pier Nicola Pagliara e Richard Schofield con molta pazienza halillo riletto il testo migliorandone la scrittura e integrando preziosi suggerimenti. La realizzazione di tale saggio ha sottrarto motto tempo che avrei invece potuto dividere con mio figlio Nicholas. A lui dedico questo lavoro.
Abbreviazioni BCA-SM = Biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna Sala Manoscrirti BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana ASB =Archivio di Stato di Bologna
F. Malaguzzi Valeri, L'architettura a Bologna nel Rinascimento, Rocca San Casciano 1899. Richard Tuttle ha ribadito I'attualira dello studio di Malaguzzi Valeri in R.]. Tuttle, Bolo/S'Ul' in EP. Fiore (a cura di), Storia dell'architettura /taliana. II Quattrocento, Milano 1998, pp. 256-271. 2 F. Malaguzzi Valeri, Der Palast der Podesta in Bologna, in «Repertorium fur Kunscwissenschaft», XIII Band, 4 Heft, Stuttgart 1895. Si veda anche Id., La chiesa della Santa a Bologna, in «Archivio Storico dell'Arte», s. n, fasc. I-II, 1896, pp. 72-87. J Per la storia del complesso del palazzo del Podesta dopo il 1506 si veda: F. Benelli, II Palazzo del Podesta di Bologna, 1200-1506. Dalla Domus Comunis al superbo ed arti(iziato modello all'antica, tesi di dottorato, Dipartimento di Storia dell'architertura, Istituto universitario di architettura di Venezia, 2001. Alcune antidipazioni di questo testo sono apparse in Id., II palazzo del Podesta di Bolo/S'Ul (ra tradizione ed innovazione, in M. Ricci (a cura di), L'architettura a Bologna nel Rinascimento (1460-1550) centro 0
peri(eria?, Bologna 2001, pp. 47-68. • II restauro di Rubbiani ebbe inizio nel 1905, sulla facciata verso it Nettuno. I lavori si estesero dal 1908 al 1912 su gran parte del complesso. Per Ie aspre polemiche che si innescarono all'interno della citta si veda O. Mazzei, Al(onso Rubbiani. La maschera e it volto della citta. Bologna 1879-1913, Bologna 1979. Per una sintetica cronologia dei restauri: Id., La Striglia nel (ianco, in F. Solmi, N~. Dezzi Bardeschi (a
cura di), Al(onso Rubbiani: i veri e i (alsi storici, Bologna 1981, pp. 49-71, in particolare pp. 63, 68-69. Cfr. anche G. Rivani, I palazzi-castelli, aspetti e singolarita dell'architettura bolognese nel periodo romanico, in «Strenna Storica Bolognese», XV, 1965, pp. 216-217. Fra gli scettici del progetto rubbianesco spicca I'avvocato Giuseppe Bacchelli che nel giro di un paio d'anni pubblico due articaJi molto polemici: G. Bacchelli, II TestauTO del Palazzo del Podesta, Bologna 1908; Id., Chi Ie mani dai nostri monumenti antichi, Bologna 1910. S II palazzo aveva comunque attrarto I'attenzione di Jacob Burckhardt che 10 cita per tre volte. ]. Burckhardt, Geschichte del' Renaissance in Italien, Eszlingen 1912, trad. italiana a cura di M. Chelardi, Venezia 1991, pp. 63, 177-178. t anche rilevato e rappresentato con tutti i dettagli decorativi da A. Haupt, ArchitettuTa dei palazzi deW/talia settentrionale e della Toscana, vol. IIl, Milano-Roma 1930, pp. 3-7. • P.c. Fallerti, Qual ee come (u la parte piti antica del Palazzo del Podesta, in «VArchiginnasio», I, 1906, pp. 191-195; L. Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna e it palazzo del Podesta, Bologna 1909; C. Zucchini, La (acciata del Palazzo del Podesta, dal sec. XV al XIX, Bologna 1909; Id., II palazzo del Podesta di Bologna, nuovi documenti e note, Bologna 1912. 7 R.]. Tuttle, Sebastiano Serlio Bolognese, in C. Thoenes (a cura di), Sebastiano Serlio, Milano 1989, pp. 22-29. , R.]. Tuttle, Urban Design Strategies in Renaissance Bologna: Piazza Maggiore, in «AnnaJi di Architettura», 5-6, 1994, pp. 39-63. 9 Per il problema storiografico dell'architertura rinascimentale bolognese si veda M. Ricci, In(luenze romane e tradizione autoctona nell'architettura civile bolognese del primo Cinquecento (1515-1530), in Ricci (a cura dil, L:architettura a Bologna nel Rinascimento ... , cit., pp. 69-96, in particolare pp. 69-70. La ricerca archivistica da me effettuata fuori Bologna non ha portato alia scoperta eli documenti importanti. Sono stati comunque rilerti e a volte correrti turti i documenti gia pubblicati. Gli archivi consultati sono: Archivio di Seato di Bologna, Biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna Sala Manoscrirti, Archivi di Srato di Milano, Firenze, Ferrara, Roma e Mantova, Archivio Segreto Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Bibliotheque Nationale de France (Parigi), Pierpont Morgan Library (New York). 10 II rilievo e stato eseguito da chi scrive con l'aiuto fondamentale di Anna Maria Mow e in parte di Vittorio Pizzigoni che ringrazio. Ringrazio anche per j'accesso ai ponteggi gli architetti Roberto Scannavini e Nullo BelJodi, 10 studio Arking di Bologna e
104
11
I'impresa di restauro Doctor. La fondazione duecentesca con l'apertura
della piazza intesa come nuovo foro, Ie ragioni della localizzazione dell'area e Ie sue impGcazioni poliriche, la contestualizzazione dell'operazione urbana comparata agli altri centri italiani, saranno argomenti pubblicati da parte di chi scrive in uno studio complessivo sui complesso podesta rile bolognese che include anche i palazzi di Re Enzo e del Capitano del Popolo. Il Questa affermazione nlttavia potrebbe essere smentita soprattutto alia luce di nuove scoperte archeologiche in quanto, come e noto, i palazzi tardoantichi nella Penisola sono del tutto scomparsi. M. Cagiano de Azevedo, Esistono un'architettura e una urbanistica longobarde?, in CD. Fonseca (a cura di), Casa Citta e Campagna nel Tardo antico e neWAlto Medioevo, Galatina 1986, pp. 57-98; Id., I Palazzi tardoantichi e altomedievali, ibidem, pp. 265-278; S. CurCic, Late-antique Palaces: the Meaning of Urban Context, in "Ars Orientalis», XXlII, 1993, pp. 67-90. Era invece frequente che i palazzi vescovili medioevali, come a Ravenna e Pistoia, venissero "ribaltati" riorientando I'entrata e la facciata principale verso la plazza. M.C Miller, The Bishop's Palace. Architecture and Authority in Medieval Italy, Ithaca-London 2000, pp. 113-114. efr. la recensione di B. Deimling in "Annali di Architettura», 14, 2000, pp. 285-287. IJ Dalla fondazione del Comune di Bologna avvenuta nel 1116 fmo al 1203, la sede del Comune era divisa in tre luoghi distinti anche se adiacenti: la cosiddetta domus comunis, la chiesa di Sanctus Ambrosius, e all'aperto, I'antistante curia. La domtlS si trovava all'angolo fra Ie attuali vie dei Pignattari e Colombina dov'e ancora visibile un'alta colonna romanica cruciforme con capitello a dado, tradizionalmente identificata come elemento della domus stessa. Hans Hubert, ragionevolmente, la considera un residuo della chiesa ill Sant'Ambrogio che, con la relativa curia, venne completamente distrutta alia fine del XN secolo con la costruzione delle prime due campate della basilica di San Petronio. Sulla domus comunis si veda: L. Savioli, Annali bolognesi, Bassano del Grappa 1784, vol. I, par. 109, pp. 113-229; G. Guidicini, Cose notabili della cittil di Bologna, Bologna 1868-73, I, p. 17 e Iv, pp. 190-201 (anche in copia anastatica, Bologna 1972); F. Cavazza, Le scuole dell'antico Studio bolognese, Milano 1896, pp. 50 sgg; Falletti, Qual ee come fu la parte piu antica ... , cit., pp. 191-195; Id., Qual ee come fu la pmte pitt antica del palazzo del Podesta?, in "II Resto del Carlino», n. 190, Bologna, 10 luglio 1906; Rivani, I palazzicastelli, aspetti e singolarita, cit., pp. 213230; P. Foschi, II Liber Tenninorum: piazza Maggiore-piazza porta Ravegnana, in F.
Bocchi (a cura di), I portici di Bologna e I'edi/izia civile medievale, Bologna 1990, pp. 205-224; A.!. Pini, Le piazze medievali di Bologna, in "Annali di Architettura», 4-5, 1992-93, pp. 122-133; C De Angelis, Le costruzioni medievali di via dei Pignattari m1golo vicolo Colombina, in "II Carrobbio», XIX-XX, 1993-94, pp. 67-76; P. Foschi, La aDOmtlS Communis Bononie" ... , ibidem, pp. 77-88; F. Giordano, La prima sede del Comune tra storia e leggenda, ibidem, pp. 89-102 e n. 5 per una maggiore bibliografia; F. Bocchi, La formazione del Comune e la difesa dell'autonomia (1116-.1.167), in Bologna. Atlante Storico delle cittil italiane, vol. I, Bologna 1996, p. 94; P. Foschi, I palazzi del Podesta, di Re Enzo e del Capitano del Popolo: problemi e proposte di interpretazione, in "II Carrobbio», XXIV, 1998, pp. 13-42; E. Guidoni, A. Zolla, Progetti per una cittil: Bologna nei secoli XlII e XIV, Roma 2000, pp. 61-63; H.w. Hubert, Architettura e urbanistica nel Duecento a Bologna, in M. Medica (a cura di), Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna, Venezia 2000, pp. 3-23 (in particolare n. 3). Fino alia fine del XlI secolo, in mancanza di spazi pubblici coperti adeguatamente capienti, Ie sedute del Comune si svolgevano all'interno di chiese e negli spazi antistanti. Troviamo infatti Ia stessa abitudine nel XlI secolo a Piacenza e Brescia: P. Racine, Naissance de la place publique en Italie, in J. Heel'S (a cura di), Fortifications, portes de villes, places publiques, dans Ie monde mediterraneen, Paris, s.a., pp. 302-303,305. " I procuratori del Comune sono numerosi e compaiono sempre in coppia in ogni contratto. Benelli, II palazzo del Podesta di Bologna, 1200-1506... , cit., pp. 112-123. 15 Gli atti d'acquisto sana quarantanove, redatti dai procuratori del Comune. I primi sei contratti ill compravendita sono datati 1200: ASB, Comune, Governo, Registro Grosso, I, cc. 921'-11 Ov. Per la trascrizione di tutto I'insieme dei documenti di compravendita, finora mai pubblicata, si veda Benelli, l/ palazzo del Podesta di Bologna, 1200-1506..., cit., pp. 112-123. Ringrazio il prof. Atti 1io De Luca per I'aiuto alia trascrizione. In passato tali documenti sono stati pubblicati singolarmente: il primo a rendere nota questa operazione, forse riprendendo una notizia fornita dall'AJidosi G.N. Pasquali Alidosi, Instruttione delle cose notabili della cittil di Bologna, Bologna 1621, pp. 131-137 (ristampa Bologna 1999) - fu Guidicini, Cose notabili della cittil di Bologna, cit., vol. II, pp. 398-399. Seguono: P.C Falletti, L'antico palazzo del Podesta in Bologna, in «Atti e memorie della regia depurazione di storia patria per Ie provincie di Romagna», VlI, 1897-98, pp. 488-489; Id., Qual ee come fu la parte pitt antica... , in
«CArchiginnasio», cit.; A. Hessel, Storia della cittil di Bologna, (Berlin 1910) Bologna 1975, ediz. a cura di G. Fasoli, pp. 231-233; Bocchi, Bologna. Atlante storico delle Citta italiane. II Duecento, cit., vol. II, pp. 11-16; Foschi, I palazzi del Podesta, di Re Enzo, e del Capitano del Popolo ..., cit., pp. 13-42. A queste voci concordanti si discosta quella del 1906 di Alfonso Rubbiani che data la costruzione del palazzo del Comune a partire dall'anno 1290 circa, posteriore sia al palazzo di Re Enzo che al palazzo del Popolo, probabilmente non conoscendo i risultati della ricerca di Falletti pubblicati 10 stesso anno. A. Rubbiani, II palazzo di Re E11Z0 in Bologl1a, in «Archivio storico italiano», Bologna 1906, pp. 6-12. Risllitati in parte anticipati in (d., in «II Resto del Carlino», 1828 novembre 1905. Rubbiani probabilmente rimane ingannato dalla cronaca Rampona in cui si afferma che nel1290 «fu hedificaro 10 palazo de Bologna dove se rende rasone». Cronaca A, in CorptlS Chrol1icorum BononiensiHm, a cura di A. Sorbelli, Citta di Castello 1910-38, tomo XVlIl, parte I, vol. U, p. 234; F. Bergonzoni, Le origini e i primi tre seco/i di vita (secc. XIII-XV), in G. Roversi (a cura di), La piazza Maggiore di Bologna, Bologna 1984, p. 24; C Salterini, Atto di vendita fra GHido di Canazedo e i procuratori del Comune Guido di Lambe1tino e Egidio Prittoni, Bologna 28 aprile 1200, in Medica (a cura di), Duece'l1to. Fonne e colori... , cit., pp. 29-30. 16 Carea e queUa compresa fra la cattedrale di San Pietro, con l'annesso palatium del vescovo, il battistero tardoantico e la rocca imperiale distrlltta nel 1115. Questi edifici, per Ie loro grandi dimensioni, dovevano emergere notevolmente dallo skyline cittadino ed erano fra loro allineati assialmente creando un percorso urbano riconoscibile aU'interno del fitto tessuto medievale. Quest'area occupava complessivamente due insulae e mezzo a ridosso dellato nord delle mura di selenite. Durante l'Impero la stessa area era occupata dal mercato e da un tempio, estendendo a ritroso nel tempo il SllO valore pubblico e monumentale. Per Ie caratteristiche urbane di Bologna antica efr. J. OrtaUi, Complessi forensi e architetture civiche nelle citta romane dell'Emilia Romagna: Ariminum, Sassina, Mevaniola, Veleia, Bononia, in M. Mirabella Roberti (a cura di), 'Forum et Basilica' in Aquileia e nella Cisalpina romana, Udine 1995, pp. 299-307. 17 Da un docllmento in ASB, Comune, Governo, Registro Grosso, I, c. 101 v. Dalla cronaca del XVI secolo del Ghirardacci si legge: "Accresciuta la citta di forze, di fortuna, & di ricchezze, Bolognesi designarono fabricare un palazzo publico, magnifico, & capace su la piazza, dove communemente si potesse fare il Consiglio, e
105
tener Ragione dal Pretore, & dai Giudici. La onde da Guido Lambertini & Egidio Prittoni Procuratori de danari del Commune furono comperate molte case per questa cagione, & anco per ampliare Ia piazza [...] Lanno seguenre [1201] essendo Pretore della Citta Guglielmo Rangoni fu edificato il palazzo nuovo della Communita: il qua Ie di presente ehabitato dai Governatori». e. Ghirardacci, Della Historia di Bologna, vol. I, 1596, in Rerum Italicarum Scriptores, a cura di A. Sorbelli, vol. XXXlII, 1, Citta di Castello 1915, p. 108. Leandro Alberti scrive: «Passando la citta Ii suoi giorni SOttO la liberta parve si facesse un Palagio ove ora habita il Podesta secondo alcuni scrittori, rna secondo altri ad un altro, poche inazi fu principia to quel del Podesta, come dicessimo». L. Alberti, Historia di Bologna, Bologna 1541 (ristampa Bologna 1970), Iibro VIII della deca prima, anno 1201; Bocchi, Bologna. Atlante storico... , cit., p. 14. FaHetti tuttavia, senza citare Ie fonti, afferma che i portici del palazzo erano gia terminati il19 maggie 1200, data che perc appare totalmente improbabile se i primi acquisti dei lotti risalgono, secondo i documenti, a venrun giorni prima! Falletti, Qual ee come fu la pm·te pii:t antica ... , in «LArchiginnasio», cit. 18 ASB, Comune, Governo, Registro Grosso, I, ff. 95r-v, 101v-102r. efr. Bocchi, Bologna. Atlante storico ... , cit., p. 14. " Sarebbe stato del res to mol to utile, in un grande canriere, avere attorno larghi spazi sui quali poter disporre i materiali, macchine ecc. da impiegare. La velocita del cantiere non deve tuttavia stupire in quanto anche il palazzo deHa Ragione di Padova, cominciato nel1218, venne completato l'anno seguente. e.G. Mor, II Palazzo della Ragione nella vita di Padova, in AA.VV., II Palaz.zo della Ragione di Padova, Venezia 1964, p. 4. A ben vedere, a parte Ie dimensioni, un palazzo di questo tipo non presenta grandi ptoblemi costruttivi, avendo una pianta estremamenre semplice in entrambi i livelli ed essendo quasi privo di decorazioni. 10 ASB, Comune, Governo, Registro Grosso, I, ff. 89r, 117r. Nella cronaca del Seccadenari compare la notizia, compatibile con i dati riportati nei documenti citati in nota 15, che i lavori alia sala grande cominciarono nel 1201 quando era podesta M. Guielmo Ramponi (0 Ramgoni) da Modena. N. Scadinaro [Seccadenari], Cronaca di Bologna dal1305 aI1513, tomo I, f. 19r. Nella cronaca Bianchini (0 Bianchina) e testimonia to che nel 1203 la sala veniva usata «a tegnire raxone»: BCA-SM, B. 79, copia della cronaca di M.A. Bianchini a opera di U. Zanetti, 1741-42, f. 61'. Si veda anche Savioli, Annali bolognesi, cit., p. 345; S. Muzzi, Annali della citta di Bologna, vol. V, pp. 97-98. Notizie riprese da Falletti,
Qual ee come fu la parte phi antica... , in «L'Archiginnasio», cit.; Hessel, Storia della citta di Bologna, cit., p. 232. 21 Nel centro Italia invece sono piu numerosi gli esempi di palazzi comunali ancora a fortezza, "pieni" e senza portico. G. Marchini, N. Rodolico, I palaz.zi del Popolo nei comuni toscani del Medioevo, Milano 1962; e. Uberti, I palazzi pubblici, in A. Restucci (a cura di), L'architettura civile in Toscana. II Medioevo, Siena 1995, pp. 151223; R.D. Russell, 'Vox Civitatis': Aspects of Thirteenth-Century Communal Architecture in Lombardy, Ph.D. diss., Princeton University, Princeton 1988. Per una ricca e utile raccolta di immagini e planimetrie di palazzi comunali in Italia senza tuttavia alcuna aspirazione scientifica: G.M. Tabarelli, Palazzi Pubblici d'ltalia, Busto Arsizio 1978. 22 Per questo elemento architettonico - da cui proviene iI termine loggia - in origine isolato e in legno apparso in Italia nel IX secolo dopo Ie invasioni longobarde, si veda M. Cagiano de Azevedo, Laubia, in «Studi Medievali», 10/2, 1969, pp. 431463; Miller, The Bishop's Palace ... , cit., p. 63. Per I'atrio porticato e I'architettura pubblica medievale si veda anche I'utile studio di e. Tosco, II castello, la casa, la chiesa, Torino 2003, pp. 10-14. 23 Si eanche sostenuto che iI tipo del palazzo comunale italiano derivi da quello dei palatia tedeschi tardoantichi come quelli di Aquisgrana 0 quello ravennate cosiddetto di Teodorico. Il palazzo di Aquisgrana servi come riferimemo per i Kaiserpfalz, i palazzi imperiali dei quali si conservano ancora quelli di Goslar e Gelnhausen. Questi edifici dovevano essere conosciuti in Italia attraverso gli intensi scambi commercia Ii e culturali tra I'area padana e la Germania. F. Cardini, S. Raveggi, Palazzi pubblici in Toscana, i centri minori, Firenze 1983, pp. 43-50. Questa proposta tuttavia puo far nascere dubbi sostenuti dal fatto che molti palazzi imperiali in ltalia, fra i quali quelli di Pavia e Bologna, vennero distrutti in segno di ribellione dall'Impero divemando quindi modelli da evitare. Un altro strumento che diffuse in Italia questo tipo di palazzo fu al,che la lex palatia emanata da Federico Barbarossa nel 1158 in occasione della Dieta di Roncaglia che 10 legittimava a edificare palazzi nel suo regno italico in qualsiasi luogo egli avesse voluto. efr. e. BrLihl, II Palazzo nelle citta italiane, in La coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento, Convegni del centro di studi sulla spiritualita medievale, Todi 1972, p. 277. 2< Gia menzionato nel 851 e definito palatium ne11122. Era provvisto al primo piano di una gtande sala, camera, dove il vescovo Javotava e riceveva, collegata al piano terreno da una scala forse di discrete dimensioni. Il grande portico ancora oggi visibile venne
costruito in gran parte probabilmente fra il 1217 e il 1234. efr. M. Fanti, La Domus 0
Palatium Domni Episcopi a Bologna nel Medioevo e nella prima meta del Cinquecento, in R. Terra (a cura di), Domus Episcopi, II Palazzo Arcivescovile di Bologna, Bologna 2002, pp. 23-34. 15 Per I'edilizia privata medievale bolognese: Hubert, Architettura e ttrbanistica net Duecento a Bologna, cit., pp. 9-12; Miller, The Bishop's Palace ... , cit., pp. 74-80 can bibliografia. Per Ie torri si veda in generaIe G. Roversi (a cura di), Le torri di BologlUl, Bologna 1989. "Forse costruito fra il1157 e i11166, costituito da almeno due distinti edifici dotati di portici e sale. Vennero demoliti in occasione della costruzione nel 1218 del palazzo della Ragione che venne a sovta ppotsi. Mor, [/ palazzo della Ragione... , cit., pp. 3-5. " J. Paul, De mittelalterlichen Kommunalpalaste in Italien, Dresda 1963, pp. 188-191; H. Porfyriou, Verona: XV-XVI sec%. Da "virtu civile" a "decom pubblico", in D. Calabi (a cura di), Fabbriche, Piaz.ze, Mercati. La citta italianil nel Rinascimento, Roma 1997, pp. 187-223. 2S Vicino al pill vecchio palacium ttrbis Mutina gia esisteme nel 1146, nel 1194 inizio 1a costruzione del palatium vetus, can portico e scala. Pur avendo un carpo separato dagli edifici circostanti, aveva un frome breve sulla piazza estendendosi invece in profondita. G. Martinelli Braglia, [/ Palazzo Comunale di Modena. Le Sedi, la Citta, il Contado, a cura di G. Guandalini, Modena 1985, pp. 18-35. 19 Il palazzo betgamasco, costruito a fianco della catted tale con un lato adiaceme a edifici preesistenti, delimita un lata della piazza rettangolare coincideme con l'antico Foro romano. Un'operazione urbana molto simile equella che accadde pochi anni prima a Patma anche se in questo caso non sono affatto chiare Ie caratteristiche del primo palazzo comunale se non il fatto che era provvisto di una loggia. Per Bergamo si veda: M. Visioli, Bergamo: XV-XVll secolo. Organizzazione e trasf01'lnazione degli spazi urbani, in Calabi (a cura di), Fabbriche, Piazze, Mercati ... , cit., pp. 159188 (can bibliografia). Per Parma: J. Schulz, The Communal Buildings of Parma, in «Mittelungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz,>, XXVI, fasc. III, 1982, pp. 279-324. Per Pavia: Paul, Die lvIittelalterlichen Kommunalpalaste ... , cit., pp. 176-178. 30 Un documento perduto di acquisizione di pili edifici da parte del Comune di Vicenza da utilizzare per pubblici incontti edatato 1200. F. Barbieri, The Basilica of Andrea Palladio, University Park and London, 1970, p. 13, con bibliografia.
106
" AndIe se, dopo 10 scioglimenro della Lega lombarda, i rapporti con Modena e Ferrara divennero bellicosi. Di seguiro si elencano i podesta in carica a Bologna e la loro provenienza (quando nora) durame la costruzione del palazzo duecemesco: 119899 Umberto Viscomi da Milano, 1200 Rolando Rossi da Parma, 1201 Guglielmo Rangoni da Modena, 1202 Gortutesta Pia (di provenienza sconosciuta), 1203 Guglielmo Puscerla da Milano. BCA-SM, AB. 470, Capitani e Podesta della citta di Bologna, f. 791 r. " In questa maniera I'accesso alia piazza poteva essere maggiormeme comrollato. Un cardine del tessuro romano am'aversa anche il palazzo comunale di Vicenza. \1 La posizione isolata e il numero delle campate si ricavano dall'esame del Liber Terminorwn, importante rilievo di piazza Maggiore effettuaro con picchettaggio nel 1286 a opera del Comune, ripetuto piLI dettagliatameme nel 1294. Col fine di delimitare 10 spazio pubblico in modo che non Fosse invaso da botteghe 0 da qualsiasi altra attivita commerciaIe, il Comune posiziona una serie di Termines in pietra attorno alia platea magna e al nucleo dei palazzi del Comune: i termini che si affacciano sulla piazza contengono la definizione iuxta plateam. Quando invece vengono date Ie coordinate dei termini che delimitano ia via che circonda jj complesso podestarile esempre data la distanza fra questi e i muri perimetrali del palazzo. In corrispondenza dei termini 14 e 15 troviamo di nuovo iuxta plateam. Ela dimostrazione che di fronte a questi picchetti non ci Fosse una via, come ericostruito da Falletti e Bocchi, rna uno spazio ben piLI largo, piu 0
meno uguale a quello odierno, a riprova che la lunghezza della facciata non doveva essere troppo diversa da quella attuale. II Liber Terminorum del 1286 ecustodito in ASB, Comune, Governo, Registro Grosso, II, cc. 123r-126v. Quello redatto nel1294 si trova alle carte 127r-158r. Trascrizione imegrale di M. Vemicelli, J "Liber Terminomm" bolognesi, in F. Bocchi (a cura di), Medieval Metropolises Metropoli Medievali, Bologna 1999, pp. 223-330. Si veda anche: Falletti, Qual ee come (u Ia parte piu antica ... , in «I":Archiginnasio", cit.; Hessel, Storia della citta di Bologna, cit., p. 232; J. Heers, Espaces public, espaces prives dans la ville. Le 'Liber Tem1inorum' de Bologne (1294), Paris 1984; Foschi, 11 Liber Te1711inorum: Piazza Maggiore . .. , cit., pp. 205-219; Guidoni, Zolla, Progetti per una citta ... , cit., pp.64-66. " Le botteghe erano soppalcare con un tipo di solaio in legno, cosiddetto tassellum, ottenendo un mezzanino che fungeva da deposito, come avveniva anche nel primo palazzo del Comune di Padova. Cfr. C.
Semenzaro, L'architettura del palazzo, in AA.VV., 11 palazzo della Ragione di Padova, cit., p. 27; Zucchini, 11 palazzo del Podesta di Bologna... , cit., p. 24. Sulle volte 0
arcovolti e sui banchi di vendita dr. ASB, Comul1e, Governo, Registro Grosso, I, ff. 195 sgg., anno 1212. Una sala media viene riportata in ASB, Comune, Governo, Registro Grosso, I, f. 332v; non echiaro tuttavia se il termine media si riferisca a una posizione di un livello in mezzo a due piani o fra due ambiemi sullo stesso piano. Hessel propende per la prima ipotesi. Hessel, Storia della citta di Bologna, cit., p. 232. " Le colonnine di pietra assomigliano molto a quelle dei chiostri bolognesi di Santo Stefano e San Vittore della fine del XII secolo; dr. Rivani, J palazzi-castelli, aspetti e singolaritil ... , cit., p. 216. 36 Non esistono tuttavia prove documentarie o archeologiche in quanto la cortina muraria originale estata sostituita cancellando qualsiasi eventuale traccia di rotture. Mentre la finestra a ovest corrisponde esattamente con I'ottava campata del portico nellaro sud, 10 stesso non accade con quella a est che non corrisponde a nessun punto notevole del prospetto. Eanche vero tuttavia che I'allineamento assiale dell'arcata con 1a finestra soprastante non era ancora una prerogativa rotalmente affermata nelle facciate di edifici pubblici del XIll secolofra Ie eccezioni si segnala il Broletto di Milano - come si puo notare, per esempio, in quella del palazzo di Cittanuova a Cremona (1206). Tale allineamento verticale nelle facciate dei palazzi pubblici diven·a prassi molto piLI tardi, nella seconda mera del XV secoJo. J7 L'ipotesi di facciata con quattro finestre e stata avanzata da Foschi nel disegno ricostruttivo di piazza Maggiore. Foschi, 11 Liber Tenninorum: Piazza Maggiore ... , cit., p. 202. J8 Se il nwnero di finestre fosse stato pari a quarn'o avrebbe escluso una finesrra centrale in asse con la quinta campata. Per Ja costruzione della ringhiera: Biblioteca Urtiversitaria di Bologna (BUB), Cronaca Villola, anno 1256; Falletti la descrive portata da quatt!ro grossi pi/astri, dotara di due arcovolti e sporgeme verso la piazza; Falletti, Qual ee come (u la parte piu antica ... , in «L'Archiginnasio", cir.; Hessel, Storia della cittil di Bologna, cit., p. 232 n. 47. J9 A fianco della soglia di questa porta e sullo stesso livello sana presenti dei fori nella muratura piLI grandi di quelli delle norma Ii buche pontaie, adatti ad alloggiare travi lignee sostenenri un ballatoio che partiva dalla torre dell'Arengo oppure un balcone che non necessariameme doveva essere di collegamento. Questa porta venne murata probabilmente negli anni settanta del XVI secolo con la costruzione del palazzo del
Tribunale della Row a opera del Terribilia 0
addirittura prima quando, come vedremo, il salone perdera la sua funzione originaria. Un altro indizio che porta a pensare che quella Fosse la quota del salone medievale eche la porta giace sullo stesso livello dell'iter in voltis, costruito prima dell'intervenro quamocenresco e quindi presumibilmente Iivellaro alia sala. L'innalzamento della quota di questo ambiente, dovuta al progetto rinascimentale, comporta la salita di sette gradini, quamo dei quali inseriti nello spessore del muro. '0 A sesro ribassaro sono anche gli archi duecemeschi sopra il passaggio posro nell'asse del palazzo. " Intorno agli anni dieci del Novecemo, durante il restaLlto del pavimento del portico, sana tornate aUa luce alcune basi dei pilasrri che sorreggevano la facciata medievale. Le stesse basi sono state nuovameme dissorterrate e fotografate nel 1990 in occasione di un rifacimemo della pavimentazione. Ringrazio la dott. Paola Foschi che cortesemente mi ha permesso di fotocopiare Ie forografie, al rempo inedite, di rale ritrovamento. Quella qui pubblicata si riferisce al pilastro di sinistra della campata centrale della facciata. Le fotografie di questi interventi appartengono all'Unita operativa stud i e imerventi storico monumemaJi del Comune di Bologna. La dott. Foschi ha pubblicaro I.a stessa foto, quasi contemporaneamente al mio saggio del gennaio 2001, nell'importante studio sulla fase medievale del complesso podestarile: P. Foschi, J palazzi del Comune di Bologna, in A.I. Pini, A.L. Trambetti Budriesi (a cura di), Bologna Re Enzo e if suo mito, Arti della giornata di studio (Bologna, 11 giugno 2000), Bologna 2001, presso la Deputazione di Storia Patria, pp. 65-102; Zucchini, 11 palazzo del Podesta di Bologna... , cit., p. 22; Foschi, J palazzi del Podesta, di Re Enzo, e del Capitano del Popolo ... , cir., p. 16; F. Benelli, 11 Palazzo del Podesta di Bologna (ra tradizione ed innovazione, in Ricci (a cura di), L'architettura a Bologna nel Rinascimento ... , cir., pp. 47-68. 42 PiJastri poJilobati sono comunque diffusi a Bologna. Nel portico del palazzo della Biada, verso I'angolo sud-ovest della piazza Maggiore, sono presenti pilastri bilobati con base modanata in pietra appoggiata su un piedistalJo rettangolare, arricchito con gri((es, molto simile al sistema rinvenuro nel palazzo del Podesta. Cfr. H.W. Hubert, Der Palazzo Comunale von Bologna, KblnWeimar-Wien 1993, pp. 13-29. Troviamo un pilastra trilobato nell'angolo fra via dei Pignattari e vicolo della CoJombina, di frome al lato ovest di San Petronio, che doveva far parte della chiesa di Sa nt'Ambrogio. Cfr. nora 13. Secondo Paul, il palazzo dell'Arengo di Rimini, cominciato
107
44
a partire dal 1206, venne costruito sui modello stilistico di quello di Bologna: i suoi pilastri, ricostruiti in stile ne11916, hanno una pianta con caratteristiche idemiche e i capitelli sono a dado. Paul, Die Mittelalterlichen Kommunalpalaste... , cit., pp. 181-183. Notizia ripresa anche da Hubert, Architettura e urbanistica nel Duecento a Bologna, cit., p. 6. " I1lato posteriore del pilastro medievale e arretrato di circa 60 cm da quello rinascimemale ed e quasi allineato al filo del pilastro della campata latera Ie sui quale si imposta l'arco del portico.
Di questa grande scala, ora abbattuta, si puo ancora vedere la traccia sulla facciata del posteriore palazzo del Capitano. Schulz, The Communal Building of Parma, cit., pp. 284-285. ., L:accesso principale quindi viene a trovarsi sullato est del palazzo, quello opposto alia platea maioI', I'asse nord-sud pill importame della citta. Potrebbe essere un ulteriore indizio delJ'operazione, da parte del Comune, di ribaltamento dei valori topografici urbani precomunali. Tale scala doveva essere di poco sporgeme dal volume del palathmt vetus. Anche i termini 29 e 30 sono rispettivameme «versus plateam comunis» e «plateam ubi olim fuit ecclesia Sancti Appolonaris», il che significherebbe che la curia potestatis, la piazza cioe fra il palatium vetus e il palatium novus di Re Enzo, costituiva un unico spazio con la via pubblica senza I'alto muro di divisione che oggi si vede. Cfr. trascrizione imegrale del Libel' Tenninorum in Vemicelli, I "Libri Terminorum" bolognesi, cit., pp. 223-330, in particolare pp. 277,279. Cfr. nota 33. .. ASB, Comune, Governo, Registro Grosso, I, c. 294v del 22 agosto 1219: «...Stationem et locum qui est subtus scalam ligneam palatii a latere sero palatii, secundum quod dicta scala lignea tenet». efr. Bocchi, Bologna. Atlante storico ... , cit., p. 16. ., A Bergamo e Firenze e proba bilmeme a Parma il podesta non risiedeva con la familia, rna in abirazioni private affittare dal Comune 0 da loro stessi. Cfr. Schulz, The Communal Buildings of Parma, cit., p. 28I. " Zucchini afferma anche che Ie sranze del podesta forma va no al primo piano una specie di grande loggiaro affacciante sullo spazio a nord della torre; Zucchini, II palazzo del Podesta di Bologna... , cit., p. 18. Inoltre tesrimonia che, durame i lavori di smamellamento del palazzo della Rota, vennero rirrovati quattro angoli eli un edificio amico cosriruiti da pierre graffire che delimitavano I'ingombro di una cosrruzione medievale, di perimerro corrispondeme all'attuale cortile sopraelevato. I quamo spigoli di questo edificio in rea Ita non sono in pietra graffita, almeno nell'angolo relativo alia curia e I'unico ancora visibile, rna di
mattoni pill scuri. Affermazione contenura in un'intervista a Guido Zucchini di E. Giovannetti, Quel che s'e trovato nel palazzo del Podesta, in «II Resto del Carlino», 10 luglio 1906. Tale tipo di mattoni sono detti "inverriati", poco porosi e resistemi all'umidita, diffusi a Bologna soprattutto su spigoli di edifici amichi. L. Marinelli, P. Scarpellini, L'arte muraria in Bologna nell'etil pontificia, Bologna 1992, p. 26. Potrebbe derivarne che a nord di questa casa poteva esserci un vicolo che scorreva parallelo al palatium vetus rangente allato sud della torre dei Lambertini, quesr'ulrima inglobara dal palazzo del Capitano del Popolo. Cfr. Foschi, I palazzi del Comune di Bologna, cit., p. 9I. " Per Ie vicende politiche di questo secolo che trasformarono Bologna in modo graduale rna turbolento da Comune a Signoria si veda la simesi in G. Tamba, I documenti del Governo e del Comune bolognese, in «Quaderni culturali Bolognesi», II, n. 6, Bologna, giugno 1978, pp. 13-16. so Per Ie vicende costruttive di tale edificio efr. !'esamiente studio di H. Hubert, II Palazzo Comunale di Bologna: da granaio a palazzo papale, in G. Perini (a cura di), II luogo ed iI ruolo della citta di Bologna tra Europa continentale e mediterranea, Bologna 1992, pp. 167-180; Id., Del' Palazzo Comunale ... , cit.; per la fase medievale in particolare pp. 13-76. " Per il palazzo dei Notai rimane fondamentale il documentato studio di G. Cencerti, II palazzo dei Notai in Bologna, Bologna 1969. 52 Per Ie fasi di costruzione di San Petronio si veda: A. Gatti, La fabbrica di San Petronio: indagini storiche, Bologna 1889; LB. Supino, Le fasi costruttive della basilica di San Petronio, in «L:Archiginnasio», YIn, 1913, pp. 127-136; M. Fanti, La fabbrica di San Petronio in Bologna dal XIV al XIX secolo. Storia di un'istituzione, Roma 1980; M. Fanti et a!' (a cura di), La Basilica di San Petronio, 2 vol!., Bologna 1983-84; A.L. Trombetti Budriesi, I primi anni del cantiere di San Petronio, in M. Fanti, D. Lenzi (a 'cura dil, Una basilica per una citta, Bologna 1994, pp. 51-75. 53 Pasquali Alidosi, Instmttione delle case notabili... , cit., p. 134. Questo portico spiega Ie allusioni a "fenestris et tegulis paJatiis veteris», 0 al «copertorio tegularum» contenute in due documenti del 1393 riguardanti botteghe posre sorto il portico del palazzo. Cfr. Zucchini, II palazzo del Podesta di Bologna... , cit., p. 2I. ,. Londra, National Gallery. Eun palazzo sullo sfondo del polirrico La vita di san Francesco nella pala del Sogno di san Francesco realizzaro a partire dal1437 per la chiesa di San Francesco a San Sepolcro. Il
palazzo ha un volume retrangolare, una torre centrale, cinque grandi finestre ad arco acuto al primo piano e una finestra con inferriate aJ piano terreno (probabilmente Ie carceri). La tetroia sporge tutravia da un muro pieno e non da un portico, dando all'edificio quelJ'aspetto tipico dei palazzi pubblici del cemro Italia. Tale sistema caratterizza anche la facciata del palazzo comunale di Mantova. 55 Anche se I'aspetto rimase inalrerato, murarono frequentemente Ie funzioni di moire delle sranze interne. Si segnala fra tutte il rrasferimento, avvenuto nel 1357, dell'archivio pubblico dal palazzo della Biada a quello di Re Enzo, ad accennlare il declino del complesso podestarile e l'affermarsi di quello comunale sui lato ovest della piazza. Pasquali Alidosi, Instmttione delle cose notabili ... , cit., p. 20. Per dorare I'archivio di stmtrure in muratura e non lignee, pill sicure in caso di incendio, il Comune inca rico Antonio di Vincenzo della costruzione di pilasrri e volre in muratura da erigersi al primo piano del palazzo di Re Enzo. Cfr. Zucchini, Ii palazzo del Podesta di Bologna ... , cit., pp. 10 sgg; Foschi, I palazzi del Podesta, di Re Enzo e del Capitano del Popolo ... , cir., p. 30. Per Antonio di Vincenzo, in seguito incaricaro della costruzione di San Petronio: A. Ghidiglia Qllinravalle, ad vocem, in DBI, vo!' III, Roma 1961, pp. 581-583; A.M. Matteucci, Affinita d'intenti nella cultura tardogotica bolognese, in «Paragone», pp. 419,421-423; Id., II protoumanesimo di Antonio di Vincenzo, in Perini (a cura di), II luogo ed il ruolo della citta di Bologna... , cit., pp. 153-166. 56 l:8 setrembre 1438 Annibale Benrivoglio, figlio narurale di Gian Galeazzo, esaurora il legato pontificio con I'aiuto di Filippo Maria Visconri la cui famiglia aveva gia remporaneamente governato Bologna alcuni anni prima. Tamba, I documenti del Govemo ... , cit., p. 20. 57 ASB, Massarolo dei Lavori, foglio sciolto, rrascritro e pllbblicato da Zucchini, Ii palazzo del Podesta di Bologna... , cit., pp. 70-76. Tale corpo di fabbrica verta distrutto nel 1572 per costruire un palazzo progettato dal Terribilia destinaro a uso di abitazione degli Auditori della Sacra Rota. l:iter in voltis verra ricosrruito abbastanza fedelmente da Alfonso Rubbiani all'inizio del XX secolo, ibidem, pp. 62-63. IS Nel 1440 per fare spazio alia nuova cosrruzione furono demolite Ie carceri che vennero trasferite sotto il palazzo di Re Enzo e d'ora in poi definire nove. Cfr. Guidicini, Case notabili della citta di Bologna, cit., vol. II, pp. 411-412. " In queJla posizione doveva gia esserci ruttavia un ingresso come ancora si vede sui fianco sinisrro dell'arruale, costruito, come
108
si legge sull'iscrizione, nel 1503. L'originale enotevolmente piu basso di quello cinquecentesco, perche eancora allo stesso livello della sala del palazzo duecentesco che, come si evisto, era a un'altezza inferiore di circa un metro. ,." BUB, ms. 584, Cronaca Saraceni, f. 63: ,,1442: Furno fatte Ie merzerie soto il palazo del podestil, fu buta ta a terra una logia ed scala ed una logeta del palazo verso Ie pescharie dove stava il dacio del sale". Zucchini pubblica questo brano del Saraceni ma senza collegare il motivo della demolizione della scala con la costruzione dell'iter in voltis. Zucchini, II palano del Podesta di Bologna... , cit., p. 27. " Hubert spiega che da] Trecento in poi l'arco ribassato ha molta fortuna a Bologna per ragioni tecnico-strutturali: nel sostituire i portici lignei cittadini, permette di collegare elasticamente pilastri preesistenti posti il piu delle volte a distanze diverse rispettando Ie altezze date, compito impossibile per I'arco a tutto sesto. H. Hubert, L'architettura bolognese del primo Rinascimento, Osservazioni e problemi, in Ricci (a cura dil, L'architettura a Bologna nel Rinascimento... , cir., p. 34. " Bartolomeo Fioravanti era fratello di Fieravante e zio del piu famoso Aristotele. Nel 1430 lavon) come muratore anche nel palazzo degli Anziani assieme al fratello Fieravante. Zucchini, II palano del Podesta di Bologna... , cit., pp. 65-78. Per Bartolomeo Fioravanti dr. A. Ghisetti Giavarina, ad vocem, in DBI, vol. XLVm, Roma 1997, pp. 100-101; Hubert, L'architettura bolognese del primo Rinascimento ... , cit., pp. 30-33. "Pasquali Alidosi, Instruttione delle cose Ilotabili ... , cir., p. 135; Guidicini, Cose notabili della citta di Bologna, cir., vol. II, p.402. (" ASB, Atti del Reggimento, 12 settembre 1449. Citato da Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna... , cir., 1909, pp. 56-57. Si ricorda che Sante Bentivoglio era Signore di Bologna, de facto, mentre Nicolo Sanuti era un dottore in legge, membro del Consiglio dei Sedici riformatori e fedele alia fazione bentivolesca, committente delJ'omonimo palazzo di via San Felice, ibidem, pp. 19-20; Malaguzzi Valeri, L'architettura a Bologna nel Rinascimento, cit., pp. 124-127. 65 Questa sistema dannoso e invasivo si ritrovera impiegato fino ad almena buona parte dell'Ottocenta come dimostra un'incisione del Basoli del 1831. Si ricorda che la sezione dei pilastri dell'edificio medievale era molta minore di quella attuale. Si potrebbe anche pensare che i pilastri duecenteschi, in quanto facilmente perforabili dagli e1ementi lignei della struttura delle botteghe, fossero costituiti
di fasce alternate di pietra arenaria e mattoni proprio come quelli del vicino palazzo della Biada. Questi ultimi, come abbiamo visto, sono stati ereni circa cent'anni dopo e con forma uguale a quelli del palatium vetus e, alia luce di questa osservazione, possiamo suggerire anche con 10 stesso uso del materia Ie. 66 M. Gualandi, Aristotele Fioravanti meccanico ed ingegnere del secolo XV Memoria, in "Ani e memorie della regia deputazione di storia patria per .le provincie di Romagna", IX, 1870, pp. 5777, in particolare p. 59; S. Tugnoli Panaro, Le opere bolognesi di Aristotele Fioravanti architetto e ingegnere del Secolo XV, in Aristotele Fioravanti a Mosca, Ani del Convegno (Bologna 4-8 ottobre 1975), in "Ane Lombarda", nn. 44-45, 1976, pp. 35-70, in particolare p. 49; Ghisetti Giavarina, ad vocem, in DBI, cit., pp. 95100 con bibliografia. " Nel 1455 venne incaricato di raddrizzare il campanile di San Biagio a Cento, del consolidamento della porra di Galliera e del raddrizzamento del campanile della chiesa di San Michele Arcangelo a Venezia. Ghisetti Giavarina, ad vocen1, in DBI, cir., p. 96. 6' BCA-SM, B. 1154, f. 6r, descrizione anonima dell'impresa con rudimentale disegno della torre. Per una descrizione esaustiva dell'evento: TugnoJi Panaro, Le opere bolognesi di Aristotele Fioravanti ... , cit., pp. 41-48. " Nella sua prima permanenza aRoma Aristotel.e fu impegnato nella scavo e trasporto di colonne giganti monolitiche destinate al. coro di San Pietro provenienti dall'area della chiesa di Santa Maria sopra Minerva, probabilmente appartenenti alia basilica di Nettuno dietro al Pantheon. E. Muntz, Les arts ala cour des Papes, I, Paris 1878, pp. 83, 108; A. Bertolotti, Artisti bolognesi, ferraresi ed alwni altri del gia Stato Pontificio in Roma nei seeali XV, XVI, XVII, Bologna 1886, pp. 2 sgg.; R. Lanciani, Storia degli scavi di Roma, Roma 1989, vol. 1, pp. 62-63; Ghiseni Giavarina, ad vocem, in DBI, cit., pp. 95-100; C.R. Mack, Bernardo Rossellino, L.B. Alberti, and Rome l of the Pope Nicholas V, in "Southeastern College Art Conference Review", 10, 1982,2, pp. 60-69. Nel secondo soggiorno venne incaricato dello spostamento dell'obelisco Vaticano - in que I tempo a fianco della rotonda di Sant' Andrea - nel centro della piazza di fronte a San Pietro in asse con l'ingresso. Per 10 spostamento, come enoto, si dovra aspettare fino a Domenico Fontana. L. Beltrami, Vita di Aristotele da Bologna, BoJogna 1912, p. 108; Ghiseni Giavarina, ad vocem, in DBI, cir., p. 96. '0 F. Bocchi, II patrimonio bentivolesea alia meta del Quattrocento, Bologna 1970; Id., I
Bentivoglio da cittadini a Signori, in "Atti e memorie della regia deputazione di storia patria per Ie provincie di Romagna", n.s., XXII, 1972, pp. 43-64. Per la committenza Bentivoglio si veda: G. Billings Licciardello, Notes on the Architectural Patronage in Bologna of the Bentivoglio, Ph.D. diss., Columbia University, Ann Arbor 1990, con molti passi discutibili. 71 «Adi 15 detto [ottobre 1468] lire vinti di quattrini [... ] a maestro Aristotelle di Fioravanti, conti per parte di L. 60 de Javorieri fa in palazzo del magnifico podesta": ASB, Ufficio del Calcolatore delle ragioni della Camera. Calcoli per spese. Tabule Bartolomei Mini. Citato da Malaguzzi Valeri, L'architetlura a Bologna nel Rinascimento, cit., p. 41; A. Filippini, Le opere architettoniche di A. Fioravanti in Bologna e in Russia, in «Cronache d'arte", II, 1925, 3, pp. 101-120, in particolare pp. 114, 119; trascrirto da TugnoJi Panaro, Le opere bolognesi di Aristotele Fioravanti ... , cit., p. 62. Sighinolfi afferma che Aristotele fra il1468 e il1470 «compiva molti ed importanti lavori di adattamento nel Palazzo del Podesta" senza pero specificare la fonte di questa informazione: Sighinolfi, L'architetlura bentivolesea in Bologna... , cit., p. 68. I.:autore per primo mette in luce, attraverso la pubblicazione di alcuni importanti documenti soprattutto estratti dai mandati e partiti del Comune bolognese, i meccanismi di finanziamento per la ricostruzione del palazzo. Nello stesso anno, il 1909, un'altra pubblicazione di Zucchini aggiunge inediti particolari all'argomento: Zucchini, La facciata del palazzo del Podesta ... , cit., pp. 16-18. 72 Pur essendo strettamente legato agli Sforza Giovanni mamenne un forte legame anche con Cosimo Medici e Lorenzo it Magnifico, sostenendolo durante la congiura dei Pazzi. G. De Caro, Giovanni Bentivoglio, in DBI, vol. VIII, Roma 1966, pp. 624-625. 73 II legame con i duchi milanesi era gia saldo in seguito al matrimonio di Giovanni nel 1464 con Ginevra Sforza, nipote di Francesco e vedova di Sante Bentivoglio. De Caro, Giovanni Bentivoglio, in DBI, cit., pp. 623-626; G. Clarke, Magnificense and the city: Giovanni II Bentivoglio and architecture in fifteenth-century Bologna, in «Renaissance Studies", vol. XIII, 4, 1999, p. 410. 74 ASB, Governo, Libel' Mandatorum, 17 giugno 1471. Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna... , cit., p. 57. 7S ASB, Governo, Libel' Mandatorum, 17 giugno 1471. Citato da SighinoJfi, L'architettura bentivolesca in Bologna... , cit., p. 57. Ai due elargi per 10 stesso scopo 227 lire di bolognini. ASB, Comune, Governo, Riformatori dello Stato di Liberta, Libri Partitorum, ff. 105r-l 07r. Anche alcuni
109
Podesta donarono somme persona Ii per la «reparatione et ornamenro» della propria residenza. ASB, Comune, Governo, Riformatori dello Staro di Liberta, Libri Partitorum, ff. 107r-109r. 7' ASB, Governo, Libel' Mandatorum, 13 agosto 1472. Citaro da Sighinolfi, L:architettura Bentivolesca in Bologna ... , cir., p. 57. 77 Lo strumenro del modello ligneo per un edificio civile era gia searo usaro a Bologna nel 1425-26 per il progerro del palazzo degli Anziani, e I'architetto incaricato fu Fieravanre Fioravanri, padre di Arisrorele. E probabilmenre il primo modello documenraro nel campo dell'edilizia civile. In precedenza anche nel progetto del San Perronio era srato usaro un modello ligneo. Huberr, L:architettura bolognese del primo Rinascimento ... , cit., p. 30. All'inrerno della casa dello scalpellino Giovanni Piccinini da Como, edocumenrara I'esisrenza di un modello del palazzo degli Srrazzaroli, conremporaneo al canriere del Podesra. Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna ... , cit., pp. 163-166. 7S ASB, Comune, Governo, Riformarori della Srato di Liberra, Libri Partitorum, f. 30r. Trascrirto e pubblicaro da Sighinolfi, ibidem, p. 147. Vedi anche pp. 57-58. 79 II Consiglio dei Quanromila era un organo di governo naro nel X1I1 secolo durance la fase di governo del popolo. I quarrromiia componenri venivano eleni in rappresenranza dei quanro quarrieri cittadini, mille per ciascuno. 11 loro compiro, di secondaria imporranza, era quello di eleggere gli ufficiali d i Bologna e del Contado e sorvegJiare illoro operaro. II mandaro durava quanro anni. Pasquali Alidosi, Istruttione delle cose notabili ... , cit., pp. 58-59; BCA-SM, ms. M. Gualandi, vol. 4-A, p. 27; Zucchini, La (acciata del palazzo del Podesta ... , cit., p. 7. so Tali dazi era no pagari dagli ufficiali del Comune all'ano della nomina e con quesra entrara, evidenremenre cospicua, iI Comune fu in grado di finanziare una parre dei lavori del palazzo stesso, la chi usa sui Reno a Casalecchio e alcuni lavori sui Naviglio. Per i denagli di quesri finanziamenti si veda no: ASB, Comune, Governo, Riformarori dello Srato di Liberra, Libri Partitorum dell'ultimo venrennio del XV secolo. Cirari da Zucchini, La (acciata del palazzo del Podesta ... , cit., pp. 7-8; Sighinolfi, L:architettura bentivolesca in Bologna... , cit., p. 82. 81 II programma polirico di Giovanni fu fin dall'inizio orienraco in rre direzioni: rinforzare il porere all'inrerno della cina, diminuire I'imporranza del legato ponrificio e ampliare e fortificare Ie alleanze con gli aleri Srari, sopranuno Firenze e Milano. Nel 1464 aumenro la magisrrarura dei Sedici a venti membri provenienri da
famiglie allea re, eletti a vira 0 per via erediraria in carica a rorazione semesrrale. Giovanni invece, gonfaloniere, dereneva la carica cosranremenre, divenrando il prior di rune Ie decisioni del Consiglio. Rinforzaro in quesco modo iI conrrollo sui parriziaro, nel 1466 limiro i poreri dellegaro stabilendo che ogni sua decisione doveva essere approvara dal Senato cinadino. Significarivamenre I'arrriburo libertas scomparve dallo sremma del governo e dalle monete. Questa mossa ovviamenre cosricui un forte srrappo con il papa Paolo II. C. Ady, The Bentivoglio o( Bologna, London 1937, pp. 60-62. F. De Bosdari, I primordi della Signoria di Giovanni II Benrivoglio a Bologna (1463-77), in "Ani e memorie della regia depurazione di sroria parria per Ie provincie di Romagna», n.s., 111,1953, pp. 185-188; De Caro, Giovanni Bentivoglio, in OBI, cit., p. 624. 82 11 Consiglio degli Anziani cunavia, con l'avvenro della Signoria benrivolesca, aveva perso la sua importanza a scapito del Consiglio dei Sedici, presieduro da Giovanni Benrivoglio. Anche se gli Anziani manrenevano la fascosa sede all'inrerno del palazzo della Biada, i poreri esercirari riguardavano sopranuno I'amminiserazione degli affari comunali. Cfr. U. Dallari, Dell'Anzianato nell'antico comune di Bologna, in "Ani e memorie della regia depurazione di scoria parria per Ie provincie di Romagna», s. III, V, 1887, pp. 189-243; Tamba, I documenti del Governo ... , cit., pp. 55-56. 53 Nicolo Sanuti era proprierario di una bonega fin dal 1459, "posra in logho donde era la scalla andava in palazo in dritto 10 palazo de i signori». ASB, Libro di Spese di Nicolo Sanuri, 23 febbraio 1459. Trascrino e pubblicaro da Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna... , cit., p. 94. Nel 1473 e 1474 si regisrrano alcuni inrervenri di ristrunurazione alia ringhiera, sorro la direzione e sorveglianza dei due parrizi bolognesi Giovanni Dell'Armi e Banista Malvezzi. ASB, Governo, Liber Mandatorum, 14 Gennaio 1473. Ciraco da Sighinolfi, L:architettura bentivolesca in Bologna ... , CIt., p. 72. S< ASB, Comune, Governo, Riformacori dello Sraco di Liberra, Libri Partitomm, 11 febbraio 1474, f. 235. Trascrirro e pubblicato da Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna ... , cir., pp. 147148. Vedi anche p. 72. 55 Bernardo da Sassuno, uomo da sempre molro fedele a Giovanni, mort runavia poco dopo, il 2 agosto e il suo incarico non venne rimpiazzato. Ghirardacci, Della Historia di Bologna, cit., pp. 227-228. Nel 1481 Pirro aveva preso il posro di Virgilio Malvezzi nel Consiglio dei Sedici. Cfr. Pasquali Alidosi, Istruttione delle cose notabiLi ... , cir., p. 44.
S6 Evidenremente I'inrervenro direno di Giovanni fu persuasivo. Le lora decisioni avevano valore uguale a quelle del luogorenente dellegaco e dei Sedici di Reggimenro. Quesra c1ausola avrebbe sveltito di molto Ie procedure burocratiche, scavalcando oltretuno i pareri dei due organi del "governo misro" bolognese. ASB, Comune, Governo, Riformarori dello Stato di Liberra, Libri Pal'titorum, c. 1081'. Trascritto e pubblicaro da Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna ... , cit., p. 153. " II papa si rese conro del porere assoluto che Giovanni si srava creando all'inrerno della citta assieme a inrenzioni indipendenrisre nei confronri del papaw. Sisro IV cunavia prefer! assecondare Giovanni anche a causa dell'imporranza della citta di cui era Signore e delle srrene alleanze che il Benrivoglio vanrava con Firenze, Milano e la Romagna. De Caro, Giovanni Bentivoglio, in OBI, cir., p. 625. " Per quesre vicende si veda: Ghirardacci, DeLLa Historia di Bologna, cir., pp. 227228; De Caro, Giovanni Bentivoglio, in OBI, cit. pp. 626-627. " Ghirardacci, Della Historia di Bologna, cir., p. 226. Sighinolfi, cirando erroneamenre il Ghirardacci, dara la demolizione delle boneghe al 1482. efr. Sighinolfi, L'architettura Bentivolesca in Bologna... , cir., p. 73. Pasquali Alidosi invece Ie dara al luglio 1483; Pasquali Alidosi, lstntttione deLLe cose notabili ... , cir., p. 135. '0 Importanre murarore, in stretto conrano con Ariscorele Fioravanri, quando era a capo dell'ane dei muracori bolognese il 12 marzo 1460 pose la prima pietra del palazzo di Sanre e poi di Giovanni Benrivoglio. Per la vira e Ie opere di Nadi si veda: R. Dondarini, Gasparo Nadi, caPOl1Ulst1'O bolognese (1418-1.104), in Bocchi (a cura di), I portici di Bologna ... , cir., pp. 135-147. " G. Nadi, Diario bolognese, a cura di C. Ricci, A. Bacchi Della Lega, Bologna 1886, p. 100. La stessa norizia eanche riportata nella cronaca Bianchina in cui si legge che andarono distruni "molri choverti e chaxe basse Ie quale erano una brura quosa da vedere chon molti chassuni de legnamo che andavano in fino in mezo piaza". BUB, ms. 294, Cronaca Bianchina, f. 79r. Vedi anche Zucchini, La (acciata del palazzo del Podesta ... , cir., p. 10. 91 Ghirardacci, Della historia di Bologna, cir., p. 228. Ghirardacci riporra anche che in quell'anno Giovanni fece dei considerevoli lavori alia chiesa di San Giacomo: "Alii 24 di luglio, il giovedi, parendo al signor Giovanni Benrivogli che il corridore che rraversava la chiesa di San Jacomo, ove era no sono l'alrare di sanra Carerina er I'alrare di san Pierro troppo sconciamenre occupasse il deno rempio, il
110
fece rimuovere et ridusse la chiesa ad un sol corpo, siccome hora si vede» (p. 226). ,; ASB, Partiti del Senato, 9 gennaio 1484, trascrirro e pubblicato da Sighinolfi, L"architettura bentivolesca in Bologna... , cit., pp. 156-157. Eda notare come la somma venne quadruplicata rispeno aile 1000 lire di bolognini stabilita neI1472. I due soprastanri vennero riconfermati annualmente fino al 1488, I'anno della cosiddetta congiura dei Malvezzi, che causo 10 sterminio da parte di Giovanni di gran parte della famiglia e I'esilio dei sopravvissuti. Si veda Ady, The Bentivoglio o(Bologna, cit., pp., 103-117. ,. II partito provvedeva a da re va lore legale aile senrenze anche se esse, al contrario di quanro stabilivano gJi statuti del Comune, erano prese al di fuori della sala magna, duranre il periodo necessario ai lavori. ASB, Comune, Governo, Signorie visconrea, ecclesiastica e bentivolesca, Liber novissimartl1n provisionum. 14711514, f. 129r. Trascritto e pubblicato da Sighinolfi, I.:architettura bentivolesca in Bologna... , cit., pp. 157-158. " In quell'anno ci fu il rovinoso crollo di una torre sulla piazza Ravegnana e adiacente al palazzo della Mercanzia, dove sotto Ie macerie morirono diverse persone. II fatto feee molto scalpore in citta e impressono i sopravvissuti che riferirono "Putabant, inquit, iam ultimum venisse iuditium». Forse questo evento contribul ad accelerare I'inizio dei lavori di ricostruzione del pericolante palazzo del Podesta. Cfr. BUB, ms. 1609, H. De Bursellis, Cronica Gestorum ac Factorum memorabilium civitatis bononie edita a (ratre Hyeronimo de Bursellis ab urbe condita ad a. 1497, in Rerum Italicarum Scriptores, a cura di A. Sorbelli, vol. XXlJI, 2, Citta di Castello, p. 106. 96 ASB, Comune, Governo, Riformatori dello Stato di Liberta, Libri Partitorum, f. 127v. Trascritto e pubblicato da Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna ... , cit., p. 158. "BCA-SM, B. 1848, Cronica di Bologna, f. 22r. La cronaca, come si legge nel fronrespizio, estata copiata a mana da Lino Sighinolfi nel 1907. 9S Nadi, Diario bolognese, cit., p. 111. La stessa versione del Nadi edata anche da Pasquali Alidosi: "il seguente anno [1484] di Novembre, e di Decembre per sudetto effetto fu a tterra ta anco la faccia ta di detto Palazzo dove era la Renghiera». Pasquali Alidosi, lstruttione delle case notabili ... , cit., p. 135. 99 BUB, ms. 430 (con pagine non numerate), Cronaca di Friano degli Ubaldini. Cfr. Zucchini, La (acciata del palazzo del Podesta ... , cit., p. 10. [ mosaici di cui si riferisce sono di epoca romana appartenenri probabilmente a una basilica. 11 dato non
specifica a quali dei dieci pilastri si riferisca e non precisa se una pertega (3,80 m) di profonditil cominci dalla quota della piazza o del portico. I dati dei recenti scavi archeologici (efr. n. 26) parlano di ritrovamenti di reperti appartenenti a una strada romana a quota -3,50 m dalliveJlo strada Ie del vol tone del Podesta. 130 em di sbalzo corrispondono all'incirca all.a differenza di quota fra la piazza e it portico (piu alto di 55 em), confermando anche quello che si vede dalla foto del 1990. II palazzo quattrocentesco quindi venne costruito a partire dalla stessa quota di quello medievale. Secondo Pasquali Alidosi tuttavia fra iJ 1404 e il1406 la piazza fu alzata di 3 piedi (1,14 m) con un pavimento di mattoni disposti a spina di pesce. Questo significa 0 che it livello del portico venne a trovarsi a una quota inferiore rispetto alia piazza, 0 che questa venne elevata a una aJtezza vicina 0 uguale a quell.a dell'imposta del palazzo. Se quest'ultima ipotesi Fosse verificata avremmo avuto un palazzo posto su un piedistallo 0 stilobate abbastanza imponenre rispetto all.a piazza, e1emento di cui tuttavia, olrre che poco probabiJe, non rimane nessuna traccia 0 notizia. Cfr. Pasqua Ii Alidosi, Istruttione delle cose notabili ... , cit., p. 39. 100 ASB, Archivio notarile, rogito di Bartolomeo Zani, n. 263, 7 novembre 1485. Trascritto e pubblicato da Sighinolfi, I.:architettura bentivolesca in Bologna ... , cit., pp. 159-161. Nel novembre del 1485 Andrea quondam AJe Cenni, merciaio bolognese, in cambio della cessione della sua bottega posta sulla piazza davanti al mercato sulla via pubblica, ricevette dagli ufficiali del Comune la terza parte di uno spazio della vecchia Tesoreria comunale al piano terreno del palazzo, lunga 20 piedi circa e larga 7,5. Egli era tenuto a finanziare la costruzione delle volte in pietl'a e calee sopra la relativa terza parte di quello spazio e del portico, ancora da costruirsi. Maestro Andrea, olrre ad aJtri oneri minori, si rese disponibile a paga re Ie spese della costruzione dei due pilastri sui lata di via degli Orefici vicino al muro della sua bottega. Tordino quondam Battista dk' Conti cambiatore, nel libro delle spese della fabbrica negli anni 1492-94, il14 marzo risulta che "Marsilio taiapreda de havere a dl 14 marzo per lavori ha facti e dati a la fabrica del palazo che a Tordin e a la fabrica zoe uno pilastro cantonerio e uno arco triangoli e capitello per lire 133 soldi 11 denari 11». [noltre risulta da un rogito del 1492 che Tordino era proprietario di una bottega sotto Ie volte verso iI palazzo dei Signori e vicino a quella dei Vitali, debitore di 25 lire verso Marsilio e di 30 verso Francesco da Dozza: ibidem, p. 9l. '0' I "brevetti d'eletta grazia» erano dazi pagati dagli ufficiali del Comune all'atto
della nomina, che costituivano una voce rilevanre per Ie entrate del Comune stesso. Zucchini, La (acciata del palazzo del Podesta ... , cit., pp. 7-8. Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna ... , cit., p. 82. 102 ASB, Comune, Governo, Riformatori della Stato di Liberra, Libl"i Partitol"um, 28 aprile 1487. Trascritto e pubblicato da Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna ... , cit., p. 168-169. Vedi anche Zucchini, La (acciata del palazzo del Podesta ... , cit., p. 8. 103 In questa occasione gli fu data la stessa importanza di Gian Galeazzo Sforza, Ludovico il Moro, Ercole d'Este e Francesco Gonzaga rinnovando I'alleanza con la Lega. Conremporaneamente rafforzo I'amicizia con Lorenzo il Magnifico prima e Piero de' Medici dopo, e ottenne dall'imperatore Massimiliano d'Asburgo il riconoscimenro della propria autorita su Bologna. Infine sempre nello stesso anno venne nominata dalla repubblica veneziana patrizio veneta e Milano 10 e1esse governatore generaJe delle armi ducali. De Caro, Giovanni Bentivoglio, in OBI, cit., pp. 626-627. 104 La congiura ebbe conseguenze estremamente violente: tutti i membri della famiglia Malvezzi vennero uccisi e solo alcuni riuscirono a scappare dalla citta e i lora seguaci 0 anche i semplici sospettati subirono la stessa sorte. Giovanni ebbe il sostegno dei suoi alleati, il duca di Milano, Lorenzo de Medici e il duca di Ferrara. Le citta che accolsero i bolognesi fuggiaschi, Venezia, Napoli e Rimini furono costrette a espellerli 0 imprigionarli. Per la congiura dei Malvezzi SI veda: Ady, The Bentivoglio of Bologna, cit., pp. 103-117; De Caro, Giovanni Bentivoglio, in OBI, cit., p. 627. Dopo la congiura, nel 1490 Giovanni fece costruire una grande torre a fianco del suo palazzo, collegata a esso rramite un ponte coperto, simbolo del proprio potere e di ammonimento verso gli avversari. Vedi: De Bursellis, Cronica Gestorum ac Factotum ... , cit., pp. 11 0-111. IDS Essi di comune accordo stabilirono che «ipsa societas duret et durare debeat quoad durabit fabricha et seu laborerium et ressiduum laborerii alias per ipsos socios et per magistrum Baptistam Zarbi et Matheum de Raigusia fieri promissi officialibus dicte fabrice et modo et forma contentis in quadam scriptura scripta manu Sebastiani de Aguchis et subscripta manu magnifici d. ]ohannis de Bentivoglis et d. Piri Malvitiis». ASB, Archivio nota rile, rogito di Bartolomeo Zani, cap. 16, n. 115, 16 aprile 1488. Trascritto e pubblicato da Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna ... , cit., pp. 170-171. '06 Gia il 7 febbraio 1479 Marsilio di Antonio Infrangipani e Tomaso quondam
111
Pietro Filippi di Varignana stipuJarono un accordo di cinque anni in cui si dichiarava la promessa d i non danneggiarsi a vicenda e di eseguite qualsiasi incarico inferiore ai 20 bolognini senza reciproco avviso. I due erano proprierari rispettivamenre delle cave di Barbiano e Varignana e questo conrratto manifesta un certo loro monopolio sui lavori in pietta all'intemo di Bologna. ASB, Archivio nota rile, rogito di Bartolomeo Zani, capp. 2, 7, febbraio 1479. Cfr. Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna ... , cit., pp. 21-32,148-150. '07 ASB, Archivio nota rile, rogiro di Bartolomeo Zani, cap. 17, n. 168, 7 luglio 1488. Trascritto e pubblicato da Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna . .. , cit., pp. 172-173. 'os Ibidem. '0' Cft. Per i materia Ii dell'edilizia bolognese: F. Rodolico, Le pietre delle citta d'Italia, Firenze 1953, pp. 161-167; Marinelli, Scarpellini, L'arte muraria in Bologna ... , cit., pp. 31-40. 110 BCA-SM, B. 1155, f. 90r-v. Memoriale di Sa E/isoi Mamolini in cui si indica anche che, insieme a Giovanni Malvezzi, furono impiccati altri dodici membri del suo gruppo. III Zucchini per altre vie conferma il fatto: senza specificare la dara rna presumibilmente prima 0 durante i restauri di Rubbiani, testimonia che vennero effettuati degli assaggi nella muratura suI lato ovest che svelarono il muro dell'anrica sala rinchiuso fra la cortina esterna a mattoni sagramati e il rivestimento interno di antico laterizio, proveniente forse dalle demoJizioni. Inoltre vennero ritrovate una piccola finestra ad arco acuto e frammenti di comici e colonnine di pietra. Zucchini, La (acciata del palazzo del Podesta ... , cit., p. 10. m Per questi argomenti si veda Ja bibliografia in nota 4. 113 De Bursellis, Cronica Gestorum ac Factorum ... , cit., p. 108. ,I< BUB, ms. 294, Cronaca Bianchina, c. 79, copia esistenre anche in BCA-MS, B. 1184, anno 1491. Vedi anche Ghirardacci, Della historia di Bologna, cit., vol. XXXIII, p. 263. liS ASB, Massarolo dei lavori, spese relative al palazzo del Podesta, fogli sciolti. Pubblicato parzialmenre da Malaguzzi Valeri, Der Palast der Podesta in Bologna, cit., p. 251; Id., La chiesa della Santa a Bologna, cit., in particolare p. 78; Zucchini, La (acciata del palazzo del Podesta ... , cit., p. 14. '16 "Marsilio taiapreda de havere a dl 14 marzo per lavori ha facti e dati a la fabrica del palazo che a Tardin e a la fabrica zoe uno pilastro cantoniero e uno arco rriangoli e capitello ... ,,: ASB, Massarolo dei lavori, cit., ff. 13-15, spese relative agli anni 1492-93. Marsilio verdI pagato dal
Comune per la realizzazione del pilastro relativo alla bottega di Giovanni Cenni solo nel 1492, conrestualmenre ai lavori svolti sullato opposto. 117 BCA-SM, B. 79, Cronica di Bologna d'incerto Autore (rna di M.A. Bianchini), f. 166r - 1492 - "E adl detto [30 marzo] se comenza a sabiare la Sala del Palazo del podesta sopra Ie Mercanzie e fue salezada in otto di". "' Nel gennaio del 1492 Marsilio fonda un'altra societa con scalpellini diversi, Alessandro Brocoli e Leonardo e Giacomo Filippi per scolpire Ie pietre del palazzo. ASB, Archivio nota rile, rogiro di Bartolomeo Zani, 13 gennaio 1492. Citato da Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna ... , cit., p. 88. "' Per ragioni di spazio e impossibile in questa sede trascrivere inregralmente I'importantissimo Massarolo dei lavori. Per questo intento si rimanda a uno studio di chi scrive in fase di svolgimenro. 120 Ora scomparsi rna che quindi indicano che il piano inferiore in origine era completamenre rivestito di pietra al pari di quello del palazzo del Podesta di Brescia. In effetti la cortina laterizia fra gli archi del portico e il balcone esconnessa, ruvida e irregolare al conrrario di quella liscia e accurata, destinata a rimanere a vista, del piano superiore. "' Queste cornici, delle quali viene data la misura della somma delle due, hanno una lunghezza pari alia distanza calcolata dalla quota di calpestio della sala, e non quella attuate che parte dallo zoccolo, piu alro di 2,25 m. 112 Euna distinzione importante: probabilmente i muratori non erano in grado di calcolare Ie lunghezze di curve. Lo sviluppo lineare dell'arco del piano terreno, dopo i dovuti calcoli, risulta di 8,08 m per un importo di 21,60 bolognini, quindi di circa un quarto piu costoso della cornice fra il primo piano e l'attico che presenra una lavorazione molto simile. L'incremenro di un quarto dell'importo epercia dovuto unicamente alla lavorazione non rettilinea dell'elemento. Inoltre, come vedremo ddll'analisi del rilievo dell'edificio, quasi tutti gli archi sono di dimensioni diverse, a volle schiacciati e con raggi diversi, al fine di compensare Ie differenze delle dimensioni delle campate. Soprattutto gli archi dei lati corti dell'edificio hanno una dimensione sensibilmente maggiore di quelli della facciata principale. Epossibile dunque che il prezzo di ogni arco Fosse diverso e deciso secondo Ie sue caratteristiche dimensionali e di forma. Purtroppo non abbiamo pagamenti per altri archi e di conseguenza non epermesso fate alcun confronto. 113 Nell'elenco degli elementi in pietra non risultano quelli del davanzale e della
ttabeazione: il davanzale infatti si sarebbe trovato in una posizione d'impaccio ai muratori che stavano lavorando al piano superiore della facciata e soggetto a essere rovinato. Si prefer! quindi realizzarlo in ultimo. 12< Guidicini, Cose notabili della citta di Bologna, cit., vol. II, p. 351. m ASB, Comune, Governo, Riformatori dello Stato di Liberta, Liber Partitorum, f. 113v. Pubblicato e trascritto da Zucchini, La (acciata del palazzo del Podesta ... , cit., p. 16. I fratelli Della Volta nel 1487 erano proprierari di una miniera di ferro nei dintorni di Bologna: ibidem, p. 16. La cronaca del De Bursellis asserisce ruttavia che solo dal 1490 i Della Volta cominciarono l'estrazione del ferro dalle montagne bolognesi mentre prima erano costretti a effettuare lunghi viaggi per acquistarlo. De Bursellis, Cronica Gestorum ac Factorum ... , cit., p. 112. Cia nonoStante il ferro esrratto non doveva essere sufficiente in quanto il 22 settembre 1496 i fratelli Della Volta richiesero un salvacondotto per il trasporro del materiale fra Piombino e Bologna. Verosimilmenre il ferro proveniva dalle vene dell'isola d'Elba. ASB, Carteggi Comune-Governo, Lettere del Comune, teg. 5 (1491-99), f. 2591'. 126 Un tale di nome Frizza, coinvolto nella congiura dei Malvezzi, vi venne infatti impiccato nel 1495 «e fu il secondo». Anche Pirro Malvezzi il 20 ottobre dello stesso anno, ormai lontano da Bologna, venne bandito proprio dalla ringhiera di que! palazzo che per anni aveva seguito e di cui aveva promosso la ricosttllzione in qllalita di soprastante. BCA-SM, B. 1184, c. 194. Notizia ripresa anche da Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna ... , cit., p. 99. Pirro, dopo la congiura del 1488, fuggi ptima a Cesena e poi aRoma dove mort nel 1506. BUB, ms. 437, Cronaca Seccadenari. 127 Lui stesso scrive: ,,10 feci anco fare il parapeto con Ii balaustri di masegna ala sala del Podesta petche prima non vi era cosa alcuna in modo che Ie persone potevano cascarci in piaza quando si facevano Ie giostre er Ii speracoli». Bologna, Biblioteca Arcivescovile, ms. K. 1, senza numerazione di pagine. Vedi anche Zucchini, La (acciata del palazzo del Podesta ... , cit., pp. 25-26; Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna ... , cit., pp. 116-117. 12' L'autore eStefano de' Corvi, un medico di origine piacentina che per con to della Confraternita dell'Ospedale della morte doveva occllparsi degli ammalati e moribondi e inventariare i loro beni e abiti che dopo la motte diventavano di proprieta dell'ospedale. Sighinolfi, L'architeUura bentivolesca in Bologna... , cit., pp. 106-111. I disegni sono cusroditi nella BCA-SM,
112
Fondo Archivio Ospedale della morte, ms. 71, cc. 41v sgg. '1' Elementi molto simili dovevano decorare anche la ringhiera del quattrocentesco palazzo dei Senatori in Campidoglio aRoma secondo Ia veduta dell'Anonimo del Louvre, Ecole d'italie, 11028. '''' Se invece tutta la baleonata Fosse stata aggettante, si sarebbe imposta come un evidente elemento architettonico a se stante e non come una "prosecuzione" della parte inferiore del prospetto che, come eadesso, "sfuma" con la sua semitrasparenza illimite superiore. Essa avrebbe quindi "tagliato" orizzontalmente la facciata in due parri, diminuendo il suo slancio verticale. '" Esso appare in una lnsigna del Comune: ASB, Anziani Consoli, Insigna, vol. XIII, c. 162a. Antonio Alessandro Scarselli, 1743. Pill chiara mente in una stampa settecentesca della facciata del palazzo: BCA, Gabinetto dei Disegni, stampa di Alfonso Torresani, senza data. "'II rilievo, a colori, appartiene aile carte di una causa tra due proprietari di botteghe al di sotto del portico del palazzo e in esso vi sono rappresentati con molta cura diversi detragJi della parte centrale delJ'edificio e soprattutto I'aspetto del baleone. BCA-SM, B. 2044. Cfr. Sighinolfi, L'al'chitettura bentivolesca in Bologna ... , cit., pp. 127-135. '" I fi!ari di bugne riportati nei due disegni di sezione coincidono con quelli esistenti, confermando I'accuratezza del rilievo. '" In forme quattrocentesche si trova sulla facciata della cappella Pazzi. A Bologna, nel palazzo degli StrazzaroJi, contemporaneo al Podesta, il prospetto del piano terreno e caratterizzato da una sequenza di archi a tutto sesto "soffocati" da paraste. Esistono anche esempi nel medioevo lombardo come nel ciborio di Sant'Ambrogio. to questo un caso abbasranza simile al problema della sovrapposizione degli archivolti in prossimitit degli angoli, gia affrontato nel Qua,ttrocento da Brunelleschi in San Lorenzo nello spigolo fra la navata e il transetto e da Michelozzo nel cortile di palazzo Medici. Per questo argomento si veda M. Bulgarelli, La cappella Cardini a Pescia, in M. Bulgarelli, M. Ceriana, All'ombra delle volte, Milano 1996, p. 67. HI BCA-SM, B. 1132, Giustiziati in Bologna dal1030 aI1796. '" Nadi, Diario bolognese, cit., p. 100. Zucchini, La facciata del palazzo del Podesta ... , cit., p. 18. '" Dopo la congiura dei Malvezzi, che gia mino la stabiJita dell'alJeanza delle maggiori famiglie cittadine, si aggiunse nel 1501 quelJa dei Marescotti, accusati di collaborazione con il Valentino. Tale famiglia venne sterminata per volere di Ermes Bentivoglio, figlio di Giovanni, innescando un progressivo isolamento dei
Bentivoglio rispetto aile altre famigJie bolognesi. R. Patrizi Sacchetti, La caduta dei Bentivoglio e it ritorno di Bologna al dominio della chiesa, in «Atti e memorie della regia deputazione di storia patria per Ie provincie di Romagna", n.s., II, 1951, pp. 109-156, in particolare p. 121. 1)8 Per gli ulrimi anni della Signoria Bentivoglio si veda: G. Gozzadini, Memorie per la vita di Giovanni II Bentivoglio, Bologna 1839, pp. 67-176. Patrizi Sacchetti, La caduta dei Bentivoglio ... , cit., pp. 109156; Tamba, I documenti del Governo ... , cit., p. 22. Giulio II aveva un'avversione personale contro Giovanni 11 ed era anche infastidito dal modo "sfrenato" di vivere dei bolognesi. Si potrebbe azzardare che uno dei simboli di questo "vivere sfrenato" bolognese potesse essere proprio il palazzo del Podesta che nel 1505 era concluso e si presentava molto piu sfarzoso di ogni palazzo omologo italiano del tempo, inclusi quelli contemporanei di Brescia, Mantova e Verona, e comunque molto piu modemo e fastoso del palazzo dei Senarori sui Campidoglio. '" Giovanni venne sepolto «con grandissimo onore" presso un non meglio specificmo convenro di San Francesco dell'Osservanza subito fllori Milano. Ghirardacci, Della historia di Bologna, cit., vol. XXXIII, p. 385. 140 Tamba, I docwnenti del Governo ... , cit., pp.22-23. 141 Gia nel 1562 nella sala si giocava al ballone. Le sue condizioni dovevano essere precarie in quanto in quel1'anno crolla il soffitto: BCA-SM, B. 1118, Cl'onaca Marescalchi, anno 1564. Dopo il 1624 la sala ospito iI teatra cittadino demolito definitivamente nel 1767: ASB, Atti del Reggimento, lstrumenti e Documenti, E, libra 38, n. 44, 28 gennaio 1656. Dal1767 la sala venne trasformara in granaio da cedere in affitto. Zucchini, La facciata del palazzo del Podesta ... , cit., p. 35. Nonostante i frequenri restauri, il palazzo rimane con un aspetto fedele aile forme originali. 142 Negli anni orranra del XV secolo la facciata di!San Perronio era ricoperta solamenre dal basamento marmoreo trecenresco e dal portale di ]acopo della Quercia. Cfr. bibliografia in nota 52. It palazzo del Legato in quegJi anni aveva da tempo raggiunto I'estensione anuale. Hubert, Del' Palazzo Comunale ... , cit., pp. 77-115. I4J 1capite IIi originali sono srati sostituiti piu di una volra. Una sostituzione avvenne certamenre fra il1835 e i11839 in occasione di un consistenre restauro dellivello inferiore in cui si sostituirono con nuovi elementi «delle forme dei preesistenri" numerosi peai lapidei originali. Purtroppo i capitelli da
sostituire dovevano essere talmente consunri che non fu possibile eseguire un caleo e si prefer! rifarli come «L:ordine d'architettura richiede>l: Archivio della Soprintendenza Belle Arti di Bologna, busta relativa al palazzo del Podesta, fogli sciolti. Vi eanche un preventivo del 1910 per il rifacimento di aleuni capitelli. Ringrazio l'architetto Maurizio Ricci per avermi gentilmente concesso la consultazione dell'archivio. Daile vedute precedenti del Podesta si nota comunque che essi dovevano essere di un ordine corinzio simile a quello odierno. ,.. Frommel lega I'idea della forma della loggia delle Benedizioni in Varicano a quella del Tabularium; c.L. Frommel, Rama, in Fiore (a cura di), Staria de/l'architettura italiana. II Quattl'Ocenta, cif., p. 182 con bibliografia. 14.< IpOlesi di proporzionamento della facciata sono state avanzate da C. De Angelis, P. Nannelli, La facciata del palazzo del Podesta a Bologna, in Aristotele Fioravanti a Mosca, Ani del Convegno, cit., pp. 79-82; Billings Licciardello, Notes on the Architectural Patronage in Bologna... , cif., pp. 172-178, in clli si anribuisce il progetto del palazzo a un bolognese vicino al Filarete che non sia AristOlele Fioravanti. '46 Le differenze dimensionali degli interassi, invisibili a occhio nudo, hanno la funzione di adattare fra lora Ie varie misure delle pareti che, soprattutto in caso di preesistenze medievali, non sono scomponibili in unira di misura costanti. Nei noti esempi di palazzo AJberini aRoma, la chiesa di Santa Maria in Polirane a San Benedetto Po fino alia Basilica vicenti.na di Palladio, tutti posteriori al palazzo del Podestit, Ie anomalie del ritmo sono risolte modificando l'ampiezza dei "vuoti". Questo sistema "elasrico" venne comunque ampiamente usato per i portici bolognesi fin dalla lora prima apparizione e quindi era gia una prassi consolidata per i cosrruttori locali. 14' Che la sala grande Fosse direttamente collegata ad almeno due stanze rerrastanti 10 si deduce da una perizia settecentesca sulle condizioni statiche del complesso podestarile in cui vengono descrirtj tutti gli ambienti. Cfr. BCA-SM, Fondo Gozzadini 169, perizia eseguita il 28 settembre 1799, cc. 283v-284r. '" Questa raffinatissima soluzione denota una conoscenza approfondita e ragionata da pane dell'architetto di aleuni passi del u'anato di Vitruvio noti anche a L.B. Alberti. Vitruvio raccomanda «Etiamque angulares columnae crassiores faciendae sunt ex suo diametro quinquagesima parte, quod eae ab aere circumcidunrur et graciliores videntur esse aspicientibus>l. Vitruvio, De Architettura, a cura di P. Gros, libra III, 8, Torino 1997, vol. I, p. 248. L:effeno ottico che il vuoto crea attomo a un elemenro pieno rendendolo piu snello equindi tenuto
113
in considerazione nella progettazione della facciata del PodestiI. D'altra parte a Bologna edocumenrata I'esistenza di una copia del testo vitruviano appartenuta al canonico e lettore Giovanni Calderini gia nel XIV secolo. Notizia riportata in I. GonzalezVaras Ibanez, Dietro il muro del Collegio di Spagna, Bologna 1998, p. 62; Cfc H.]. Becker, G. Calderini, in DBI, vol. XVI, Roma 1973, pp. 606-608. Nel XV secolo, fra il1426 e il 1455, Carlo Ghisilieri era in possesso di una copia, come anche il cardinale Bessarione, legato in citta dal 1450 a11455. Hubert, L'architettura bolognese del primo Rinascimento ... , cit., p. 35 con bibliografia. Anche L.B. Alberti era a conoscenza dell'effetto che il vuOto crea attorno aile colonne: «Nam compertum quidem est, columnas in aere positas graciliores videri, quam quae in concluso collocentur [... ] Ea re sic moment: angulares columnas, quod libero aere ad prospectum prae caeteris circumarctentur, crassiores facito, aut striarum numerum augeto». L.B. Alberti, De re aedificatoria, libro VII, 9, ed. a cura di G. Orlandi, P. Porroghesi, Milano 1966, vol. II, pp. 599-603. '" La diversa misura dei due lati viene dissimulata dall'uso delle bugne: ne compaiono quattro sullato frontale e tre su quello latera Ie. La sovrapposizione sfalsara dei filari sulle facce del pilastro attemla 10 scarro dimensionale dei suoi lati. Lo stratagemma del diverso dimensionamento dei pilastri angolari al fine di ottenere una misura scomponibile in moduli uguali era gia stato adottato da Francesco di Giorgio Martini nel corti Ie del palazzo Ducale di Gubbio: efr. FP. Fiore, 1I Palazzo Ducale di Gubbio, in FP. Fiore, M. Tafuri (a cura di), Francesco di Giorgio Architetto, Milano 1994, pp. 200-204. In precedenza 10 si trova anche nei pilastri angolari del portico del palazzo del Podesta di Pienza, come ho poruto constatare da un rilievo del pilastro effettuato personal mente. 150 Tale soluzione venne gia proposta dal Filarete che nel prospetto della "Casa Regia", con caratteristiche simili al palazzo bolognese, rafforzo gli spigoli del portico al piano terreno con due solidi pilastri. I
Filarete, Trattato di Architettura, ed. a cura di A.M. Finoli, L. Grassi, Milano 1972, tav. 33 (f. 58v, fig. 41). 151 La ringhiera veniva usata non solo per la lettura dei bandi e I'esecuzione delle condanne. Se COS! Fosse sarebbe stato sufficiente un solo balcone come in tutti gli aJrri palazzi comunali italiani. La funzione alternativa era quella di "tribuna" privilegiata per Giovanni Bentivoglio e la nobilta cittadina per assistere aile feste sulla piazza che proprio SOtto Giovanni divennero sempre piu frequenti. Tale funzione continuo fino ad almeno al XVIII secolo, secondo
quanto risulta dalle numerose Insigne custodite presso I'ASB. Per questi argomenri si veda: F Pezzarossa, Ad honore et laude Bentivoglio. La lettemtura della festa nel secondo Quattrocento, in B. Basile (a cura di), Bentivolorum Magnificentia, Roma 1984, pp. 35-113; P. Fazion, "Nuptiae Bentivolorum". La citta in festa nel commento di Filippo Beroaldo, ibidem, pp. 115-133. Sono a me note solo due ringhiere quattrocentesche, precedenti a quella bolognese, che corrono, a sbalzo, per tutta la facciata: quella distrutta del palazzo dei Senatori in Campidoglio aRoma, documentata dal disegno dell'Anonimo del Louvre (Ecole d'Italie, 11028), che corre fra Ie due torri angolari e quella, ripewta nei due livelli, sulla facciara di palazzo Pitti a Firenze. 152 Commissionato nel1484 a Tommaso Formenton rna costruito a partire dal 1492. Cfr. D. Hemsoll, Bramante and the Palazzo della Loggia in Brescia, in "Arre Lombarda», 86-87, 1988,3-4, pp. 167-179; Id., Le Piazze di Brescia nel Medioevo e nel Rinascimento, in "Annali di Architettura", 4-5,1992-93, pp. 168-177; G. Lupo, Platea Magna communis Brixiae (1433-1509), in M. Tafuri (a cura di), La piazza, la chiesa, il parco: saggi di storia dell'Architettura (X VXIX secolo), Milano 1991, pp. 56-95; A. Scotti, L'ordine inferiore del palazzo della Loggia (1492-1509), in V. Frati, I. Gianfranceschi, F Robecchi (a cura di), La Loggia di Brescia e la sua piazza, Brescia 1995,2 voll., pp. 5-83; M. Morresi, Venezia, in Fiore (a cura di), Storia dell'architettura italiana. 1I Quattrocento, cit., pp. 222-223. 153 Nell'esedra del foro di Traiano ruttavia l'assenza di partirure verticali annulJa il problema dell'allineamento assiale. E significativo it caso dell'arco quadrifronte di Malborghetto, siruato al chilometro 19,4 deJia via Flaminia e rappresentato in un disegno di Giuliano da Sangallo (BAV, Cod ice Vat. Barb. Lat. 4424, f. 36v). In una prima analisi Ie opposte facciate principali, perpendicolari alia via, sembrano presentare anch'esse illivello superiore arretrato rispetto a quello inferiore, anche se 10 slittamento non rigira sullo spigolo ai lati adiacenti. In rea Ita si tratta del caso in cui, diversamente dal palazzo del Podesta, un unico corpo allivelJo inferiore viene circondato da colonne libere e trabeazioni, ricadendo in uno dei tipici sistemi dell'architettura romana dove la struttura trilitica e indipendente e staccata dal retrostante volume pieno, caratteristica notata e reimpiegata da Bramante nel tempietto di San Pietro in Montorio. Nel palazzo bolognese invece il volume superiore si fonde al piano terreno con il sistema dei pilastri e archi, inrroducendo nell'architettura quattrocentesca
un'importante innovazione. Eda notare come un arretramento del secondo livello rispetto al primo, simile a quello del Podesta, venga immaginato da E. Duperac nella ricostruzione del Tabularium: Disegni de Ie mine di Roma e come anticamente erono, riproduzione anastatica a cura di R. Wittkower, Milano s.d., ff. 94v-95v. E tuttavia una ricostruzione a Iquanto improba bile se messa a confronro con la planimetria. Cfr. A. Mura Sommella, Contributo allo studio del Tabularium attraverso I'analisi di alcuni documenti iconografici e d'archivio relativi al palazzo Senatorio, in "PaJiadio», 14, 1994, pp. 45-54. IS' Fanno eccezione Ie campate [7] e [8]. 155 Soprattutto in Toscana si era gia diffuso iI raddoppio dell'eJemenro angolare, costituito pero dalla semplice duplicazione della parasta, usato per la prima volta in un edificio da Michelozzo nella facciata della chiesa di Sant'Agostino a Montepulciano. In questa ottica, dunque, tale motivo michelozzesco rappresenra una soluzione meno complessa e sintatticamente meno "specializzata" dell'accoppiamento pilastroparasta. Per questi argomenri si veda A. Bruschi, L'Antico e la riscoperta degli ordini architettonici nella prima meta del Quattrocento. Storia e problemi, in S. Danesi Squarzina (a cura di), Roma centro ideaIe della cultura dell'Antico nei secoli XV e XVI, Milano 1989, pp. 410-434; Id., L'antico e il processo di identificazione degli ordil1i nella seconda meta del Quattrocento, in L'emploi des ordl·es dans I'architecture de la Renaissance, Actes du coJloque (Tours 1986), Tours 1992, pp. 11-57. Per I'ordine binato nel Quattrocento efr. Bulgarelli, La cappella eardini a Pescia, cit., p. 94 n. 45, con bi bliogra fia precedenre. 156 A causa di tale motivo, facciate a loggia, sia a colonne libere che con pilastri e semicolonne, con piedistallo al primo ordine, precedenti a quella del Podesta sono abbastanza rare: piedistalli vengono usati nella loggia delle Benedizioni in Vaticano secondo la veduta di M. van Heemskerck (Vienna, Albertina), nel cortile di palazzo Venezia aRoma e nel palazzo del Consiglio di Verona. Esse sono ancora piu rare nell'architettura antica. Dubbio eil caso della presunta Crypta Balbi la quale e provvista di piedistallo nel disegno di Giuliano da Sangallo e senza nel codex Escurialensis. Colonne 0 pilastri su piedistalli sono invece caratteristici degli archi trionfali e dei porrali, in cui a questi elemenri architettonici viene assegnato un valore prevalenremente formale e decorativo piuttosto che strutturale. 157 La soluzione angolare del palazzo deUa Loggia di Brescia benche molto simile e, come detto, posteriore.
114
''" BAV, Cod ice Vat. Barb. Lat. 4424, f. 28r. Riproduzione anastatica, Citta del Vaticano 1984. La pianta eraffigurata nel f. 63v. Per In fortuna di questo edificio nel rinascimemo si veda: A. Ghisetti Giavarina, La Basilica Emilia e la rivalutazione del Dorico nel Rinascimento, in «Bollettino del Centro Studi per la Storia dell'Architettura», 29, 1983, pp. 9 sgg.; P.w. Lelunann, Alberti and the Antiquity: Additional Observations, in «The Art Bullettin», LXX, 1988, n. 3, pp. 388-400, in particolare pp. 392-394; A. Bruschi, Edifici privati di Bramante aRoma. Palazzo Castellesi e Palazzo Caprini, in «Palladio», n.s., II, 4, luglio-settembre 1989, pp. 20-24, nn. 26, 27; C. Syndikus, Zu Leon Battista Albertis Studium del' Basilica Aemilia auf dem Forum Romanum, in «Zeitschrift fur Kunstgeschichte», LVlI, 1994, n. 3, pp. 319-329; Bulgarelli, La Cappel/a Cardini a Pescia, cit., p. 82 n. 188. 'N EutiJe notare a tale proposito come nel gia citato arco di Malborghetto I'angolo abbia una composizione opposta a quella della basjlica Emilia, con colonne angolari (Iibere) e paraste che ritmano la u'ipartizione della facciata. Strutturalmeme questa soluzione, anche se opposta all'edificio del Foro romano, ealtrettanto coereme in quanto, avendo una pianta formata da qllattro robusti piloni, Ie forze si scaricano in pari misura su tutta fa loro sezione orizzontale. Egiusto quindi che gli spigoli siano segnati da paraste angolari, che acquistano in quesro modo 10 stesso significato strutturale preseme nella basilica Emilia. Le coiOlUle, staccate dalla costruzione e quindi virtualmente scariche da forze proveniemi dall'alto, si riducono a un valore di pura decorazione. 'oo Per la architravis triumphata dr. S. Valtieri, L'architettura aRoma nel XV secolo: l'Antico come "imitazione" e come "interpretazione" nel suo processo fonnativo ed evolutivo, in Danesi Squarzina (a cura di), Roma centro idea Ie della cultura deWAntico ... , cit., p. 262; c.L. Fromme!, Roma, in Fiore (a cura di), Storia del/'architettura italiana. II Quattrocento, cit., p. 382. 'Ol Anche se di ridotte dimensioni e parte di una romba parietaJe, 10 stesso motivo, e in forme identiche, epresente nello spigoJo del secondo ordine del mausoleo di Ladislao di Durazzo in San Giovanni a Carbonara a Napoli datato 1428 e portatomi all'attenzione da Fulvio Lenzo che ringrazio. '6l Anche se nel fronrespizio di Nerone vi e un pilastro e non una semicolonna, il principio resta identico e sembra essere un motivo alquanto raro nell'antico. II dettaglio erilevato da A. Desgodetz, Les edifices antiques de Rome: dessines et mesures tres exatement, Paris 1682 (ristampa San Francisco 1981), p. 151, e vena comunque
ripreso in maniera identica da Giacomo Della Porta nel cortile di Sant'Ivo alJa Sapienza a Roma. Una soluzione simile venne rilevata da Baldassarre Peruzzi in un piedistallo antico nel disegno Uffizi 482Ar: in H. Wurm, Baldassarre Peruzzi Architekturzeichmmgen, Tubingen 1984, p. 455. Se tutte Ie modanature della semicolonna avessero circondato il pilastro si sarebbero ottenure due condizioni entrambe sfavorevoli: 0 la riduzione delle dimensioni della base del pilastro, che avrebbe tuttavia alterato it rapporto esatto di 1:8 fra la luce deH'arco e il diametro della semicolonna, 0
la sporgenza delle modanature dal pilastro, scomode e a rischio di deterioramento per la loro posizione estremamenre esposta. 163 Sotto il portico, voltato a crociera, i pilastri in origine erano specchiati sui muro inrerno da peducci, sostiruiti in data imprecisata da paraste gia visibili nel XVII secolo, come si deduce da numerose Insigne del Comune. 'M Gli occhi di un architetto 0 ingegnere moderno possono notare Ja maniera in cui Ie forze provenienti dalla copertura e dal primo piano si scaricano eccemricamente sui piloni. Ai fini dell'assorbimento di tali forze e buona regola, e qui applicata, aumenrare la sezione dei sostegni daJla parte opposta dell' area compressa, norma comunque gia ben conosciuta fin dal periodo gotico per quello che riguarda il dimensionamenro delle sezioni dei comraffoni. Un'altra chiave di interpretazione della sezione del pilastro quasi quadrata enel ricordo diretto delle logge antiche come il TabuJarium, iI Colosseo e i teatri in genere. La sezione dei pilastri delle logge romane rinascimentali e infatti, come nota Christof Thoenes, moira piu sottile. Si tratterebbe nel caso bolognese di una imitazione della architettura antica, non superficiale, rna di «sostanza strutturale": dr. C. Thoenes, Bramante e la "bella maniera degli antichi", in Sostegno e adol'namento, Milano 1998, pp. 59-65. '" Per la forma della facciata medievale preesistente della chiesa fiorentina: G. Kiesow, Die Gotische Siidfassade von S. Maria Novrlla in Florenz, in «Zeitschrift fur Kunstgeschichte", XXV, 1962, p. 10; Lehmann, Alberti and Antiquity: Additional Observations, cit., pp. 388-400; H. Burns, Leon Battista Alberti, in Fiore (a cura di), Storia dell'architettura italiana. II Quattracento, cit., pp. 137-140. 16' L'architrave a due fasce ediffuso sia in architetture di dimensioni ridotte che grandi un po' ovunque; in particolare se ne segnala I'uso nella cappella Cardini di Pescia e nel porta Ie che introduce al chiostro Spinelli a Firenze, nella facciata della chiesa di Sant'Aurea a Ostia, alJ'esterno di Santa Maria presso San Sa tiro a Milano, nel primo ordine del cortile di palazzo Venezia e in
quello di Urbino. Nella facciata del tempio malatestiano di Rimini 10 stesso tipo di trabeazione earricchito da una sottile gola dritta che separa Ie fasce, delle quali l'inferiore epiu schiacciata. '67 Per i balaustri nel rinascimento, con bibliografia che comprende anche iJ tema della ringhiera, si veda P. Davies, D. Hemsoll, Renaissance baluster and the antique, in "Architectural History. Journal of the Society of Architectural Historians of Great Britain", 26,1983, pp. 1-23. In realtil un precedente simile, derivame dalla loggia delle Benedizioni in Vaticano, sembra essere quello del portico della chiesa di Santa Maria in Gradi a Viterbo che presenta anche una soluzione angolare con pilasrro e semicolonna, databile al 1466 circa. J6S Sembrerebbe questo un altro acuto accorgimento ottico che compensa la forte separazione che la ringl1iera e l'arretramento del primo piano creano fra i due livelli. 16' Sono noti gli esempi della facciata delJ'ospeda Ie degli Innocenti, del palazzo di Parte Guelfa, del cortile di palazzo Medici e del prospetto di palazzo Rucellai. Nel palazzo mediceo tuttavia I'architrave non corrisponde al solaio che e in posizione rialzata, a circa la meta del fregio. Per il rilievo di palazzo Medici Riccardi: A. Bossi, M.T. Bartoli, II Rilievo metrico, in G. Cherubini, G. Fanelli (a cura di), II Palazzo Medici Riccardi di Firenze, Firenze 1990, pp. 316-359. '70 Si veda in particolare la veduta dell'Albertina di Vienna di M. van Heemskerck. Con alcune differenze secondarie, che comunque non alterano la sequenza verticale, 10 stesso sistema e rappresentato anche nella veduta dell'Anonimo del disegno di Dresda, da Claude Duchet, da Zuppelli, e da Benozzo Gozzoli. Per la loggia delle Benedizioni e per una raccolta di vedute si veda soprattutto c.L. Frommel, Francesco del Borgo: Architekt Pius' fl, und Pauls fl, in «Romisches Jahrbuch fur Kunstgeschichte", band 20, 1983, pp. 107-154. '71 Una vera trabeazione ionica dorata di tutti i suoi e1ementi costitutivi, senza essere dunque un semplice riempimenro degli spazi fra Ie colonne, si trova nella loggia al secondo livello di facciata nella chiesa di San Marco a Roma, rna in questo caso essa ha un valore strutturalmente ridondame, replicando la sottostante trabeazione che si appoggia su pilastri e semicolonne. Soluzioni simi Ii a quella bolognese, per quanto ne sappia, non esistono neanche in architetture dipinte precedenti al Podesta. 172 La stessa soluzione vena adottata da Antonio da Sangallo il Vecchio nella loggia sui cortile della rocca di Civitacastellana. Nel primo livello del cortile del palazzo della Cancelleria aRoma si nova un uso
115
molro simile a queJlo descritto, rna il davanzale non ha I'aspetto di una trabeazione completa in quanto la cornice etroppo sottile e semplificata. '73 Paraste con decorazioni a candelabre scolpite 0 dipinte - con fllnzione ritmica erano in qllegli anni molto pill diffuse in interni e in manufatti di piccole dimensioni. Illoro impiego esterno era soprattutto relegaro a portali e solo a volte incorniciavano gli spigoli di un volume (cappella Colleoni e in seguiro palazzo dei Diamanti e Prosperi Sacrati a Ferrara). Fanno eccezione il secondo livello de! pa lazzo della Loggia a Brescia (anche se realizzato a partire daI1554), qllello del ConsigJio a Verona, la facciata della certosa di Pavia (dove nell'ultimo decennio si aggiunse a questa categoria il palazzo Beccaria). Per questi argomenti dr. L. Giordano, 1.:ordinamento architettonico dipinto sul/e (acciate dei palazzi lombardi del XV sewlo, in G. Rotondi TermineJlo, F. Simonetti (a cura di), Facciate dipinte. Conservazione e restauro, Genova 1984, pp. 57-63. In un disegno di ricostruzione de! tempio dei Dioscuri attribuiro al Cronaca tali paraste partiscono illivello superiore dei fianchi. A. Barroli, I monumenti antichi di Roma nei disegni degli U(fizi di Firenze, Roma 1914, vol. I, tav. Xll, fig. 25. Per un'attribuzione a Peruzzi del gruppo dj disegni a cui questo appartiene si veda c.L. Fromme!, Peruzzi Romische An(iinge, in «Romisches ]ahrbuch fUr Kunstgeschichte», 1991-92, pp. 137-182. 174 In questa maniera, sovrapponendo un sistema di semicolonne con capiteJli corinzi addossate a pilastri al piano terreno e paraste a quello superiore, si ortiene la stessa organizzazione di facciata dell'anfiteatro castrense aRoma. Questo sistema e rintracciabile anche nella porta Palatina a Torino. L. Crema, L'architettura romana, Torino 1959, fig. 234. 175 Questa esigenza venne avvertita da A. Torresani, aurore di un'incisione settecentesca che ra ppresenta la faccia ta del palazzo (Bologna, BCA, Gabinetto dei Disegni): gli spigoli de! livello superiore sono descritti con due paraste affiancate di cui quella pill interna sj sovrappone a quella angolare risultando pill elegante e riuscita di quella effettivamente adottata. L'arretramento della parasta angolare infatti avrebbe evitaro I'unica e debole fila verticale di bugne sui fianco. In rea Ita, come dimostrano alcune Insigne del Comune (ASB) precedenti a questa immagine, I'angolo fin dall'inizio venne risolto nella maniera che noi vediamo e quindi non eil risultaro di qualche maldesrro resrauro. Un'analisi effetruata con la lente di ingrandimento da chi scrive non ha rilevato differenze di lavorazione ne un diverso tipo
di pietra 0 ammorsature sospette fra il "pilastro" bugnato e la parasta. 176 Essendo scolpiti sullo stesso piano, tali elementi possono essere interpreta ti non come parti strutturalmente indipendenti, rna come un diverso trattamento decorativo della stessa parte di muro. Lo spigolo bugnato puo addirittura perdere totalmente il significato di pilastro, ed essere letto come un breve tratto di parete bugnata. '" L'oculo viene raffiguraro in un veloce schizzo di Fileno delle Tuate. Lo schizzo che rappresenta la facciata de! palazzo Bentivoglio econservaro nella BUB, ms. 1439, Fileno delle Tuate, Historia di Bologna, vol. 11, f. 327v. Ne! disegno del f. 597v tuttavia gli oculi non compaiono. Si confronti Ja ricostruzione in Hubert, 1.:architettura bolognese del primo Rinasci171ento ... , cit., pp. 41-44. '" II palazzo ferrarese venne costruito fra il 1323-26 e demoliro nel 1944. II prospetto, anche se di forme gotiche, ha una progressione portico-finestre-attico molro simile al palazzo bolognese. Tuttavia in vedute antiche l'attico non echiara mente distinguibile, facendo sorgere il dubbio che sia un'aggiunta rarda. Cfr. M. Folin, Ferrara: 1385-1505. AI/'ombra del Principe, in Calabi (a cura di), Fabbriche, Piazze, Mercati ... , pp. 354-384. Pia Khel pubblica una fotografia del palazzo prima dell'abbattimento in cui eancora visibile l'attico con gli oculi: P. Khel, Ferrara, in Fiore (a cura di), Storia dell'architettura ltaliana. II Quattrocento, cit., p. 246. Oculi che illuminano la parte superiore della sala grande erano presenti anche nel palazzo Ducale di Venezia e in quello della Ragione di Vicenza. L'attico con oculi sembrerebbe avere un prorotipo antico nel sepolcro dei Gordiani aRoma sulla via Prenestina, edificio tuttavia a pianta circolare. Per I'uso degli oculi nell'attico fra Ferrara, Mantova e Bologna dr. P. Davies, Quattrocento palaces in Mantua and Ferrara, in F. Ames Lewis, A. Bednarek (a cura di), Mantegna and 15th-century Court Culture, London 1993, pp. 72-83. 179 II p,alazzo brunelleschiano ha una facciata li bera da partiture verticali con eccezione degli spigoti marcati con paraste. Esso, come l'edificio bolognese, al primo piano contiene una grande sala illuminata da finestre ad arco sormontate in asse da una serie di oculi rimasti incompiuti. Tuttavia sembra che essi non siano stati pensati per dar luce alia sala rna per accogliere stemmi e rilievi. Per il palazzo di Parte Guelfa si veda: H. Saalman, Filippo Bnmel/eschi. The Buildings, London 1993, pp. 335 sgg.; D. Zervas Finiello, The Parte Guel(a, Bnmel/eschi and DonateI/o, New York 1987; A. Bruschi, Brunel/eschi e la nuoua architettura (iorentina, in Fiore (a cura di), Storia del/'architettura Italiana. II
Quattrocento, cit., pp. 79-81 e n. 77 (con bibliografia aggiornata). Nella nota Arnaldo Bruschi gillstamente afferma che il sistema della monofora arcllata sormontata dall'occhio venne gia usata nelle pareti a fianco dell'altare della cappella Pazzj e potrebbe derivare da motivi due-trecenteschi presenti in architetture religiose toscane rna anche romane. Si puo aggiungere che questo sistema di aperture potrebbe anche essere inteso come una semplificazione 0 astrazione delle campate laterali dell'arco di Costantino, se si sottrae il secondo tondo e il rimanente 10 si posiziona in asse verticale con I'apertura arcuata. Tale astrazione e stata applicata e raggiunta da L.B. Alberti nell'interno della navata di Sant'Andrea a Mantova. Cfr. Burns, Leon Battista Alberti, cit., p. 155. 180 Filarete, Trattato di Architettura, cit., ff. 58v, 83v, 871', 991', 120r, 1401', 1511', 1611', 162v. Solo ne! disegno del f. 1401', che rappresenta il Collegio dei fanciulli, il terzo ordine del corpo centra Ie ha una facciata pI' iva di partjture verticali. Sempre in ambito lombardo si vedano gli esempi di casa Marliani a Milano e la facciata di abitazione ricostruita all'interno del giardino de! castello Sforzesco. S. Caroselli, The casa Marliani and the Palace building in the late Quattrocento Lombardy, Ph.D. diss., J. Hopkins University Baltimore, New York 1985. 181 Decorazioni floreali molto simili sono presenti in diverse architetture religiose rna mai applicate su bugne ne tantomeoo su pilastri: a titolo d'esempio si citano I.e forme lie de! porta Ie di ]acopo della Quercia in San Petronio, quelle de! sottarco della cappella Corner a Venezia e di quello del duomo nuovo di Siena, e de! basamento del duomo di Vicenza. 182 Queste bugne molto decorate si sovrappongono al senso strutturale del pilastro: un precedente simile, rna giustificato da un esempio antico, il livello inferiore del mausoleo di Adriano rappresentato da Filarete nel portale bronzeo di San Pietro, si trova nella facciata di palazzo Piccolomini a Pienza nella qua Ie Ie paraste hanno la superficie trattata a bugnato liscio come il resto della facciata. Ringrazio Massimo Bulgare!li per l'informazione sui protottpo antico. Questa tendenza a rendere bugnato un elemento strutturale avra una conseguenza a Bologna nella facciata di palazzo Fantuzzi, progettata nel 1525 e completata nel 1533. Cfr. M. Ricci, Bologna, in A. Bruschi (a cura di), Storia del/'architettura italiana. II primo Cinquecento, Milano 2002, pp. 310-311 con bibliografia. 183 Alberti considera J'opera rustica adatta ad architetture militari: Alberti, De re aedi(icatoria, cit., pp. 538-542. Delio stesso
116
avviso sembrerebbe essere Giuliano da Sangallo, che nella sua interpretazione ricosrrurriva dell'arco di Fano colloca bugne a "punta di diamante" nel secondo ordine. BAV, Codice Vat. Barb. Lat. 4424, f. 61 v. Esse comunque appaiono anche nel primo livello della facciata di un palazzo cirradino in un disegno della collezione Soane, ispira te probabilmente da quelJe della Ca' de! Duca a Venezia. Cfr. L. Fairbairn, Italian Renaissance Drawings, London 1998, vol. I, p. 24. Esse, a mia conoscenza e solo in architetture dipinte, vengono in alcuni casi usate anche come superfici di soffirri, ad esempio nell'affresco di Paolo Uccello in Santa Maria del Fiore raffiguranre il monumento equestre di Giovanni Acuto (nel basamento) e nella loggia rappresentata nelJa pala della citra ideale della Staatliche Museen di Berlino. Per questo argomento si veda I'utilissimo lavoro di Roberto Gargiani: R. Gargiani, Principi e costruzione nell'architettura italiana del Quattrocento, Roma-Bari 2003, pp. 484-489. 18' IJ palazzo Sanuti Bevilacqua eprivo di uno studio monografico aggiornato ed esaustivo. L'inizio della costruzione risale probabilmente aI1475-79. Esso eprovvisto di una singolare tripartizione orizzontale de! prospetto con rispettivi tipi diversi di bugne. Per un'informazione essenziale: G.B. Comelli, Di Nicolo Sanuti primo conte della Porretta, in «Atti e memorie delJa regia deputazione di storia parria per Ie provincie di Romagna", s. rrr, XVII, 1899, pp. 106161; Malaguzzi Valeri, L'architettura a Bologna nel Rinascimento, CiL, pp. 124-127; A. Rubbiani, JI palazzo Bevilacqua in Bologna, in «Rassegna d'arte", 8,1908, pp. 124-129; Sighinolfi, L'architettum bentivolesca in Bologna .... CiL. pp. 19-20; G. Cuppini, G. Roversi, I palazzi senatorii a Bologna, Bologna 1974. pp. 55-57, 140147; Tuttle, Bologna, CiL, pp. 265. Per una breve descrizione si veda Benelli, Jl palazzo del Podesta di Bologna, 12001506... , cit., pp. 53-55. Facciate a bugne a "punta di diamante" graffite dovevano comunque esistere a Bologna gia dal medioevo. Lo si deduce da un disegno assonometrico di un'abitazione bolognese conservato in ASB, Demaniale, 55. Naborre e Felice, sec. XVI, pubblicato da C. De Angelis, Le case a struttura lignea, in Bocchi (a cura di), I portici di Bologna ... , CiL, p. 183. II precedente di bugne lavorate in palazzi signorili italiani quarrrocenteschi 10 si trova nel palazzo della Penna e in quello della famiglia Sanseverino entrambi a Napoli, a Venezia nel primo livello della Ca' del Duca (lavori gia avviati nel 1457), a Vicenza nel basamento e angolo di palazzo Thiene. Per I'architettura quattrocentesca napoletana si veda A. Beyer, Parthenope: Neapel und del' suden del' Renaissance,
Munchen 2000, in particolare pp. 80-135. Matteo Ceriana ne propone un'origine serrentrionale segnalandone la presenza in un edificio dipinto da Gentile da Fabriano nella Gerusalemme, parte della predella della pala Strozzi. M. Ceriana, La cappella Corner nella chiesa dei Santi Apostoli a Venezia, in Bulgarelli, Ceriana, AII'ombm delle volte, cit., pp. 109-110 con bibliografia sulla Ca' del Duca in nota 21, p. 172. Si segnalano tuttavia due esempi di bugne a "punta di diamante" che per la loro ubicazione potrebbero aprire nuove ipotesi sulla lora origine geografica e storica: esse compaiono in un mosaico che raffigura la costruzione della torre di Babele all'interno della cappella Palatina di Palermo e in piccole architerrure ra ppresentate ne! mosaico paleocristiano dell'arco trionfale (parricolare del tempio di Venere e Roma) in Santa Maria Maggiore a Roma. Bugne sia a punta di diamante che decorate a volte compaiono sullo sfondo di miniature e dipinti de! gotico catalano. 18' La vetrata della chiesa di San Domenico ha origini duecentesche ed eora cusrodita nel Museo civico medievale di Bologna. Cfr. G. Valagussa, Maestro francese (e restauratore), Croci(issione, 1235 ca., in Medica (a cura di), Duecento. Forme e colori... , cit., pp. 264-266. II tipo di bugna a piramide tronca con rosa appare anche sullo sfondo di un affresco - Madonna con Bambino e san Francesco - di inizio del XV secolo a opera di Lorenzo Salimbeni, custodito presso la Pinacoteca comunale di San Severino Marche. Cfr. S. Papetti, Lorenzo Salimbeni, Madonna con Bambino e San Francesco, in V. Sgarbi (a cura di), Lorenzo e ]acopo Salimbeni di Sanseverino e la civilta tardogotica, Milano 1999, pp. 110-111. 1S6 La decorazione ridondante ecomunque una delle maggiori caratteristiche dell'architettura quattrocenresca bolognese, agevolata dall'uso della terracotta diffuso fino agli anni ottanta del secolo e della pietra arenaria, molto facile da scolpire. Questi argomenti sono affrontati da parte di chi scrive in un saggio di prossima pubblicazione. 1S7 Una delle poche eccezioni si trova ne! conile del palazzo del Legato sui porrale eli accesso all'atrio che introduce alia rampa principale. Per un abaco di esempi di bugnato si veda S. SerJio, Architettura civile, Venezia 1584, libro IV, cap. V, f. 138v (copia anastatica, Bologna 1987). 1S8 II bastone termina con un piccolo capitello a dado, simile a quello del portico de! palazzo della Biada e a quello presenre ne! frammenro sopravvissuto della domus comunis in via de Notari, Forse un dettaglio pensato per evocare un legame fra i tre edifici.
18' E presente anche in spigoti di palazzi gotici veneziani e vicentini e in genere in tutta l'Italia centro-serrentrionale e, per quanro io ne sappia, aRoma ne sopravvive un solo esempio in un angolo di torre quattrocentesca in piazza San Simeone. A Bologna restano due esempi apparentemente quattrocenteschi in un porta Ie all'angolo fra via Oberdan e via Altabella e in un altro sotto iI portico sudovest di piazza Santo Stefano. 190 II piedritto che regge Ie arcate della pseudoportico dell'arco di Augusto di Fano, rappresentato nell'incisione incastonata sulla facciata della chiesa di San Michele, dovrebbe essere, secondo Howard Burns, il prototipo antico. H. Burns, "Restaurator delle ruyne antiche": tradizione e studio dell'antico nell'attivita di Francesco di Giorgio, in Fiore, Tafuri (a cura di), hancesco di Giorgio architetto, cit., pp. 151-181, in parricolare p. 169. II motivo della cornice che ripiega su due lati corri di cui quello superiore esorretto da un bastone, 10 rroviamo usa to spesso nel tardogotico toscano anche al di fuori dell'architettura: ne eesempio la cornice della pala del Maestro di Montefloscolo custodita nella Pinacoteca comunale di Bologna. '" Precedenti si trovano prevalenremenre in architetture dipinte e per 10 piu di ambito bramantesco lombardo: negIi affeschi con i "filosofi" di Bergamo del 1477 in cui una parasta senza capitello rna con trabeazione regge una spessa cornice e nell'incisione Prevedari nell'arcata di sinistra. Nel costruito invece appaiono nel coro e nel secondo ordine della sacrestia di Santa Maria presso San Satiro e nel palazzo della Loggia di Brescia. Fuori dalla Lombardia compaiono nell'arco trionfale della Citta ideaIe nella pala della Walters Art Gallery di Baltimora e in un dettaglio della Disputa di san Tommaso con gli eretici a opera di Filippo Lippi nella cappella Carafa in Santa Maria sopra Minerva a Roma. Tutti questi esempi hanno un architrave a due fasce. Per questi argomenti efr. Bruschi, Lantico e il processo di identificazione degli ordini... , cit., pp. 31-43. 191 Questa ultimo aspetto era gia noto nell'architettura antica nella quale all'imposta di archi, in assenza di capitello, si trova sempre una trabenione contratta senza architrave, sia in archi rrionfali che in facciate a loggia. Fa eccezione porra Maggiore a Roma nella quale una trabeazione abbreviata senza fregio presenta un architrave che corre sui lati interni dei fornici grandi, mostrando in facciata la sua sezione. 193 Per questi argomenti efr. Bruschi, L'antico e it pl'Ocesso di identificazione degli ordini... , cit., pp. 34-35. t doveroso tuttavia precisare
117
che il rapporto fra strurtura e forma nell'architettura quattrocentesca non e costante e varia da edificio a edificio e da architerto ad architetto. Per applicare un criterio di giudizio basato sulla coerenza formale-strurturale e prudenre isolare il singolo caso e non cadere in una rischiosa generalizzazione. ,,, Eun tipo di lavorazione molro economica che permette di scolpire la pietra fuori opera senza la numerazione dei blocchi, che possono essere posti in qualsiasi parte dell'architrave e in ogni momento. '" [ mattoni sono ben squadrati e arrotati con graffiature diagonali, posti in opera in maniera accurata con una prevalenza di disposizione di fascia e con fughe estremamenre ridotte: quelle orizzonrali non superano i 5 mm menrre quelle verticali sono quasi inesistenri e spesso prive di malra. ,% "Furono dalla Camera di Bologna fane fa bbricare Ie prigioni nel palazzo che si nomina del Podesta, fatto di fabrica superbissima, rna anchora non ridutto a quella perfenione cbe mostra il disegno di Bramante, Arcbitettore famoso»: BCA-SM, ms. B. 1114, Lo Stato, il govemo et i magistrati della citta di Bologna, libro II, p. 314. Trascritto e pubblicato da S. Verardi Ventura, L'ordinamento bolognese dei secoli XVI-XVII, in "L'Archiginnasio», 1981, p. 296. II manoscritto edell'inizio del XVII secolo. Citato anche da Tuttle, Urban Design Strategies in Renaissance Bologna ... , cit., p. 58. 19' Per il dibarrito sull'artribuzione si veda: G. Bianconi, Guida del forestiere per Ia citta di Bologna e i suoi sobborghi, Bologna 1835, p. 63; A. Ricci, Storia dell'architettura in Italia dal secolo IVai XVIII, Modena, 1857-60, II, p. 566; G. Gozzadini, Note per gli studi sull'architettura civile in Bologna dal sec. XIII al XVI, in "Arti e memorie della regia deputazione di storia parria per Ie provincie dell'Emilia n , n.s., I, 1877, p. 33; Malaguzzi Valeri, Der Palast der Podesta in Bologna, cir., p. 247; Id., L'Architettura a Bologna nel Rinascimento, cir., p. 111; Tuttle, Urban Design Strategies in Renaissance Bologna... , cit., pp. 39-63. '" «Gli epoi un nobilissimo loggione derro Ie volte dei Merzari con dieci misteriosi pilastri di macigno lavorati d'architertura di Corinto di Bramante, 0 d' Aristotele Feravanre, che sopra ha una bella Renghiera, e un balaustrato di macigno laorato, che fa un corridore inanzi alia bella facciata del gran Salone del Palazzo deno del Podesta": Pasquali Alidosi, Istruttione delle cose notabili... , cir., p. 147. Ripreso da Turrle, Urban Design Strategies in Renaissance Bologna... , cir., pp. 39-63, in particolare p. 58. 19' "In quesro tempo [venne deciso] di fare un gran salone per le comedie et altri spettacoli
congionti al palazzo del Podesca sopra Ie volte chiamate de marzari, secondo il disegno di Bramante, famoso archirerto, altri dicono di Ridolfo Ferravante»: G. Negri, Annali della patria connessi alii fatti estemi piit memomndi mccolti dal sig.r Giovanfrancesco Negri cittadino bolognese, ms. sec. XVII, 14 voll., BUB, cod. 1107, senza numerazione dei fogli, sorto I'anno 1485. Si veda anche Tugnoli Partaro, Le opere bolognesi di Aristotele Fioravanti ... , cir., pp. 35-70. 200 Per l'opera di Bramante e Giulio II a Bologna si veda R.]. Tuttle, Julius II and Bramante in Bologna, in A. Emiliani (a cura di), Le arti a Bologna e in Emilia dal XVI al XVII secolo, Bologna 1982, pp. 3-8. Ora in R.]. Turtle, Piazza Maggiore. Studi su Bologna nel Cinquecento, Venezia 2001, pp. 47-54. Cfr. anche R.]. Turtle, Un progetto di Giulio II per Ia Romagna, Ravenna 2001. 201 Solo a partire dal 1478, data approssimativa di inizio del cantiere di Santa Maria presso San Sa tiro, Donato dimostra di essere in grado di usare e1ementi dell'antico in maniera appropriata e dimostrando una conoscenza dei monumenri romani e fiorenrini. Cfr. R. Schofield, Florentine and Roman Elements in Bramante's Milanese Architecture, in CH. Smith, G.C Garfagnini (a cura dil, Florence and Milan: Comparisons and relations, Acrs of two Conferences at Villa I Tarti in 1982-84, Firenze 1989, pp. 201-222; [d., Brmnante e un rinascimento locale all'antica, in F.P. Di Teodoro (a cura di), Donato Bramante. Ricerche, proposte, riletture, Urbino 2001, pp. 54-62. Si ricorda inolrre che Bologna gia nel XII secolo aveva perso ogni rraccia di architerture antiche. 202 L'a ffascinante suggestione ein Ceriana, La cappella Corner nella chiesa dei Santi Apostoli a Venezia, cir., p. 155 e n. 294. Per Francesco di Giorgio a Venezia: M. Mouesi, Francesco di Giorgio e Bramante: osservazioni su alctmi disegni degli Uffizi e della Laurenziana, in L. Paterra (a cura di), II disegno di architettura, Milano 1989, pp. 117-124. Bramanre potrebbe non aver apprezzato iI palazzo boJognese non solo per l'arrerratezza delle decorazioni rna anche per iI lqro uso eccessivo: la ridondanza degli ornamenti I'avrebbe infatti gia molto infasridito nel palazzo della Loggia di Brescia, lamentela che avrebbe espresso in una sua lettera, non datara e dispersa, che viene citata nel 1778. Cfr. Lupo, Platea magna communis Brixiae... , cit., p. 81. 201 Proprio in questi anni iI milanese Pietro da Brambilla venne assunro a Bologna come ingegnere per la ricosrruzione del canale del Naviglio e nel1485 Ascanio Maria Sforza divenne legato pontificio della cina - senza mai risiedervi - nomina ruttavia non gradita a Ludovico il Moro. Non bisogna dimenticare inoltre che la madre di Giovanni II Bentivoglio, Donnina Visconti, era
milanese. A. Rubbiani, II Castello di Giovanni II Bentivoglio a Ponte Poledrano, in «Ani e memorie della regia deputazione di storia patria per Ie provincie di Romagna», S. N, vol. lll, fasc. I, gennaiofebbraio 1913, pp. 145-234; Tuttle, Urban Design Strategies in Renaissance Bologna..., cit., p. 58. Per Ascanio Maria Sforza si veda I'imponenre e documentato studio di M. Pellegrini, Ascanio Maria Sforza, Roma 2002, vol. I, pp. 162 sgg. 20' Per la formazione di Bramante si veda I'ancora insuperaro studio di A. Bruschi, Bramante, Roma-Bari 1969, pp. 37-99; si veda anche Id., La formazione e gli esordi di Bramante: dati, ipotesi, problemi, in CL. Frommel, L. Giordano, R. Schofield (a cura di), Bramante milanese, Venezia 2002, pp. 45-65. '0.\ L'errore egiusrificabile dalla secolare confusione dovura al frequenre variare dei nomi dei palazzi, e anche dal rrasferimento del palazzo del Comune da quello del Podesta a quello derto d'Accursio. efr. n. 197. Per I'intervenro di Bramante nel palazzo d'Accursio: Hubert, Der Palazzo Comunale ... , cit., pp. 117-127. '06 Lupo propone un intervenro bramanresco piu limitato e suggerisce una collaborazione con Vincenzo Foppa. Anche iI palazzo della Loggia di Brescia deriva da un modello di cartone eseguito nel 1468 da Taddeo Della Torre, molti anni prima dell'inizio della cosrruzione avvenuta nel 1492, e modificato nel 1489. Lupo, Platea magna communis Brixiae ... , cit., pp. 6061, 75, 77-87; E. Arslan, Commento breve alia Loggia di Brescia, in "Commentari dell'Ateneo di Brescia», CLN, 1955, pp. 49-70; D. Hemsoll, Bramante and the Palazzo della Loggia in Brescia, in "Arte Lombarda», 1988, pp. 167-179; [d., Le piazze di Brescia nel Medioevo e nel Rinascimento ... , cir., pp. 168-177. 207 Cfr. nora 69. Per la bibliografia su Aristotele Fioravanri si veda soprattuno: L. Beltrami, Vita di Aristotele da Bologna, Bologna 1912; Aristotele Fioravanti a Mosca, Arti del Convegno, cir.; Mack, Bernardo Rossellino, L.B. Alberti and the Rome of Pope Nicholas V, cit., pp. 60-69; Ghisetti Giavarina, Aristotele Fioravanti, in DBI, cir., pp. 95-100. La voce e la migliore sintesi pubblicara sui bolognese con bibliografia aggiornata. Per un'introduzione ai temi dell'ingegneria nel XV secolo si veda rutile saggio di P. Galluzzi, Le macchine senesi. Ricerca antiquaria, spirito di innovazione e cultura del tenitorio, in P. Galluzzi (a cura di), Primo di Leonardo. Cultura delle macchine a Siena nel Rinascimento, Milano 1991, pp. 15-44. 20S Alberti stava concludendo il De re aedificatoria di cui Aristorele poteva aver conosciuro a1cuni contenuri. Enoto come il
118
trattato albertiano prima della sua pubbJicazione nel 1485 abbia avuto una diffusione molto limitata, rivolta soprattutto a personaggi infJuemi. Burns, Leon Battista Alberti, cit., p. 120 con bibJiografia. Proprio in quel periodo, in seguito alia decisione di Sigismondo Malatesta presa fra il luglio e I'agosto del 1450 di trasformare la chiesa di San Francesco di Rimini net tempio Malatestiano, Leon Batrista si trovo ad affromare la fase iniziale di questo progetto che presemava vincoli e problemi di inserimento di un involucro moderno attorno a preesistenze medievali, simili a quelli del Podesta. Per la cronologia della costtllzione efr. C. Hope, The Early History of the Tempio Malatestiano, in «Journal of the \X!arburg and Courtald Institutes", 55, 1992, pp. 51-154. m Bernardo Rossellino aveva avuto stretti contatti con Pagno di Lapo Portignani, celebre architetto e scalpellino di origine fiesolana autore anche del distrutto palazzo Bemivoglio, a sua volta in contatto con Aristotele. C. von Fabriczy, Pagno di Lapo Portigianni, in «Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen", xxrv, 1903, pp. 119139; A. Foratti, I.:attivita di Pagno di Lapo Portignani in Bologna, in Miscellanea di Storia dell'arte in onore di I.B. Supino, Firenze 1933, pp. 353-373. 110 Nello da Bologna, Commissarius Generalis delle opere architettoniche sotto iJ pontificato di Nicolo V, potrebbe essere colui che chiamo aRoma il suo compatriota Aristotele. 111451 segna J'inizio della carriera del Fioravanti che, dalle notizie a mia conoscenza, non aveva ancora fatto parJare di se a Bologna, tranne per !'innalzamento della campana del Podesta nel 1437. Forse Nello aveva conosciuto il padre e 10 zio di Aristotele, rispettivamente Fieravante e Bartolomeo, ingegneri gia molto affermati. Un'importante figura che lega Roma a Bologna eanche il cardinale Bessarione, legato pontificio fra il1450 e il 1455 e intimo con Nicolo V. Cfr. M. Tafuri, Cives esse non Iicere. Nicolo V e Leon Battista Alberti, in Ricerca del Rinascimento, Torino 1992, pp. 33-88, in particolare p. 40; in questo fondamemale saggio sulla Roma nicolina, Fioravanti tuttavia non viene mai nominato. Per Bessarione a Bologna: E. Nasalli Rocca, II Card. Bessarione legato pontificio in Bologna (1450-1455), in «Atti e memorie della regia deputazione di storia patria per Ie provincie di Romagna", s. rv, X)(, fasc. rv-VI, luglio-dicembre 1930, pp. 17-80. Per Nello da Bologna: M. Gargano, Architettura delle acque. Idraulica, fontane, ponti, fiume e porti nella Roma del XV e del XVI sec%, tesi di dottorato, Istituto universitario di architettura di Venezia, 1987; C. Burroughs, Below the Angel: an Urbanistic Project in the Rome of Pope
Nicholas \1, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes", 45, 1982, pp. 94-124; Id., From Sign to Design. Environmental Process and Reform in Early Renaissance Rome, Cambridge-London 1990, in particolare pp. 99-113. 211 Per il palazzo dei Senatori nel XV secolo efr. S. Romano, La facciata medievale del palazzo Senatorio: i documenti, i dati, e nuove ipotesi di lavoro, in M.E. Tittoni (a cura di), La facciata del palazzo Senatorio in Campidoglio, Pisa 1994, pp. 39-62; R. Magri, II palazzo Senatorio clal pontificato di Bonifacio IX ai primi del '500, ibidem, pp. 63-80; S. Guarino, II palazzo dei Conservatori tra Quattm e Cinquecento, in M.E. Tittoni (a cura di), II palaz.zo dei Conservatori e if palazzo nuovo del Campidoglio, Pisa 1996, pp. 41-50. 212 II 9 luglio 1461 fornt un parere a Filarete sulla costruzione delle capriate che avrebbero coperto una Juce simile a quella della sala grande del palazzo del Podesta bolognese. Beltrami, Vita di Aristotele da Bologna ... , cit., pp. 54 sgg. Nel suo trattato Filarete cita AristoteJe tre volte chiamandolo Letistoria, anagramma del suo nome: per il progetto di un castello nel piacentino, per 10 spostamemo di colonne e per la costruzione di macchine. Filarete, Trattato di Architettura, cit., pp. 391,436, 470,472. Oi queste tre indicazioni Ie ultime due sono documemate: Aristotele a Roma venne incaricato sotto Nicolo V dello spostamento di colonne gigami da un luogo nei pressi di piazza della Minerva (efr. nota 127) e cOStrul macchine che gli permisero 10 spostamento della torte di strada Maggiore nonche opere di ingegneria in tutta Italia. Riguardo al progetto di castello nel piacentino non si hanno notizie precise, rna vista I'attendibilita delle informazioni del FiJarete su Aristotele, I'attribuzione meriterebbe una rice rca approfondita. Nel cantiere dell'ospedale Maggiore Aristotele molto probabilmenre conobbe anche il pittore Vincenzo Foppa, autore delle decorazioni del portico e legato a Filarete che, secondo Lupo, avre~be avuto un importante ruolo nel progetto del palazzo della Loggia di Brescia. Lupo, Platea magna communis Brixiae... , cit., pp. 85-87. 213 Allo stesso modo gia ne11456, quando per la prima volta venne eletto massaro dell'arte dei Muratori, gli venne subito affidato l'incarico della copertura della torre del palazzo del Podesta. Ghisetti Giavarina, Aristotele Fioravanti, in DBI, cit., p. 94. Si ricordano poi i gia citati Javori eseguiti all'interno del palazzo nel 1468. 2H Huber, Der Palazzo Comunale ... , cit., pp. 77-115. Ghisetti Giavarina, Fieravante Fioravanti, in DBI, vol. XLVIII, Roma 1997, pp. 105-107 con bibliografia.
119