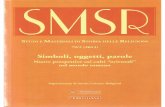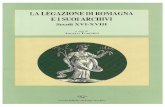Palazzo Gualtieri
Transcript of Palazzo Gualtieri
Presidenza del Consiglio dei MinistriCommissario delegato per la Ricostruzione
Vice Commissario delegato per la tutela dei Beni culturali
L’UNIVERSITÀ E LA RICERCA PER L’ABRUZZOIl patrimonio culturale dopo il terremoto del 6 aprile 2009
ideazione e coordinamento della ricerca Vice Commissario Luciano Marchetti
a cura di
Lucia Milano, Carmela Morisi, Chiara Calderini, Adalgisa Donatelli
TEXTUSEDIZIONI
0_Introduzioni_1_38_Layout 1 15/01/12 17.46 Pagina 5
Realizzazione editorialeTextus s.r.l.
Consulenza editorialeStefania De NardisSilvia Grillo
Didascalie regesto immaginiMauro Congeduti
Progetto graficoMINDMADE | Andrea Padovani
Coordinamento generaleLucia MilanoCarmela Morisi
© Copyright 2011 Textus s.r.l. Casa editriceL’Aquila, via Rosso Guelfaglione, 36www.textusedizioni.it
stampa
San Giovanni Teatino (CH)
ISBN 978-88-87132-80-9
referenze fotograficheMauro Congeduti pp. 22, 23
Luca Del Monacopp. 2, 4, 9, 10, 12, 14-18, 20, 26, 28, 30,32, 34, 35, 37, 44, 46, 56, 64, 65, 68, 85,91, 94, 99, 108, 133, 137, 138, 154, 163,166, 168, 176, 186-187, 246, 252, 266,284, 300, 310, 320, 326, 331, 338, 346,354, 399, 400, 410, 454, 472, 475-479
con la gentile collaborazione diVenanzio Gizzi
Ideazione e coordinamento della ricercaa cura del Vice CommissarioLuciano MarchettiPresidenza del Consiglio dei MinistriCommissario delegato per la RicostruzioneVice Commissario delegato per la tutela deibeni culturali
A cura di Lucia Milano, Carmela Morisi, ChiaraCalderini, Adalgisa Donatelli
Segreteria editoriale Antonella LopardiAlessandra Mancinellii
Il volume comprende le memorie del convegno L’UNIVERSITÀ E LA RICERCA PER L’ABRUZZO Il come e il perché dei danni ai monumentitenutosi all’Aquila nei giorni 17-19 dicembre2009
Le immagini contenute nel volume sono staterealizzate e messe a disposizione dagli autoridelle singole memorie
Si ringrazianoil comitato organizzatore, gli autori e tutti ipartecipanti al convegno
il Dipartimento di Protezione Civile
i Vigili del Fuoco
le Curie
i parroci
la Direzione Generale per il paesaggio, le bellearti, l’architettura e l’arte contemporanee
la Direzione Regionale per i Beni Culturali ePaesaggistici per l’Abruzzo e le Soprintendenzedi settore
gli Enti, pubblici e privati, e i cittadini proprietaridei Beni
l’Ufficio del Vice Commissario delegato per latutela dei Beni Culturali
Provincia dell’Aquila
CITTÀ DELL’AQUILA
0_Introduzioni_1_38_EDILFRAIR_Layout 1 17/01/12 11.15 Pagina 6
PUBLISH pre&stampa
11 PresentazioniGianni ChiodiAntonio Del CorvoMassimo Cialente
19 PrefazioneLuciano Marchetti
21 IntroduzioneGiovanni Carbonara
Il ruolo della ricerca per il restauro e laricostruzione dell’Aquila e del suo territorio
23 Sergio Lagomarsino25 Claudio Modena27 Donatella Fiorani29 Vincenzo Gattulli31 Salvatore Russo33 Gaetano Manfredi36 Tatiana Kirova
40 Atlante dei casi di studio
Crolli e danni molto gravi
45 Basilica di Santa Maria di Collemaggio all’AquilaElena Antonacci, Vincenzo Gattulli,Antonio Martinelli, Fabrizio Vestroni
52 Basilica di Santa Maria di Collemaggio all’AquilaMaurizio Cerone, Giorgio Croci, Carlo Giavarini
58 I danni, gli interventi d’urgenza e la copertura nella basilica di CollemaggioGiorgio Croci, Luciano Marchetti
62 Chiesa di Santa Maria Paganica Risposta sismica al terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009Caterina F. Carocci, Serena Cattari,Sergio Lagomarsino, Cesare Tocci
70 Chiesa di Santa Maria PaganicaNicola Augenti, Antonio Borri, Silvia Bongi, Paola Brescia, Giovanni Cangi, Andrea Giannantoni, Marilena Liris
78 Chiesa di San Marco all’Aquila Valutazione preliminare dei danniBruno Silva, Jacopo Magi, Filippo Casarin, Claudio Modena, Maria R. Valluzzi, Luigia Binda, Paola Condoleo
86 Complesso Monumentale della chiesa di San Pietro di Coppito all’AquilaGiosuè Boscato, Angelo Di Tommaso,Salvatore Russo, Francesca Sciaretta
92 Analisi del danno strutturale e del comportamento sismico di palazzo CarliElena Antonacci, Dante Galeotta,Vincenzo Gattulli, Lorenzo Fanale
98 Torre di Santo Stefano di SessanioGiosuè Boscato, Lorenzo Lazzaroni,Salvatore Russo, Elena Sperotto,Luciano Marchetti
Chiese all’Aquila
104 Chiesa di Sant’AgostinoChiara Calderini, Sergio Lagomarsino
110 Chiesa di San Biagio AmiternoLuigia Binda, Claudio Chesi,Maria Adelaide Parisi, Francesca da Porto,Corrado Marsili
115 Chiesa di San Biagio d’Amiternum. Catalogosismico locale e meccanismi di collassoLuigi Sorrentino, Elisabetta Raglione, Domenico Liberatore, Luis D. Decanini
121 Teatro San FilippoAntonio Castellucci, Giandomenico Cifani, Alberto Lemme, Marilena Liris, Anna Rita Mazzariello, Francesca Martegiani
127 Oratorio di San Giuseppe dei Minimi. Influenza di condizioni di vincolo e moto del terreno sulla rispostaLuigi Sorrentino, Elisabetta Raglione, Omar Al Shawa, Domenico Liberatore, Luis D. Decanini
131 Comportamento sismico di alcune chiese dell’Aquila in seguito al sisma dell’aprile 2009Giuseppe Lucibello, Giuseppe Brandonisio, Elena Mele, Antonello De Luca
136 Il comportamento sismico della chiesa dei Santi Marciano e NicandroAnna Brignola, Emanuela Curti, Sonia Parodi, Stefano Podestà
143 Chiesa di Santa Maria degli Angeli fuori Porta NapoliPiero Gelfi, Ezio Giuriani, Alessandra Marini, Giovanni Metelli, Fausto Minelli, Giovanni Plizzari, Marco Preti
147 Danni e vulnerabilità della chiesa di Santa Maria del CarmineClaudia Casapulla, Carlalberto Anselmi, Claudio Cristilli, Ennio De Rosa, Filomena Galizia, Mariarosaria Gargiulo, Fabrizio Lauro, Alessandra MaioneAtanasio Pizzi
152 Chiesa di Santa Maria del SoccorsoValerio Alecci, Silvia Briccoli Bati, Mario Fagone, Giovanna Ranocchiai, Tommaso Rotunno
157 Chiesa di Santa MargheritaGiorgio Cacciaguerra, Maria Paola Gatti, Maurizio Piazza, Roberto Tomasi, Francesca Bortot, Daniele Zonta, Massimo Dalle Vedove, Moreno Rosi
164 Chiesa di San SilvestroAntonio Borri, Giovanni Cangi, Mauro Caraboni, Alessandra Giancarlo, Fabrizio Menghini, Laura Procacci, Riccardo Vetturini
Chiese nella Conca aquilana
169 Gli edifici di culto della Baronia di CarapelleCarmela Morisi, Giovanni Cialone, Giandomenico Cifani, Aurelio Petracca, Antonio Castellucci, Veronica De Vecchis
177 Chiesa di Sant’Eusanio Martire e borgo di Sant’EusanioVittorio Ceradini, Manuela Praticò, Paola Terenzi
185 Santuario di Santa Gemma vergine a Goriano SicoliMauro Sassu, Gerardo Masiello, Tommaso Conti, Alessio Vezzosi
193 Chiesa di Santa Giusta a BazzanoLuigia Binda, Christian Amigoni, Giuliana Cardani, Fabio Maroldi, Filippo Lorenzoni, Corrado Marsili, Marcello Marchetti
199 Chiesa della Immacolata Concezione a Paganica Anna Brignola, Emanuela Curti, Sonia Parodi, Stefano Podestà
203 Chiesa di Santa Maria ad Cryptas a FossaFabrizio De Cesaris, Adalgisa Donatelli, Donatella Fiorani, Alessia Placidi, Gianmarco de Felice, Alberto Mauro
208 Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Civita di BagnoGiulio Mirabella Roberti, Paolo Riva, Alessio Cardaci, Luca Ferrario
215 Chiesa di San Paolo di Peltuinum a Prata d’AnsidoniaCarmela Morisi, Antonio Castellucci, Lucia Milano, Alberto Lemme, Giandomenico Cifani, Aurelio Petracca,Franco De Vitis
225 Chiesa di San Pietro Apostolo a CoppitoBruno Silva, Catarina Costa, Claudio Modena,Maria R. Valluzzi, Luigia Binda, Paola Condoleo, Laura Bolondi, Riccardo De Ponti
231 Chiesa di San Raniero a Civita di BagnoMaurizio De Vita, Giacomo Tempesta, Ulrike Schulze
234 Chiesa di Santo Stefano di Castelnuovo a San Pio delle CamereAndrea Vignoli, Andrea Borghini, Emanuele Del Monte, Barbara Ortolani
240 Santuario della Madonna della Croce di Poggio di RoioMaria Luisa Beconcini, Pietro Croce,Laurent D’Onofrio, Paolo Formichi, Mario Marchisio
indice
0_Introduzioni_1_38_Layout 1 15/01/12 17.46 Pagina 7
Edilizia storica civile all’Aquila
245 Casa di Ser Jacopo di Notar NanniAntonio Borri, Andrea Giannantoni,Barbara Porticelli, Ciro Urselli
253 Palazzo Alfieri in via FortebraccioPaolo Rocchi, Carmen Piccirilli, Andrea Valerio Canale, Marianna Mazzanobile
259 Palazzo Camponeschi. Giuseppe Morelli, Maria Rosaria Ferrari,Giorgio Fontana, Maria Anglona Lasalandra,Luisa De Zio, Ramona Vitale
265 Miglioramento sismico e recupero di palazzo Camponeschi Mario Centofanti, Romolo Continenza, Pierluigi De Berardinis, Angelo Di Egidio, Donatella Dominici, Dante Galeota, Vincenzo Gattulli, Renato MorgantiGianfranco Totani
272 Palazzo Carli BenedettiFabrizio De Cesaris, Donatella Fiorani, Adalgisa Donatelli, Alessia Placidi, Carla Bartolomucci
279 Palazzo Carli BenedettiAntonio Borri, Roberta Verrecchia, Riccardo Vetturini
285 Palazzo CentiGiuseppe Lucibello, Giuseppe Brandonisio,Elena Mele, Antonio De Luca
289 Palazzo Ciavola Cortelli Porcinari Antonio Ceradini, Arianna Dari Salisburgo
294 Palazzo Ciolina-CiampellaGianmarco de Felice, Stefano De Santis,Antonio Martinelli, Aurelio Petracca
301 Palazzo della Direzione generale CarispaqMario Centofanti, Simonetta Ciranna,Pierluigi De Berardinis, Dante Galeota,Vincenzo Gattulli, Renato Morganti
309 Palazzo Dragonetti in via Santa GiustaGiovanni Morabito, Paola Veneto, Irene Castelli, Stefano Benedetti,Luigi Sorrentino
316 Palazzo Fiore. Inquadramento dei danni e indicazioni per il consolidamentoMauro Sassu, Gerardo Masiello,Tommaso Conti, Alessio Vezzosi
321 Palazzo GualtieriIvo Caliò, Francesco Cannizzaro,Massimo Marletta, Bartolomeo Pantò, Marco Intelisano, Rosa Caponetto,Giuseppe Margani, Marco Lepidi
327 Palazzo Margherita. Proposte perl’adeguamento sismicoAlessandro De Stefano, Gianluca Ruocci,Gian Paolo Cimellaro
332 Palazzo Pica AlfieriAntonio Borri, Roberta Verrecchia, Riccardo Vetturini
339 Palazzo del GovernoAntonio Castellucci, Alberto Lemme, Giandomenico Cifani, Marilena Liris, Francesca Martegiani, Corrado Marsili, Giuseppe Di Girolamo, Bianca Maria Colasacco
347 Palazzo QuinziLucia Milano, Antonio Mannella, Carmela Morisi, Antonio Castellucci,Alberto Lemme, Giovanni Luca Conti,Aurelio Petracca, Corrado Marsili
355 Modellazione non lineare della Torre civica Gian Paolo Cimellaro, Giovanni Salluzzo,Alessandro De Stefano, Andrei M. Reinhorn
360 Considerazioni sui danni agli edifici in muratura del centro storico dell’AquilaBruno Calderoni, Emilia A. Cordasco,Pietro Lenza, Gaetana Pacella
Il Forte spagnolo all’Aquila
369 Fortezza spagnola. Analisi del comportamento strutturaleFilippo Casarin, Filippo Lorenzoni,Claudio Modena, Luigia Binda, Lorenzo Cantini, Stefano Munda, Roberto Ciabattoni, Antonio di Stefano
Centri storici minori nella Valle dell’Aterno
375 Rilievo costruttivo e del danno, indagini ed indicazioni per il recupero di CasentinoCaterina F. Carocci, Concetta Borgia, Margherita Costa, Chiara Circo, Davide Indelicato, Manuela Marino,Sergio Lagomarsino, Serena Cattari, Francesca Cianci, Alessia Dal Bo’, Stefania Degli Abbati, Daria Ottonelli,Chiara Romano, Michela Rossi, Nicoletta Serafino, Gerolamo Stagno, Giandomenico Cifani, Antonio Martinelli, Antonio Castellucci, Alberto Lemme, Marilena Liris, Francesca Martegiani, Anna Rita Mazzariello, Lucia Milano, Carmela Morisi, Aurelio Petracca, Cesare Tocci,Daniela Pittaluga, Rita Vecchiattini
381 La rimozione delle macerie e la messa in sicurezza di Villa Sant’Angelo Caterina F. Carocci, Chiara Circo, Davide Indelicato, Sergio Lagomarsino, Serena Cattari, Gerolamo Stagno, Giandomenico Cifani, Antonio Martinelli, Antonio Castellucci, Alberto Lemme, Marilena Liris, Francesca Martegiani, Anna Rita Mazzariello, Lucia Milano, Carmela Morisi, Aurelio Petracca, Cesare Tocci
Siti archeologici nell’Aquilano
385 Il terremoto sui beni archeologici: una casistica dei danniCarla Bartolomucci
390 La necropoli di Fossa. Analisi del danno e della vulnerabilità sismica delle tombe a cameraMaria Rita Copersino, Berardino Di Vincenzo
395 Aepiscopio Sancti Maximi a Civita di Bagno Giovanni Cialone, Maria Gabriella Florio, Anna Rita Mazzariello
Altre esperienze di studio a cura dell’editore
401 Palazzo MarinacciLuciano Beddini, Claudio Ricottini,Riccardo Vetturini
407 Palazzo Perrone Giancarlo Di Rosa, Massimiliano Vagniluca
411 Teatro stabile d’Abruzzo “Nazzareno De Angelis” Gianlorenzo Conti , Luca Carosi, Claudio Modena, Giuseppe Santoro
Conclusioni
417 Terremoto e gestione dell’emergenzaGiandomenico Cifani
419 Valutazioni speditive di sicurezzain condizioni di emergenzaClaudio Modena
423 Lo stato di conservazione e la qualità murariaLuigia Binda, Giuliana Cardani
427 Pareti in muratura soggette ad azioni fuori del pianoGiorgio Croci
431 Analisi del danno in elementi vulnerabili. Inquadramento del problemaDonatella Fiorani
435 Prime considerazioni sul danno strutturale di torri e campanili indotto da azione sismicaSalvatore Russo, Elena Sperotto
441 Considerazioni sul danno alle CupolePaolo Rocchi, Andrea Valerio Canale,Corin Frasca
449 Restauri di consolidamento moderni Sergio Lagomarsino
457 Prime risultanze del monitoraggio sullo stato del territorio aquilano interessato dal sismaTatiana Kirova, Carla Bartolozzi
463 Il “ben costruire”. Dalle tecniche tradizionali alla ricostruzioneAngela Marino
469 Il post-terremoto del 6 aprile 2009. Gli scenari possibili Maurizio Galletti
473 Regesto immagini
0_Introduzioni_1_38_Layout 1 15/01/12 17.46 Pagina 8
SommarioA seguito del rovinoso evento si-smico occorso nell’Aquilano il 6aprile 2009, alle perdite di viteumane si sono aggiunti gravissimidanni a tutto il patrimonio storico-architettonico della città. Sonostati soprattutto palazzi storici echiese a subire i maggiori danni,in alcuni casi irreversibili.Gli studi sintetizzati nel presentescritto sono relativi all’edificio de-nominato palazzo Gualtieri.L’obiettivo della ricerca è stato dianalizzare i danni subiti dall’edifi-cio, anche allo scopo di giustifi-carne il danneggiamentoevidenziato, attraverso l’uso dimodelli numerici di previsione chepossano risultare utili ai fini dellavalutazione del rischio sismico delpatrimonio storico-monumentale.La ricerca ha visto il coinvolgi-mento di diverse figure professio-nali, orientate, da un lato allaricostruzione delle informazionistorico-architettoniche e al rilievo,dall’altro alla simulazione nume-rica della risposta sismica dell’edi-ficio, da porre a confronto con lasperimentazione al vero operatadal sisma.
Descrizione sintetica dell’edificioe note storico-architettonichePalazzo Gualtieri (noto anchecome palazzo Bonomo-Ximenes),precedentemente palazzo Alfieri(poi Alfieri Ossorio), costituisce ilfronte meridionale di piazza
Santa Giusta, ha ingresso al ci-vico n. 5 della stessa piazza (fig.1) ed è oggi di proprietà plurifa-miliare.Il palazzo viene fatto risalire dallatradizione al secolo XV. Tuttavia glielementi che, in mancanza di do-cumenti sicuri, permettono una da-tazione approssimata (peresempio le cornici di finestre eportali), tenderebbero a spostarel’epoca di costruzione al tardo se-colo XVI. Il cortile principale, malconservato ma tuttora leggibile,appartiene con relativa certezzaal pieno Seicento, pur mante-nendo spunti tardo rinascimentaliche improntano i monumentali pro-spetti. Simili elementi si ritrovano inparticolare nell’armoniosa compo-sizione dei fronti laterali, non alte-rata dalle aperture di comodo cheinvece svisano il fronte principalesu piazza Santa Giusta (fig. 2).Tuttavia il palazzo, nel suo im-pianto originario, risulta più anticodi quanto oggi non possa appa-rire a causa della presenza di di-versi inserimenti posticci, risalentisoprattutto ai secoli XVI e XVII.Di un certo pregio storico-architet-tonico è il cortile: anticamente cir-condato da un portico con arcate,oggi in gran parte tamponato, la-scia intravedere, tuttavia, l’ele-gante conformazione originaria.L’edificio è isolato lungo tre fronti,mentre parte del prospetto orien-tale è addossato ad un palazzoadiacente, che ne riprende il ca-
Ivo Caliò Francesco CannizzaroMassimo Marletta Bartolomeo Pantò Marco Intelisano Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, Università degli Studi di Catania
Rosa CaponettoGiuseppe Margani Dipartimento di Architettura, Università degliStudi di Catania
Marco LepidiDipartimento di Ingegneria delle strutture,delle acque e del terreno, Università degliStudi dell’Aquila
Pala
zzo
Gua
ltier
i
46
Figura 1. Immagini d’archivio di palazzoGualtieri, da M. DANDER, M. MORETTI, Archi-tettura civile aquilana (dal XIV al XIX secolo),Japadre, L’Aquila 1974
1
Edilizia storica civile all’Aq
uila
32
1
parte_4_Layout 1 16/01/12 00.09 Pagina 321
Palazzo Gualtieri
32
2
Figura 2. Un’immagine recente del prospetto set-tentrionale
Figura 3. Planimetrie storiche e aerofoto recente
Figura 4. Prospetti nord e ovest
2
4
rattere architettonico. Sul corpo ad-dossato, al piano terra, si apre unpassaggio arcuato (arco dei Fran-cesi), che consente lo sbocco inpiazza alla via dei Francesi (fig. 4). Il palazzo, articolato su tre livelli, èalto 14m ed è caratterizzato da unapianta pressoché rettangolare, conlati di circa 36m e 28m. La corte in-terna, anch’essa rettangolare, pre-senta lati di circa 7,5m e 10m.Le immagini riportate in figura 3 mo-strano le trasformazioni morfologicheche hanno interessato l’edificio dal1590 ad oggi.
Rilievo geometrico e del quadro fes-surativoDurante i sopralluoghi, effettuati nellafase di emergenza post-sismica, èstato eseguito un rilievo geometricodiretto del fabbricato, che ha consen-tito di restituire graficamente piante,prospetti e sezioni nonché il quadrofessurativo riscontrato su ciascunfronte e sul vano più danneggiato.In figura 4 sono riportati il prospettosettentrionale e occidentale dell’edifi-cio, con i relativi quadri fessurativi; infigura 5 la pianta del piano terra edelle coperture. Poiché non è statopossibile accedere a tutti gli apparta-menti, le piante sono state ricostruite
anche sulla base dei documenti ac-quisiti.In figura 6 è riportata la sezione tra-sversale A-A, con evidenza delle co-perture voltate e del tipo di struttura asostegno dei tetti.In particolare, in corrispondenzadell’ampio salone presente al primopiano (denominato vano B), è statopossibile osservare un’elevata con-centrazione di danni, sia alle pareti,che, soprattutto, alla volta sovra-stante, in parte crollata (fig. 7). Talecrollo rappresenta il principale disse-sto subito dal fabbricato e la mag-giore perdita, soprattutto per il pregioartistico dei dipinti che ne decoranola superficie. La muratura sul pro-spetto di via San Michele ha subitocrolli parziali e una perdita di vertica-lità in corrispondenza della zona inte-ressata dal passaggio di una cannafumaria. Questo vano è stato oggettodi specifiche simulazioni numeriche, icui risultati sono riportati nei paragrafisuccessivi.Per quanto concerne gli elementi co-struttivi, da un’indagine a vista è statopossibile individuare le seguenti carat-teristiche:- muratura intonacata sui fronti nord,ovest e su via dei Francesi, costituitada conci calcarei sommariamente
sbozzati con presenza di elementi inlaterizio; sul fronte sud sono presentidue diversi tipi di muratura conparamento a vista: il primo(parzialmente rinzaffato) costituito daconci calcarei irregolari, il secondoda conci calcarei irregolari e ricorsi“a tratti” in mattoni (fig. 8);- cantonali con conci di pietrasquadrata (lasciata a vista, nonperfettamente levigata), legati conmalta di calce, impostati “a filomuratura” (fig. 8);- attacchi a terra con intonaco “frataz-zato”, sui fronti nord e sud, e “arric-ciato”, sul fronte sud;- cornicioni con palombella doppia osemplice su tavolato;- porte terranee (più ampie) con archi-travi monolitici, quelle più piccole, ele finestre dei piani superiori, con ar-chitravi composti da più conci e archidi scarico in mattoni (fig. 8);- volte dei vani A e B in mattoni pienidisposti a coltello, con nervature inlegno distribuite secondo le direttrici ele generatrici dei fusi.
Intervento di miglioramento strutturaleNei primi anni Novanta l’edificio èstato oggetto di un intervento di mi-glioramento strutturale. Tuttavia la
3
parte_4_Layout 1 16/01/12 00.09 Pagina 322
frammentazione della proprietà e i ri-correnti ritardi e ridimensionamentidell’intervento non hanno consentitola realizzazione di un progetto orga-nico ed unitario. Ciò nonostante i nu-merosi interventi locali effettuati hannodeterminato un miglioramento signifi-cativo delle criticità più evidenti, es-senzialmente legate alla scarsaqualità dell’apparecchio murario edegli ammorsamenti tra le pareti. Atal riguardo sono state eseguite ope-razioni di “cuci e scuci”, chiodaturadi pareti ortogonali e realizzazione diintonaci armati. L’intervento è statosottoposto all’approvazione da partedegli uffici competenti del Comunedell’Aquila, del Genio civile e dellaSoprintendenza ai beni architettonici. Nel corpo principale l’intervento hacomportato alcune demolizioni loca-lizzate delle murature per la realizza-zione di un vano ascensore. Nelcortile interno è stato realizzato unnuovo vano scala in aderenza allepareti esistenti, ad esse ammorsatotramite perni in acciaio. Tra le misureadottate, volte ad assicurare un mi-glior comportamento scatolare glo-bale dell’edificio, occorre citarel’ancoraggio della parete prospicientepiazza Santa Giusta che presentavaun evidente spanciamento verso
l’esterno della facciata, storicamenteimputabile alla parziale rimozionedegli orizzontamenti al secondo livelloper la realizzazione dei due ampi sa-loni archivoltati retrostanti (vani A e Bdi figura 5). Nel corso dell’interventoin questione, al contenimento del feno-meno è stata dedicata la realizza-zione di un leggero telaio pianoorizzontale di profilati metallici, tenutoda catene ancorate al maschio mura-rio centrale di spina dell’edificio e na-scosto nello spessore dell’intonacoesterno di finitura.La scarsa qualità dell’apparecchiomurario è stata diffusamente trattataattraverso iniezioni di malta cementi-zia antiritiro a bassa pressione. Seb-bene riconosciute vulnerabili, le voltea copertura dei due saloni non sonostate oggetto di intervento per motividi limitate disponibilità economiche.La copertura lignea è stata revisio-nata, con mantenimento dello schemastrutturale esistente in capriate ed inse-rimento di numerosi tiranti in acciaiocollaboranti con le catene delle ca-priate. I tiranti sono annegati in uncordolo in calcestruzzo armato disommità, posto alla testa delle paretiin muratura. Gli elementi lignei origi-nali delle capriate sono stati conser-vati, a meno di modeste sostituzioni.
Il vecchio tavolato delle falde di co-pertura, fortemente ammalorato, èstato oggetto di completa sostitu-zione.Nel corpo in aggregato, posto a sini-stra dell’arco dei Francesi, l’inter-vento, complessivamente più invasivo,ha interessato tutti i piani dell’edificio.In particolare ha previsto la realizza-zione di un nuovo piano completa-mente interrato in calcestruzzoarmato, le cui pareti armate costitui-scono la fondazione di un nuovo te-laio tridimensionale realizzato fino allivello della copertura e in aderenzaalla struttura preesistente, a cui risultasolidarizzato mediante ancoraggi inacciaio annegati nella muratura. Lanuova copertura a falde del corpo inaggregato è stata realizzata con traviinclinate e solai in laterocemento.
Simulazioni numericheIn questo paragrafo sono sintetizzati irisultati relativi alle simulazioni numeri-che condotte su alcuni modelli del pa-lazzo, realizzati sulla base del rilievogeometrico, delle tipologie murarieosservate e della documentazione ac-quisita.In particolare, sono state effettuatedue diverse modellazioni caratteriz-zate da un diverso grado di accura-
Edilizia storica civile all’Aq
uila
32
3
Figura 5. Pianta del primo piano e delle coper-ture
Figura 6. Sezione A-A
Figura 7. Restituzione grafica del quadro fessura-tivo del vano B
5
6 7
parte_4_Layout 1 16/01/12 00.09 Pagina 323
tezza: una modellazione di dettaglio,orientata alla simulazione della rispo-sta della volta a schifo che ha subitoil crollo della parte centrale affre-scata, e una modellazione globale tri-dimensionale, rivolta alla simulazionedella risposta globale dell’edificio.I modelli di calcolo utilizzati sono statisviluppati da un gruppo di ricercatoridell’Università di Catania. In partico-lare, per il modello globale è stata uti-lizzata una modellazione basata suun macro-elemento piano1 in gradodi simulare i principali meccanismi dicollasso nel piano della muratura e diconsiderare l’interazione della mura-tura con cordoli, travi e pilastri.2 Talescelta è anche motivata dal fatto che,nel suo complesso, l’edificio può con-siderarsi a comportamento scatolaree quindi nella modellazione globale imeccanismi di primo modo vengonoconsiderati inibiti. Per il modello didettaglio della sala è stato impiegatoun elemento discreto,3 che rappre-senta un’evoluzione di quello piano,in grado di cogliere il comportamentonel piano e fuori piano della mura-tura, anche in presenza di elementi ageometria curva, come evidente-mente necessario per la simulazionedegli elementi voltati.
Simulazioni numeriche condotte sulmodello localeCome accennato, i danni più signifi-cativi si sono verificati in corrispon-denza dei due saloni posti al primolivello dell’edificio e sormontati davolte a schifo con la parte centrale af-frescata. Entrambe le volte hanno su-bito gravi danneggiamenti, ma inparticolare quella relativa al saloneidentificato con la lettera B in plani-metria (fig. 5) ha manifestato il crollototale della parte centrale, come sievince dalle fotografie riportate in fi-gura 9. Allo scopo di giustificare at-traverso simulazioni numeriche il
danneggiamento rilevato, è stato rea-lizzato un modello del vano B consi-derando i muri perimetrali e la volta aschifo sovrastante (fig. 10). I risultati delle analisi sono stati formu-lati mediante deformate a collasso ecurve di capacità. Le curve di capa-cità sono state espresse in termini dirisultante delle forze applicate in fun-zione dello spostamento di un puntodella sommità della volta. Le pro-prietà meccaniche assunte alla basedella modellazione sono: modulo diYoung E=120 kN/cm2, modulo dielasticità tangenziale G=48kN/cm2,resistenza a trazionest=0,01 kN/cm2, resistenza a com-pressione sc=0,3 kN/cm2.Sono state considerate due diverse di-rezioni di carico, una verticale e unaorizzontale, entrambe proporzionalialla massa. Per la direzione trasver-sale, i cui risultati sono riportati di se-guito, è possibile notare unaresistenza massima pari al 45% delpeso della struttura e un comporta-mento scarsamente duttile (fig. 11). Ladeformata e il quadro fessurativo alcollasso (fig. 11) mostrano una con-centrazione del danno in corrispon-denza della volta e della zona dellaparete corrispondente alla canna fu-maria, caratterizzata da un forte re-stringimento della sezione muraria.Per la direzione verticale i risultati intermini di curva di capacità (fig. 11)evidenziano un ridotto margine di sicu-rezza nei confronti degli incrementi deicarichi verticali (circa 1,2). La defor-mata e il quadro fessurativo al collasso(fig. 11), evidenziano come la partesommitale della volta (quella effettiva-mente crollata) rappresenti la zonasoggetta agli spostamenti massimi.
Simulazioni numeriche condotte sulmodello globale Allo scopo di simulare la risposta glo-bale dell’edificio è stato realizzato un
modello tridimensionale dell’interastruttura con il software 3DMacro, ba-sato su un macro-elemento piano.4
Nel modello, limitatamente agli ele-menti di cui si è potuto ottenere ri-scontro, sono stati considerati anche irecenti interventi di miglioramento si-smico (fig. 12). In particolare, nelcorpo a sinistra dell’arco dei Fran-cesi, è stato modellato il nuovo telaioin cemento armato e l’effetto irrigi-dente conferito dai solai di nuova co-struzione (fig. 12).L’edificio risulta caratterizzato daun’ampia variabilità di spessori dellesezioni murarie e da una complessitàgeometrica non indifferente.Le proprietà dei materiali assunte allabase del calcolo sono: E=69kN/cm2, G=23 kN/cm2, st=0,005kN/cm2, sc=0,1 kN/cm
2, resistenzaa taglio t0=0,002 kN/cm2, pesospecifico w=1900 kg/m3. La variabi-lità nelle tipologie murarie riportatanella modellazione per macro-ele-menti è associata ai diversi spessorimurari. Il peso sismico dell’edificio èstato stimato pari a circa 60.500 kN.Sono state condotte analisi statichenon lineari, con distribuzione di forzeproporzionale alle masse, assumendoun punto di controllo per ciascuno deisolai, che sono stati considerati defor-mabili. Nelle due direzioni l’edificiorisulta caratterizzato da un coeffi-ciente di taglio alla base massimopari a circa 0,13 in direzione longitu-dinale e 0,18 in quella trasversale,ed un comportamento sufficiente-mente duttile (fig. 13).I meccanismi di collasso mostrano unadiffusione del danneggiamento piutto-sto estesa; tuttavia nella direzione lon-gitudinale prevalgono le rotture dellefasce di piano a tutti i livelli (in ac-cordo al quadro fessurativo effettiva-mente riscontrato), con rotazione deimaschi murari alla base, mentre in di-rezione trasversale il collasso avviene
Palazzo Gualtieri
32
4
Figura 8. Particolari dell’apparecchiatura costrut-tiva
Figura 9. Immagini della volta parzialmente crol-lata
Figura 10. Vista assonometrica del modello strut-turale ai macro-elementi
8
9
10
9
parte_4_Layout 1 16/01/12 00.09 Pagina 324
prevalentemente per rottura dei ma-schi murari del piano terra (fig. 14).Al fine di confrontare i risultati ottenutimediante analisi statiche non linearicon la risposta sismica dell’edificio alterremoto aquilano, è stata condottaun’analisi dinamica non lineare su unsistema elasto-plastico, ottenuto sullabase di un’equivalenza energeticacon la curva di pushover in direzionelongitudinale (più debole). Tale si-stema è stato quindi sottoposto all’ac-celerogramma XTE (componentetrasversale) registrato all’Aquila il 6aprile 2009. I risultati indicano chelo spostamento massimo registratonell’analisi dinamica non eccede lacapacità del sistema elasto-plasticoequivalente (fig. 15), a conferma delbuon comportamento sismico chel’edificio ha manifestato in termini dirisposta globale.
ConclusioniIl presente lavoro sintetizza l’attività diricerca orientata all’analisi della rispo-sta sismica di palazzo Gualtieri in se-guito al terremoto aquilano.Dopo una necessaria fase conosci-tiva, la ricerca ha avuto come obiet-tivo la giustificazione della buonaprestazione sismica globale dell’edifi-cio anche attraverso simulazioni nu-meriche basate sulla logica dellamodellazione per macro-elementi. I ri-sultati ottenuti sembrano indicare chegli approcci di modellazione permacro-elementi possono risultare effi-caci anche nelle valutazioni della vul-nerabilità sismica degli edifici acarattere storico-monumentale.
RingraziamentiGli autori ringraziano: l’ingegnere Vittorio Poli-dori per aver fornito il supporto necessario allaricostruzione dell’intervento di miglioramento si-
smico eseguito all’inizio degli anni Novanta delNovecento; l’ingegnere Lucia Milano per il pre-zioso supporto offerto con entusiasmo e conti-nuità; il Vice Commissario ingegnere LucianoMarchetti per le innumerevoli iniziative promossea sostegno della ricerca; i proff. Luigia Binda,Sergio Lagomarsino e Claudio Modena per l’in-sostituibile attività di coordinamento svolta congrande competenza e professionalità; i vigili delfuoco per la grande professionalità e per la cor-tese disponibilità offerta nel corso delle opera-zioni di rilievo.
note1 I. CALIÒ, M. MARLETTA, B. PANTÒ, A simplifiedmodel for the evaluation of the seismic behaviorof masonry buildings, Atti del Convegno 10th In-ternational Conference on Civil, Structural andEnvironmental Engineering Computing, (Rome30 August-2 September 2005), Paper no. 195,Editor: B. J. Topping.2 I. CALIÒ, F. CANNIZZARO, E. D’AMORE, M. MAR-LETTA, B. PANTÒ, A new discrete-element appro-ach for the assessment of the seismic resistanceof composite reinforced concrete-masonry buil-dings, Atti del Convegno 2008 Seismic Engi-neering International Conferencecommemorating the 1908 Messina and ReggioCalabria Earthquake (MERCEA’08), (Reggio Ca-
labria 8-11 July 2008).3 I. CALIÒ, F. CANNIZZARO, M. MARLETTA, A di-screte element for modeling masonry vaults, Attidel Convegno 7th International Conference onStructural Analysis of Historical Constructions,(Shanghai 6- 8 October 2010).4 I. CALIÒ, M. MARLETTA, B. PANTÒ, A simplifiedmodel for the evaluation of the seismic behaviorof masonry buildings, cit.
Edilizia storica civile all’Aq
uila
32
5
Figura 11. Curve di capacità e deformate a col-lasso: direzioni trasversale e verticale
Figura 12. Viste del modello geometrico e delmodello computazionale; mappa di colore per ladescrizione della variabilità degli spessori murari
Figura 13. Curve di capacità: direzione longitu-dinale e trasversale
Figura 14. Meccanismo di collasso in direzionelongitudinale, vista globale e del prospetto nord(in alto), e in direzione trasversale, vista globalee del prospetto ovest (in basso)
Figura 15. Analisi dinamiche non lineari sul si-stema elasto-plastico equivalente
12
13
11
14 15
parte_4_Layout 1 16/01/12 00.09 Pagina 325