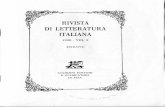F. BARELLO, La collezione numismatica di Carlo Alberto e le raccolte sabaude, in Il Medagliere del...
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of F. BARELLO, La collezione numismatica di Carlo Alberto e le raccolte sabaude, in Il Medagliere del...
Estratto da
il MedAGliere del PAlAZZo reAle di torino
StoriA e reStAUro dellA SAlA e delle ColleZioni
Volume Speciale (2013 - Serie VII)
FederiCo BArello
lA ColleZione nUMiSMAtiCA di CArlo AlBertoe le rACColte SABAUde
MiniStero dei Beni e delle AttiVità CUltUrAli e del tUriSMo©
Bollettino d’Arte
De Luca eDitori D’arte
taV. i
torino, palazzo reale, sala del medagliere
L’immagine è stata ripresa durante la mostra “Volti sovrani. Ritratti ducali su monetee medaglie al tempo della Sindone di là dai monti” (30 marzo 2010 – 30 gennaio 2011).
taV. iV
bologna, biblioteca comunale dell’archiginnasio
gabinetto dei disegni e delle stampe, fondo palagi:a) pelagio palagi: disegno dell’ornato centrale
della porta (n. 2715)b) pelagio palagi: disegno della parte bassa
della porta (n. 2716)
a
b
taV. Vi
torino, palazzo reale, sala del medagliere
gabriele capello detto il moncalVo su disegno di palagi: mobile a tempietto
taV. Vii
torino, palazzo reale, sala del medagliere
pietro ayres e diego marielloni: dipinti e stucchi della Volta
La foto è stata scattata dopo il riallestimento del Medagliere a seguito del restauro.
torino, palazzo reale, sala del medagliere
pietro ayres e diego marielloni: particolare della Volta con la musa erato (?)
taV. Viii
taV. iX
torino, palazzo reale, sala del medagliere
particolare dello scomparto centrale della Volta – pietro ayres: mercurio
taV. X
torino, palazzo reale, sala del medagliere, particolare della Volta
pietro ayres: le quattro parti del mondo, l’africa
taV. Xi
torino, palazzo reale, sala del medagliere, particolare della Volta
pietro ayres: le quattro parti del mondo, l’america
taV. Xii
torino, palazzo reale, sala del medagliere, particolare della Volta
pietro ayres: le quattro parti del mondo, l’asia
taV. Xiii
torino, palazzo reale, sala del medagliere, particolare della Volta
pietro ayres: le quattro parti del mondo, l’europa
taV. XiV
bologna, biblioteca comunale dell’archiginnasio, gabinetto dei disegni e delle stampe, fondo palagi, n. 1512pelagio palagi: fregio con putti e medaglie
taV. XV
torino, palazzo reale, sala del medagliere, particolare del fregio
pietro ayres ed ernesto contaValli: putto alato e ghirlande
taV. XVi
bologna, biblioteca comunale dell’archiginnasio, gabinetto dei disegni e delle stampe, fondo palagi, n. 2453pelagio palagi: progetto per una cartella d’ornato degli stucchi della Volta
taV. XVii
torino, palazzo reale, sala del medagliere
diego marielloni: cartella d’ornato degli stucchi della Volta
taV. XViii
torino, palazzo reale, sala del medagliere
diego marielloni: particolare degli stucchi della Volta
1 – torino, palazzo reale, sala del medagliere, particolare del fregiopietro ayres ed ernesto contavalli: putti alati che reggono una medaglia
48
La raccolta di monete fatta radunare tra il 1832 edil 1849 dal re di sardegna, Carlo Alberto savoia–Cari-gnano (figg. 1–19), è la più antica testimonianza mate-riale del collezionismo numismatico sabaudo giuntaintatta sino a noi.
La storia dei medaglieri di corte precedenti è carat-terizzata, infatti, da un buio profondo, appena rischia-rato, qua e là, da lampi di luce costituiti da sporadichenotizie sull’attività di ricerca di questo o quel perso-naggio per conto del suo signore. Di fatto, le origini siriallacciano strettamente alla definitiva sanzione ditorino come capitale e residenza permanente delduca con Emanuele Filiberto, rientrato in città al ter-mine dell’occupazione francese (febbraio 1563), e alparallelo nascere di un interesse collezionistico rivoltoalle antichità e ai prodotti artistici, finalizzato al pre-stigio di corte.
Già nel dicembre del 1560 è documentato un ordi-ne del duca di consegnargli, dietro pagamento, tutte«le midaglie d’oro o d’argento o d’altro metallo» chesi fossero rinvenute nel corso dei lavori per la costru-zione della cittadella di Vercelli:1) la raccomandazioneebbe un certo esito, poiché in un inventario del 1677viene citata
«una scatola di bosco con un piccolo Inviluppo di sopra, dettascatola e pachetto pieno di monete antiche, che si sono ritrova-te nel fondamento delle nuove fortificazioni di Vercelli».2)
L’interesse del duca verso tutti i generi di antichità ètestimoniato da doni, come quello di 163 «medagliedi mezzo rilievo» papali — da Lino, successore di Pie-tro, a Pio IV oppure V (saliti al soglio rispettivamentenel 1559 e nel 1566) — fattogli il primo gennaio 1572dal medico francese di corte, anch’egli collezionista,Ludovic Demoulin de Rochefort (Blois 1515 – Basilea1582).3) Quest’ultimo aveva soggiornato a Padova peri suoi studi e qui si era fatto ritrarre intorno al1549/15504) dal medaglista Giovanni da Cavino(1500–1570), famoso per la sua ampia produzione dieccellenti imitazioni dei bronzi romano–imperiali.5)
nell’ambiente patavino operavano in quel momentoeruditi e collezionisti di antichità e monete come Ales-sandro maggi da Bassano (Alessandro Bassiano, 1508circa–1587), ritenuto il maggior committente dei falsidel Cavino, e Alessandro mantova Benavides(1489–1582).6) Il primo gareggiò con il suo mentore,il cardinale Pietro Bembo, per ricchezza e conoscenzadella propria raccolta di monete; il secondo, giurista eumanista, fu soprattutto collezionista di antichità.7)
Indicatori rilevanti sono, inoltre, gli acquisti che icorrispondenti sabaudi effettuarono a Roma e Vene-
zia: sopravvivono documenti sulla compera della col-lezione del «diamantaro» veneziano Rocco zanettoscarizza nel 1573, comprendente anche «80 medagliedi bronzo»,8) e l’invio da Roma di una grande collezio-ne da parte del canonico Orazio muti nel 1574, nellaquale erano comprese 2.027 «medaglie»,9) acquisizio-ne che fu poi completata con altre 300 nel 1583, sottoCarlo Emanuele I. Questi, ancora giovane principe,aveva ricevuto in dono da Orazio muti, nel 1577,dieci «medaglie di bronzo» e altre quattro «non trivia-li ne vulgari» nel 1578, mentre Rocco zanetto gliaveva inviato nell’aprile 1580 «una scatola di meda-glie d’argento, in numero di circa 300, la maggiorparte antiche».10)
Evidentemente, il materiale da collezione potevaessere anche ottenuto al di fuori dei canali del com-mercio antiquario, come il tagliapietre Pietro AntonioVanello, cui furono corrisposti 10 scudi nel 1590 per«certe medaglie antiche parte di metallo et parte d’ar-gento che gli furono consegnate da un pover homosuo amico»,11) mentre Roma restava il centro principa-le di ricerca per eventuali pezzi rari, come la «meda-glia di timoleone», ambita nel 1620.12)
I contatti con l’ambiente antiquario di Roma,mediati dagli ambasciatori, comprendevano anchepersonaggi come Domenico Compagni, medaglista eincisore di cammei papale, nonché attivo restauratoree commerciante di monete antiche negli anni ’80 delXVI secolo:13) di queste doveva essere in grado di pro-durre delle imitazioni, come risulta dall’inventario deisuoi conî, per lo più riproducenti monete greche oromane, venduti da un suo erede al cardinale Ferdi-nando de’ medici.14)
Il legame tra personaggi di questo tipo e l’attività dizecca — che nel caso specifico sarebbe interessantevalutare ricostruendo il grado di parentela tra il Com-pagni e scipione de Comitibus, zecchiere per Paolo IIIa Camerino nel 1546 —15) risulta molto bene evidentenel caso di Alessandro Cesati detto il Grechetto, origi-nario di Cipro ma vissuto quasi sempre a Roma, dove,grazie all’amicizia con Annibal Caro, fu introdotto allacorte dei Farnese. Fu «incisore e maestro delle stam-pe» alla zecca, a partire del 1540, e lavorò anche inquella di Parma per Ottavio Farnese, tra il 1557 ed il1559.16) nel 1561 si recò a torino, ingaggiato il 10dicembre di quell’anno come «generale intagliatorede’ cugni delle monete che in tutte le zecche de nostristati tanto di qua quanto di là de’ monti si batterannoe stamperanno».17) ma il Cesati non era giunto in Pie-monte da solo, come siamo informati grazie ad una
49
FEDERICO BARELLO
LA COLLEzIOnE numIsmAtICA DI CARLO ALBERtO E LE RACCOLtE sABAuDE
lettera del 31 agosto 1561 di Annibal Caro per l’archi-tetto militare del duca di savoia, il perugino France-sco Paciotto, dove si annuncia che «messer Alessandroe mario si vanno spedendo per venire a trovarvi»:18)
questo mario è, con ogni evidenza, mario d’Aluigi,detto Perugino, che sarà orefice ducale per EmanueleFiliberto (2 maggio 1562), poi guardia alla zecca ditorino (22 gennaio 1567) ed infine maestro nelle zec-che di nizza, torino, Vercelli, Aosta, Asti, in momentidiversi e ancora sotto Carlo Emanuele I (1576–1584,1588–1589).19) suo figlio Ludovico proseguirà l’atti-vità di orefice in torino, e coprirà anche l’incarico di«guardia di zecca».20) una lettera di un torinese con-temporaneo (1574) definisce mario Romano «creatu-ra» di Alessandro Greco,21) lasciando intendere che nefosse discepolo, e in tale ottica si comprende bene larichiesta di Annibal Caro al d’Aluigi di inviargli dellemedaglie «del fatto vostro», dal momento che già ilCesati gli aveva fatto pervenire
«un par di medaglie per antiche, molto belle e con unabella vernice. ma in vero credo che sieno moderne, perchéla vernice mostra d’esser fresca» (7 ottobre 1564):22)
dunque entrambi producevano false monete antiche,e del resto nella medesima lettera si richiedono anchecopie fuse da realizzarsi da parte del d’Aluigi calcandomonete originali, eventualmente da ricercarsi pressosua Altezza, dal momento che il Caro aveva rivenduto leproprie.23) Proseguendo su questo filone si può inoltrecitare il cremonese Belisario Cambio detto Bombarda,scultore del duca di savoia dal 1587, incisore dei conîalla zecca di torino tra 1588 e 159024) e in seguito perVincenzo I Gonzaga duca di mantova, per il quale rea-lizzò anche delle medaglie,25) che un documento del1575 ci fa scoprire anche imitatore di monete antiche,citandolo per un aureo dell’imperatore Didio Giuliano.26)
In che misura, dunque, in questi primi embrioni dimedaglieri alle monete antiche potessero esseremescolati esemplari creati ad hoc, coniati o fusi daquesti personaggi, od altri,27) per accontentare unadomanda sempre crescente di antichità, non è possi-bile dire, essendo essi per noi irrimediabilmente per-duti, ma certo la fitta trama che legava zecchieri emedaglisti al mercato antiquario fa pensare che i falsidovessero essere presenti in quantità rilevante.
50
2 – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIEREGABRIELE CAPELLO DEttO IL mOnCALVO: mOBILE A tEmPIEttO COn CAssEttI EstRAIBILI
E mOBILE DA CEntRO COn LE ALEttE APERtE, ChE AmPLIAnO LA zOnA DI LAVORO PER GLI stuDIOsI
se a Emanuele Filiberto è strettamente legato ilprogetto di una biblioteca/museo noto come TeatroUniversale di tutte le Scienze,28) al figlio, Carlo Ema-nuele I, si unisce indissolubilmente il progetto decora-tivo e la realizzazione della Grande Galleria, quellamanica di passaggio che univa la residenza ducale alCastello e che, secondo le intenzioni del duca, tra il1587 e il 1608 venne trasformata in biblioteca e luogodi raccolte d’arte e di storia naturale grazie all’inter-vento di numerosi artisti e decoratori:29)
vi «raccolse (...) molti oggetti appartenenti ai tre regni distoria naturale; i saggi dei marmi che a quel tempo siestraevano dalle cave del Piemonte; vi pose una biblioteca,una collezione di medaglie, di armature e di anticaglie»,30)
ma non è chiaro se vi fosse ospitato il medagliere.Indubbiamente, la presenza di testi di numismaticanella biblioteca, che comprendeva una coppia diarmadi, l’undicesima e ultima verso il palazzo nelladescrizione di un inventario del 1659, dedicata a Pic-tura Scultura Antiquitates, fa supporre che alcunemonete antiche potessero trovare spazio nelle medesi-me guardarobe.31) nella Recognizione o sia Inventarode’ libri ritrovati nelle Guardarobbe della Galleria diS.A.R.le doppo la morte del S.r Protomedico Boursier fattain marzo 1659 dal S.r Protomedico Torrini e S.r Secreta-rio Giraudi d’ordine di S.A.R. è possibile riconoscerel’opera dell’incisore e numismatico olandese hubertGoltz (1526–1583):32) infatti l’armadio di levante con-servava nella prima scansia il Caesar Augustus e nellaquarta il Julius Caesar del celebre studioso,33) che viaveva raccolto il frutto della sua instancabile ricerca dimonete romane presso centinaia di raccolte in tuttaEuropa.34) Dello stesso autore nella quarta scansia erail Thesaurus epigrafico,35) mentre più incerto è il titolooriginale del volume che venne registrato nella terzascansia come Viri in Romanorm numismata,36) probabil-mente una delle tante raccolte iconografiche che fiori-rono nella letteratura numismatica cinque–seicente-sca, a partire dalle Illustrium Imagines di AndreaFulvio (Roma 1517) sino all’Historia Augusta di Fran-cesco Angeloni (Roma 1641).37)
Intorno al 1608 si era alla ricerca, per la bibliotecaducale, del De asse et partibus ejus dello studioso fran-cese Guillaume Budé (Parigi 1514),38) che per lungotempo rimase un caposaldo nel campo della metrolo-gia monetale.39)
Che il medagliere ducale fosse strettamente connes-so alla biblioteca appare evidente dalla richiesta daparte di Vittorio Amedeo I, nel 1633, di un biblioteca-rio che «s’intenda anco di statue et di medaglie»,40) maquesto non significa che la raccolta numismatica fossecostituita da un unico nucleo fisicamente associatoalla libreria. non è chiara la misura con la quale gliincendi che colpirono la Galleria nel 1659 e nel 1667ci hanno privato di elementi per conoscere esatta-mente la consistenza delle collezioni ivi radunate.41)
una serie di inventari seicenteschi permette, tutta-via, di riscontrare l’esistenza di raccolte conservatenelle stanze private dei duchi.42) nell’aprile del 1631venne redatto un inventario delle monete «ritrovate
nella Guardarobba di s.A.R. doppo il ritorno di m.R.dalla savoia»:43) dunque la collezione di Carlo Ema-nuele I fu fatta verificare dopo la sua morte (luglio1630) da Cristina di Francia, rientrata a torino all’e-saurimento dei pericoli della guerra e della peste. Lemonete si trovavano nel «Palazzo dietro s. Giovanni»ed erano in custodia di un certo signor Alamandi e diun tappezziere.44) In effetti sul lato settentrionale delvecchio palazzo ducale, detto «di s. Giovanni»,45)
accanto alla stanza di san Lorenzo, camera da letto diVittorio Amedeo I, era il “Gabinetto degli stucchidorati”
«così chiamato dalle decorazioni della volta; sulle paretiinsieme a dipinti stavano delle carte geografiche; sopra letavole, armadietti e piccoli scaffali, si conservavano inge-gnosi lavori fatti con legni forestieri, tartaruga, madreperla,ecc., parecchi libri e medaglie».46)
Attiguo al “Gabinetto degli stucchi” era il “museo”,il cui nome «indica quale ne fosse la destinazione».47)
La nota elenca diversi tipi di contenitori (scatole, cas-sette, scrittorî, laiette, borse, involucri) con le rispetti-ve quantità di medaglie, non sempre in modo preciso,
51
3 – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIEREGABRIELE CAPELLO DEttO IL mOnCALVO: mOBILE A tEmPIEttO
COn CAssEttI EstRAIBILI COntEnEntI mEDAGLIE RInAsCImEntALI
e raramente specificandone il tipo. tirando le sommesi hanno poco più di 11.000 esemplari, di cui 471sono specificati come antichi, 1.481 di Casa savoia, 96con l’arma di saluzzo, cui va aggiunto il contenuto di127 «viluppi di carta con diverse medaglie parte d’ar-gento, parte di metallo e alcune d’oro» e di 373«viluppi di medaglie antiche».48) Difficile capire cosasiano le 140 «medaglie doppie cornisate», le 5 «meda-glie d’argento piccole con le cornici d’ossa» e le 274«medaglie piccole ligate in osso parte bianco e partenegro», ma sembra di capire che fosse in uso incasto-nare le monete o medaglie in cornicette d’osso.
In ogni caso, il principe conservava immediatamen-te accanto ai suoi appartamenti i beni privati che con-siderava più significativi o preziosi, e tra questi, quelloche doveva essere, viste le proporzioni, il medagliereducale più ricco.
Esistevano altre forme di raccolta di materialenumismatico, come nel caso di «un’urna rota piena dimedaglie» citata, insieme ad una congerie di altrioggetti, da un inventario dell’epoca di Emanuele Fili-berto all’interno di un gabinetto «serrato» non più
individuabile,49) oggetto che fa addirittura pensare adun ripostiglio monetale ancora conservato con il con-tenitore originale; era accompagnato, tra l’altro, da
«una borsa (...) con molti vilupi di medaglie di Piombo emetallo, tre scatole con alcune medaglie di Bronzo e Piombo,una sacheta di tella con alcune medaglie antiche dentro»,
mentre in altri due gabinetti sono citati«una cassetta ove sono dentro alcune stampe di medaglie
et altri ferri, una tasca con alcune stampe di monete, unacon alcune mostre di monete false, una tascha piena dimedaglie, la bilancia come si usa in zecha, una scatola senzacoperchio con alcune medaglie».50)
Ancora una volta il raccogliere le monete si ricolle-ga, oltre che alle collezioni d’arte ed all’erudizionestorica, all’attività di zecca, luogo ove andavano natu-ralmente a radunarsi le monete ritirate dal corso equelle false, esercizio che in questi ricetti di materialieterogenei è testimoniato dalla presenza di conî edaltri strumenti, nonché di una bilancia.51)
un’altra raccolta minore, conservata nello «scritto-rio» di Carlo Emanuele II, venne inventariata dopo lasua morte (avvenuta nel giugno 1675): insieme a chia-vi, gioielli ed oggetti religiosi sono mescolate, neitiretti del mobile, monete e medaglie antiche emoderne. Come al solito, le definizioni generiche del-l’elenco non consentono di cogliere esattamente ilsignificato dell’insieme, che comprendeva 64 «meda-glie antiche», 38 «medaglie, un Ducatone, una livra,un quarto di livra, uno soldo, uno dà trè grossi et undinaro, (...) una moneta come un Du.ne dorata, mone-te d’arg.to n° nove».52)
Le collezioni ducali dovettero comunque incomin-ciare a costituire il principale termine di riferimentodegli studiosi, dal momento che lo storiografo dicorte samuel Guichenon (mâcon 1607 – Bourg 1664)citò «le cabinet de s.A.R.», insieme alla Grande Galle-ria, come fonte documentaria principale per la suaHistoire généalogique de la Royal Maison de Savoye,pubblicata a Lione nel 1660 con numerose illustrazio-ni di monete e sigilli.53)
mancano i documenti che consentano di seguire l’e-voluzione delle raccolte: un ulteriore inventario delmedesimo guardaroba54) fu fatto compilare da mariaGiovanna Battista di savoia–nemours nel marzo del1677, durante la reggenza per Vittorio Amedeo II,allora decenne, ma non è possibile raffrontarlo conquello del 1631, dal momento che elenca solo lemonete meno preziose, lasciate nell’armadio sotto lacustodia di Pietro Giofredo, «bibliotecaro de’ libridella Real Corona»: non è chiaro quale sia stato ildestino di quelle d’oro e d’argento, evidentementeconservate altrove, e che già nel 1631 erano sotto lacustodia del tappezziere, allora figura gerarchicamen-te importante tra i cortigiani.55) manca un conteggiopreciso di tutti gli esemplari: da sottolineare la pre-senza, oltre delle già citate monete antiche rinvenutea Vercelli, di un «inviluppo di medaglie di rame nuo-vamente trovate à trino» e di alcuni gruppi di «meda-glie di rame» con cornici d’osso.56)
52
4 – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIEREGABRIELE CAPELLO DEttO IL mOnCALVO: mOBILE A tEmPIEttO
COn CAssEttI EstRAIBILI COntEnEntI LE mOnEtE
53
5 – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIEREGABRIELE CAPELLO DEttO IL mOnCALVO: CAssEttO EstRAIBILE DEL mOBILE A tEmPIEttO
COntEnEntE mEDAGLIE RInAsCImEntALI
54
6a–b – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIEREsEstERzIO In BROnzO DI nEROnE COn sCEnA DI DECuRsIO suL ROVEsCIO (ROmA, CIRCA 64 D.C.), InV. D.C. 9159
a b
a b
7a–b – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIEREsEstERzIO In BROnzO DI nEROnE COn sCEnA DI DECuRsIO suL ROVEsCIO, InV. D.C. 9158
Si tratta ad evidenza di un falso fuso, tratto per calco da un esemplare originale.
8a–b – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIERE – sEstERzIO In BROnzO DI nEROnE, InV. D.C. 9209
Imitazione moderna attribuita a Giovanni da Cavino, il Padovano (Padova 1500–1570).
a b
9a–b – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIERE – REGEnBOGEnsChüssELChE, COPPEttA DELL’ARCOBALEnOO stAtERE D’ORO DELLA VInDELICIA (II sECOLO A.C.), InV. D.C. 17461
Al diritto testa di uccello verso sinistra e al rovescio sei globetti contornati da torques.
tutte queste serie sono accomunate da un interesseantiquario e storico–dinastico che le fa associare adaltri materiali eterogenei (libri, esemplari di storianaturale, oreficerie, opere di glittica),57) tanto daricordare maggiormente le eclettiche aggregazionidelle Wunderkammern tardo–rinascimentali,58) piutto-sto che far pensare a veri e propri medaglieri dove siesercitasse uno studio numismatico rigoroso. A titolodi esempio ci si chiede in che cosa potesse consisterela cosiddetta “borsa di nerone” menzionata dall’in-ventario del protomedico Giulio torrini del 1659 inuna stanza al di sotto della Grande Galleria.59) Conte-neva delle monete antiche?
nella cerchia di corte l’esempio ducale doveva esse-re seguito da altri che s’adoperavano per mettereinsieme raccolte significative,60) come la contessa diVerrua, Jeanne–Baptiste d’Albert de Luynes (Parigi1670–1736),61) che a Ginevra, con l’intermediazionedel priore Francesco Antonio Renzi, aveva acquistatoparte dell’importante medagliere milanese del conteFrancesco mezzabarba Birago (Pavia 1645 – milano1697), disperso nel 1698. Il figlio di questi, GiovanniAntonio (milano 1670–1705) — padre somasco cheproseguì nel progetto di studi antiquari–numismaticidel padre, definito da Lodovico Antonio muratori«pratichissimo dell’erudizione antica» —,62) stava pre-parando il catalogo della collezione della contessaquando questa, già favorita di Vittorio Amedeo II,fuggì improvvisamente da torino in Francia (4 otto-bre 1700), portando via i suoi tesori.63) nel 1683 erastata presentata a Vittorio Amedeo II la riedizione ita-liana, edita a milano a cura dello stesso Francescomezzabarba, del celebre volume del medico tedescoAdolf Occo, Imperatorum Romanorum Numismata aPompeo Magno ad Heraclium (Anversa 1579).64)
L’impostazione “meravigliosa” delle raccolte ducalisi riflette ancora nel momento in cui le collezioni pas-sano dalla sfera puramente privata del sovrano a quel-la pubblica: si veda il progetto per l’ordinamento delnuovo museo dell’università, commissionato da CarloEmanuele III, redatto e consegnato il 2 aprile 1739
dal professore di anatomia Giovan Battista Bianchi.Dei cinque «scompartimenti» che lo costituiranno, iprimi quattro saranno di fisica, matematica, botanicae anatomia, il quinto conterrà «una raccolta di oggettidiversi, rari o preziosi, sicché riesca come una Cameradi Curiosità, ossia di Comune Galleria»,65) con «simu-lacri, ed Impronti, cioè statue, idoli, Amuleti, Votidegli Antichi, e medaglie, monete, Camei, talismani,sigilli, Divise».66)
nel 1746 fu dato incarico «di ordinare le coseappartenenti all’antichità, le quali già erano state rac-colte a spese dell’università, ovvero regalate dal Re» alpadovano Giuseppe Bartoli, che dal 1745 teneva lacattedra di eloquenza italiana e lettere greche.67) tra imateriali esposti l’anno successivo in una stanza dellabiblioteca vi erano «alcune centinaia di medaglied’oro e d’argento, molte migliaia di bronzo donate dalRe insieme con parecchi camei ed antichi eccellentiintagli».68) Vennero realizzati due medaglieri, con 216e 76 piani scorrevoli rispettivamente, collocati a pianoterreno, nel «salone delle antichità minute e dellemedaglie»,69) e da tale collezione trarrà spunto il Bar-toli per la sua fantasiosa esegesi della celebre TazzaFarnese di napoli, esposta in 1300 versi accompagnatida alcune immagini esplicative di monete.70)
È probabile che molte delle monete antiche elargiteda Carlo Emanuele III provenissero dalle raccolte deisuoi predecessori sopracitate. non è chiaro dove que-ste fossero conservate: le commissioni reali all’ebani-sta di corte Pietro Piffetti non consentono di identifi-care con certezza dei mobili di pregio con questadestinazione. L’armadio–medagliere intarsiato, oranella camera del re alla Palazzina di caccia di stupini-gi, è stato recentemente riportato al «coffano fortetavolino» per l’appartamento di Elisabetta di Lorena atorino, saldato nel 1737, destinato probabilmente allegioie della regina.71) Di altri due «coffani forti» uno,pagato nel 1734, è stato individuato a Palazzo Reale,ma un inventario napoleonico (1805) lo cita comescrittoio–biblioteca,72) mentre l’altro, «tutto di nocecon placcaggi di mettallo», pagato nel 1763, potrebbe
55
a b
essere stato riservato alla collezione di monete moder-ne cominciata nel 1755 (vedi infra), e non è più rin-tracciabile.73)
I «due medaglieri coll’ossatura di noce impeliciati d’acia-ro di Calabria, cad.no con otto tavole amovibili a forma ditiretti per riporvi midaglie et altro»,
ordinati nel febbraio 1739 e pagati nel giugno dellostesso anno,74) non potevano essere dei mobili d’arre-do, dato il bassissimo prezzo (21 lire e 5 soldi), e furo-no forse destinati al trasporto della collezione. Benaltra cassetta fu quella commissionata a Luigi Prinottonel 1730 per contenere le 318 medaglie con episodidella vita del Re di Francia, Luigi XIII, intarsiata inavorio e madreperla, oggi al museo Civico di torino,pagata 1.100 lire.75)
Il rapporto con l’entourage di corte proseguì anchedopo la creazione del museo, come mostra il dono diCarlo Amedeo Battista di san martino d’Agliè, dettoil marchese di Rivarolo, per tramite di Carlo France-sco Vincenzo Ferrero di Roasio, marchese d’Ormea,nel 1740. Purtroppo, la lettera che accompagnò lacassetta non specifica né il numero né la natura dellemolte medailles offerte al sovrano.76) Il Rivarolo eragovernatore di novara dal 1738, dopo essere statogovernatore di nizza (1733) e vicerè di sardegna(1735);77) l’Ormea era Primo segretario di stato pergli affari interni ed esteri e notaio della Corona.78) Lelamentele del primo sulla mancanza di una personaadatta al riordino della collezione reale dovetterocomunque trovare una qualche soddisfazione con lanomina, qualche anno dopo, del Bartoli come anti-quario regio.
Con motivazioni del tutto differenti nacque, invece,una seconda e più celebre serie commissionata daCarlo Emanuele III, quella delle monete sabaude editaliane. La riforma della monetazione del regno,bandita nel febbraio 1755, rese infatti necessario veri-ficare la qualità delle monete anteriori, andate fuoricorso, per fissarne il cambio, così come di quelle stra-
niere.79) Il cavalier Carlo Filippo morozzo fu incarica-to dunque di raccogliere una campionatura degliesemplari che confluivano alla zecca di torino dalletesorerie provinciali per essere fusi; fu presto affianca-to dal conte Risbaldo Orsini di Orbassano e dall’abateFrancesco Ludovico Berta,80) bibliotecario dell’univer-sità, nonché dal barone Giuseppe Vernazza di Freney,importante figura di studioso e numismatico,81) chia-mato a collaborare alla segreteria di stato. si incaricòinoltre l’ambasciatore del Regno di sardegna a Romadi fare in loco ricerche di monete sabaude e pontifi-cie, che produssero, tuttavia, scarsi risultati. Dopo lamorte di Carlo Emanuele III, solo nel 1782 VittorioAmedeo III fece riprendere le indagini, questa voltaperò più indirizzate ai documenti d’archivio relativialle coniazioni sabaude che all’incremento della colle-zione numismatica, custodita dal tesoriere reale.82) nefu incaricato Clemente Alessandro Carlevaris, che sifece aiutare dagli avvocati stefano e Giuseppe Darbe-si, cui subentrò, nel 1787, il conte Gian Francesco
56
10a–b – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIEREDuPOnDIO In BROnzO DELL’ImPERAtORE PuBLIO hELVIO PERtInACE (ROmA, 193 D.C.), InV. D.C. 11579
Al diritto l’imperatore con corona radiata, simbolo del Sole, al rovescio personificazione della Provvidenza degli dei.Presente nella collezione in numerosi esemplari in quanto unico imperatore romano cui sia attribuita una nascita piemontese.
11 – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIEREFRAzIOnE DI sILIQuA In ARGEntO AttRIBuItA
AL RE LOnGOBARDO PERtARItO (672–688), InV. D.C. 2128
Al diritto monogramma PE(rctaritus) R(e)X.
a b
Galeani napione di Cocconato, altra figura di riferi-mento nel campo degli studi subalpini. Fu in queltempo acquisita la collezione privata dell’abate Berta,dopo la morte di costui (1787), composta da «monetedei bassi tempi, ricca di cose d’Italia e straniere», dellacui classificazione fu incaricato il Vernazza.83)
una grave dispersione si ebbe nella contingenzadell’occupazione francese. Carlo Emanuele IV si fececonsegnare dal talpone le monete d’oro e d’argento,insieme, evidentemente, ad altri valori:84) è il momen-to della resa (8 dicembre 1798). Il giorno successivo ilre partì per l’esilio, in sardegna, a Cagliari. Le mone-te non tornarono più a torino, così come il loro pro-prietario. Quello che era rimasto della collezione, cioèle monete «in biglione e in rame ed i ponzoni di zeccao conj di monete», era stato consegnato, per ordinedel governo provvisorio piemontese, dai talponeall’università di torino (19 febbraio 1799), mentre ilnapione aveva là riversato ciò che era in suo possesso,cioè i documenti d’archivio, più le monete che egliaveva personalmente acquistato per conto del re equelle acquisite dal Vernazza. Dall’università il mate-riale passò poi agli Archivi Reali, dove, dopo la restau-razione, Carlo Felice aveva ordinato (1823) di prose-guire la raccolta: siamo a conoscenza un acquisto di«alcune monete antiche» per 1.500 lire nell’agosto del1830.85) non è chiaro dove siano confluiti monete,coni e punzoni,86) ma certo dovettero trovare unanuova collocazione durante la risistemazione comple-ta degli archivi, condotta da Giorgio Fea e michelenegri tra 1820 e 1839, dopo gli sconvolgimenti pro-dotti dalle manomissioni francesi.87)
Quello che risulta evidente è che continuava a nonesistere un luogo univoco destinato alla conservazionedella collezione numismatica reale, né una figura isti-tuzionale deputata alla catalogazione, allo studio e alsuo incremento. I nuclei sono molteplici, e in conti-nuo spostamento, con riduzioni e accrescimenti legatia circostanze casuali. Questa situazione cambiò radi-
calmente con la salita al trono di Carlo Alberto diCarignano, e soprattutto dall’incontro tra il nuovo reed un cultore degli studi storici quale Domenico Casi-miro Promis (torino, 1804–1874).
Assunta la corona nell’aprile del 1831, un annodopo ebbe con il ventottenne Promis una conversa-zione risolutiva, così raccontata dal biografo di que-st’ultimo:
«Il Re [...] lo fece chiamare a sé. Ebbe luogo un lungo col-loquio, che valse al Promis quanto un rigoroso esame. Il Refu contento del suo candidato e gli manifestò il desiderio difar acquisto della sua collezione numismatica. Esitò il Pro-mis, che non sapeva spogliarsi di oggetti a lui tanto cari eche gli costarono fatiche, privazioni e studi; ma all’insisten-za del Re cedette a patto che lo nominasse conservatoreonorario, senza stipendio, per continuare ad amplificarlo.Era però per non staccarsi tutto ad un tratto da ciò chetanto amava. Carlo Alberto accettò e lo stupendo medaglie-re ebbe origine in questo modo l’anno 1832».88)
Il compenso venale ricevuto dal Promis per la suacollezione, sinora sconosciuto,89) ci viene riportato dallacontabilità privata di Carlo Alberto: il 26 aprile 1832vennero corrisposte a Promis 8.000 lire per «una seriedi monete e di medaglie della savoja e del Piemon-te».90) Vale la pena sottolineare che lo studioso vieneancora definito «Cassiere della Regia zecca di tori-no»,91) e non ancora «Conservatore delle medaglie dis.m.», come risulta invece nel successivo pagamentodel 20 gennaio 1833, per 1.504 lire «in soddisfazione dimedaglie presentate alla m.s. nello scorso anno e collo-cate nel suo medagliere».92)
Dunque, dopo aver valutato la collezione di Promis,la sua catalogazione e gli studi da lì scaturiti — comerisulta dalla lettera indirizzata da Cesare saluzzo dimonesiglio93) a Carlo Alberto il 18 aprile 1832, recen-temente pubblicata —,94) il re provvide a pagarlo e,subito dopo, a nominarlo, come richiesto, Conserva-tore del Regio medagliere. ma nell’immediato furonoprese in considerazione solo le monete sabaude e pie-
57
12a–b – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIEREGROssO D’ARGEntO DI FILIPPO D’ACAJA (tORInO, 1297–1301), InV. D.C. 658
Al rovescio la croce doppia accantonata dalle iniziali PhIL. Prima emissione conosciuta della Zecca di Torino,affidata nel 1297 allo zecchiere Durand Carriere.
a b
nianza esemplare in questo senso si rivela la questionerelativa alle monete con legenda mARsACOnA. si trattadi due serie parallele di denari del XII–XIII secolo,ben note ai numismatici piemontesi per la frequenzacon cui venivano rinvenute nel territorio della regio-ne: sappiamo che all’inizio del 1832 alcuni esemplarierano conservati nel medagliere reale, pur nell’incer-tezza su quale fosse la zecca che li aveva prodotti.98)
ma quando Promis ebbe modo di occuparsi della que-stione, decidendo per un’attribuzione alla cittadinafrancese di marsanne,99) decretò in qualche modoanche la sorte di quelle monete, le quali, in quantonon italiane, furono espunte dal medagliere.100) Altreserie antiche rinvenute nel territorio piemonteseentrarono, invece, stabilmente nella collezione reale:le cosiddette Regenbogenschüsselchen, ovvero «coppet-te dell’arcobaleno», monete celtiche d’oro, battuteprobabilmente in Vindelicia (odierna Baviera) e forseportate dai Cimbri durante la loro invasione dell’Ita-lia (101 a.C.), donde la frequenza di rinvenimenti nelvercellese,101) e le cosiddette «mezze silique di Pertari-to», monetine argentee longobarde rinvenute in gran-de quantità in un ripostiglio a Biella nel 1833, riposti-glio in gran parte acquisito da Promis stesso.102)
L’incremento della raccolta procedette sempre inmodo regolare: i rimborsi a Promis per monete,medaglie o sigilli da lui comperati, sempre attingendodai fondi personali del re, sono documentati nelConto del tesoriere privato di S.M.103) A partire dal1837, quando Promis fu nominato Regio Biblioteca-rio,104) nelle registrazioni insieme alle monete sonoquasi sempre comprese anche le acquisizioni dilibri.105) nel 1844 furono procurati i dischetti d’ossoutilizzati per separare le singole serie all’interno dellecassettiere dei mobili del medagliere.106)
Anche nel difficile periodo tra 1848 e 1849 Promiscontinuò a fare acquisti, che gli vennero regolarmenterimborsati, sia pure con qualche ritardo.107)
Grande sforzo fu rivolto alle acquisizioni dirette diimportanti collezioni, come quelle del conte Orti diVerona, nel 1834,108) e del conte Pietro Gradenigo diVenezia. La prima va ricondotta a Giovanni GirolamoOrti manara (1803–1858), storico, antichista, cavalie-re dell’ordine dei santi maurizio e Lazzaro di sarde-gna, conservatore del Lapidario maffeiano, direttoredel giornale Il Poligrafo, il quale, negli anni ’20, si eracimentato in qualche breve saggio numismatico infar-cito di erudizione antiquaria.109)
La vendita della seconda fu oggetto di diverse tratta-tive, condotte in torino per intermediazione di PierAlessandro Paravia (zara 1797 – torino 1857), professo-re di eloquenza all’università dal 1832, amico di fami-glia dei Gradenigo, come apprendiamo dall’epistolariocon la madre e la sorella. Già nel 1833 scrive che
«l’abate Gazzera ha scorso il catalogo delle medaglie de’nostri Gradenigo, e ne trovò la raccolta assai pregevole; miconsigliò di parlarne al Cav. saluzzo, e lo farò presto e contutto il cuore»:110)
vengono coinvolti dunque personaggi di primopiano nel milieu culturale subalpino, quali l’abate
58
13 – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIEREJEAn mAREnDE: mEDAGLIA PER FILIBERtO II DI sAVOIA
E mARGhERItA D’AustRIA (1502), InV. D.C. 5601
Il campo è riempito da nodi sabaudi e margherite, simboli dei duepersonaggi. Il duca è rappresentato in abiti civili, come nei
modelli regali francesi. Copia in argento smaltato dell’originalein oro, realizzata a bassorilievo per ricevere la smaltatura
e priva del rovescio.
montesi. In un secondo momento venne acquistatoanche il resto della collezione, che era stato, comun-que, già depositato nel gabinetto numismatico, inattesa, evidentemente, che ne fosse stimato il valore.
Che l’interesse prevalente fosse di tipo storico–dina-stico, nel quadro delle iniziative di politica culturalepromosse da Carlo Alberto, è palese nelle tre missioniin stati esteri di cui furono incaricati Promis stesso eLuigi Cibrario, tra il 1832 ed il 1834, alla ricerca didocumenti utili alla ricostruzione della storia sabau-da:95) durante il primo di questi viaggi furono raccol-te 40 monete di cui mancava un corrispettivo nelmedagliere.96)
Dall’originaria collocazione, sconosciuta, la colle-zione di monete e medaglie verrà poi definitivamentecollocata nella sala predisposta tra la galleria Beau-mont dell’Armeria Reale e il Gabinetto delle lacchecinesi,97) affrescata da Pietro Ayres tra il 1835 e il 1837e dotata di quattro armadi appositamente disegnatida Pelagio Palagi per contenere i preziosi oggetti, rea-lizzati dal minusiere Gabriele Capello detto moncal-vo. Questi ne realizzò altri sei tra il 1843 e il 1846.
A Promis dovette essere lasciata carta bianca nellescelte e nell’ordinamento dell’insieme di monete,medaglie e sigilli, quale è giunto sino a noi: testimo-
Costanzo Gazzera, segretario dell’Accademia dellescienze, e Cesare saluzzo, segretario dell’AccademiaAlbertina e direttore dell’Accademia militare. L’annosuccessivo, nel mese di giugno,
«sarà a Venezia il mio amico Cavalier Cibrario col signorintendente Promis (…); non sarà male che gli presentiate alConte Gradenigo, perché veggano il suo museo e possanopoi informarne il signor Laris»:
quest’ultimo è il collezionista e direttore della zeccaFilippo Lavy (torino 1775–1851) che deve essere“invogliato”, ma che risulta poi, definitivamente(dicembre 1834) «essere alieno dal noto acquisto; lospaventa il prezzo».111) nel 1836 Paravia mette inguardia gli amici dall’interesse del numismatico pari-gino Rollin, dal momento che
«il signor Promis non crede che il conte Gradenigo possafare un buon negozio con m. Rollin, che è un puro specula-tore; avvisatene il n… perché si regoli».112)
una nuova visita viene poi raccomandata per ilconte Giulio Cordero di san Quintino
«illustre letterato e mio stimatissimo amico, che a fine novem-bre 1838 sarà a Venezia: procurate di agevolargli il modo divedere il museo Giustinian sulle zattere, e Gradenigo».113)
L’acquisto per Carlo Alberto ebbe luogo in duemomenti distinti: nel 1834, evidentemente su iniziati-va di Promis, si provvide ad acquistare un primonucleo di «medaglie e sigilli» per 5.000 lire;114) in unsecondo, Carlo Cornaglia, professore di disegnoall’Accademia militare, fu inviato a Venezia per porta-re a termine le trattative per il resto della raccolta;l’accordo fu raggiunto con il conferimento al conte diun vitalizio di 6.000 lire annue a partire dal 17 marzo1843,115) e Cornaglia poté tornare a Venezia a ritirarela collezione.116)
La collezione Gradenigo117) di antichità e moneteera stata incrementata soprattutto da Pietro Gradeni-go (1695–1776), che la lasciò ai nipoti, figli del fra-tello Girolamo, zuanne Agustin (1725–1774) e Jaco-po (1721–1796). Quest’ultimo acquistò inoltre laraccolta di Antonio savorgnan (nato nel 1693), diuna potente famiglia di origini friulane, con tenute
sul sito di Aquileia, il quale, a sua volta, aveva acqui-sito il medagliere dell’abate Onorio Arrigoni (Vene-zia 1668 circa – 1758) dopo la morte di questi, fortedi circa ventimila pezzi; l’Arrigoni stesso ne avevapubblicato in quattro volumi di tavole (l’ultimopostumo) il catalogo118) ad usum juventutis. Jacopocedette poi un nucleo di esemplari in oro al baroneprussiano di schellerscheim, che collezionava mone-te antiche in questo metallo.119) L’ultimo erede fuVicenzo Pietro (1790–1849), che vendette al re disardegna il resto della raccolta. Resta il dubbio senella Gradenigo sia confluita parte della celebre col-lezione numismatica del cardinale Pietro Bembo(Venezia 1470 – Roma 1547):120) l’unica traccia ècostituita dal sigillo del cardinale giunto per tale vianel medagliere Reale,121) ma le notizie sulla disper-sione della grande collezione d’arte e antichità daparte del figlio torquato, del nipote Orazio e deglieredi farebbero pensare piuttosto che ciò che rima-neva del medagliere finì nel 1599 all’astronomo fran-cese nicolas Claude Fabri de Peiresc (Belgentier1580–1637), il quale avrebbe acquistato «universampaene rerum antiquariam suppellectilem».122)
non è chiaro il motivo per cui la missione a Venezianon venne affidata a Promis; Cornaglia, che si eradistinto negli studi numismatici con la pubblicazionedella collezione lasciata da Filippo Lavy all’Accademiadelle scienze nel 1835,123) venne infine gratificato di500 lire per la «cooperazione prestata nel collocare eclassificare nel R.° medagliere le monete».124)
Anche Alessandro Paravia possedeva una propriaraccolta, portata a torino e proposta in vendita alministro dell’Interno, il conte Carlo Beraudo di Pra-lormo (torino 1784–1855),125) con scarso successo:
«il ministro dell’Interno le possiede tutte, e alcune ne hapersin triplicate; il che mostra che son tutte comuni; intantoil vantaggio, che ho avuto portandole a torino, si è da aver-le tutte classificate; ora converrà a poco a poco riportarle aVenezia, e combinare qualcosa con il signor Weber, che mimostrò da un pezzo desiderio di acquistarle».126)
nel 1845 venne messa all’asta a Vienna la collezionehelzel, ed il conte di sambuy, regio ministro in quella
59
14a–b – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIEREQuADRuPLA D’ORO DI CARLO EmAnuELE I DuCA DI sAVOIA (tORInO, 1586), InV. D.C. 386
a b
città, provvide ad acquistare per il re «varie meda-glie».127) nel 1847 furono acquistate «medaglie e mone-te antiche» che facevano parte dell’eredità del marche-se Giovanni Battista d’Oncieux de La Bâthie,128) giàministro e consigliere di stato a torino.129)
Gli acquisti sono contabilizzati talvolta direttamen-te ai commercianti della capitale che fornivano ilmateriale, come l’antiquario Gioanni Cannaferi-na,130) l’orefice Giovanni Canavero, che cedette unamedaglia e «diverse antiche monete» nel 1846,131) edi librai Federico Peppi132) e michele Vita Foa,133) chein più occasioni vendettero libri, disegni, antichità emonete. mandati di rimborso venivano inviati airappresentanti diplomatici all’estero che avevanocurato gli acquisti, come il regio inviato a Roma,conte Broglia, che acquistò un sigillo nel 1839,134) ilcavaliere Romualdo tecco, primo Dragomanno pres-so la Porta Ottomana, che procurò in due occasionigruppi di monete,135) o il signor Kralewsky, fornitoredella serie di medaglie in bronzo raffigurante i 24 redi Polonia.136)
Ancora si può trattare di semplici acquisti da varipersonaggi che offrivano materiale in loro possesso,come l’avvocato Benzo, Vicario Generale della Dioce-si di Ivrea, che vendette «alcune antiche moneted’oro ritrovate in Ivrea state presentate a sm dallaCongregazione dell’Ospedale di detta Città»,137) o imusij, padre e figlio, orologiai di sua maestà, cheoffrirono «sei monete antiche»,138) il cavalier Damianosauli, maggiore del Corpo del Genio marittimo, chepresentò al re, a sarzana, «alcune medaglie ed unanello»,139) il signor Domenico Roggero, che offrì 23monete d’oro e 16 d’argento,140) il signor Bartolomeo
Rossi, che consegnò «un’antica moneta d’oro trovatanegli scavi che si fanno per le costruzioni da eseguir-si sul bastion verde»,141) il signor Bartolomeo Bianchi,di Bannio, che fece omaggio di «antiche monete emedaglie che egli raccolse nel Caboul e nell’Afgani-sta» [sic],142) il primo Architetto Disegnatore cavalierErnesto melano, per «un’antica moneta»,143) il signorFilippo Benucci, che vendette «due antiche moneted’oro e otto altre d’argento»,144) il conte AlessandroBiancoli, che fece omaggio di tre medaglie «rappre-sentanti s.m., s.s. il Papa Pio IX, e s.A. il Gran Ducadi toscana».145)
I soggiorni del re fuori della capitale potavano for-nire occasione per incrementare le collezioni, e così fudurante un viaggio in savoia del 1839, quando venne-ro acquistate alcune «medaglie»,146) o durante le vil-leggiature nella tenuta reale di Pollenzo, che permise-ro l’acquisizione di due monete antiche d’oro.147)
Carlo Alberto si interessava anche alla contempora-nea produzione di medaglie: sottoscrisse così la rac-colta della produzione del napoletano Lorenzotaglioni,148) quella di Pietro moris149) e la serie degliUomini illustri piemontesi150) di Gaspare Galeazzi,151) diquest’ultima sottoscrivendone dieci esemplari per cia-scun tipo, in previsione, evidentemente, di utilizzarlicome doni. L’incisore Giambattista solari venne grati-ficato non solo con l’acquisto della sua medaglia raffi-gurante Cristoforo Colombo (1837) in sei copie,152)
ma anche con un ulteriore compenso di 250 lire,153)
probabilmente per l’alta qualità del lavoro eseguito.nel 1846 venne sottoscritta anche la Serie iconograficanumismatica dei più famosi italiani, in corso di realizza-zione a Roma da parte dell’incisore Pietro Giromet-
60
15 – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIEREGuILLAumE DuPRé: mEDAGLIA PER VIttORIO AmEDEO I DI sAVOIA
1636 (?), InV. D.C. 5609
16 – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIEREGuILLAumE DuPRé: mEDAGLIA PER CRIstInA DI FRAnCIA
1635, InV. D.C. 5610
ti154) e dello zecchiere papale niccolò Cerbara,155) conl’acquisto dei primi 24 esemplari;156) nel 1848 vengo-no registrati i numeri 25–26–27,157) mentre i numeri28, 29 e 30 rientreranno tra le spese del 1850 di Vit-torio Emanuele II.158)
Il primo inventario conosciuto della collezione risa-le al 1848;159) è di tipo quantitativo, con le moneteraggruppate per classi, zecche o autorità emittenti, dicui si specifica il numero per tipo di metallo: sonodati sufficienti per un raffronto con l’inventario patri-moniale particolareggiato del 1886160) (vedi tABELLA1). Risulta subito evidente come nell’intervallo tempo-rale tra la compilazione dei due inventari l’incremen-to subìto dalla collezione sia stato di ridotta entità,per lo più monete greche e romane, nessuna medieva-le o moderna, né medaglie. Deve trattarsi di un ulti-mo acquisto, o serie di acquisti, prima della cessioneallo stato. Questa ebbe luogo nel difficile momentosuccessivo all’abdicazione di Carlo Alberto (23 marzo1849). Il re incontrò il 26 aprile, ad Antibes, nel corsodel viaggio che lo porterà ad Oporto, il sovrintenden-te generale della Lista Civile (dell’Azienda, cioè, dellaReal Casa),161) conte Cesare trabucco di Castagnetto,per dargli istruzioni in merito al suo patrimonio pri-vato.162) Questo
«non era vistoso, se si toglievano da esso i valori costituitida oggetti d’arte. E però non è difficile supporre che ilCastagnetto avesse fatto presente al Re la convenienza del-l’accettazione di un appannaggio, avuto riguardo alla dona-zione fatta allo stato delle opere d’arte. Il Re si oppose; edinsistette anche da Oporto nel rifiuto, così scrivendo alCastagnetto [6 maggio]: “Ricordate bene che io non voglioassolutamente che voi abbiate a parlare né di gallerie, né dioggetti d’arte. In questo momento in cui lo stato è oppressoda tanti pesi io preferirei mangiare del pane nero tutti igiorni che mi restano della vita, piuttosto che si possa direche in tempi così terribili io abbia voluto dare imbarazzi allefinanze dello stato nel mio interesse personale”».163)
Inoltre, una conferma di tale donazione è contenu-ta in una relazione del conte di Castagnetto al mini-stro delle Finanze, del 2 maggio 1849, concernente laretribuzione del re abdicatario:
«Qual Re il quale con Atto magnanimo scendendo daltrono non volle domandare un obolo alla nazione, diede alsottoscritto suo procuratore Generale l’espresso divieto dinulla ripetere pel valore delle stupende collezioni d’oggettid’arte a sue spese riunite nei Reali Palazzi, volendo cherestino annessi alla corona come dono da lui fatto allo stato.In questo disinteressato e nobil modo di procedere tutto sispiega l’animo di Carlo Alberto, la cui vita fu una continuaabnegazione di tutto se stesso (...)».164)
Da quel momento in poi, dunque, la collezionenumismatica entrò a far parte, insieme agli altrioggetti raccolti da Carlo Alberto, della Dotazione dellaCorona, l’insieme cioè dei beni di proprietà patrimo-niale dello stato, mobili ed immobili, messi a disposi-zione del sovrano.165) tale istituto giuridico era natocon il passaggio dalla monarchia assoluta a quellacostituzionale sancito dallo Statuto (4 marzo 1848):questo, all’articolo 19, prevedeva che
«Il Re continuerà ad avere l’uso dei Reali Palazzi, ville egiardini e dipendenze, non che tutti indistintamente i benimobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario adiligenza di un ministro responsabile».166)
Vittorio Emanuele II, come d’obbligo per un nuovoregnante salito in carica, stabilirà in dettaglio con lalegge n. 1004 del 16 marzo 1850 la consistenza dellaDotazione del Re, e condizioni del godimento dei benicostituenti la dotazione della Corona: tra i beni immobi-li sono compresi il Palazzo Reale ed il Palazzo Vecchio(articolo 2), mentre
«la dotazione in beni mobili comprenderà le gioie, perle,pietre preziose, le statue, i quadri, compresi quelli dellaReale Galleria, i medaglioni, le armerie antiche ed altrioggetti d’arte, le biblioteche, il vasellame e gli oggetti tuttiin argento e oro, le biancherie, e gli arredi ed effetti mobilid’ogni sorta esistenti nei palazzi, castelli, fabbriche, parchi egiardini indicati nel detto elenco non che nei guardamobili(...)» (articolo 3).
Inoltre «sarà formato a spese delle finanze ed in contrad-dittorio del sovr’intendente generale della Real Casa uninventario tanto dei beni stabili col relativo piano figurativo,quanto di tutti gli oggetti mobili che costituiranno la dota-
61
17a–b – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIEREmOnEtA DA CInQuE DOPPIE D’ORO DI CARLO EmAnuELE III RE DI sARDEGnA (tORInO, 1756), InV. D.C. 588
a b
zione come al precedente articolo. A quelli degli oggettimobili che per l’uso sono soggetti a deterioramento saràfatto l’estimo del loro valore (...)» (articolo 4).
Viene precisato, infine, che«le spese tutte per la manutenzione e per la conservazio-
ne in buono stato dei beni, tanto immobili, quanto mobili dicui si compone questa dotazione, rimangono a carico dellaCorona. tuttavia i mobili portati nell’inventario con estimopotranno essere permutati od alienati a condizione di esseresurrogati» (articolo 6).
si delinea così la questione della seconda collezioneReale, quella oggi definita come Sua Maestà, per laquale disponiamo di un inventario particolareggiatoiniziato, anch’esso, nel 1886167) (vedi tABELLA 2). seda una parte è probabile che nella proprietà privatadei reali siano rimasti alcuni oggetti di acquisizionecarloalbertina non entrati nel medagliere della Dota-zione Corona, come i sigilli168) e le medaglie moderne,è evidente che il nucleo numismatico di questa secon-da collezione si deve essere formato in epoca successi-va.169) non c’è motivo di pensare, infatti, che le acqui-sizioni sostenute dai successori di Carlo Albertoandassero a incrementare un bene pubblico, e non,piuttosto, la proprietà privata del sovrano, proprietàprivata che era un principio fondamentale sancitodall’ordinamento legislativo dello Statuto Albertino.170)
Le acquisizioni private dei reali dovettero infatti con-tinuare regolarmente, certo su iniziativa di DomenicoPromis: per l’ultimo anno di cui si disponga della con-tabilità, il 1850, risultano spese 120 lire per «medagliee monete antiche», più le solite somme cumulativeper Biblioteca e medagliere.171) L’anno successivo fu
acquisita parte della collezione trivulzio, ceduta daCristina di Belgioioso. Da tempo è nota una lettera diquesta a Promis, del novembre 1850, per iniziare latrattativa di vendita
«di quella parte del medagliere che mi appartiene e checontiene le monete e medaglie coniate da Valentiniano edOnorio sino ai giorni nostri».172)
La principessa di Belgioioso disponeva, per via ere-ditaria, di una porzione della grande collezionenumismatica iniziata in milano nel XVIII secolo daifratelli Alessandro teodoro e Carlo trivulzio. Essatoccò nel 1789 al nipote di quest’ultimo, Giorgio teo-doro, alla cui morte (1802) venne spartita tra i figliGian Giacomo e Gerolamo. Cristina era figlia delsecondo. Gian Giacomo, invece, accrebbe la propriaraccolta, soprattutto di libri, e la lasciò nel 1831 alfiglio Giorgio teodoro, che proseguì gli acquisti,come farà anche il figlio di questo, Gian Giacomo, apartire dal 1856.173)
All’opera di Domenico Promis si affiancò, a partiredal 1865, quella del figlio Vincenzo, che preferì essereassociato alla Direzione del medagliere e della Biblio-teca piuttosto che spostarsi a Firenze con il ministerodegli Esteri, da cui dipendeva, con il trasferimentodella capitale del Regno174). succederà al padre allamorte di questi, nel 1874. nel 1889 gli subentrerà, asua volta, il barone Domenico Carutti.175)
nel 1898 umberto I incaricò il ministro PonzioVaglia di acquistare dagli eredi la collezione di Filippomarignoli, specializzata in monete italiane, ma le trat-tative giungeranno a buon fine solo con Vittorio Ema-nuele III.176)
62
18a–b – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIEREGAsPARE GALEAzzI: mEDAGLIA In BROnzO DI CARLO ALBERtO RE DI sARDEGnA
COmE PROtEttORE DELLE ARtI (tORInO, 1833), InV. D.C. 5742
Che le due raccolte, Dotazione Corona e Sua Maestà,fossero fisicamente contigue lo dimostra il fatto chenella valutazione quantitativa del medagliere Realenon si facesse distinzione tra l’una e l’altra, calcolandol’intero insieme in circa 40.000 pezzi.177) ma che giuri-dicamente fossero di qualità ben diverse, una dema-niale e l’altra privata, è ben chiaro nella storia dientrambe, essendo la prima rimasta intatta, mentre laseconda, come proprietà personale, venne assorbitanel monetiere di Vittorio Emanuele III, il re numi-smatico per eccellenza. Dall’inventario Sua Maestàrisultano due operazioni di scarico, la prima, limitataa pochi pezzi, registrata sui libri il giorno 11 maggio1901, la seconda, ben più consistente, il 13 giugno1923, comprendendo anche le monete già espuntevent’anni prima. I cartellini originali di Vittorio Ema-nuele III, oggi conservati con la collezione al museonazionale Romano, riportano la dicitura Reale Rac-colta Privata 1901 per indicare quella provenienza.178)
Il fatto che siano in numero molto superiore al movi-mento registrato sugli inventari a quella data, mentremanca un tipo di cartellino con l’indicazione del1923, fa pensare che il vecchio cartellino predispostoa stampa nel 1901 sia stato poi utilizzato in seguitoper accompagnare le monete via via rimosse, sino alladefinitiva quantificazione del movimento nel 1923.Altro punto da notare è che, essendo Vittorio Ema-nuele III notoriamente disinteressato alla monetazio-ne antica, di epoca greca e romana,179) concentrò lasua attenzione di collezionista unicamente alla numi-smatica italiana medievale e moderna, arrivando araccogliere più di centomila pezzi.180) tuttavia, tra il1901 e il 1923 fece prelevare anche le monete e le tes-sere romane dal medagliere sua maestà, e dunquedobbiamo pensare che le abbia vendute od utilizzatecome merce di scambio per ottenere altri pezzi di cuiera alla ricerca.181)
tornando al medagliere della Dotazione della Coro-na, una prima valutazione possibile riguarda, sempli-cisticamente, l’aspetto quantitativo: pur con un campodi applicazione che fu ristretto alle monetazioni anti-che e a quella italiana medievale e moderna, non siraggiunsero le dimensioni delle raccolte reali euro-pee, che, create in tempi più lunghi e con maggioririsorse, e spinte da una motivazione di esaustività,raggiungevano, all’inizio del nostro secolo, dimensio-ni ben più ragguardevoli, tra i cento e i duecentomilaesemplari.182) La Dotazione Corona rientra, invece, nel-l’ordine di singole collezioni private, raccolte daappassionati che, spesso, dedicarono ad esse la mag-gior parte del loro tempo e delle loro finanze, come,per restare in Piemonte, quella messa insieme da Gio-van Battista Adriani a Cherasco (1826–1905),183)
oppure quella dello stesso Pelagio Palagi, ora almuseo Civico di Bologna.184) si possono ricordarealtre grandi collezioni italiane, come quella del mar-chese Filippo marignoli, a Roma, forte di 33.000pezzi acquistati da Vittorio Emanuele III nel 1900,185)
quella del conte nicolò Papadopoli Aldobrandini, dal1922 al museo Correr di Venezia,186) quella di Rodolfo
di Colloredo mels, dal 1953 al museo Civico diudine,187) quella di nicolò Bottacin, dal 1865 nell’o-monimo museo di Padova188) e quella del barone sal-vatore Pennisi di Floristella ad Acireale.189)
L’inventario del 1848 procede in senso cronologico,cominciando dalle monete greche (Numismata Graecaautonoma, Regia et Colonialia), disposte nell’ordinegeografico delle zecche stabilito nel secolo precedentedalla Doctrina Nummorum Veterum dell’abate Josephhilarius Eckhel (Vienna, 1792–1798) secondo la geo-grafia straboniana,190) da occidente (spagna) versooriente (nord Africa) intorno al bacino del mediterra-neo; seguono i bronzi fusi (Aes Grave Romanum et Ita-licum), le monete romane di epoca repubblicana, divi-se per famiglie dei magistrati monetali (in ordinealfabetico), con in fondo le incerte e le cosiddette“romano–campane” (Nummi Consulares Romani), poi iNummi Imperiales Romani, a partire da Pompeo eCesare sino agli imperatori bizantini; il gruppo suc-cessivo è quello delle Monete italiane del medio evo emoderne, dagli stati sardi di terraferma al LombardoVeneto,191) Annessi a Stati esteri,192) Parma, Piacenza,modena, la toscana, lo stato Romano, napoli, Corsi-ca, malta, sardegna, sicilia e Crociati. Alla fine iMedaglioni Italiani, divisi tra savoia, Papi e Italianiillustri. L’inventario del 1886 rispecchierà gli stessicriteri, cominciando però dalle monete italiane, cuiseguono le medaglie, le monete romane, quelle arabe,le tessere romane, i regni barbari, un supplemento dimonete romane, quelle greche, i piombi, ed infine unsupplemento di monete greche.
63
19 – tORInO, PALAzzO REALE, sALA DEL mEDAGLIEREADOLFO PIEROnI: mEDAGLIA In ARGEntO COmmEmORAtIVADI DOmEnICO CAsImIRO PROmIs, COnsERVAtORE DEL REGIO
mEDAGLIERE (FIREnzE, 1874–1875), InV. s.m. 5391
64
cLasse invenTario�1848 invenTario�1886 Differenza
monete greche 9310 11394 + 2084
monete romane 8688 8888 +200
monete bizantine [da Anastasio in poi] 797 890 +93
monete savoia 703 701 -2
monete italiane e di italiani all’estero 4900 4899 -1
medaglie 1753 1753 0
monete arabe 0 12 +12
tessere romane 0 20 +20
Nummi barbari 0 13 +13
Tesserae Plumbeae 0 27 +27
tOtALE 26151 28597 +�2446
cLasseinvenT.
1886
invenT.
1891
posT
1891ToTaLi
scarico
1901
scarico
1923
monete romane 666 8 0 674 0 674
tessere e piombi romani 49 237 0 286 0 237
monete savoia 172 1 22 195 4 174
monete italiane e annessi 4662 38 1 4701 29 4671
medaglie, placchette, targhe, onorificenze 1898 919 418 3235 0 dato in corso
di verifica
Punzoni e conî 0 6 0 6 0 0
Bolle 188 0 0 188 0 187
sigilli 1285 146 32 1463 0 0
Oggetti vari 52 41 27 120 4 dato in corsodi verifica
tOtALE 8972 1396 500 10868 37 5943
tABELLA 1
COLLEzIOnE numIsmAtICA DOtAzIOnE DELLA COROnA
tABELLA 2
COLLEzIOnE numIsmAtICA suA mAEstà
Alcuni esemplari appartenenti alla Dotazione dellaCorona furono pubblicati nel catalogo della mostraorganizzata a Palazzo madama nel 1964 per illustrarei tesori del medagliere Civico, appena costituito(1958) riunendo le collezioni del museo di Antichità edi Palazzo Reale con quelle del museo Civico di ArteAntica:193) particolarmente significativa, se non mag-gioritaria all’interno del materiale selezionato, è lapresenza di esemplari greci ed italiani. ma pezzi digrande rarità sono presenti anche nell’ambito dellamonetazione romana, dei regni barbari, dei savoia.
La collezione del Regio medagliere (Dotazione dellaCorona) costituisce un esempio intatto di collezioni-smo del primo Ottocento: accanto all’eterogeneità deimateriali raccolti — in cui comunque prevaleva l’inte-resse per la storia patria, piemontese e italiana —,sarà di grande interesse tentare di ricostruire i nucleiprovenienti dal collezionismo sabaudo precedente(Carlo Emanuele III?), da altre collezioni (come la set-tecentesca Arrigoni) o da rinvenimenti (come quelli diIvrea, Pollenzo e torino), ma anche gli strumenti concui la collezione venne formata e ordinata (libri, con-tattti commerciali, scambi scientifici).
La sfida è costituita da realizzare una classificazionecon criteri catalogici attuali di ciascun esemplare, chenon venne fatta al momento dell’inclusione della rac-colta nel medagliere civico.194) Questa formerà il fon-damento, inoltre, di ogni tentativo di scrivere una sto-ria della collezione, andando a riconoscerne, almenoin parte, i vari elementi costitutivi così come sonostratificati ed aggregati dai tempi della collezione diDomenico Promis sino all’ordinamento nei mobili diPalagi e Capello ed all’inventariazione definitiva.
Un ringraziamento a Paolo Venturoli e ad AlessandraGuerrini per il costante sostegno nel corso di questa ricerca.
1) Cfr. GuERRInI 1989, pp. 125–127; PEnnEstRì 1995, p.203; e mAmInO 19951, pp. 317 e 318.
2) Ast, Archivio di Corte, Materie politiche per rapportoall’interno, Gioie e Mobili, mazzo 2, n. 29.
3) mAmInO 19951, p. 319, dà per scontato che il quartoPio dell’elenco sia papa Ghislieri: potrebbe invece trattarsidel suo predecessore, Giovan Angelo de’ medici; a questoseguono nell’elenco Giulio II e un Leone (X?). La collezionenumismatica del Rochefort venne acquisita nel 1576 daBasilius Amerbach, giurista e collezionista di Basilea(1533–1591) (ibidem, p. 318) ed è oggi conservata all’histo-risches museum di quella città.
4) Ibidem, p. 319, fig. 1.
5) KLAWAns 1977; GORInI 1987, pp. 45–54; e mARtInI,JOhnsOn 1989.
6) si vedano le medaglie che ritraggono lo stesso Cavinoaffiancato al Bassiano, una delle quali presenta al rovescio ilritratto del mantova Benavides, in Rinascimento e passione2008, pp. 522 e 523, nn. 122 e 123.
7) FAVAREttO 1990, pp. 107–115.
8) Il termine «medaglia» indica in genere monete anticheo fuori corso e così va inteso nei documenti sugli acquistiducali tra XVI e XVII secolo.
9) sono tutte monete antiche, delle quali esiste un som-mario elenco nel contratto di pagamento del muti: greche140 di bronzo e 48 d’argento, consulari 27 e 280; da Cesareed Augusto sino a Gordiano le quantità sono specificate sin-golarmente od a piccoli gruppi, seguono «posteriori 75 e296, di donne 88 e 74, Adriano e Lisia 2 e 2, posteriorid’oro n.° una» (mAnnO 1878, pp. 218 e 219, 221). Il totaleassomma a 983 di bronzo, 1043 d’argento e una d’oro. Car-teggi medicei ricordano, nello stesso 1573, trattative tra ilDuca sabaudo e un Rocco Carizzoli veneziano, per l’acquistodi medaglie «molto belle invero» (AGOstI 1996, p. 142); nonè chiaro se il personaggio sia il medesimo Rocco scarizza(BAVA 1999, p. 313 nota 6).
10) Cfr. GuERRInI 1989, p. 125; mAmInO 19951, nota 20; eBAVA 19951, pp. 136–138 e 176.
11) BAVA 19951, p. 167 nota 118.
12) mAmInO 19951, nota 22.
13) BAVA 19951, p. 159 nota 85.
14) mCCRORy 1982, pp. 647 e 648; e mCCRORy 1987.
15) muntOnI 1973, p. 268.
16) BALBI DE CARO 1980.
17) BAuDI DI VEsmE 1901, pp. 10 e 11.
18) Ibidem, p. 14.
19) BAuDI DI VEsmE 1963–1982, I, pp. 28–32; e sImOnEttI
1967, pp. 329–331, 398–402.
20) Come si ricava dal riconoscimento di una pensione a«Ludovico de Ludovici detto il Perugino, orefice in questacittà nostra», datato 4 novembre 1617, per questa caricaassunta senza stipendio (BAuDI DI VEsmE 1963–1982, I, p.31). nel 1623 e nel 1625 risulta ancora controguardia(sImOnEttI 1967, p. 401).
21) ROnChInI 1864, p. 260 nota 5.
22) BAuDI DI VEsmE 1901, pp. 18 e 19; e BALBI DE CARO
1980, p. 230.
23) BAuDI DI VEsmE 1901, pp. 20 e 21; mAmInO 19951, p.318 nota 14. nella lettera si citano «una decurseon di nero-ne», ovvero un sesterzio di nerone con al rovescio una scenadi decursio, e «quella di sapho, che mi faceste d’oro grandecon quel cuffietto in testa e quel polpo per traverso» (cfr.suthERLAnD 1984, pp. 159, 162, 175, 177, 180 e 184); que-st’ultima è una falsa moneta di mitilene, creazione eruditanota grazie a disegni di Pirro Ligorio (cfr. ROmAnO 1999,pp. 298–303), molto probabilmente ispirata alle litre di Vsecolo a.C. della zecca di siracusa, con al diritto la testa diArethusa ed al rovescio il polpo (si veda ad esempio, SyllogeNummorum Graecorum 1988, nn. 129–133, 137–143, 277,282–283, 286, 293 e 294).
24) BAuDI DI VEsmE 1963–1982, I, pp. 32, 152 e 153;CERRAtO 1965, p. 60.
25) ROssI 1995, p. 428.
26) si tratta di una lettera del mercante bolognese ErcoleBassi a Francesco I de’ medici, per offrirgli la riproduzione,
65
opera di Bombarda da Cremona, insieme ad alcune moneteantiche, citata da: POLLARD 1974, p. 143.
27) Quale il già citato Giovanni da Cavino (cfr. supra,nota 5).
28) mAmInO 19952, p. 73. secondo l’Autore il Duca, cherivaleggiava per la sua raccolta numismatica con GiacomoBoncompagni, figlio di papa Gregorio XIII, avrebbe utiliz-zato come motto per il suo Teatro un verso palindromo del-l’erudito Filiberto Pingone di contenuto misticheggiante(Iesum irim ama miri Musei: «ama Gesù, arcobaleno del-l’ammirabile museo»), associato all’emblema di un gruppodi volumi sormontato da un arcobaleno, a sua volta fian-cheggiato da due monete. tale immagine (ibidem, fig. 2,presa da PInGOnE 1577, p. 131) riporta, tuttavia, non duemonete, bensì due elementi circolari su piedistalli, uno conil busto di Cristo, la lettera aleph e il nome di Gesù in ebrai-co, l’altro una scritta, sempre in ebraico, su cinque righe,solo parzialmente traducibile: «Il messia re è venuto in pace(…), il sangue versato vive» (ringrazio Bruno Chiesa dell’u-niversità di torino per la traduzione). tali elementi nonpaiono dunque poter costituire un riferimento alla collezio-ne numismatica ducale.
29) DARDAnELLO 1995, pp. 64–104; mAmInO 19952;mAmInO 1999, pp. 289–309; e BAVA 2008.
30) ROVERE 1858, p. 3.
31) Per la disposizione degli armadi: BAVA 19952, pp.330–332. Per la presenza della raccolta numismatica: mAmI-nO 1999, p. 293. Per la presenza di ricche collezioni archeo-logiche, soprattutto statuaria e lapidaria: BAVA 1999, pp.311–327.
32) Ast, Archivio di Corte, Materie …, cit., mazzo 5d’addizione, n. 30, p. 73.
33) Indicati come Goltzij Cesar li. 2’ e Goltzij JuliusCesar. I titoli originali sono: Caesar Augustus sive HistoriaeImperatorum Caesarumque Romanorum ex antiquis numi-smatibus restitutae. Liber secundus. Accessit Caesaris Augu-sti vita et res gestae (Bruges 1574) e C.Julius Caesar siveHistoriae Imperatorum Caesarumque Romanorum ex anti-quis numismatibus restitutae. Liber primus. Accessit C.JuliiCaesaris vita et res gestae (Bruges 1562) (cfr. in propositoGRAEssE 1862, pp. 113 e 114).
34) BABELOn 1901, coll. 102–104.
35) Thesaurus rei antiquariae 1575.
36) Potrebbe trattarsi delle Icones imperatorum Romano-rum 1558 dello stesso Goltzius; cfr. GRAEssE 1862, p. 113.
37) BABELOn 1901, coll. 91–131.
38) mAmInO 19951, p. 317.
39) BABELOn 1901, coll. 90 e 91; e BAssOLI 1985, pp. 8 e9, 19–23.
40) mAmInO 19951, pp. 320 e 321 nota 22; e sPIOnE 1995,p. 342.
41) sulla ridotta portata di tali incendi: VIsCOntI ChERA-sCO 2008, pp. 29 e 30.
42) PEnnEstRì 1995, pp. 204–206.
43) Ast, Archivio di Corte, Materie …, cit., mazzo 2, n. 6:La Nota delle Medaglie d’oro/ Argento e metallo che sono/
nelle guardarobbe di S.A.R./ a carico del S. Alamandi e delTapissere/ il qual hà quelle d’oro e d’argento/ Nel Palazzodietro S.Gio. … estratta da una Minuta d’inventario com-municatomi da Mons.r Denis’ (non è firmata). Il documentoè trascritto per intero in Appendice.
44) I due personaggi di cui viene riferito il nome noncompaiono nell’elenco di cavalieri ed ufficiali della casa diVittorio Amedeo I (1631–1632) pubblicato in mAssABòRICCI, ROssO 1988, pp. 30 e 31; un Giovanni matteo Alle-mandi è aiutante di guardaroba per Carlo Emanuele II nel1650 (ibidem, p. 34).
45) si tratta del Palazzo tardo–cinquecentesco sorto inglo-bando le case ed i Chiostri dei Canonici, accanto alla demo-lita basilica di san salvatore, a nord–est del Duomo rinasci-mentale: ROVERE 1858, pp. 1–14; PALmAs 1986, pp. 19–36; eRE 1997, pp. 21–37.
46) ROVERE 1985, p. 9.
47) Ibidem.
48) Per queste e le prossime citazioni si veda infra il docu-mento riportato in Appendice.
49) BAVA 19952, pp. 281 e 282.
50) Ast, Archivio di Corte, Materie …, cit., mazzo 5 d’ad-dizione, n. 39.
51) La sede della zecca torinese fu, forse sin dalle origini(1297), in contrada Cappel Verde, nel luogo dove ora sitrova il settecentesco palazzo del seminario Arcivescovile, inuna casa di proprietà (XV secolo) della famiglia de Gorzano;nel XVI secolo essa aveva anche occupato una seconda casacontigua, proprietà dell’Ospedale di san Giovanni; nel1677 venne appaltata la costruzione della nuova sede, adia-cente alla Cavallerizza ducale lungo la via che prese il nomedi via della zecca (ora via Verdi), essendo utilizzata a partiredal 1679 sino alla chiusura nel 1870 (CERRAtO 1965, pp. 12,22–24, 55 e 56, 71 e 72, 82 e 83; BARELLO 2004).
52) Ast, Archivio di Corte, Materie …, cit., mazzo 2, n.16: Inventario di ciò che si è ritrovato in un Scrittorio di fùS.A.R. diviso in due parti (non firmato né datato).
53) sPIOnE 1995, pp. 345–347.
54) Ast, Archivio di Corte, Materie …, cit., mazzo 2, n.29: «hoggi 15 marzo 1677 si è apperta la Guardarobbadelle medaglie ed Impronti della Corona Reale, qual si ètrovata sigillata nell’istesso modo, ch’il fù s.r Conte sansorl’haveva lasciata, e che hora si trovano in custodia dell’Aiu-tante di camera di s.A.R. e Guardamobile d’essa Guarda-robba, s.r Giulio Francesco torrelli, esatta la separazioned’ordine di m.R. di quelle d’oro e d’argento dalle medaglieed impronti di metallo, rame, stagno, e Piombo. si sonorimesse, cioè le sudette di metallo, stagno, Rame, e qualcheparte d’argento in custodia del sig. D. Pietro Giofredo, Ele-mosiniere di s.A.R. Bibliotecaro dè Libri della Real Corona,qui pñte ed accettante, sotto la di lui cura e custodia, e con-segnata di nuovo la chiave di detta Guardarobba al detto s.r
torrelli, sigillata dalle armi di m.R. e di quelle di me sotto-scritto con obligo all’un et all’altro di tenerne e darne fedelconto sempre ed ogni volta che richiederà il Real servitio,cioè il sig.r D.Pietro di quelle qui espresse nelli seguentiArticoli, alla presenza dell’Ill.mo et Eccellent.mo sig.r marche-se di s.Germano, Cava.re Gran Croce, e Gran Chiambellanodi s.A.R. e di noi Cons.re di stato e seg.ro del gabinetto
66
Commandamenti e Finanze di loro AA.RR.» (firmato PietroGioffredi e Giuseppe de Lescheraine).
55) sPIOnE 1995, pp. 334, nota 4, e 336. nel periodoimmediatamente successivo, un ruolo di rilievo tra le cari-che inferiori del personale di camera venne assunto dagliaiutanti di camera e di guardaroba (mAssABò RICCI, ROssO1988, pp. 21, 36 e 37), quale il citato torrelli.
56) mAnnO s.d. (si tratta della copia dattiloscritta in piùvolumi di un manoscritto conservato presso la BibliotecaReale di torino).
57) PEnnEstRì 1995, pp. 203–206.
58) su queste nell’ambito dell’antiquaria europea: sCh-nAPP 1994, pp. 109–157.
59) Ast, Archivio di Corte, Materie …, cit., mazzo 5 d’ad-dizione, n. 30, p. 77.
60) sulla storia del collezionismo numismatico in Pie-monte: BARELLO 2009.
61) nel 1683, a tredici anni, era andata in sposa a Giu-seppe maria Augusto manfredi scaglia, conte di Verrua,primo colonnello dei Dragoni blu (mAnnO s.d., XXVI, p.249).
62) Lettera ad Antonio magliabechi del 1 aprile 1699, inLettere inedite 1854, p. 77.
63) mIssERE FOntAnA 2000, pp. 197–200.
64) LEVI mOmIGLIAnO 20042, pp. 200 e 201. sulla revisio-ne dell’opera di Occo: mIssERE FOntAnA 2006, p. 299.
65) VALLAuRI 1846, p. 117.
66) DI mACCO 2003, pp. 33–35 e 50.
67) mOREttI 1964.
68) VALLAuRI 1846, p. 137. sarà questo il nucleo di par-tenza della formazione della raccolta dell’università, poidel museo di Antichità, arricchita nel 1752 con 130 mone-te d’argento e 400 di bronzo rinvenute negli scavi dell’a-bate Antonio Rivautella ad Industria (monteu da Po), piùmolte altre d’argento e 196 d’oro «consegnate dagli abi-tanti di quel villaggio» (ibidem, pp. 154 e 155). nel 1832vi si aggiungeranno le monete della collezione Drovettidel museo Egizio, nel 1866 quelle della collezione diFilippo Lavy, già all’Accedemia delle scienze, in seguitoaltre private (collezioni Rossi, Cornaglia, strozzi e Riccio,a proposito delle quali vedi: GnECChI, GnECChI 1903, pp.363 e 364) ed i materiali rinvenuti nel corso degli scavi inPiemonte.
69) DI mACCO 2003, pp. 41–43.
70) Le Medaglie del Museo di Sua Maestà 1769, descrit-to da LEVI mOmIGLIAnO 1980.
71) mALLÈ 1968, pp. 172–175 e 476; e FERRARIs 1992, pp.37–39, n. 11, e p. 201, nn. 40 e 42.
72) FERRARIs 1992, pp. 28–31, n. 7, e p. 200, n. 29.
73) Ibidem, p. 211, n. 138.
74) CLAREttA 1893, p. 88, nota 1; e FERRARIs 1992, p.202, n. 52.
75) FERRARIs 1992, pp. 151, n. 2, e p. 225, n. 40; e COR-RADO 1995, pp. 22–25.
76) Ast, Archivio di Corte, Materie …, cit., mazzo 6 d’ad-dizione, n. 4: «monsieur, Avec cette lettre V.E. recevrà unepetite Boete, qui contient plusieurs medailles assèz raresdans leur espece, et dignes du muséo du Roi; le seul regret,qui me reste, c’est qu’il n’y ait pas a turin un homme assèzhabile pour le mettre dans l’ordre, qu’il merite, c’est un tre-sor en ce genre, dont il me paroit que s.m. jusque ici faitpeu de cas, cependant j’ose hazarder que dans l’etat, ou ilest, il vaut de grosses sommes; comme c’est moi, qui l’aicrèe, je n’épargne ni soins, ne depence pour l’elever. Je deu-vois par quelque marque certaine étre persuadé du plaisir,que celà peut faîre au Roi, c’est a s.E. a me la procurer.J’ai l’honneur d’être avec le respect, que je dois monsieurDe V.E. trés humble et trés obeissant serviteur Rivarolnovare Le 10e fevrier 1740».
77) Cariche del Piemonte 1798, tomo II, Appendice I, pp.5 e 6; mAnnO, Il Patriziato Subalpino, s.d., XVII, p. 329.
78) Cariche del Piemonte 1798, tomo III, pp. 2, 55 e 56.
79) tutte le notizie sono state ricavate da: tELLuCCInI1910, pp. 485–530.
80) su questa figura di erudito: RICuPERAtI 1967, pp.434–437.
81) notizie autobiografiche in: VERnAzzA DI FREnEy 1813,pp. 133–141. In generale: LEVI mOmIGLIAnO 20042, in parti-colare pp. 46 e 47 per le vicende qui delineate.
82) Il conte talpone, che risiedeva nel già citato palazzodi san Giovanni.
83) VERnAzzA DI FREnEy 1813, p. 141.
84) ma non i gioielli e i tesori della corona, rimastinella praetiosorum cella, fatta costruire da Carlo Emanue-le II nel 1664 all’interno del nuovo palazzo ducale, percustodire i gioielli di Cristina di Francia, nel luogo oveora si trova il pregadio di Carlo Alberto (ROVERE 1858,pp. 24–27). Questa non risulta aver mai contenuto alcunaparte delle collezioni numismatiche sabaude, come sievince dall’Inventario delle Gioje della Corona, redattonel 1725 e costantemente aggiornato sino al 1757 (Ast,sezioni Riunite, Casa di Sua Maestà, Inventario ..., cit.,4507/3), ove viene preso in carico da parte del Custodedelle Gioje della Corona di turno il contenuto della Guar-darobba di ferro situata nella Galleria di levante del Palaz-zo Reale, «vicina al Gabinetto verde di s.m., detta anchedel sig.r Cavaliere Daniel».
85) tELLuCCInI 1910, pp. 515 e 516.
86) «I documenti tacciono a questo riguardo e malgradoogni diligente ricerca non ci è stato dato di trovare alcunanotizia» (tELLuCCInI 1910, p. 516). L’ipotesi più verosimile èche le monete antiche siano entrate a far parte delle colle-zioni del museo di Antichità, mentre quelle medievali emoderne siano tornate alla proprietà diretta della corona.
87) CARAssI, mAssABò RICCI 1989, pp. 37 e 38.
88) tEttOnI 1874, pp. 23 e 24.
89) LuPPI 1893, p. 382; FAVA 1967, p. 42; FAVA 1989, p. 7;tRAVAInI 1991, pp. 36 e 37; e PEnnEstRì 1995, p. 207.
90) Ast, sezioni Riunite, Casa di Sua Maestà, Conto deltesoriere privato di S.M., per l’Amministrazione dei ServiziSecreti ordinati da S.M., inv. 4324/A, n. 140.
67
91) succeduto al padre matteo nella carica di cassiere nel1823, sarà poi nominato nel 1837 Regio Commissario dellazecca (LuPPI 1893, p. 382; Calendario Generale 1837, p.407), carica che abbandonerà subito per assumere quella diRegio Bibliotecario (vedi sotto).
92) Ast, sezioni Riunite, Casa di Sua Maestà, Conto deltesoriere privato di S.M. ..., cit., inv. 4325/A, n. 83.
93) Dal 1830 era il precettore dei figli del re.
94) PEnnEstRì 1995, p. 213.
95) ROmAGnAnI 1985, pp. 119–158.
96) CIBRARIO, PROmIs 1833, pp. 18 e 19, 93 e 94: in realtà,solo 31 sono descritte nel volume, insieme ad una medaglia(ibidem, pp. 379–389).
97) ROVERE 1858, pp. 55, 125 e 126; DALmAssO 1977; eVEntuROLI 20011.
98) GAzzERA 1832, pp. 69–74.
99) PROmIs 1836.
100) non ve n’è, infatti, traccia negli inventari. Attual-mente, l’ipotesi più verosimile è che le monete in questionesiano state battute da uno dei marchesi del Carretto in unaloro zecca (Cortemilia?), interpretando la legenda comemar(chio) Sagona(e), cioè marchese di savona, titolo delquale i del Carretto continuarono a fregiarsi anche quandola città ligure non fu più sotto il loro dominio: FAVA 1970.
101) Il Comm. Domenico Promis 1865–1866. Per un’ana-lisi della questione, con cronologie contrastanti: PAutAssO1975; PInK 1975. Gli esemplari nel medagliere sono 22.
102) PROmIs 1858, pp. 101–103: illustra 11 esemplari(tav. X), che dovrebbero corrispondere ai dodici registratinell’inventario del 1848 (cfr. infra nota 159). Per una valuta-zione critica della serie: ARsLAn 1998, pp. 296–297.
103) Ast, sezioni Riunite, Casa di Sua Maestà, Conto deltesoriere privato di S.M. ..., cit., inv. 4326/A, n. 112(14/2/1834: lire 4.912,45); inv. 4327/A n. 145 (27/3/1835:lire 6.904,84), n. 337 (9/8/1834: lire 1.432,75, per «monetee medaglie antiche»), n. 419 (13/10/1835: lire 2.240,20 per«monete e medaglie»); 4328/A, n. 152 (29/3/1836: lire3.713,78 per monete e medaglie), n. 367 (25/8/1836: lire1.525,95 per «monete e medaglie e altri oggetti»), n. 444(20/10/1836: lire 1.496,65 per «varie medaglie e altri ogget-ti»); inv. 4329A, n. 85 (18/1/1837: lire 2.910,45 per «monete,medaglie ed altre spese relative al regio medagliere»), n.216 (17/4/1837: lire 608.15 per «medaglie e monete anti-che»), n. 294 (30/6/1837: lire 896,05 per «medaglie ed altrioggetti provvisti al medagliere»); inv. 4331/A, n. 111(2/3/1839: lire 335,10 per «servizio del medagliere dis.m.»); inv. 4333/A, n. 531 (20/12/1841: lire 1.540,05 per«compra di medaglie e monete antiche»); inv. 4334/A, n.309 (1/8/1842: lire 968,85, per «medaglie ed antiche mone-te»), n. 419 (19/9/1842: lire 671,70, per «antiche monete»);inv. 4339/A, n. 510 (10/7/1847: lire 543,70 per «monete,medaglie ed oggetti di antichità»), n. 547 (20/10/1847: lire2.036,50 per «oggetti di antichità, monete e medaglie»). Iltotale della spesa ammonta a 31.240,52 lire.
104) LuPPI 1893, p. 384; Calendario Generale 1838, p.163.
105) Ast, sezioni Riunite, Casa di Sua Maestà, Conto deltesoriere privato di S.M. ..., cit., inv. 4329/A, n. 442
(2/10/1837: lire 1.646,90 per «provviste di libri e manoscrit-ti, di sigilli, d’antiche monete ed altri oggetti»); inv. 4330/A,n. 65 (22/1/1838: lire 2261,20 per «provviste fatte (...) a van-taggio della Regia Biblioteca e medagliere»), n. 192(26/4/1838: lire 1.409,15 per «spese (...) pel Regio meda-gliere e Biblioteca»), n. 239 (27/6/1838: lire 490,75 per«spese fatte per la Regia Biblioteca e R.io medagliere»), n.420 (30/10/1838: lire 1.513,90 per «antiche monete e meda-glie ed altre provviste»); inv. 4331/A, n. 250 (4/6/1839: lire492,60 «per servizio della Biblioteca e del medagliere»), n.483 (2/11/1839: lire 313,20 «per servizio della R.a Bibliotecae del R.o medagliere»), n. 603 (21/12/1839: lire 861, idem);inv. 4332/A, n. 134 (10/3/1840: lire 599,42, «varie provvi-ste»), n. 298 (12/6/1840: lire 1.300,45, «medaglie, moneteantiche e da altre spese»), n. 384 (21/7/1840: lire 990,45,«provviste di medaglie e di libri»), n. 427 (18/9/1840: lire1.981,75), n. 438 (26/9/1840: lire 814,05, «prezzo di meda-glie e di libri»), n. 524 (19/11/1840: lire 535,45); inv.4333/A, n. 92 (5/2/1841: lire 1.135,45), n. 157 (12/3/1841:lire 1.018,29), n. 230 (12/4/1841: lire 460,90), n. 250(8/6/1841: lire 1.275,20, per «libri, disegni e monete, emedaglie»), n. 392 (7/9/1841: lire 1.466,90, idem); inv.4334/A, n. 141 (22/3/1842: lire 1.999,70); inv. 4335/A, n.362 (10/2/1843: lire 943,90 per «antiche medaglie e mone-te, disegni, stromenti ed altre cose»), n. 635 (2/11/1843: lire935,50, «prezzo di libri, di medaglie e di monete antiche»);inv. 4336/A, n. 741 (febbraio 1845: lire 4.342,75, «prezzo dimanoscritti, libri, monete e medaglie antiche»); inv. 4337/A,n. 481 (1/8/1845: lire 1.107,20), n. 575 (2/12/1845: lire698,25 per «libri, manoscritti e monete antiche»); inv.4338/A, n. 175 (5/2/1846: lire 1.648,20 per «libri, medagliee monete antiche»), n. 246 (10/4/1846: lire 1.077,62 per«libri, manoscritti e monete antiche»), n. 435 (5/9/1846: lire578,85 per «libri, manoscritti, monete ed oggetti di anti-chità, ed altre spese»); inv. 4339/A, n. 74 (16/1/1847: lire2.694 per «libri manoscritti, sigilli, medaglie e monete anti-che»), n. 159 (13/3/1847: lire 2.321 per «manoscritti, libri,medaglie e monete antiche»). La spesa totale ammonta alire 38.385,13.
106) Ibidem, inv. 4336/A, n. 608 (lire 77,50 «a Busca Gio.Ant. neg. in torino, prezzo di gettoni in Avorio provvistipel medagliere di s.m.»).
107) Ibidem, inv. 4340/A, n. 99 (marzo 1848: lire 1.219,50per «spese a vantaggio del R.io medagliere» nel 1847), n.236 (luglio 1848: lire 885 per spese «a vantaggio della R.Biblioteca e del R. medagliere»); inv. 4341/A, n.11(5/1/1849: lire 1.713,15 per «libri, monete e medaglie»acquistate nel 1847), n. 414 (7/12/1849: lire 355,60 «peracquisti a vantaggio della R.a Biblioteca e del R.o medaglie-re»). Il totale ammonta a lire 4.173,25.
108) Ibidem, inv. 4326/A, n. 318 (23/8/1834: lire 5.050«per una collezione di medaglie antiche italiane»). Il conteGiovanni Girolamo sarà podestà di Verona tra 1838 e 1848.
109) ORtI mAnARA 1825, lettere dedicate all’abate Giu-seppe Venturi e al marchese Ferdinando zenetti (monetescaligere e viscontee); ORtI mAnARA 1828, lettera dedicataal tenente colonnello degli ussari, Carlo Giovanni Gyurts’akde Gyurtsa’k–Falva; e ORtI mAnARA 1827, con dediche amichele Lopez, direttore del museo di Parma, dove sonoconservate le monete, a Pietro Vitali dell’università diParma e al cav. Bartolommeo Borghesi.
110) PARAVIA 1877, pp. 35 e 36.
68
111) Ibidem, pp. 113–114, 125, 141 e 154.
112) Ibidem, p. 223. Charles Louis Rollin (1777–1853) fucambiavalute, poi convertito allo studio e al commercionumismatico, esercitato in esclusiva a partire dal 1834 conl’aiuto del figlio, Camille (1813–1883), al quale si associònel 1860 l’editore Felix Feuardent (1819–1907) (MedievalEuropean Coinage 1986, p. 410).
113) PARAVIA 1877, pp. 448 e 449. Il Cordero (mondovì1778 – torino 1851) fu studioso di architettura, archeolo-go (primo conservatore del museo Egizio) e numismatico(Della zecca 1821; Recensio numorum veterum 1826;CORDERO DI sAn QuIntInO 1834; Dell’instituzione dellezecche 1836; Notizie sopra alcune monete 1837; CORDERODI sAn QuIntInO 1845; Monete del decimo 1846; DellaZecca 1847).
114) Ast, sezioni Riunite, Casa di Sua Maestà, Conto deltesoriere privato di S.M. …, cit., inv. 4327/A, n. 120(7/3/1835: «una collezione di medaglie e sigilli provvista almedagliere della ms nel 1834»).
115) Ibidem, inv. 4335/A, nn. 140 (16/2/1843: lire 500,«viaggio e soggiorno fatto a Venezia per esaminare la colle-zione di antiche medaglie e monete posseduta dal sig.Conte Gradenigo»); nn. 258, 344. La pensione venne rego-larmente pagata al Gradenigo sino al 1850, ultimo anno delquale sia stato possibile verificare la contabilità privata deireali.
116) Ibidem, inv. 4335/A, n. 253 (4/4/1843: lire 515,50,«viaggio fatto a Venezia all’oggetto di ritirare la collezionenumismatica che la m.s. ha acquistato dal sig. Conte Grade-nigo»).
117) BABELOn 1901, col. 242; Collezioni di antichità1988, pp. 102 e 103, 132–134, 114 e 115; e FAVAREttO1990, pp. 202 e 203.
118) ARRIGOnI 1741–1759; e BAssOLI 1985, pp. 34 e 45.L’opera è riportata nell’inventario del 1848 della BibliotecaReale (vedi infra, nota 159). tOnDO 1990, pp. 192–194, citala revisione del catalogo arrigoniano pubblicata dall’abatefiorentino sestini (sEstInI 1805), ma crede di trovare la con-ferma della presenza di monete dell’Arrigoni della zecca diIasos di Caria nel catalogo ottocentesco della collezione delmuseo di Antichità di torino, che, come visto più sopra,deriva dal museo dell’università e nulla ha a che fare con ilmedagliere Reale.
119) VOn sChELLERshEIm 1800. Il barone Freiherr vonschellersheim visse a Firenze, fu collezionista di antichità(primo acquirente del tesoro tardoromano dell’Esquilino:Aurea Roma 2000, p. 142, e di monete (sEstInI 1796), non-ché scopritore del teatro romano di Fiesole (1809).
120) FAVAREttO 1990, pp. 103–107; e BODOn 2008, pp.121–139.
121) PROmIs 1870, pp. 323–327. Da segnalare anche lapresenza di una medaglia in rame del Bembo (inv.DC6787), con al rovescio Pegaso.
122) EIChE 1983, p. 357.
123) CORnAGLIA 1839–1840. nel 1866 l’Accademia cedet-te la collezione al museo dell’università, dove confluì anchela collezione personale del Cornaglia (GnECChI, GnECChI1903, p. 364).
124) Ast, sezioni Riunite, Casa di Sua Maestà, Conto deltesoriere privato di S.M. …, cit., inv. 4335/A n. 578(14/10/1843). sulla vicenda vedi anche GuERRInI, in corso distampa.
125) Fu ministro a Vienna (1821–1834), delle Finanze(1834–1835) e poi dell’Interno (1835–1841).
126) Lettera del 26 gennaio 1838 (PARAVIA 1877, p. 387).nel maggio successivo, tuttavia, il ministro acquistò «alcunemedaglie» per 80 lire (ibidem, p. 408).
127) Ast, sezioni Riunite, Casa di Sua Maestà, Conto deltesoriere privato di S.M. …, cit., inv. 4337/A, n. 307(10/5/1845: lire 785,77).
128) Ibidem, inv. 4339/A, n. 410 (13/7/1847: lire1.346,20).
129) Calendario Generale 1841, pp. 121, 127, 177 e 183.
130) Ast, sezioni Riunite, Casa di Sua Maestà, Conto deltesoriere privato di S.M. …, cit., inv. 4339/A, n. 432(10/7/1847: lire 338, per «oggetti di anichità e medaglie»).
131) Ibidem, inv. 4338/A, n. 157 (5/3/1846: lire 340).
132) Ibidem, inv. 4331/A, n. 477 (28/1071839: lire 424,per «libri, disegni e medaglie»); inv. 4339/A, n. 462(16/9/1847: lire 39, per «medaglie»).
133) Ibidem, inv. 4335/A, n. 269 (19/4/1843: lire 185,50,per «libri e medaglie antiche»); inv. 4336/A, n. 406 (giugno1844: lire 75, per «un’antica moneta, un anello d’oro pureantico, ed alcuni libri»), n. 542 (settembre 1844: lire 697,per «due antichi pugnali e varie antiche monete»), n. 765(marzo 1845: lire 258, per «due antiche monete e libri»);inv. 4338/A, n. 101 (5/2/1846: lire 1.895,50, per «libri, stam-pe, monete ed oggetti di antichità»), n. 520 (13/10/1846: lire401, per «libri e monete»); inv. 4339/A, n. 394 (10/7/1847:lire 60, per «una moneta d’oro»); inv. 4340/A, n.,159 (aprile1848: lire 351,50, per «medaglie e antiche monete»); inv.4341/A, n. 401 (25/11/1849: lire 204,50, per «libri e moneteantiche»).
134) Ibidem, inv. 4331/A, n. 507 (21/12/1839: 117 scudiromani, pari a 643,50 lire).
135) Ibidem, inv. 4336/A, n. 412 (giugno 1844: lire 1.141,per «antiche monete d’oro, d’argento e di rame»); inv.4339/A, n. 428 (4/8/1847: lire 3.266, per «antiche moneted’oro, argento e rame»).
136) Ibidem, inv. 4338/A, n. 448 (5/9/1846: lire 135).
137) Ibidem, inv. 4329/A, n. 130 (16/2/1837: lire 1.495).
138) Ibidem, inv. 4329/A, n. 314 (4/7/1837: lire 350).
139) Ibidem, inv. 4329/A, n. 380 (17/8/1837: lire 120).Verrebbe da pensare si trattasse di reperti dall’antica Luni.
140) Ibidem, inv. 4330/A, n. 198 (30/4/1838: lire 508).
141) Ibidem, inv. 4332/A, n. 272 (11/5/1840: lire 40, «atitolo di mancia»).
142) Ibidem, inv. 4334/A, n. 526 (17/9/1842; lire 1.500).
143) Ibidem, inv. 4338/A, n. 205 (24/2/1846: lire 6).
144) Ibidem, inv. 4338/A, n. 542 (13/10/1846: lire 200).
145) Ibidem, inv. 4340/A, n. 81 (marzo 1848: 150 lire).
69
146) Ibidem, inv. 4331/A, n. 480 (8/10/1839: lire 323), n.545/2 (31/12/1839: lire 2, per le «spese di trasporto»).
147) Ibidem, inv. 4332/A, n. 274 (23/5/1840: lire 40 all’e-conomo generale Giuseppe Confalonieri per «una monetaantica d’oro comprata per conto di s.m.»); inv. 4338/A, n.410 (8/8/1846: lire 20 al sovrintendente generale Di Casta-gnetto per «un’antica moneta d’oro presentata a s.m.» daGiuseppe troglia).
148) Ibidem, inv. 4325/A, n. 203 (3/6/1833: lire 31,80 perle prime sei medaglie della serie). Di questo incisore L. FOR-RER 1916, p. 8, conosce la medaglia del dottor s. Di Ruggie-ro salernitano, nonché (ibidem, vol. VIII, p. 231) quelle di P.Ovidio nasone, Bernini, Vitruvio, torquato tasso, FlavioGioia, su disegno, al diritto, di V. Catenacci e al rovescio diA. Arnaud.
149) Autore sconosciuto al Forrer. Risulta l’acquisto diuna medaglia di Alcmeone (Ast, sezioni Riunite, Casa diSua Maestà, Conto del tesoriere privato di S.M. …, cit., inv.4325/A, n. 396: 6/11/1833, lire 5,30) e di una del medicosalernitano trotula (ibidem, inv. 4326/A n. 431: 13/12/1834,lire 5,30).
150) Risultano acquistati dieci esemplari della secondamedaglia della serie, quella dedicata a Luigi Lagrange (ibi-dem, inv. 4329/A n. 126: 31/1/1837, lire 50), altri dieci dellaterza, per Lorenzo Cigna (ibidem, n. 216: 17/4/1837), dellaquarta, per Vittorio Alfieri (ibidem, n. 376: 10/8/1837, lire50), della quinta e della sesta, per Giambattista Beccaria etommaso Valperga Caluso (ibidem, inv. 4330/A, n. 139:24/3/1838, lire 100), della settima e dell’ottava, per il contenapione e per Carlo Botta (ibidem, inv. 4332/A, n. 567:31/12/1840, lire 100), della nona, per Giovan Battista Bogi-no (ibidem, inv. 4333/A, n. 379: 11/8/1841, lire 50), delladecima, per Giuseppe Vernazza (ibidem, inv. 4334/A, n. 72:14/1/1842, lire 50), dell’undicesima e della dodicesima, peril chimico Giobert e per Vassalli Eandi (ibidem, inv. 4334/A,n. 518: 8/12/1842, lire 100), della tredicesima e della quat-tordicesima, per Franco Bonelli e Giovan Battista Bodoni(ibidem, inv. 4335/A, n. 279: 18/471843, lire 100), e dellaquindicesima, per Diodata saluzzo (ibidem, inv. 4337/A, n.314: 7/5/1845, lire 50).
151) Personaggio quasi sconosciuto, nativo di Vigevano,sulla cui attività a torino vi sono poche notizie: FORRER1904, II, p. 189, e FORRER 1923, p. 336 (lo chiama Giusep-pe e non Gaspare); FAVA 19802, III, pp. 980 e 981, 985–990,1442; FAVA 1995, pp. 50 e 51; PEnnEstRì 1995, p. 208 e fig.a p. 212; PEnnEstRì 1998, pp. 401 e 402. Dalla contabilitàprivata reale sappiamo che fornì anche medaglie in rame edargento rappresentanti la m.s. ed il monumento ad Ema-nuele Filiberto (Ast, sezioni Riunite, Casa di Sua Maestà,Conto del tesoriere privato di S.M. …, cit., inv. 4331/A n.482, 2/11/1839, lire 800; inv. 4333/A n. 134, 11/2/1841, lire210; inv. 4334/A n. 334, 13/8/1842, lire 80), ed un «meda-glione a cameo su pietra rappresentante il monumento eret-to a s.m. in Casale» (ibidem, inv. 4339/A n. 241, 23/4/1847,lire 300). sue medaglie sono raffigurate in COmAnDInI1902–1907, pp. 289, 446, 588, 805, 895, 967, 980 e 1140.
152) Ast, sezioni Riunite, Casa di Sua Maestà, Conto deltesoriere privato di S.M. …, cit., inv. 4329/A, n. 268:8/6/1837, sei esemplari a lire 35 ciascuno. Questa medagliaè l’unica dell’autore genovese che sia nota al FORRER 1912,p. 565.
153) Ibidem, inv. 4329/A n. 520 (25/11/1837): «Largizioneda sm concessagli per il conio da lui fatto d’una medagliarappresentante Cristoforo Colombo».
154) su questo incisore di gemme e medaglie, morto nel1850: FORRER 1904, II, p. 274; e FORRER 1923, p. 368.
155) Fu incisore di monete e medaglie e direttore dellazecca (1793–1869): FORRER 1904, I, pp. 386–388; e FORRER1923, p. 172.
156) Ast, sezioni Riunite, Casa di Sua Maestà, Conto deltesoriere privato di S.M. …, cit., inv. 4338/A, n. 518(13/10/1846: lire 134,40).
157) Ibidem, inv. 4340/A, n. 248 (agosto 1848: lire 16,80).
158) Ibidem, inv. 4342/A, n. 273 (28/2/1850: lire 16,80).
159) Ast, Versamento Genio Civile 1936, mazzo 13, n.41, Inventario originale. sulla prima pagina è indicatoCatalogo dei libri stampati della Biblioteca di S.M. il reCarlo Alberto a tutto li 8. marzo 1848. seguono gli inventa-ri delle carte geografiche, dei manoscritti, delle Monete emedaglie esistenti nel medagliere di S.M. e dell’Armeria,senza ulteriori date di compilazione. una copia del solomedagliere, non datata, è in Ast, sezioni Riunite, Casa diSua Maestà, Conto del tesoriere privato di S.M. …, cit., inv.4770 (Dotazione della corona/Medagliere/Inventario).
160) si tratta di otto volumi, con i pezzi numerati einventariati singolarmente, per una stima totale di168.655,85 lire (compreso il n. 28.598, «un vaso di porcella-na di Persia di forma ovale dipinto a fiori e foglie di varicolori, munito di maniglie» del valore di 500 lire), «condichiarazione che tutti gli oggetti furono senza difficoltàvalutati dallo Incaricato dell’Inventario stesso, per cui non siebbe a ricorrere all’intervento di alcun perito». Purtroppoquesto redattore non si è firmato. La sua dichiarazione èdatata torino, 1887. una nota manoscritta aggiunta alprimo volume — per confermare l’entità patrimoniale delRegio medagliere il giorno 8 gennaio 1912, a cura dellaDirezione Provinciale della Real Casa in torino, firmata dal-l’incaricato dell’Intendenza di Finanza, ing. michele sicari,dall’incaricato della Real Casa, V. Quenda, dal DirettoreBoas e da funzionari del ministero delle Finanze e del mini-stero della Real Casa — specifica che questo inventario erastato «chiuso con verbale in data 4 febbraio 1886». L’inven-tariazione dei beni mobili pertinenti agli edifici reali ebbenotevole impulso nel 1879, con una circolare del ministerodella Real Casa che ne fissò una precisa normativa di com-pilazione, in concomitanza con l’ascesa al trono di umbertoI (mAssABò RICCI 1986, pp. 116–118; BERtAnA, CAmBuRsAnO1986, pp. 133–135).
161) Per la storia della gestione della casa reale sabauda:mAssABò RICCI 1986, pp. 108–112.
162) L’incontro è confermato da un appunto autografo diCarlo Alberto, dove sono annotate le tappe del viaggio d’e-silio con i fatti principali: qui è riportato «le 26 à Antibes» e«Le Commandant d’Antibes, Castagnetto et Dogliotti» (F.sALAtA 1931, pp. 445–449).
163) RODOLICO 1943, pp. 573 e 574.
164) Ast, sezioni Riunite, Casa di Sua Maestà, Gabinet-to dell’Intendente Generale, inv. 3427 (già 38/7). La relazio-ne continua poi: «un sovrano che in si strette circostanzericusi inoltre di ripetere il valore di ricchi e preziosi oggetti,
70
di cui è provveduta la Corona a decoro dello stato, ascen-dente come dalla tabella n. 2 [manca] a £ 1.386.016,03 (...)non sarà egli secondato (...) colla sanzione all’uopo dell’au-mento di £ 200/m. alla Lista Civile (...) onde fargli libere lerendite del privato suo Patrimonio sopra le quali egli vuolefondanti unicamente i mezzi della decente sua sussistenza?».
165) FERRACCIù 1934, p. 271. secondo il giurista, il reesercita su questi beni un diritto pubblico patrimoniale digodimento, che non è assimilabile né all’uso (più ampio), néall’usufrutto (più ristretto), quali previsti dal codice civileitaliano.
166) ALIBRAnDI, FERRI 1988, p. 19.
167) si tratta di cinque volumi rilegati, senza frontespizio,dello stesso tipo di quelli della Dotazione della Corona. nelquarto volume una nota manoscritta, aggiunta a matitadopo il numero di inventario 8970, segnala: «Carico fino al29 maggio 1886, epoca di compilazione dell’inventario».L’ultimo gruppo di oggetti inventariati (nn. 8919–8970),dopo monete, medaglie, bolle e sigilli, sono gli «oggetti con-servati nella sala del medagliere di s.m.». Poi l’inventarioprosegue, sino al numero 10.366, con materiali numismaticie non, aggiunti via via senza raggruppamenti per classi, eviene chiuso il 31 dicembre 1891 con presa in carico daparte dell’archivista della Biblioteca Reale (Luigi Pezzi), delcompilatore (G. martinengo) e del Direttore (G. sala?). Ilvolume è poi interamente compilato con nuovi numeri (sinoal 10.609), sempre nello stesso modo. Il volume successivo,la cui legatura denuncia una creazione posteriore agli altriquattro, continua sino al numero 10.866 senza chiusure, néulteriori date, ma è evidente una formazione nei primi annidel ’900, per la presenza di alcune monete e medaglie data-bili all’inizio del secolo.
168) sigilli erano certamente presenti, infatti, nella colle-zione Gradenigo e in altri acquisti sopra citati.
169) A differenza di quanto sostenuto da: FAVA 1967, p.43; D’InCERtI 1971, p. 241; e tRAVAInI 1991, p.37.
170) Art. 20: «Oltre i beni che il Re attualmente possiedein proprio formeranno il privato suo patrimonio ancoraquelli che potesse in seguito acquistare, a titolo oneroso ogratuito, durante il suo regno’, e art. 29: ‘tutte le proprietà,senza alcuna eccezione, sono inviolabili» (ALIBRAnDI, FERRI1988, p. 12). una parte dei beni della corona furono cedutial demanio da Vittorio Emanuele III, con il Regio Decreto1792 del 3 ottobre 1919, data che segnò il momento inizia-le del passaggio delle proprietà reali allo stato (mELOGRAnI1998, pp. 184–190).
171) Ast, sezioni Riunite, Casa di Sua Maestà, Conto deltesoriere privato di S.M. …, cit., inv. 4342/A, n. 69(28/2/1850: lire 348,65 in rimborso di spese sostenute nelquarto trimestre 1849), n. 108 (26/5/1850: lire 900, «peressere impiegate secondo le sovrane intenzioni»), n. 291(20/8/1850: lire 120).
172) tEttOnI 1874, p. 128.
173) GnECChI, GnECChI 1903, pp. 61 e 62, riportano unammontare di 12.574 pezzi tra monete greche, romane,italiane e medaglie. Gian Giacomo lasciò in eredità (1902)biblioteca, pinacoteca e collezione numismatica al nipote,che portava lo stesso nome, figlio di Luigi Alberico. Questiacquistò dal figlio, nel 1926, il museo e ne iniziò neglianni ’30 l’alienazione (PEttEnAtI 1996, p. 188). Le mone-
te italiane vennero vendute in due aste distinte, per untotale di 4.082 lotti, dalla ditta michele Baranowsky dimilano: Ricca collezione numismatica di antica e nobilefamiglia dell’Italia settentrionale e di altri amatori. Mone-te di zecche italiane dalla caduta dell’impero romano ainostri tempi. Parte I: monete avanti il Mille di tutte leregioni. Parte II: Monete dal Mille in avanti dalle regionisettentrionali (23 giugno 1931). Parte III: Monete di zec-che italiane, Toscana, Stato Pontificio, Meridione d’Italia eSicilia. Monete Estere (2 febbraio 1932) (CLAIn stEFAnEL-LI 1985, p. 900, n. 10229).
174) AmBROsOLI 1890, p. 155.
175) GnECChI, GnECChI 1903, p. 363.
176) Vedi infra alla nota 185.
177) tEttOnI 1874, pp. 24 e 25, computa circa 10.000monete greche, altrettante romane, 3.000 di Casa savoia,7.000 italiane, 1.200 sigilli, 3.000 medaglie, più bolle e sigil-li in cera. Gli inventari del 1886 forniscono un quadro leg-germente diverso (cfr. tabelle 1 e 2 a fondo testo): 11.394monete greche, 10.444 romane (le bizantine sono incluse),873 savoia, 9.561 italiane, 3.651 medaglie.
178) tRAVAInI 1987, p. 187; tRAVAInI 1991, p. 153; e tRA-VAInI 1997, pp. 54 e 55.
179) tRAVAInI 1991, pp. 31, 70 e 71, e passim.
180) nel luglio del 1943 il totale era di 106.788 pezzi(D’InCERtI 1971, p. 247). Dopo la guerra risultarono man-canti un centinaio di monete d’oro, rubate, e tutte le mone-te sabaude, portate con sé dal re in esilio (ibidem, p. 260).umberto II morendo, nel 1983, fece dono della sua colle-zione allo stato italiano (BALBI DE CARO 1983): è moltoprobabile che in questo modo sia stato ricostituito il nucleooriginario.
181) «Ritirò dal medagliere privato di sua maestà ditorino (...) tutte le monete, in numero di 6.038, ed immisenella sua raccolta quelle di esse che vi mancavano» (D’In-CERtI 1971, p. 249). Il numero totale dei pezzi prelevati èpiù alto di quello calcolato sulla base degli inventari (tAB.2), probabilmente perché comprende anche altri oggetti(medaglie, onorificenze, miniature, ecc.) qui non presi inconsiderazione.
182) traggo le notizie da GnECChI, GnECChI 1903, allesingole voci: Vienna, Kunsthistorisches hofmuseum:200.000; Copenhagen, Regio Gabinetto numismatico:120.000; Parigi, Biblioteca nazionale: 232.000; Berlino,Regio Gabinetto numismatico: 200.000; monaco di Bavie-ra: 220.000; Londra, British museum: 200.000; e madrid,museo Archeologico: 120.000.
183) Ibidem, p. 297 (17.970 pezzi).
184) Ibidem, pp. 286 e 287 (39.438 pezzi). sul collezioni-sta: PAnVInI ROsAtI 1977, pp. 345–349; e BAssAnELLItOGnOLI 1979, pp. 19–34 (acquisto di 10 dramme padanerinvenute intorno al 1854 a Varzo e Ornavasso).
185) tRAVAInI 1991, pp. 110, 149 e 150.
186) Catalogo della raccolta 1925 (17.637 pezzi).
187) COsmI 1955 (16.699 pezzi).
188) GnECChI, GnECChI 1903, pp. 338–340 (20.292pezzi).
71
189) Ibidem, pp. 281 e 282 (35.000 pezzi).
190) L’Autore fu, a partire dal 1774, direttore della sezio-ne di numismatica classica del museo di Corte a Vienna: lasua opera, in otto volumi, comprendeva tutta la monetazio-ne greca e romana, e costituì la base per ogni ulteriore svi-luppo della numismatica antica. Venne interamente ristam-pata tra il 1828 ed il 1839 (BABELOn 1901, coll. 187 e 188;BAssOLI 1985, p. 40).
191) In questo sono inclusi, in appendice, i re longobardie d’Italia.
192) ticino, trento, trieste, Gorizia.
193) Il medagliere 1964.
194) FAVA 1967, p. 46.
APPEnDICE
Ast, Archivio di Corte, Materie politiche per rapporto all’in-terno, Gioie e Mobili, mazzo 2, n. 6 (anno 1631)
Nota delle Medaglie d’oro Argento e metallo che sono nelleguardarobbe di S.A.R. a carico del S. Alamandi e delTapissere il qual hà quelle d’oro e d’argento Nel Palazzodietro S.Gio[vanni].
«nota delle medaglie e monete ritrovate nella GuardarobbaDi s.A.R. doppo il ritorno di m.R. dalla savoiaEstratta da una minuta d’Inventaro communicatomida mons.r Denis
una cassetta di noce con dodici tiretti et 15 medaglie pertiretto
un Gabinetto di bosco negro con 12 tiretti foderatti di sati-nada verde e ornati di madreperle dentro quali si son tro-vate medaglie mezane 131 et altre 14 per grandi
una cassetta di noce a 12 tiretti con 12 medaglie doppiecornisate per cadun tiretto eccetto in due tiretti ne qualimancano due per tiretto
Altra cassetta di noce con ondici tiretti di medaglie tuttivacui
Altra cassetta di noce con dodici tiretti et 12 medaglie cor-nisate per ogni uno
Altra scatola d’Ebano con tavole 6 ne quali vi sono meda-glie antiche 39 per caduna et una di più per ognuna d’es-se tavole
Altra scattola d’Ebano simile con altretante tavole e meda-glie
Più altra simile con altretante tavole e medagliePiù altra simile con altretante tavole e 239 medaglieuna scatola di bosco con 21 medaglie parte de quali son
dorateun libro con sei tavole a modo di pagine di colore rosso
con 48 medaglie per tavola, et 2 altre con 36 medagliel’una
Più un piccol scrittorio fodrato di veluto verde con tavolesei con 22 medaglie l’una et due di più fuori delle tavole
Altro piccol scrittorio fodrato di veluto nero e coperto dicorame dorato con sei tavole ne quali si son trovatemedaglie 130 [o 131?]
un scrittorio coperto di corame negro dorato e fodrato diveluto negro con tavole sei ne quali si sono trovate meda-glie o sia monete la maggior parte di casa savoia 253delle quali una di Carlo 2° si è levata per mostrarla am.R. [a margine: monete di casa savoia]
una piccola cassetta coperta di corame negro dorato eargentato fodrato di baretta verde dentro la quale si sontrovate Piastre di basso rilevo ornate d’Argento 14 Piùnumero 21 medaglie d’Argento grandi mezane, e piccole[a margine: medaglie d’argento]
Più altro scrittorio coperto di ciagrino profilato d’oro, efodrato di veluto negro con tavole otto ne quali si sonotrovate medaglie 195 La maggior parte d’oro e qualche-dune d’argento e metallo indorato. Descritte in un bollet-tino che si è trovato e rimesso in detto scrittorio [a margi-ne: D’oro e Argento]
Più altro scrittorio coperto di corame negro ciagrinato, efodrato di veluto nero con tavole sei, et medaglie 39d’oro per caduna tavola, con più medaglie num. 7 oroinvolte in carta. Più altra medaglia d’oro di scipione Afri-cano. una catena di medaglie 25 d’oro, et altro meda-glione d’oro con diversità d’armi smaltate. [a margine:D’oro 268]
un Effigie grande di Cotton [?] dorato di Ludovico Duodecimouna borsa di veluto solio cremesino con medaglie 1337
d’Argento comprese 87 involte in carta [a margine: D’ar-gento]
una borsa di veluto verde dentro la quale si sono ritrovatemedaglie d’argento piccole numero 1200 [a margine:Argento]
un protratto di Carlo Em. d’alto rilievo rotondo d’oro odorato [a margine: Oro]
Cinque medaglie d’argento piccole con le cornici d’ossa [amargine: Argento]
una scatola verde dentro la quale si sono ritrovate moneted’Argento 729 de quali quattro si sono levate per farvedere a madama Reale l’arma di Cipro portata sin daquei tempi da Duchi di savoia [a margine: monete disavoia d’Argento]
una borsa di corame con 400 denari d’argento col fert dauna parte e dall’altra la croce savoia [a margine: Disavoia d’Argento]
Più nella medema borsa in un invoglio di carte numero 96Dinari d’argento coll’impronto dell’arma di saluzzo
Più in altro Invoglio Dinari d’argento per grandi numero21 con l’arma di savoia et altre [a margine: Di savoiad’Argento]
Più denari separati in altra carta n. 86 di liga con Croceuna laietta coperta di corame negro dorato fodrata di velu-
to negro con sei tavole quattro de quali hanno 12 meda-glie antiche l’una et l’altre due 13 l’una
Altra laietta come sopra con 6 tavole 3 delle quali hanno 18medaglie l’una l’altra 19 altra 23 et altra 25
Altra laietta simile a sei tavole due con 22 medaglie l’unanell’altre quattro 31, 27, 25 e 33 per ciascuna
altra layetta simile a sei tavole guarnite di medaglie vecchiedi metallo cioe in due 33 per ciascheduna e nelle altrequattro 33–21–24 e 25
una scatola longa dentro la quale si sono trovati 127 viluppidi carta con diverse medaglie parte d’Argento parte dimetallo et alcune d’oro [a margine: Oro et Argento]
Altra laietta a sei tavole con medaglie 145 in tuttouna cassetta fodratta di satino celeste operato con 508
medaglie
72
una scatoletta bianca con 19 medaglieuna layetta verde con dodici tavole con 327 medaglie in
tuttoDodeci medaglie di metallo ligate insiemePiù 78 medaglie di metallo sopra 3 tavole censa [?] la Cas-
siettaPiù 12 Imperatori in un cartone che s’apre con L’InscrittionePiù una laietta coperta di corame negro fodrato di veluto
negro con 146 medaglie sovra sei tavoleAltra laietta rossa dorata fodrata di satinada verde con 238
medaglie sovra nove tavoleuna cartella di satinada rossa con cinque medaglieAltra laietta negra dorata con 90 medaglie sovra otto tavoleAltra verde dorata e fodrata di veluto verde con 115 meda-
glie sovra sette tavolePiù dentro due coperti di bosco 274 medaglie piccole ligate
in osso parte bianco e parte negroPiù una laietta negra fodrata di satinada rossa con 36
medaglie in tre tavole
una scattola di bosco con 6 tiretti guarniti di medaglienumero cento e una et un sacchetto di tela con medaglie1680 piccole
una laietta grande corame negro profilata d’oro fodrata disatinada verde con 373 viluppi di medaglie antiche
Li 28 Aprle 1631 nella guardarobba di s.A.R. [il mese sem-bra riscritto su: xbre]
Primo una scatola di corame rosso nella quale vi sono seitavole con 12 medaglie di teste antiche per tavola
Altra scatola più piccola di corame negro fodrata dentrod’ormesin verde ove vi sono otto tavole con 72 medagliedi teste antiche fra quali ve ne sono 18 dorate
Altra scatola di corame con un toro dorato sopra nellaquale vi sono 7 tavole con 55 medaglie in tutto
Altra scatola negra con il toro nella quale vi sono sei tavolecon 46 medaglie».
73
182
1 – torino, palazzo reale, sala del medagliere, particolare dei dipinti e degli stucchi della volta
pietro ayres e diego marielloni: la musa euterpe (?)
archivio fotografico delle collezioni alinari 1972
archivio fotografico sBsae Piemonte = archivio fotografi-co della soprintendenza per i beni storici, artistici edetnoantropologici del Piemonte, torino
armeria reale di torino, archivio storico, Inventario RegioMedagliere S.M., voll. i–v
ast = archivio di stato, torino
ast, archivio di corte, Archivio Alfieri, mazzo 28, StatoDescrittivo de’ Quadri Esistenti negli Appartamenti delReale Palazzo di Torino, 1822
ast, archivio di corte, Materie politiche per rapportoall’interno, Gioie e Mobili
ast, Genio Civile
ast, sezioni riunite, Archivio Thaon di Revel
ast, sezioni riunite, Camerale Piemonte, art. 217, RegistroSpese della Real Casa, 1836
ast, sezioni riunite, Camerale Piemonte, art. 687, RegistroPatenti
ast, sezioni riunite, Casa di Sua Maestà
ast, sezioni riunite, Casa di Sua Maestà, Conto del teso-riere privato di S.M., per l’Amministrazione dei ServiziSecreti ordinati da S.M.
ast, sezioni riunite, Casa di Sua Maestà, Gabinetto del-l’Intendente Generale
ast, sezioni riunite, Casa di Sua Maestà, Inventario delleGioje della Corona, 1725–1757
ast, sezioni riunite, Casa di Sua Maestà, Minutaro deiContratti e delle Sottomissioni
ast, sezioni riunite, Casa di Sua Maestà, Parcelle e Conti
ast, sezioni riunite, Casa di Sua Maestà, Registro Manda-ti del Bilancio Generale
ast, sezioni riunite, Casa di Sua Maestà, Testimoniali diStato dei Beni Immobili facenti parte della Dotazionedella Corona in provincia di Torino
ast, sezioni riunite, Patenti Controllo Finanze
ast, sezioni riunite, Real Casa, Inventario Mobili diDotazione della Corona, 1880–1908, voll. 1–7
ast, sezioni riunite, Real Casa, Inventario Palazzo Gran-de Dotazione della Corona, 1850 circa
ast, sezioni riunite, Real Casa, Inventario Palazzo Reale,1966, voll. i–iii
ast, sezioni riunite, Real Casa, Progetto di bilancio perl’anno 1835
ast, versamento Genio civile, 1936, mazzo 13, n. 41, Inven-tario originale
Palazzo reale di torino, Inventario dei Mobili esistenti nelR. Palazzo di Torino e Fabbricati dipendenti. Dotazionedella Corona, 1879–1880
183
Fonti archivistiche
mAnOscRITTI
venezia, Biblioteca del museo correr, FondoGradenigo–dolfin, ms. 65, G. GRevemBROch, Varie venetecuriosità sacre e profane, 3 voll.
Ibidem, ms. 108, G. GRevemBROch, Antichità sacre e profane,3 voll.
cInquecenTIne
Icones imperatorum Romanorum e priscis numismatibus advivum delineatae, Bruges 1558 (ed. italiana Anversa1559)
F. PInGOne, Augusta Taurinorum, Torino 1577
Thesaurus rei antiquariae uberrimus ex antiquis tam numis-matum quam marmorum inscriptionibus pari diligentiaqua fide conquisitus ac descriptus et in locos communesdistributus, Anversa 1575
sTAmPATI
s.d.
A. mAnnO, Il Patriziato Subalpino. Dizionario genealogico,dattiloscritto in 29 volumi, Torino (www.vivant.it)
1741–1759
O. ARRIGOnI, Numismata quaedam cuiuscunque formae etmetalli Musei Honori; Arigoni veneti ad usum juventutisrei nummariae studiosae, 4 voll., Treviso
1758–1771
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts etdes métiers ..., a cura di m. dIdeROT, m. d’ALemBeRT, Paris
1769
Le Medaglie del Museo di Sua Maestà eretto in Torino espli-catrici della gran tazza antica d’Agata Oriental figurata delMuseo Farnese, adesso Reale di Napoli a Capo di Monte:la quale rappresenta la venuta dell’imperatore Traiano inItalia dalla Germania l’anno di Roma DCCCLII e dellaquale si pubblica un nuovo esatto disegno, Torino
1781
O. deROssI, Nuova Guida per la Città di Torino, Torino
1796
d. sesTInI, Descriptio numorum veterum ex Museis Ainslie,Bellini, Bondacca, Borgia, Casali, Cousinery, Gradenigo,
Sanclemente, de Schellersheim, Verità etc. cum multis ico-nibus, Lipsiae
1798
Cariche del Piemonte e Paesi Uniti colla serie cronologicadelle persone che le hanno occupate ed altre notizie di nudaistoria dal fine del secolo decimo al dicembre 1798, Torino
1800
F. vOn scheLLeRsheIm, Numismata aurea antiqua indubita-te fidei familiarum, Augustorum, Augustarum, et Caesa-rum ad Heraclium usque, quae colligit et possidet liberBaro de Schellersheim, s.l.
1805
d. sesTInI, Catalogus numorum veterum Musei Arigonianicastigatus nec non descriptus et dispositus secundum siste-ma geographicum, Berlin
1813
G. veRnAzzA dI FReney, Vita di Giambatista di Savoia prin-cipe del sangue e notizia delle sue monete, Torino
1815
m. zucchI, Le raccolte di stemmi inedite della Biblioteca diS.M. il Re in Torino, in Bollettino della Consulta Araldica,vIII, 1815, pp. 3–26
1818
Raccolta di regj editti, manifesti, ed altri provvedimenti de’magistrati ed uffizi, vII, Torino, pp. 174–184, capo I, 7.
1819
m. PAROLeTTI, Turin et ses curiosités, Torino
1821
Della Zecca e delle monete degli antichi marchesi dellaToscana, Pisa
1822
G. BRIOLO, Nuova Guida dei Forestieri per la Reale Città diTorino, Torino
1825
G. G. ORTI mAnARA, Lettere sopra due medaglie inedite,verona
1826
Recensio numorum veterum qui apud haeredes cl. viri equi-
185
BIBLIOGRAFIA
A cuRA dI
ALessAndRA GueRRInI
tis ab. Joan. Baptistsae Incisa e comitibus S. StephaniAugustae Taurinorum asservantur, Torino
1827
G. G. ORTI mAnARA, Illustrazione di tre medaglie inedite conalcune notizie sopra un codice manuscritto inedito posse-duto dal prof. Vitali di Parma, verona
1828
G. G. ORTI mAnARA, Illustrazione di una medaglia ineditaspettante a Segesta e di due tori trovati nelle rovine dellastessa città, verona
1831
Dieci Giorni in Torino ossia Descrizione antica e modernadella Città, Torino
1832
c. GAzzeRA, Discorsi intorno alle zecche e ad alcune raremonete degli antichi marchesi di Ceva, d’Incisa e del Car-retto, in Memorie della Reale Accademia delle Scienze diTorino, xxxvII, pp. 47–122
1833
L. cIBRARIO, d. PROmIs, Documenti, sigilli e monete apparte-nenti alla storia della monarchia di Savoia, raccolti inSavoia, in Isvizzera ed in Francia per ordine del re CarloAlberto, Torino
1834
Calendario Generale pe’ Regii Stati, xI, Torino
L. cIBRARIO, d. PROmIs, Sigilli de’ principi di Savoia, Torino
G. cORdeRO dI sAn quInTInO, Descrizione delle medaglie deinomi, ossia delle province dell’antico Egitto, che si conser-vano nel Regio Museo di Torino, in Memorie della RealeAccademia delle Scienze di Torino, s. I, xxxvII, pp. 1–20
1836
Calendario Generale pe’ Regi Stati compilato d’ordine diS.M. per cura della Regia Segreteria di Stato per gli Affa-ri Interni, xIII, Torino
Collezione celerifera delle leggi pubblicate nell’anno 1836,Torino, pp. 461–481
Dell’instituzione delle zecche gia possedute dai marchesi diSaluzzo in Piemonte, Lucca
d. PROmIs, Recherches sur deux monnaies du Moyen Age surles quelles se trouve le mot Marsacona, in Revue de laNumismatique Françoise, I, pp. 348–354
Regolamento pel Servizio d’Arte dei Reali Palazzi, Fabbrichee loro dipendenze, in Atti del Governo di S.M. il Re diSardegna, vol. Iv, 140, Torino, pp. 469–503
1837
Calendario Generale pe’ Regii Stati compilato d’ordine diS.M. per cura della Regia Segreteria di Stato per gli Affa-ri Interni, xIv, Torino
Notizie sopra alcune monete battute in Piemonte dai conti diProvenza, Torino
1838
Calendario Generale pe’ Regii Stati compilato d’ordine diS.M. per cura della Regia Segreteria di Stato per gli Affa-ri Interni, xv, Torino
Catalogo dei Prodotti dell’Industria de’ R. Stati ammessialla pubblica esposizione dell’anno 1838 nelle sale delRegio Castello del Valentino e degli Oggetti di Belle Artiche ne accrescono l’ornamento, Torino
1839
sTendhAL, La Certosa di Parma, edizione consultata contraduzione di e. Tadini, milano 1993
1839–1840
c. cORnAGLIA, Museo Numismatico Lavy appartenente allaReale Accedemia delle Scienze, Torino
1840
d. BeRTOLOTTI, Descrizione di Torino, Torino
1841
Calendario Generale pe’ Regii Stati compilato d’ordine diS.M. per cura della Regia Segreteria di Stato per gli Affa-ri Interni, xvIII, Torino
1844
c. I. GIuLIO, IVa Esposizione d’Industria e di Belle Arti alReal Valentino. Giudizio della R. Camera d’Agricoltura eNotizie sulla Patria Industria, Torino
1845
G. cORdeRO dI sAn quInTInO, Delle monete dell’imperatoreGiustiniano II. Ragionamento, in Memorie della RealeAccademia delle Scienze di Torino, s. II, vIII, pp. 6–124
1846
Monete del decimo e dell’undecimo secolo scoperte nei dintor-ni di Roma nel 1843, Torino
T. vALLAuRI, Storia delle Università degli Studi del Piemon-te, III, Torino
1847
Della Zecca e delle monete di Lucca nei secoli di mezzo,Lucca
1851
G. cAsALIs, Dizionario geografico storico–statistico–commer-ciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, xxI, Torino
1854
Lettere inedite di Lodovico Antonio Muratori scritte a Tosca-ni dal 1695 al 1749, Firenze
1858
d. PROmIs, Monete dei Romani Pontefici avanti il Mille,Torino
c. ROveRe, Descrizione del Reale Palazzo di Torino, Torino
186
1859
v. dI sAnT’ALBInO, Gran dizionario piemontese–italiano, edi-zione consultata ristampa anastatica, Torino 1962
1862
A. cAImI, Delle arti del disegno e degli artisti nelle provinciedi Lombardia dal 1777 al 1862, milano
J. G. Th. GRAesse, Trésor de livres rares et précieux ou nou-veau dictionnaire bibliographique, III, dresden
1864
A. ROnchInI, Il Grechetto, in Atti e Memorie delle R.R.Deputazioni di Storia Patria per le province modenesi eparmensi, II, pp. 251–261
1865–1866
Il Comm. Domenico Promis espone le seguenti ricerche dalui fatte sopra alcune monete antiche scoperte nel Vercelle-se, in Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, I,pp. 159–170
1870
d. PROmIs, Sigilli italiani illustrati, in Miscellanea di StoriaItaliana, Ix, pp. 319–371
1873
G. cAsALe, Guida al Real Castello e Parco di Racconigi,savigliano (cn)
c. d. FInOcchIeTTI, Della scultura e tarsia in legno degliantichi ad oggi: notizie storico–monografiche, Firenze
1874
v. PROmIs, Sigilli italiani editi ed illustrati, in Miscellanea diStoria Italiana, xv, pp. 85–127
L. TeTTOnI, Della vita e delle opere del commendatoreDomenico Promis. Memorie storiche, biografiche e biblio-grafiche con documenti inediti, Torino
1877
P. A. PARAvIA, Lettere alla madre e alla sorella, raccolte edannotate da J. BeRnARdI, Torino
1878
A. mAnnO, I principi di Savoia amatori d’arte, in Atti dellaSocietà Archeologica e di Belle Arti della Provincia diTorino, II, pp. 197–226
1888
c. mARzORATI, Guida di Torino, Torino
1890
s. AmBROsOLI, Necrologie. Vincenzo Promis, in Rivista Ita-liana di Numismatica, III, pp. 155–157
1893
G. cLAReTTA, I Reali di Savoia munifici fautori della Arti,in Miscellanea di Storia Italiana, xxx, pp. 1–307
c. LuPPI, Vite di illustri numismatici italiani. Domenico
Casimiro Promis, in Rivista italiana di Numismatica, vI,pp. 381–388
1901
e. BABeLOn, Traité des monnaies grecques et romaines, p. I,t. I, Paris
A. BAudI dI vesme, Di alcune monete, medaglie e pietre dureintagliate per Emanuele Filiberto Duca di Savoia, Torino
1902–1907
A. cOmAndInI, L’Italia nei cento anni del secolo XIX giornoper giorno illustrata, 1826–1849, II, milano
1903
F. GnecchI, e. GnecchI, Guida numismatica universale,milano
1904
L. FORReR, Biographical Dictionary of Medallists, I e II,London
1907
h. mARceL, h. BOuchOT, e. BABeLOn, La Bibliothèque Natio-nale, Batiments, collections, organisation. Département desestampes. Département des médailles et antiques, Paris
1910
A. TeLLuccInI, La raccolta numismatica di Carlo EmanueleIII Re di Sardegna e il tesoro di Papa Sisto V in CastelSant’Angelo in Roma, in Rivista Italiana di Numismati-ca, xxIII, pp. 485–530
1911
P. TOescA, Torino, Bergamo
1912
L. FORReR, Biographical Dictionary of Medallists, v, London
1915
v. cIcALA, Ville d’Italia. Piemonte e Liguria, Torino
1916
L. FORReR, Biographical Dictionary of Medallists, vI, London
1923
L. FORReR, Biographical Dictionary of Medallists, vII, London
1925
Catalogo della raccolta Papadopoli–Aldobrandini compilatoda G. Castellani, venezia
1927
J. BABeLOn, Le cabinet du Roi ou le Salon Louis XV de laBibliothèque Nationale, Paris
1931
v. RAnGOnI mAchIAveLLI, Stemmi di Casa Savoia, in Bollet-tino della Consulta Araldica, Ix, 41, pp. 173–203
187
F. sALATA, Carlo Alberto inedito. Il diario autografo del Re,lettere inedite ed altri scritti inediti, milano
1931–1943
n. ROdOLIcO, Carlo Alberto, Firenze, 3 voll.
1934
A. FeRRAccIù, Lista Civile, in Enciclopedia Italiana di scien-ze, lettere e arti, xxI, Roma, pp. 270 e 271
1937
d. L. GALBReATh, Inventaire des sceaux vaudois, Losanna
1943
n. ROdOLIcO, Carlo Alberto negli anni 1843–1849, Firenze
1955
c. cOsmI, Catalogo della raccolta numismatica Rodolfo diColloredo Mels, udine
1956
J. PLesTeRs, Cross–Section and Chemical Analysis of PaintSamples, in Studies in Conservation, 2, pp. 110–157
1957
A. OmOdeO, La leggenda di Carlo Alberto nella recente sto-riografia, milano
1958
G. TOmAsI dI LAmPedusA, Il Gattopardo, milano
1963–1982
A. BAudI dI vesme, Schede Vesme. L’arte in Piemonte dal XVIal XVIII secolo, voll. 4, Torino
1964
A. GRIseRI, Pietro Ayres, in Dizionario Biografico degli Ita-liani, I, Roma, pp. 734 e 735
Il medagliere delle raccolte numismatiche torinesi, catalogodella mostra, a cura di A. s. FAvA, L. sAcheRO, v. vIALe,Torino, museo civico d’Arte Antica, novembre 1964,Torino
L. mOReTTI, Giuseppe Bartoli, in Dizionario Biograficodegli Italiani, vI, Roma, pp. 578–581
1965
G. ceRRATO, La Zecca di Torino, Torino
n. nAdA, Roberto d’Azeglio, I, 1790–1846, Roma
1966
R. J. GeTTens, G. sTOuT, Painting Materials: A Short Enci-clopaedia, new york
1967
s. FAvA, Vita e problemi del «Medagliere». Documentazionestorica e artistica nelle raccolte numismatiche torinesi, inTorino, 1, pp. 41–46
G. RIcuPeRATI, Francesco Ludovico Berta, in DizionarioBiografico degli Italiani, Ix, Roma, pp. 434–437
L. sImOneTTI, Monete italiane medioevali e moderne, I,Casa Savoia, parte I, Firenze
1968
L. mALLè, Stupinigi. Un capolavoro del Settecento europeotra barocchetto e classicismo, Torino
1969–1978
G. c. BAscAPé, Sigillografia, 2 voll., milano
1970
A. s. FAvA, Su alcune monete dal Museo ‘San Massimo’ diCollegno, in Ad Quintum, I, pp. 13–19
1971
v. d’InceRTI, La raccolta numismatica del re, in Rivista Ita-liana di Numismatica, LxxIII, pp. 239–262
G. eLzInGA–TeR hAAR, On the Use of the Electron Micropro-be in Analysis of Cross–Section of Paint Samples, in Stu-dies in Conservation, 16, pp. 41–55
1972
Catalogo fotografico della Collezione Alinari, Firenze
1973
F. munTOnI, Le monete dei Papi e degli Stati Pontifici, Iv,Roma
A. PeyROT, v. vIALe, Immagini di Torino nei secoli, Torino
1974
G. POLLARd, Cambio (Cambi), in Dizionario Biografico degliItaliani, xvII, Roma, pp. 140–144
1975
A. PAuTAssO, Sui rinvenimenti di stateri vindelici nel Vercel-lese, in Rivista Italiana di Numismatica, xxIII, pp.99–111
K. PInK, L’epoca di coniazione delle ‘Regenbogenschüssel-chen’ della Germania meridionale, in Rivista Italiana diNumismatica, xxIII, pp. 67–98
1976
L. BAndeRA GReGORI1, Disegno di tappezzeria, in PelagioPalagi ..., cit. infra, p. 193, n. 172
L. BAndeRA GReGORI2, Palagi ornatista e arredatore, in Pela-gio Palagi …, cit. infra, pp. 177–187
L. cATeRInA, La collezione cinese, in Pelagio Palagi …, cit.infra, pp. 417–420
R. GRAndI, Un pittore tra Rivoluzione e Restaurazione, inPelagio Palagi …, cit. infra, pp. 31–103
G. GuALAndI, Il Palagi collezionista, in Pelagio Palagi …,cit. infra, pp. 221–232
A. m. mATTeuccI, Scenografia e architettura nell’opera diPelagio Pelagi, in Pelagio Palagi …, cit. infra, pp.105–175
188
c. mORIGI GOvI, La collezione etrusco–italica, in PelagioPalagi …, cit. infra, pp. 291–295
F. PAnvInI ROsATI, La collezione numismatica, in PelagioPalagi …, cit. infra, pp. 345–367
Pelagio Palagi artista e collezionista, catalogo della mostra acura di G. c. cAvALLI, Bologna, museo civico, aprile–set-tembre 1976, Torino, Palazzo Reale, novembre 1976 –febbraio 1977, Bologna
1977
L’Armeria Reale riordinata, a cura di F. mAzzInI, Torino
F. dALmAssO, Di Pietro Ayres nel Medagliere, di un suo omo-nimo nell’Armeria, e una nota sul Palagi, in L’ArmeriaReale ..., cit., pp. 193–201
z. h. KLAwAns, Imitations and Inventions of Roman Coins:Renaissance Medals of Julius Caesar and the RomanEmpire, santa monica
e. mARTIn, Some Improvement, in Techniques of Analysis ofPaint Media, in Studies in Conservation, 22, pp. 63–67
F. mAzzInI1, La sede museale. Restauri e recuperi dell’am-biente. Il Medagliere, in L’Armeria Reale …, cit., pp.37–65
F. mAzzInI2, Origine e vicende del Museo, in L’Armeria Reale…, cit., pp. 17–29
1979
P. BAssAneLLI TOGnOLI, Le dramme padane del Museo Civi-co di Bologna, in Rivista Italiana di Numismatica,LxxxI, pp. 19–34
1980
e. BAccheschI1, Gabriele Capello detto il Mancalvo, in Cul-tura figurativa …, cit. infra, III, Biografie, p. 1416
e. BAccheschI2, Note sui mobili del Regno Sardo dallaRestaurazione a Vittorio Emanuele II, in Cultura figura-tiva …, cit. infra, II, pp. 628–648
s. BALBI de cARO, Cesati Alessandro, in Dizionario Biografi-co degli Italiani, xxIv, Roma, pp. 229–231
Cultura figurativa e archittettonica negli Stati del Re diSardegna 1773–1861, catalogo della mostra a cura di e.cAsTeLnuOvO, m. ROscI, Torino, Palazzo Reale, Palazzinadella Promotrice, Palazzo madama, maggio–luglio 1980,3 voll., Torino
F. dALmAssO1, La pittura in Piemonte nella prima metà del-l’Ottocento, in La pittura in Italia ..., cit. infra, I, pp.45–63
F. dALmAssO2, Pietro Ayres, in Cultura figurativa …, cit., III,Biografie, pp. 1392 e 1393
F. dALmAssO3, Pietro Ayres, in La pittura in Italia ..., cit.infra, II, p. 672
A. s. FAvA1, Gaspare Galeazzi, in Cultura figurativa …, cit.,III, Biografie, p. 1442
A. s. FAvA2, Monete, medaglie e sigilli, in Cultura figurativa…, cit., III, pp. 943–1013
L. LevI mOmIGLIAnO, Giuseppe Bartoli. Le medaglie delMuseo di Sua Maestà ... etc., in Cultura figurativa …,cit., I, p. 49, n. 49
n. nAdA, Il Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848, Tori-no
La pittura in Italia. L’Ottocento, 2 voll., milano
1981
P. AsTRuA, L. Valpenga (1754–1822) su disegno di G. P.Bogetti (1764–1831), Arco romano a Susa, in I ramiincisi dell’Archivio di Corte: sovrani, battaglie, architettu-re, topografia, catalogo della mostra a cura di B. BeRTInI
cAsAdIO, I. mAssABò RIccI, Torino, Palazzo madama,novembre 1981 – gennaio 1982, Torino, pp. 284 e 285, n.143
m. cuOGhI cOsTAnTInI, Dagli sciamiti ai lampassi, in Tessu-ti antichi nelle chiese di Arona, catalogo della mostra acura di d. devOTI, c. ROmAnO, Torino, mole Antonellia-na, novembre–dicembre 1981, Torino, pp. 3–47
A. s. FAvA, Tipari ossia matrici di sigilli religiosi italianinelle raccolte nuntismatiche torinesi, in Studi e ricerche distoria dell’arte in memoria di Luigi Mallé, Torino, pp.61–74
m. m. LAmBeRTI, La Società Promotrice di Belle Arti in Tori-no: fondatori, soci, espositori dal 1842 al 1832, in Qua-derni del seminario di Storia della Critica d’Arte, ScuolaNormale Superiore, Pisa, pp. 301–395
m. PAsTOuReAu, Les sceaux, Turnhout
1982
A. cAvALLARI muRAT, Come carena viva, Torino
m. A. mccRORy, Compagni (Compagno) Domenico (Dome-nico de’ Cammei), in Dizionario Biografico degli Italiani,xxvII, Roma, pp. 647 e 648
s. PInTO, La promozione delle arti negli Stati italiani dal-l’età delle Riforme all’Unità, in Storia dell’Arte Italiana,6, 2, pp. 791–1079
1983
s. BALBI de cARO, Da Vittorio Emanuele III a Umberto II diSavoia: una famiglia per la numismatica, in Rivista Ita-liana di Numismatica, Lxxxv, pp. 227–230
s. eIche, On the Dispersal of Cardinal Bembo’s Collections,in Mitteilungen des Kunsthistorisches Instituts in Florenz,xxvII, pp. 353–359
1984
c. h. v. suTheRLAnd, The Roman Imperial Coinage, I,From 31 BC to AD 69, London
1985
R. AnTOneTTO, Minusieri ed ebanisti del Piemonte, Torino
F. BAssOLI, Monete e medaglie nel libro antico dal XV al XIXsecolo, Firenze
e. e. cLAIn sTeFAneLLI, Numismatic Bibliography, münchen
A. GRIseRI, Documenti per l’esotismo nella decorazione inPiemonte dal 1732 al 1794, in Studi Piemontesi, xIv, 2,pp. 361–364
G. P. ROmAGnAnI, Storiografia e politica culturale nel Pie-monte di Carlo Alberto, Torino
189
Il sigillo nella storia della civiltà attraverso i documenti del-l’Archivio Segreto Vaticano, catalogo della mostra, cittàdel vaticano, Archivio segreto vaticano, 19 febbraio–18marzo 1985, città del vaticano
Il sigillo nella storia e nella cultura. Mostra documentaria,catalogo della mostra a cura di s. RIccI, venezia, Bibliotecamarciana, 6 luglio – 31 agosto 1985, Roma
1986
Artist’s Pigments: A Handbook of their History and Charac-teristics, a cura di R. L. FeLLeR, I, washington d.c.
c. BeRTAnA, G. cAmBuRsAnO, Inventari dei Palazzi Reali diTorino, in Porcellane e argenti …, cit. infra, pp. 125–135
d. BIAncOLInI, I Reali Palazzi dall’età napoleonica alle cele-brazioni dell’Unità Nazionale, in Porcellane e argenti ….,cit. infra, pp. 38–48
G. GRITeLLA, Rivoli. Genesi di una residenza sabauda,modena
I. mAssABò RIccI, La magnificenza della Corte e la suamemoria documentaria, in Porcellane e argenti …, cit.infra, pp. 108–124
Medieval European Coinage, with a Catalogue of the Coinsin the Fitzwilliam Museum Cambridge, I, The EarlyMiddle Ages (5th-10th centuries), by Ph. GRIeRsOn, m.BLAcKBuRn, cambridge
c. PALmAs, La Fabbrica del Palazzo Nuovo Grande di SuaAltezza, in Porcellane e argenti …, cit. infra, pp. 19–37
Porcellane e argenti del Palazzo Reale di Torino, catalogodella mostra a cura di A. GRIseRI, G. ROmAnO, Torino,Palazzo Reale, settembre–dicembre 1986, milano
G. P. ROmAGnAnI, Storie di archivi e di archivisti. I «peccati»del cavalier Datta, in Almanacco dell’arciere, pp. 186–193
1987
G. GORInI, New Studies on Giovanni da Cavino, in ItalianMedals, pp. 45–54
Italian Medals, a cura di J. G. POLLARd, washington d.c.
m. A. mccRORy, Domenico Compagni: Roman Medalist andAntiquities Dealer of the Cinquecento, in Italian Medals,pp. 115–129
c. sTAnGO, La corte di Emanuele Filiberto: organizzazione egruppi sociali, in Bollettino Storico Bibliografico Subalpi-no, Lxxxv, pp. 445–502
L. TRAvAInI, La storia della collezione di Vittorio EmanueleIII nei cartellini autografi del Re, in Collezione di VittorioEmanuele III di Savoia. Zecca di Ferrara: parte I. Etàcomunale ed estense, Roma, pp. 185–190
P. venTuROLI, Armeria Reale 1837–1987, giornale per lariapertura, Torino
1988
T. ALIBRAndI, P. c. FeRRI, Il Diritto dei Beni Culturali. Laprotezione del patrimonio storico–artistico, Roma
e. A. ARsLAn, Uno statere aureo geto–dacico dal vercellese,in Studia Numismatica Labacensia A. Jelocnik Oblata,Ljubljana, pp. 15–25
Collezioni di antichità e Venezia nei secoli della Repubblicadai libri e documenti della Biblioteca Marciana, a cura dim. zORzI, Roma
I. mAssABò RIccI, c. ROssO, La corte quale rappresentazionedel potere sovrano, in Figure del barocco in Piemonte, acura di G. ROmAnO, Torino, pp. 12–40
Sylloge Nummorum Graecorum: The Collection of the Ame-rican Numismatic Society, v, new york
1989
m. cARAssI e I. mAssABò RIccI, Gli Archivi del Principe.L’organizzazione della memoria per il governo dello Stato,in Il Tesoro del Principe. Titoli carte memorie per il gover-no dello Stato, catalogo della mostra, Archivio di stato diTorino, 16 maggio – 16 giugno 1989, Torino, pp. 21–39
Diana trionfatrice. Arte di corte nel Piemonte del Seicento,catalogo della mostra a cura di m. dI mAccO, G. ROmAnO,Torino, Promotrice delle Belle Arti, 27 maggio – 24 set-tembre 1989, Torino
s. FAvA, Museo Civico di Numismatica, Etnografia, ArtiOrientali, Torino
A. GueRRInI, Sculture antiche ed all’antica nelle collezionisabaude, in Diana trionfatrice …, cit., pp. 125–127
R. mARTInI, c. JOhnsOn, Milano, Civiche Raccolte Numi-smatiche, Catalogo delle medaglie, 2. Secolo XVI: Cavino,Roma
L’ombra di Core. Disegni dal fondo Palagi della Bibliotecadell’Archiginnasio, a cura di c. POPPI, Bologna, Galleriacomunale d’arte moderna “Giorgio morandi”, novembre1988 – marzo 1989, Bologna
s. PeTTenATI, L’ornamento prezioso. Miniature, mobili,curiosità, in Diana trionfatrice …, cit., pp. 134–139
1990
I. FAvAReTTO, Arte antica e cultura antiquaria nelle collezio-ni venete al tempo della Serenissima, Roma
L. TOndO, Domenico Sestini e il medagliere mediceo, Firenze
1991
Francesco Gonin 1808–1889, catalogo della mostra a cura diF. dALmAssO, R. mAGGIO seRRA, Torino, Accademia Alberti-na di Belle Arti, 15 gennaio – 17 febbraio 1991, Torino
P. meRLIn, Tra guerra e tornei: la corte sabauda nell’età diCarlo Emanuele I, Torino
L. TRAvAInI, Storia di una passione: Vittorio Emanuele III ele monete, salerno
1992
G. FeRRARIs, Pietro Piffetti e gli ebanisti a Torino,1670–1838, Torino
G. GRITeLLA, Juvarra. L’architettura, 2 voll., modena
K. POmIAn, Les deux pôles de la curiosité antiquaire, in L’an-ticomanie. La collection d’antiquités au 18e et 19e siècles,“Actes du colloque International, montpellier, Lattes9–12 juin 1988”, a cura di A.–F. LAuRen, K. POmIAn,Paris, pp. 59–68
Torino sul filo della seta, a cura di G. BRAccO, Torino
190
1993
Artist’s Pigments: A Handbook of their History and Charac-teristics, a cura di A. ROy, II, washington d.c.
m. BeLLezzA ROsInA, m. cATALdI GALLO, Cotoni stampati emezzari dalle Indie all’Europa, Genova
d. devOTI, m. cuOGhI cOsTAnTInI, La collezione Gandini.Tessuti dal XVII al XIX secolo, modena
s. KuczynsKI, Rapport concernant l’enquête sur les matricesdes sceaux, in Janus, I, pp. 18–24
Roma, Torino, Parigi 1770–1830, catalogo della mostra acura di G. ROmAnO, Torino, Lingotto Fiere, 27 febbraio –7 marzo 1993, Torino
1994
I dieci riquadri dipinti artisticamente alla chinese della VillaReale di Monza. Appunti di restauro, a cura di m. ROsA,milano
La “quinta di facciata” dei palazzi e ville reali. Riflessioni etestimonianze di storia e di restauro, a cura di d. BIAncO-LInI, “Atti della giornata di studi, Torino 15 aprile 1994”
T. sARmAnT, Le Cabinet des Médailles de la BibliothèqueNationale 1661–1848, Paris
A. schnAPP, La conquista del passato, milano
1995
A. m. BAvA1, Antichi e moderni: la collezione di sculture, inLe collezioni …, cit. infra, pp. 135–210
A. m. BAvA2, La collezione di oggetti preziosi, in Le collezioni…, cit. infra, pp. 265–332
Le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia, a cura di G.ROmAnO, Torino
F. cORRAdO, Le medaglie di Luigi XIV lo scrigno di LuigiPrinotto e l’impazienza di Carlo Emanuele III, in Bollet-tino di Numismatica, 24, pp. 22–25
G. dARdAneLLO, Memoria professionale nei disegni daglialbum Valperga. Allestimenti decorativi e collezionismo dimestiere, in Le collezioni …, cit. infra, pp. 63–134
A. s. FAvA, Genesi e vicende della Storia Metallica della RealCasa di Savoia, in Bollettino di Numismatica, 24, pp.45–51
s. mAmInO1, Collezionismo numismatico tra Torino e Basileaalla fine del Cinquecento: Alessandro Ardente medaglista,in Studi Piemontesi, xxIv, 2, pp. 315–326
s. mAmInO2, Reimagining the Grande Galleria of CarloEmanuele I of Savoy, in RES. Anthropology and Aesthe-tics, 27, pp. 71–88
Il Palazzo Reale di Torino nelle Guide della Città, a curadell’Associazione Amici di Palazzo Reale, Torino
s. PennesTRì, Uomini, libri, medaglieri. Note su collezioninumismatiche e strumenti bibliografici a Torino tra ’500 e’900, in Bollettino di Numismatica, 24, pp. 203–216
G. ROmAnO, Artisti alla corte di Carlo Emanuele I: lacostruzione di una nuova tradizione figurativa, in Le col-lezioni …, cit., pp. 13–62
m. ROssI, Le medaglie dei Gonzaga. Catalogo, in I Gonza-ga. Moneta, arte, storia, a cura di s. BALBI de cARO, cata-
logo della mostra, mantova, Palazzo Te, 9 settembre – 10dicembre 1995, milano
G. sPIOne, La tutela delle collezioni, in Le collezioni …, cit.,pp. 333–347
1996
G. AGOsTI, Una presentazione per «Le collezioni di CarloEmanuele I», in Studi Piemontesi, xxv, pp. 133–144
c. BeRTOLOTTO, Visita all’appartamento reale di VittorioEmanuele II, in Il Castello di Moncalieri. Gli Apparta-menti Reali, a cura di F. PeRnIce, Torino, pp. 81–97
s. PeTTenATI, L’emulazione verso i musei americani: gliacquisti delle collezioni Gualino e Trivulzio. Il Tesoro diDesana, in Il Tesoro della città, catalogo della mostra acura di s. PeTTenATI, G. ROmAnO, Palazzina di caccia distupinigi, 31 marzo – 8 settembre 1996, Torino, pp.201–203
c. POPPI, La non edificante storia di un patrimonio disperso,in Pelagio Palagi pittore, milano, pp. 230–240
1996–1997
n. OsTOReRO, Dalla Grande Galleria di Carlo Emanuele Iall’Armeria e Biblioteca Reale, tesi di laurea, Politecnicodi Torino, relatore prof. vera comoli mandracci
1997
Artist’s Pigments: A Handbook of their History and Charac-teristics, a cura di e. wesT FITzhuGh, III, washingtond.c.
s. GhIsOTTI, Decorazione e arredo: dal gusto di corte car-loalbertino agli interventi del nostro secolo, in Il Real Col-legio e i Barnabiti a Moncalieri, catalogo della mostra acura di c. BeRTOLOTTO, moncalieri, collegio carlo Alber-to, 27 settembre – 20 dicembre 1997, Torino, pp. 54–64
s. PennesTRì, L’Università dei Padroni Parolari di Torino inun sigillo del Medagliere Reale, in Studi Piemontesi,xxvI, 1, pp. 79–91
L. Re, Identità storica e conservazione, in Piazze e strade diTorino. Piazza San Giovanni, Torino, pp. 21–37
G. ROLAndO PeRInO, Rilievo preliminare al restauro deigabinetti cinesi, in Villa della Regina …, cit. infra, pp.139 e 140
L. TRAvAInI, La provenienza delle monete di Bergamo nellacollezione di Vittorio Emanuele III di Savoia, in CorpusNummorum Bergomensium, 2 voll., Roma, I, pp. 51–54
Villa della Regina. Diario di un cantiere in corso, a cura dic. mOsseTTI, Torino
1997–1998
G. mAzzOnIs, L’opera di Pelagio Palagi nel Palazzo Reale diTorino. Gli arredi, tesi di laurea, università di Torino,Facoltà di Lettere
1998
e. A. ARsLAn, Problemi di circolazione monetaria in Piemon-te dal V all’VIII secolo, in Archeologia in Piemonte. IlMedioevo, a cura di L. meRcAndO, e. mIcheLeTTO, Tori-no, pp. 289–307
191
c. e. BeRTAnA, Torino 1815–1849. Objets de vertu, momen-ti e curiosità ai tempi di Carlo Alberto, in Pagine delPiemonte, 6, pp. 53–58
e. cOLLe, Il mobile impero in Italia, milano
A. meLOGRAnI, Brevi cenni sul passaggio allo Stato italianodei beni della Corona e di alcune dimore storiche, in Abita-re la storia. Le dimore storiche–museo. Restauro, sicurezza,didattica, comunicazione, “Atti del convegno internaziona-le, Genova, Palazzo Reale, 20–22 novembre 1997”, a curadi L. LeOncInI, F. sImOneTTI, Torino, pp. 148–190
L. meRcAndO, Dalle prime scoperte alla ricerca archeologica,in meRcAndO, zAndA, Bronzi …, cit. infra, pp. 9–30
L. meRcAndO, e. zAndA1, Bronzi di Industria, Roma
L. meRcAndO, e. zAndA2, Il Santuario Isiaco di Industria,in Archeologia in Piemonte, II, Torino, pp. 180–187
s. PennesTRì, Il Medagliere di Casa Giulio e la storia diTorino tra Ancien Régime e Regno d’Italia, in Studi Pie-montesi, xxvII, 2, pp. 395–408
1999
A. m. BAvA, Le Collezioni di Carlo Emanuele I (gli oggettiarcheologici), in Politica e cultura …, cit. infra, pp.311–327
e. cOLLe, Pelagio Palagi e gli artisti al servizio della cortesabauda, in Arte a Bologna. Bollettino dei musei civicid’arte antica, 5, 1999, Bologna, pp. 58–109
s. mAmInO, Quarantotto immagini naturalistiche per la«Grande Galleria» di Carlo Emanuele I di Savoia, inPolitica e cultura …, cit. infra, pp. 289–309
Il Medagliere Reale: un nuovo museo per la città, giornaledella mostra, Torino, Armeria Reale, 4 giugno – 4 settem-bre 1999, Torino
A. OTTAvI cAvInA, Felice Giani 1758–1823 e la cultura difine secolo, milano
Politica e cultura nell’età di Carlo Emanuele I. Torino, Pari-gi, Madrid, “Atti del convegno, Torino, 21–24 febbraio1995”, a cura di m. mAsOeRO, s. mAmInO, c. ROssO,Firenze
Riapertura del Medagliere di Pelagio Palagi dopo il restau-ro, giornale a cura di P. venTuROLI, Torino, ArmeriaReale, 4 giugno 1999, Torino
G. ROLAndO PeRInO, Il rilievo della volta e dei mobili, inRiapertura del Medagliere ..., cit.
m. ROmAnO, Gli interessi numismatici «Umor mio principa-le» di Anibal Caro, in Rivista Italiana di Numismatica,xcx, pp. 293–303
Le stanze di Artù. Gli affreschi di Frugarolo e l’immaginariocavalleresco nell’autunno del Medioevo, catalogo dellamostra a cura di e. cAsTeLnuOvO, Alessandria, complessoconventuale di san Francesco – ex Ospedale militare, 16ottobre 1999 – 9 gennaio 2000, Alessandria
P. venTuROLI, Il Gabinetto delle antichità di S. M. CarloAlberto, in Riapertura del Medagliere ..., cit.
2000
Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristiana, catalo-go della mostra a cura di s. ensOLI ed e. LA ROccA,
Roma, Palazzo delle esposizioni, 22 dicembre 2000 – 20aprile 2001, Roma
L. GARy cAPeLLInI, A. ROzzI mAzzA, Arte e cultura nella sto-ria del sigillo. La Spezia – Civico Museo del Sigillo.Guida alla visita, La spezia
F. mIsseRe FOnTAnA, Francesco Mezzabarba Birago(1645–1697) tra collezione ed erudizione numismaticanella Milano del Seicento, in Rivista Italiana di Numi-smatica, cI, pp. 159–215
2001
L’Armeria Reale di Torino. Guida breve, a cura di P. venTu-ROLI, Torino
e. cOLLe, A. GRIseRI, R. vALeRIAnI, Bronzi decorativi in Ita-lia, milano
Le quattro voci del mondo: arte, culture e saperi nella colle-zione di Stefano Borgia (1731–1804), in “GiornateInternazionali di studi, velletri, Palazzo comunale – salaTersicore, 13 e 14 maggio 2000”, cura di m. nOccA,napoli
P. venTuROLI1, Il Medagliere, in L’Armeria Reale di Torino..., cit., pp. 49–52
P. venTuROLI2, Storia dell’Armeria Reale, in L’ArmeriaReale di Torino ..., cit., pp. 11–29
2002
P. dRAGOne, I pittori dell’Ottocento in Piemonte. Arte e cul-tura figurativa 1800–1830, Torino
I. FAvAReTTO, Arte antica e cultura antiquaria nelle collezio-ni venete al tempo della Serenissima, Roma
P. venTuROLI, La Galleria Beaumont 1732–1832, Torino
2003
m. dI mAccO, Il “Museo Accademico” delle scienze nelpalazzo dell’Università di Torino. Progetti e istituzioninell’Età dei Lumi, in La memoria della scienza. Musei ecollezioni dell’Università di Torino, a cura di G. GIAcOBI-nI, Torino, pp. 29–52
2004
R. AnTOneTTO, Gabriele Capello “Moncalvo” ebanista didue Re, Torino
F. BAReLLO, Monete, in Torino. Il grande libro della città,Torino, pp. 795 e 796
G. cARITà eT ALII, Pollenzo: una città romana per una “realvilleggiatura” romantica, savigliano (cn)
Di fino colorito. Martino Spanzotti e altri casalesi, catalogodella mostra a cura di G. ROmAnO, A. GueRRInI, G.mAzzA, casale monferrato, museo civico, 21 febbraio –25 aprile 2004, casale monferrato
L. LevI mOmIGLIAnO1, All’origine dei Musei universitari, inIl Palazzo dell’Università …, cit. infra, pp. 91–110
L. LevI mOmIGLIAnO2, Giuseppe Vernazza e la nascita dellastoria dell’arte in Piemonte, Alba (cn)
Il Palazzo dell’Università di Torino e le sue collezioni, a curadi A. quAzzA, G. ROmAnO, Torino
192
s. PeTTenATI, Mobilità degli arredi del Castello, in Pollenzo.Una città …, cit. infra, pp. 242–275
A. quAzzA, Arredi, strumenti e riti, in Il Palazzo dell’Univer-sità …, cit., pp. 169–228
J. P. ReveRseAu, Armes et armures de la Couronne au Muséede l’Armée, dijon
2005
G. ROLAndO PeRInO, Il rilievo degli arredi di Villa dellaRegina, in Villa della Regina ..., cit. infra, pp. 153–164
Villa della Regina. Il riflesso dell’Oriente nel Piemontedel Settecento, a cura di L. cATeRInA, c. mOsseTTI,Torino
2006
F. mIsseRe FOnTAnA, Adolf Occo postillato dagli antiquariromani fra Cinquecento e Seicento, in Rivista Italiana diNumismatica, cvII, pp. 297–354
O. RenAudeAu, Histoire d’un fonds prestigieux, in Musée del’Armée. Histoire des collections. Armes et armures ancien-nes, dijon, pp. 5–29
2007
e. cOLLe, Il mobile dell’Ottocento in Italia, milano
Disegnare l’ornato. Interni piemontesi di Sei e Settecento, acura di G. dARdAneLLO, Torino
2008
L’Armeria Reale nella Galleria Beaumont, a cura di P. ven-TuROLI, Torino
P. AsTRuA, La Galleria Beaumont dall’antico regime allespoliazioni francesi, in L’Armeria Reale ..., cit., pp.193–208
A. m. BAvA, Per una storia della Galleria Beaumont comequadreria di palazzo: antefatti e trasformazioni, in L’Ar-meria Reale ..., cit., pp. 139–160
G. BOdOn, Archeologia e produzione artistica fra Quattro eCinquecento: Andrea Riccio e l’ambiente padovano, inRinascimento e passione per l’antico ..., cit. infra, pp.121–139
Rinascimento e passione per l’antico. Andrea Riccio e suotempo, catalogo della mostra a cura di A. BAcchI, F. de
GRAmmATIcA e L. GIAcOmeLLI, Trento, museo diocesanoTridentino, 5 luglio – 2 novembre 2008, Trento
G. ROLAndO PeRInO1, Dalla Galleria seicentesca alla Galle-ria napoleonica: analisi di un cantiere, in L’ArmeriaReale ..., cit., pp. 79–92
G. ROLAndO PeRInO2, Le boiseries della Villa al Quirinaleattraverso il rilievo, in Juvarra a Villa della Regina. Lestorie di Enea di Corrado Giaquinto, a cura di c. mOsseT-TI, P. TRAveRsI, Torino, pp. 95–102
B. TuzzOLInO, Filippo Juvarra (1678–1736), in Comunica-re la Maestà, a cura di d. BIAncOLInI, cinisello Balsamo,pp. 22–25
P. venTuROLI, Un cantiere ininterrotto 1732–1832, in L’Ar-meria Reale ..., cit., pp. 103–138
m. c. vIscOnTI cheRAscO, Da Filippo Juvarra a BenedettoAlfieri, a Giuseppe Battista Piacenza: un percorso archi-tettonico fra barocco e restaurazione, in L’Armeria Reale…, cit., pp. 23–78
2009
F. BAReLLO, Del raccogliere medaglie. Il collezionismo numi-smatico, in Colligite fragmenta ..., cit. infra, pp. 119–132
s. cAsTROnOvO, Una Bibbia francese del Trecento nellabiblioteca di Carlo Emanuele I di Savoia, in Per Giovan-ni Romano. Scritti di amici, savigliano (cn), pp. 44 e 45
Colligite fragmenta. Aspetti e tendenze del collezionismoarcheologico ottocentesco in Piemonte, “Atti del convegno,Tortona, Palazzo Guidobono, 19 – 20 gennaio 2007”,Bordighera
Feste barocche. Cerimonie e spettacoli alla corte dei Savoiatra Cinque e Settecento, catalogo della mostra a cura di c.ARnALdI dI BALme, F. vARALLO, Torino, Palazzo madama,7 aprile – 5 luglio 2009, Torino
e. mIcheLeTTO, Collezionismo dinastico a Torino nell’Otto-cento. Le raccolte sabaude di archeologia e il Regio Museodi Antichità, in Colligite fragmenta ..., cit., pp. 83–104
F. mIsseRe FOnTAnA, Testimoni parlanti. Le monete antichea Roma tra Cinquecento e Seicento (Monete, 4), Roma
2010
100 anni del Corpus Nummorum Italicorum, “Atti dellaGiornata di studio, milano, 15 maggio 2009”, a cura diA. sAvIO e A. cAvAGnA (Collana di Numismatica e ScienzeAffini, 6), milano
La collezione di Vittorio Emanuele III e gli studi di storiamonetaria, “Atti del convegno, Roma, 21–22 ottobre2010”, in Bollettino di Numismatica, 54
B. de ROyèRe, Pelagio Palagi et l’aménagement des résiden-ces du roi Charles–Albert en Piémont, tesi di dottorato,université Aix–marseille
Le strategie dell’apparenza. Cerimoniali, politica e societàalla corte dei Savoia in età moderna, a cura di P. BIAnchIe A. meRLOTTI, Torino
2011
F. vARALLO, Dal Theatro alla Grande galleria. La bibliotecaducale tra Cinque e Seicento, in Il teatro di tutte le scienze ele arti. Raccogliere libri per coltivare idee in una capitale dietà moderna. Torino 1559–1861, catalogo della mostra, acura di I. mAssABò RIccI, s. PeTTenATI e m. cARAssI, Tori-no, Archivio di stato, 22 novembre 2011 – 29 gennaio2012, Torino, pp. 25–34
2013
Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento, catalogo dellamostra a cura di G. BeLTRAmInI, d. GAsPAROTTO, A. TuRA,Padova, Palazzo del monte di Pietà, 2 febbraio – 19 mag-gio 2013, venezia
In corso dI stampa
A. GueRRInI, “Il più ricco, e l’unico rimasto”. La venditadella collezione Gradenigo a Carlo Alberto di Savoia, inSaggi e memorie di Storia dell’arte, in corso di stampa
193
SOMMARIO
Presentazione di MARIO TuReTTA VII
Presentazione di edITh GAbRIellI IX
Introduzione di AleSSAndRA GueRRInI XI
TAVOle XIII
STORIA
AleSSAndRA GueRRInI: Carlo Alberto, un progetto palagiano e qualche decennio di assenza: 2
la storia del Medagliere Reale
GReGORIO ThAOn dI ReVel MAzzOnIS: Il Gabinetto delle medaglie nei documenti d’archivio 24
GIORGIO ROlAndO PeRInO, PAOlO VenTuROlI: Il Gabinetto de’ fiori 28
AnnA MARIA COlOMbO: La tappezzeria del Medagliere: un raro esempio di esotismo in età neoclassica 38
FedeRICO bARellO: La collezione numismatica di Carlo Alberto e le raccolte sabaude 48
AndReA CAlzOlARI, luISA ClOTIlde GenTIle: La collezione sfragistica del Medagliere Reale di Torino 74
PAOlO VenTuROlI: Il “gabinetto delle antichità” di Sua Maestà Carlo Alberto 84
ReSTAuRI
MARIA CARlA VISCOnTI CheRASCO: Il ripristino del terrazzo soprastante la volta del Medagliere Reale 92
GIORGIO ROlAndO PeRInO: Il rilievo della volta e dei mobili 98
KRISTIne dOneuX: I dipinti a tempera e gli stucchi dorati su volta e pareti 122
AnTOnIeTTA GAllOne: Analisi del colore dei dipinti della volta 134
GIAn luIGI TeRRenI: I mobili 140
† FRAnCeSCO AlbeRGOnI: Analisi di campioni di legno 146
CAROlA CIPRAndI: Infissi e scuri 148
SAnTO MACCARROne: Decorazioni in bronzo 150
dOCuMenTI
GReGORIO ThAOn dI ReVel MAzzOnIS: Appendice documentaria 154
GReGORIO ThAOn dI ReVel MAzzOnIS: Regesto degli artigiani e artisti attivi per il Gabinetto delle medaglie 174
VAleRIA ROnCuzzI: Regesto dei disegni di Pelagio Palagi 178
FOnTI
Fonti archivistiche 182
Bibliografia 184
Abstracts 195





























































![E]E!DH - RERO DOC](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63233b14f3cd44b80906ba12/eedh-rero-doc.jpg)