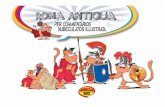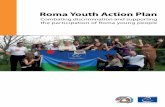Le scale coclidi di Borromini, in M. Tabarrini, Borromini e gli Spada. Un palazzo e la committenza...
Transcript of Le scale coclidi di Borromini, in M. Tabarrini, Borromini e gli Spada. Un palazzo e la committenza...
1. I prototipi quattro-cinquecenteschi1
I disegni progettuali di Borromini con scale coclidi, sembrano non discostarsi dalla tradi-zione rappresentata dalla trattatistica rinascimentale e dai vari esempi di scale italiane delCinquecento. Un confronto serrato tra le ideazioni borrominiane e quelle dei possibili mo-delli, è però in grado di dimostrare non solo una particolare applicazione a questo tema, maanche una straordinaria capacità di formulare ipotesi innovative. Sarà utile ricercare le origini e seguire l’evoluzione storica di questa tipologia, passando poiin rassegna quegli esempi della tradizione certamente noti a Borromini o per conoscenza di-retta o per la loro divulgazione attraverso i trattati e gli architetti2. Nel medioevo le scale avevano un ruolo secondario, in funzione della utilitas: la disposizione pla-nimetrica più frequente rifletteva la concezione di manufatto di servizio, relegato in posizionemarginale rispetto alla organizzazione distributiva del palazzo. Ancora alla metà del Quattrocento,Leon Battista Alberti, nel primo libro del De re aedificatoria (1485), affermava che le scale costi-tuivano un elemento di disturbo negli edifici, per cui “quanto manco scale saranno in una fabri-ca, e quanto minor spatio occuparanno tanto migliori saranno”3. Tuttavia possiamo riconoscereproprio all’Alberti la paternità di un interessante e precoce esempio di scala elicoidale a doppiarampa, ascendente-discendente in continuum (tipo che sarebbe stato approfondito da Leonardonei suoi studi di scale), inserita nei piloni della crociera di S. Andrea a Mantova (fig.1) 4. Solo nel-la seconda metà del secolo le scale cominceranno ad assumere una rilevanza maggiore, passandodal legno alla pietra e posizionandosi sotto i portici dei cortili oppure entro un’ala dell’edificio, va-lorizzandosi nel contempo con nuove significazioni rappresentative. La tipologia a elicoide era conosciuta fin dall’antichità, come riferisce l’Alberti5 e vogliono dimo-strare Serlio e Palladio nelle tavole ricostruttive degli edifici degli antichi6. In età paleocristiana,esempi di minore entità, ma con funzione architettonica di volume puro, erano sopravvissuti nel-le scale doppie degli amboni nelle ‘scholae cantorum’ delle basiliche. Scale di carattere utilitario,ma ancora in funzione architettonica, erano state adattate nelle torri ai due lati dell’ardica di S.Vitale a Ravenna. Dall’inserimento di scale a chiocciola in campanili e torri scalarie in epoca ca-rolingia, ottoniana (Westwerk e Bauwerk) e romanica7 si era arrivati alle scale a chiocciola estra-dossate nelle guglie delle cattedrali gotiche e tardo-gotiche con il muro all’interno o all’esternosvuotato da una serie di colonnine: si veda il bell’esempio nella guglia “dell’Amadeo” nel duomodi Milano8. All’interno degli edifici civili, piccole scale a chiocciola si prestavano bene all’inseri-mento negli spazi di risulta e alla comunicazione segreta fra i vari piani.
Le scale coclidi di Borromini 79
1Questo capitolo, che prende spunto dagli in-terventi di Borromini a palazzo Spada, inten-de proseguire una linea di studio aperta daMartin Raspe (2000) in occasione del quartocentenario della nascita di Borromini e si con-centra su un particolare tipo di scale, quelle apianta concentrica, alla ricerca dei possibilimodelli che le hanno ispirate.2 Sull’evoluzione storica e tecnologica dellascala, concetti generali nei vari manuali di ar-chitettura come: F. Milizia 1972, pp. 227-235; Il Costruttore…1886, vol. VI, pp. 59-91;G.A. Breymann 1931, vol. I, cap. IV, pp. 282-324; Id. 1985 e 2003; D. Donghi 1925, vol.I, pp. 115-135, 517-519, 654-659, vol. II, pp.27-43; e, tra i più recenti, J.L. Gauthier 1985,C. Gambardella 1993, M. Fumo 1993, M.Bonavia 1997. Sugli sviluppi monumentalivedi N. Pevsner 1966, pp. 472– 490, l’esca-lier…1985, J. Templer 1992, A. Jarrard 1997,V. Ficklin 2001, H. Falkenberg 2002.3 Il passo citato dal trattato albertiano De re ae-dificatoria (Libro I, cap. XIII) è tratto da B.Adorni 1974, p. 60 (traduzione daiCommentarii di Alessandro Farnese). Sui prin-cipi architettonici albertiani vedi i numerosicontributi prodotti dal Comitato Nazionalecostituitosi per il VI centenario della nascitadell’architetto, in particolare M. D. MorozzoDella Rocca 2005, P.N. Pagliara 2006, H.Günther 2007.4 La scala è stata esaminata da J. Johnson1975, pp. 16-18. Sulla storia progettuale del-la chiesa vedi M.Bulgarelli 2003, C.L.Frommel 2006.5La tipologia è nota sin dall’antichità come ri-ferisce L. B. Alberti nel Libro Terzo sull’archi-tettura volgarizzato da Cosimo Bartoli (Dellaarchitettura Libri Dieci…1833, p. 75): “Gliantichi […] per la comodità acciò si potessesalire da basso ad alto dell’edificio e forse an-che per spendere manco vi facevano dentrouna scala a chiocciola”. L’utilizzo di scale a chiocciola che salivano dal‘naos’ o dal ‘pronaos” al sottetto è riscontratoanche nei templi greci che avevano la necessitàdi accesso a un livello superiore: si ricordanoal riguardo il tempio A di Selinunte, il tempio
1. L. B. ALBERTI. Crociera della chiesadi S. Andrea a Mantova (da Johnson1974).2. B. PERUZZI. Ricostruzione delportico di Pompeo a Roma (disegno;Firenze, GDSU 484 Ar; da Wurm1984).
PARTE SECONDA
Le scale coclidi di Borromini
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 79
Importante per lo sviluppo della tipologia monumentale è la tradizione delle scale francesi(dalla vis de Saint-Gilles del XII secolo alla vis du Louvre del Trecento avanzato) che, nell’ul-tima fase del gotico, raggiunsero una particolare complessità, arricchendosi di nuove signi-ficazioni in accordo con l’accresciuta sensibilità spaziale e l’accentuazione del valore dina-mico degli assi9. Il culmine è rappresentato dalle scale realizzate a Blois e a Chambord sottoFrancesco I (1515-1547), certamente assorbendo anche l’influenza dei primi modelli rina-scimentali italiani.Un esempio veneziano più tardo, apparentemente riconducibile alla stessa concezione, è lascala del Bovolo (1499) in palazzo Contarini, realizzata ancora con tecniche costruttive go-tico-bizantine e forme proto-rinascimentali, forse ispirate dal trattato del Filarete10. La sca-la, assegnata recentemente a Giorgio Spavento contro l’attribuzione tradizionale a GiovanniCandi, si snoda all’interno di una torre cilindrica traforata da archeggiature ascendenti, po-sta all’angolo dell’edificio e prospiciente su una piccola corte11.Non trascurabile è inoltre la tradizione costruttiva spagnola importata dall’architettomaiorchino Guglielmo Sagrera nel cantiere di ristrutturazione di Castel Nuovo a Napoli(dal 1450), dove realizzò la scala a chiocciola a “occhio aperto” per l’accesso alla Sala deiBaroni (fig. 3). La corte di Alfonso d’Aragona era tra le più importanti sedi di elaborazionee circolazione della nascente cultura umanistica rinascimentale. Il complesso sistema di re-lazioni diplomatiche, politiche e familiari, con la corte papale, gli Sforza, gli Estensi e iMontefeltro, fu determinante nel favorire il fertile interscambio di conoscenze, modelliarchitettonici e tecniche costruttive tra la Spagna e le province italiane nel XV secolo. Tragli artisti chiamati a lavorare al rinnovamento di Castel Nuovo compare anche LucianoLaurana che qualche anno dopo, nel 1468 a Urbino, nell’ideare la facciata ovest del palaz-zo Ducale, riprese il motivo già sperimentato a Napoli dei torrioni che racchiudono l’ar-co trionfale, inserendo in ciascun torrione una scala a chiocciola a “occhio” aperto deriva-ta dal modello di Sagrera12.Le scale urbinati, in cui è omessa la lavorazione del cordolo di raccordo centrale ed è aggiuntauna ringhiera metallica costituita da montanti di ferro impiombati negli scalini, vanno a de-finire una variante decisiva per gli sviluppi successivi in Italia (fig. 4). Sotto l’influenza diLuciano Laurana, Baccio Pontelli realizzò la straordinaria scala a pozzo aperto della rocca ro-veresca di Senigallia (1480). La scala fu costruita a blocchi monolitici sovrapposti e incassa-ti nel muro, senza alcuna protezione verso il vuoto centrale, che si alzano dai sotterranei pertutta l’altezza del torrione nord adiacente alla zona residenziale13.Tra la fine del ’400 e gli inizi del ’500, Francesco di Giorgio Martini con le sue realizzazio-ni a canna centrale traforata, e Leonardo da Vinci con i suoi schizzi di scale a due e persino
80 PARTE SECONDA
di Era a Paestum, il Partenone. Scale a chioc-ciola erano ricavate nello spessore dei massic-ci murari degli antichi edifici romani.Interessante la descrizione di G. A. Guattani(1805, p. 62) di due scale a chiocciola all’in-terno della muraglia del Tempio della Pace chesi vedevano sull’angolo verso il giardino dellachiesa dei SS. Cosma e Damiano tuttora esi-stenti (ringrazio per la segnalazione AnnarosaCerutti Fusco). Per quanto riguarda ancoraRoma e lo sviluppo di varianti tipologiche ori-ginali, si ricordino anche le colonne coclidi(vedi quelle di Traiano e di M. Aurelio (II sec.d.C.), monumenti onorari formati da enormirocchi di marmo sovrapposti e scavati all’in-terno così da formare scale a chiocciola. Unarampa elicoidale di grandi dimensioni è nelmausoleo di Adriano (P. Spagnesi 2005).6 S. Serlio ed. 1978, Libro III, cap. III, pp. 75,77, 80, 96; A. Palladio ed. 1980, Libro II, cap.XI, p. 141, Libro III, cap. XVIII, p. 232, cap.XIX, p. 236. Sebbene le ricostruzioni dei duetrattatisti debbano considerarsi in alcuni casifantasiose, la tipologia risaliva effettivamenteall’antichità. Vedi i numerosi rilievi eseguiti dagli architettie antiquari tra il XV e il XVII secolo: ricordia-mo, come esempi dimostrativi, i disegni delmuseo cartaceo di Cassiano Del Pozzo in I.Campbell 2004, vol. I, nn. 31, 34, 50; vol. IInn. 172, 196, 204, 205; vol. III, nn. 355, 356.Vedi anche le ricostruzioni di tempietti sepol-crali con rampe elicoidali, in gran parte peròda ritenersi rielaborazioni dall’antico, di G.B.Montano (L. Fairbairn 1998, schede 1191,1201, 1203, 1205, 1260, 1270, 1279. 7 Si vedano in Italia quelle di S. Claudio alChienti, ai lati della facciata.8 R. Bonelli, C. Bozzoni, V. Franchetti Pardo1997. 9Sui prototipi, sviluppi e massimi risultati del-la vis in Francia, compresi gli esempi realizza-ti sotto Francesco I, si vedano i contributi di F.Boudon e J. Blécon, J. Guillaume, C. Mignot,J.M. Pérouse de Montclos, M. Whiteley inL’escalier 1985. Sulla “grande viz” del Louvre(XIV sec.) vedi anche M. Whiteley 1989. 10 Sulle illustrazioni del trattato (c. 1464) diAntonio Averlino detto il Filarete vedi A.M.Finoli, L. Grassi 1972, M. Beltramini 2001.11 Sulla scala del “Bovolo”, parola venezianache significa chiocciola, si vedano L. SalvadoriRizzi 1996, P. Stevanato 1999. Sull’evoluzionedella tipologia elicoidale a Venezia vedi P.L.Sohm 1985, G. Baroni, A. Ulandi 2000, I.Chiappini di Sorio 2003.12 Guglielmo Sagrera vantava l’importantemodello di scala a chiocciola a “occhio aper-to” impiegato nella torre d’angolo dellaLonja di Maiorca, che diede il nome a un ar-chetipo della stereotomia spagnola: il“Caracol de Mallorca”. Questo prototipo, ri-proposto da Sagrera in forme monumentalinel Castel Nuovo di Napoli (dopo il 1450),influenzò in Italia centrale la realizzazione,attribuita a Luciano Laurana, delle due sca-le a chiocciola nelle torri d’ingresso del pa-lazzo ducale di Urbino (1468 c.), e quelladella scala della Certosa di Padula. Sulla ste-reotomia delle scale a chiocciola “ad occhioaperto” e sulla dipendenza degli esempi so-pra citati dal modello napoletano di ascen-denza spagnola vedi J. Calvo López, E. DeNichilo 2005.13 Sulla rocca di Senigallia vedi F. Mariano2001. Sull’architettura di Luciano Lauranavedi F.P. Fiore 1995, W. Lutz 1995, JanezHöfler 2004. 14 La residenza fortificata del palazzo ducale di
3. G. SAGRERA. Scala a chiocciola a“occhio aperto” per l’accesso alla saladei Baroni di Castel Nuovo a Napoli.4. L. LAURANA. Palazzo Ducale diUrbino. Scala a pozzo aperto in unodei torricini della facciata.
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 80
a quattro e otto spirali, furono tra i primi a dare un decisivo impulso allo sviluppo e diffu-sione della tipologia strutturale, svolgendo un ruolo fondamentale nell’elaborazione di pro-totipi monumentali. La presenza di rampe elicoidali nei palazzi ducali di Urbino, Urbaniae Gubbio, nel monastero di S. Chiara e nella rocca di Sassocorvaro (figg. 5, 6) testimonia lanotevole esperienza tecnico strutturale di Francesco di Giorgio Martini nel risolvere un or-ganismo architettonico così complesso 14. La splendida scala interna a doppia chiocciola –due spirali parallele nella stessa tromba – nel Donjon del castello di Chambord potrebbeinvece derivare dai progetti di Leonardo, che morì nella Loira lo stesso anno in cui l’edifi-cio fu cominciato (1519) 15. Il vero prototipo rinascimentale delle scale elicoidali in Italia è però la scala circolare delBelvedere in Vaticano progettata da Bramante intorno al 1507 (fig. 7), un cilindro cavo nelquale si svolge una spirale con ampia tromba aperta, sostenuta al centro da colonne isolateche, partendo dal basso, si succedono senza soluzione di continuità con capitelli toscani, do-rici, ionici e compositi. La coclide, pur essendo parte integrante dell’originario progetto bra-mantesco, è inserita in una struttura autonoma visibile dall’esterno, una disadorna torre di-slocata al limite estremo del complesso, addossata alla villa di Innocenzo VIII.Precoci tentativi di imitazione sono dovuti a Raffaello, che pochi anni dopo abbozzò una sca-la elicoidale, aperta al centro e fiancheggiata da colonne, in uno schizzo del 1519 per villaMadama, a Peruzzi che ne realizzò una copia semplificata nella villa a Santa Colomba pres-so Siena (fig. 8) 16, ad Antonio da Sangallo il Giovane che la propose in più progetti, com-preso un disegno per palazzo Farnese17. La grande ammirazione destata dal prototipo bramantesco tra i contemporanei è river-berata dalla letteratura e dalla iconografia artistica intorno alla metà del secolo18 (fig. 9).L’apparentemente inedito organismo spaziale aveva ovviamente antecedenti, che i trat-tatisti tentarono di individuare. Per il Vasari Bramante era stato ispirato dalla torre cam-panaria di S. Nicola di Pisa (XII-XIII secolo) 19, all’interno della quale si sviluppa una ori-ginalissima scala libera impostata verso il pozzo centrale su una galleria elicoidale di ar-chetti rampanti sostenuti da colonnine. Secondo Serlio – seguito da Palladio e Vignola –fonte di ispirazione era l’antico e in particolare il “portico di Pompeo” a Roma che, se-condo un’ipotesi ricostruttiva derivata dai disegni di Giuliano da Sangallo e BaldassarrePeruzzi (Firenze, Uffizi 484 Ar), comprendeva scale rotonde con rampe colonnari (fig. 2)20. Senza precedenti era invece la soluzione eretica degli ordini architettonici posti, senzasoluzione di continuità, lungo un piano di appoggio inclinato21. Peruzzi, a sua volta ispi-rato dai campanili di Pisa, elaborò numerose varianti di scale inscritte in volumi cilindrici(fig. 11) 22. Il disegno Uffizi U 10Ar, identificato come copia di una fantasiosa variante al
Le scale coclidi di Borromini 81
Urbino è collegata al sottostante piano delMercatale da una grande rampa elicoidale incomunicazione con le stalle della Data e l’e-sterno delle mura. Sul giardino pensile a rac-cordo dell’ex castellare del palazzo sorge unaseconda rampa elicoidale che, partendo dalpiano seminterrato, si sviluppa fino alla som-mità dell’edificio. Nel palazzo ducale diGubbio i due corpi di fabbrica al primo pia-no, disposti tra loro ad angolo retto, sono in-cerneriati in una rampa elicoidale. Nel mona-stero di S. Chiara la rampa elicoidale venne in-nalzata nel torrione semicircolare, che era si-tuato all’incrocio tra le vecchie mura urbichemedievali e il nuovo tratto delle mura rinasci-mentali. Nella rocca di Sassocorvaro la scala a“lumaca” che conduce dal piano terreno alpiano superiore, è inserita all’interno della tor-re malatestiana preesistente e ha come based’appoggio la volta a botte di una grande ci-sterna adibita alla raccolta delle acque piova-ne. Francesco di Giorgio, chiamato daiMontefeltro a realizzare una serie di fortezze infunzione di presidi militari, progettò scale eli-coidali anche nelle rocche di Mondavio eMondolfo. Sull’opera e i principi architetto-nici di Francesco di Giorgio Martini si veda-no F.P. Fiore, M. Tafuri 1993, F.P. Fiore 2004. 15 Lo scalone di Chambord è l’esempio piùnoto in Europa di scala doppia a spirali intrec-ciate. La struttura, a pianta circolare, si svilup-pa nel mezzo di un corpo di fabbrica quadra-ta che costituisce la parte padronale del castel-lo. La gabbia, formata da otto massicci pilastriche salgono fino al tetto, è interamente apertasia all’esterno che all’interno delle rampe inmodo che queste siano completamente in vi-sta dalle quattro vaste gallerie che a ogni pianosi dipartono da essa formando una croce gre-ca. L’attribuzione è controversa. La citazionefattane dal Palladio nel I libro dell’Architettura(1570) è per A. Chastel (1965, parte II, p. 15)argomento a favore di quanti lo ritengono dimatrice italiana, ideato da Leonardo da Vinci.Per A. Blunt (1957, pp. 11-12) il progetto sa-rebbe invece di Domenico da Cortona, mo-dificato durante i lavori dalle maestranze loca-li, e la scala andrebbe collegata alla tradizionefrancese delle scale medievali a doppia rampa.Si vedano più recentemente i contributi di: J.Guillaume 1968, 1987 (pp. 261-266), e2005; H. Tanaka 2005. Sulla stabilizzazione del tipo architettonico inEuropa occidentale a partire dal XIV secolovedi M. Whiteley 1993, che cita numerosiesempi in Inghilterra e in Francia, di piccoledimensioni all’interno di edifici religiosi e mi-litari per il periodo tardo medievale, e succes-sivamente con sviluppi monumentali all’in-terno di edifici reali. 16 Per quanto riguarda Raffaello vedi C.L.Frommel in C.L. Frommel, S. Ray, M. Tafuri1984, p. 337. Sull’attribuzione non docu-mentata della villa senese al Peruzzi e sulla di-pendenza della scala coclide della villa dal mo-dello bramantesco vedi G. Neri 1982. 17 Il Metropolitan Museum of Art di NewYork conserva due disegni progettuali per pa-lazzo Farnese. Uno mostra il piano del palaz-zo al livello terreno che si accorda sostanzial-mente con l’edificio esistente, con un numerodi piccole varianti, alcune concentrate sull’an-golo nord-occidentale dell’edificio, dove com-pare una scala a spirale a pozzo aperto con so-
5. F. DI GIORGIO MARTINI. Scalaelicoidale nel torrione della Data aUrbino (da Fiore, Tafuri 1993). 6. F. DI GIORGIO MARTINI. Pozzodella rampa elicoidale nel monasterodi S. Chiara (da Fiore, Tafuri 1993).
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 81
progetto di S. Pietro e riferito al computista Antonio Della Valle (fig. 10), mostra in pian-ta l’architettura visionaria di una basilica con grande antipiazza semicircolare serrata ver-so l’esterno da una corona esagonale di ambienti circolari interpretabili in alzato cometorri campanarie che racchiudono in sequenza alternata scale a chiocciola. Queste ulti-me nella forma di impianto a � ρ, rinviano al tipo realizzato da Alberti nei piloni di S.Andrea a Mantova. Ispirazione bramantesca, suggestioni filaretiane e martiniane, speri-mentazione, confluiscono in un immaginario organismo architettonico che ha destatopiù volte l’interesse della critica23. Non sorprende che, nonostante il successo letterario seguito alla sua realizzazione, della pro-posta bramantesca al Vaticano, col progressivo affermarsi del vitruvianesimo, venisse accan-tonato proprio l’aspetto più trasgressivo, preferendo nelle sue varianti più tarde il regolare euniforme utilizzo degli ordini classici. Lo scalone circolare di Vignola a Caprarola, iniziatonel 1559, già sperimentato in piccolo a villa Giulia (scala a chiocciola con colonne libereal centro poi tamponate) (figg. 14-16), amplificò il tema bramantesco sovrapponendo co-lonne binate doriche proiettate sulla parete circostante in forma di paraste separate da nic-chie24. La straordinaria scala farnesiana, di circa dieci metri di diametro, comincia nel pia-no delle cantine, è illuminata su tre lati nei suoi due piani superiori e culmina in una ro-tonda-vestibolo cupolata che dà sul piano nobile del cortile. La scala del Belvedere, legata in origine a una sorta di cisterna per la raccolta dell’acqua piovana,nonché la semplicità e robustezza delle scale martiniane urbinati, ispirarono Antonio da Sangalloil Giovane nell’ideazione della scala elicoidale del pozzo di Orvieto (1529-1633) (figg. 12, 13),un modello a canna centrale traforata da bucature finestrate25. La costruzione fu ordinata nel1527 da Clemente VII, rifugiatosi a Orvieto per sfuggire al Sacco di Roma, al fine di garantirel’approvvigionamento idrico della città in caso di assedio. Sangallo impiantò una corona circo-lare di due cilindri in laterizio all’interno della quale si sviluppa una doppia elica che scende peroltre sessanta metri nello strato tufaceo su cui poggia la città: i lavori vennero condotti prima sca-vando nel tufo e poi nell’argilla e, una volta raggiunta l’acqua, ricostruendo in mattoni il pozzoe le scale laterali. Le due scale a chiocciola – una di 248 e l’altra di 247 gradini – indipendenti enon comunicanti fra loro, girano intorno alla canna in maniera tale che le persone e i muli chescendono per approvvigionarsi non si incontrino creando intralcio con chi risale.
82 PARTE SECONDA
stegni colonnari intermedi, secondo il model-lo realizzato da Bramante al Belvedere. Cfr. A.Blunt 1960-61. Vedi anche il corpus sangalle-sco pubblicato da C.L. Frommel 1994: scaleelicoidali circolari con rampe colonnari nei di-segni Uffizi 999, U 37A, U865 A.18 Sull’iconografia della scala bramantesca nelXVI e XVII secolo vedi C. Denker Nesselrath1997.19 Sulla scala pisana, in mancanza di docu-mentazione, la critica architettonica indica,come possibili autori, Nicola Pisano,Diotisalvi o Giovanni di Simone. Cfr. G.Nannicini Canale 1956, C.L. Ragghianti1995, S. Alabiso 2006. Secondo il Vasari(1568) l’opera, citata nella “Vita di Giovannie Niccola Pisani”, fu presa a modello daBramante e Antonio da Sangallo rispettiva-mente per la progettazione della scala delBelvedere in Vaticano e del pozzo di Orvieto.20 S. Serlio ed. 1978, Libro III, p. 75. Vediquanto scrive a riguardo A. Palladio ed. 1980,Libro I, cap. XXVIII, p. 88: “Erano anco neiportici di Pompeio, i quali sono in Roma perandare in piazza Giudea, tre scale a lumaca dimolto laudabile invenzione, percioché, essen-do esse poste nel mezo, onde non potevanoaver lume se non di sopra, erano fatte su le co-lonne, acciocché il lume si spargesse ugual-mente per tutto. Ad esempio di queste,Bramante, a’ suoi tempi singolarissimo archi-tetto, ne fece una in Belvedere, e la fece senzagradi, e vi volse i quattro ordini di colonne,cioè il dorico, ionico, corinthio e composito.A far tali scale si divide tutto lo spazio in quat-tro parti: due si danno al vacuo di mezo, et unaper banda à gradi e colonne”. La storiografia
7. BRAMANTE. Scala elicoidale delBelvedere in Vaticano.8. B. PERUZZI (attr.). Scala elicoidaledella villa a Santa Colomba pressoSiena.
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 82
Il tipo formulato da Sangallo rappresenta una variante sul tema della scala spiraliforme,utilizzato come soluzione funzionale a un problema ‘ingegneristico’: l’impresa colpìprofondamente il Vasari, che la definisce “cosa ingegnosa, comoda e di meravigliosa bel-lezza […] gli antichi non fecero mai edificio pari a questo né d’industria né d’artifitio”26.Nella seconda metà del Cinquecento l’innovazione tipologica della scala a spirale passò at-
traverso il principale topos geometrico della cultura cinquecentesca a partire da Peruzzi fi-no a Vignola, e cioè attraverso la sostituzione del cerchio con l’ovale, percepito come stru-mento di libertà e duttilità compositiva27. L’impianto ovale consentiva alla scala di man-tenere, come nelle strutture rettilinee, una certa longitudinalità – prodotta dallo schiac-ciamento del perno o del pozzo centrale – utile al passo della rampa e al controllo del nu-mero di spire di elevazione, e allo stesso tempo di mantenere la scultorea capacità centra-lizzante propria delle piante centrali.L’attrazione per le scale spiraliformi associata all’interesse teorico per le curve policentrichechiuse traspare chiaramente da numerosi schizzi di Peruzzi. L’architetto non solo tentò perprimo di definire la costruzione geometrica dell’ovale ma ne sperimentò le applicazioni an-che relativamente alla tipologia strutturale della scala, di cui offre un esempio grafico nel pro-getto per S. Giacomo degli Incurabili (Uffizi U 577A)28.
Le scale coclidi di Borromini 83
9. P. GALLE da Marten vanHeemskerck. Scena con adorazione deiMagi ispirata alla “lumaca” delBelvedere in Vaticano (da Borsi 1989).
In basso10. B. PERUZZI. Copia del progetto diAntonio della Valle per la nuovabasilica di San Pietro (disegno; Firenze,GDSU, U10Ar; da Wurm 1984).11. B. PERUZZI. Studio per una torrescalaria (disegno; Firenze, GDSU 472Ar; da Wurm 1984).
moderna (J. S. Ackerman 1954, p. 40; A.Bruschi 1969, p. 421 nota 160) è scettica sul-l’effettiva originaria esistenza di rampe colon-nari all’interno dell’antico edificio romano,ipotesi scaturita da una ricostruzione conget-turale del Peruzzi (Firenze, Uffizi 484 Ar) pro-babilmente dipendente dal prototipo bra-mantesco. Sull’identificazione dei portici diPompeo con la Crypta Balbi vedi F.Castagnoli 1946, pp. 190-193.21 Poiché la spirale non presenta interruzioninella sua continuità, non è possibile stabilire ilpunto preciso dal quale un ordine (colonnapiù trabeazione) muta in un altro. In altri ter-mini si mescolano tra loro ordini disomoge-nei. Cfr. A Bruschi 1969, pp. 417-433. Vedianche l’analisi di B. Angelini 1999, pp. 63-85. 22H. Wurm 1984, pp. 179, 289-293: si veda-no gli schizzi di torri scalari ispirati ai campa-nili di Pisa (Firenze, Uffizi: 362 Ar, 471–472Ar; 474-475Ar). La Torre Pendente (XII-XIV sec.), ha la struttura di un enorme pozzoalto più di 50 m, e dispone di una scala elicoi-dale di 294 gradini che conduce alla terrazza.23Per il disegno Firenze, Uffizi U 10Ar, si veda-no P. Portoghesi 1971, I, p. 66, vol. II, tav. XX-VIII; H. W. Hubert 2005, pp. 407, 628 fig. 24. 24 In origine il perno della chiocciola di villaGiulia era costituito da colonnine di traverti-no libere, ma ben presto si dovette riempire ilpozzo centrale, murandole per un quarto. Unsaggio eseguito nel 1982 sulla muratura ha ve-rificato che le colonnine sono intere e che imattoni usati per murare il foro centrale sonodello stesso tipo di quelli usati in genere nellafabbrica. Forse fu necessario intervenire du-rante la costruzione stessa della villa. I dati evi-denziano anche l’esiguità dei muri d’ambitoed è anche chiaro che non fu possibile darle ladimensione necessaria al suo buon funziona-mento statico. Cfr. S. Cocchia, A. Palminteri,L. Petroni 1987. Sulla villa di Caprarola si ve-dano: L. Partridge 1970; M. Fagiolo 1988; P.Portoghesi 1996. Sul Vignola in generale si ve-dano da ultimi Vignola 2002, M. Fagiolo2007 con testi e bibliografia aggiornati. 25 Allo stesso Sangallo si deve anche la costru-zione dello scalone rettilineo di palazzoFarnese, contributo romano fondamentale al-la tipologia della scala del palazzo urbano nelCinquecento. Cfr. C.L. Frommel 1985, pp.135– 143.26 G. Vasari 1568, Parte III, “Vita d’Antonioda Sangallo architettore fiorentino”. 27 Sul tema geometrico-architettonico dell’o-vale ha scritto per primo V. Fasolo 1931,
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 83
84 PARTE SECONDA
p. 310: “Questo problema architettonico sem-bra eccitare (soprattutto) la fantasia degli ar-chitetti che seguono il ciclo michelangiolesco,quasi fossero attratti dalla opposizione ch’essopresenta alla leggi della simmetria e all’ordineclassico”. Segue la trattazione fondamentale diW. Lotz 1955. Sui vari aspetti del problema sisono cimentati in molti, ricordiamo qui J.H.Müller 1967, M. Fagiolo 1982b, M. Curti1989, S. Benedetti 1995,R. Migliari 1995, M.R. Nobile 1996. Interessanti i numerosi con-tributi sulle costruzioni geometriche dell’ova-le pubblicati nella rivista “Disegnare IdeeImmagini”; si vedano in particolare F. Ragazzo1995, il numero monografico Il Colosseo(1999), E. Dotto 2000. 28 Cfr. W. Lotz 1997, nota 76.29 Per le costruzioni geometriche dell’ovale ve-di S. Serlio ed. 1978, Libro I, p. 14; per la scalalumaca quadra vedi Libro II, p. 42. Quantoscarso fosse invece l’interesse teorico di Vignolaper la forma ovale, lo si ricaverebbe secondo W.Lotz (1997, nota 119), dal commento diEgnazio Danti al capitolo VIII dell’edizionedel 1611 di Le due regole della prospettiva pra-tica, p. 113: “la figura, curvilinea, che eschi dal-la sezione parabolica, ò da quella dell’anello, oda qualsivoglia altra sezione del cilindro, o delconio, in ogni loro punto, et anco le figure mi-ste di linee rette e curve: delle quali tutte nonessendo stato parlato dal Vignola”. 30 A. Palladio ed. 1980, Libro I, cap. XXVIII,p. 61. W. Lotz (1997, p. 31), esaminando leopere letterarie e architettoniche di Palladio al-la ricerca di quale fosse il suo atteggiamentonei confronti dell’ovale, osserva che l’architet-to nei “Quattro Libri” preferisce nei suoi edi-fici i “siti regolari” misurabili, in particolarequelli circolari, mentre riserva l’irregolare ova-le unicamente alle scale. Sulle scale palladianehanno scritto: A. Chastel 1965; F. Mielke1980; G. Bordignon Favero 1980; B.Morimando 2002; A. Barbieri, A. DiTommaso, R. Massarotto 2003; R. Cevese2005; F. Barbieri 2005; M. Bourke 2006.31Mentre la scala francese è una scala lumacadoppia, quella disegnata da Palladio in piantaè più semplicemente una scala lumaca con larampa pausata da quattro ripiani e il pozzo nelmezzo. Sull’errore di Palladio nella rappresen-tazione vedi F. Mielke 1980, p. 170.32 Il progetto ligoriano è documentato da undisegno risalente all’epoca del pontificato diPio IV (1559-1565), pubblicato da A.Modigliani 1932-33, pp. 211sgg. Vedi al ri-guardo W. Lotz 1997, nota 98. G. Marcolin eG. Marcon (1987) attribuiscono a Ligorio ungrandioso progetto di ampliamento del pa-lazzo Bentivoglio di Ferrara (Archivio di Stato,Ferrara, Periti, Mappe, cartella L, piante n. 14e 15) comprendente uno scalone circolare condoppia rampa a tenaglia che si espande in unulteriore doppio scalone a base quadrata.Secondo l’ipotesi attributiva, Ligorio avrebbeelaborato il progetto intorno al 1574, al tem-po delle aspirazioni regali di Alfonso II d’Este.Nel 1583, alla morte di Ligorio il prosegui-mento dell’opera sarebbe stato affidato al gio-vane Giovan Battista Aleotti. L’attribuzionedel palazzo è però controversa, e i disegni pro-gettuali sono stati più verosimilmente asse-gnati all’Aleotti poiché la concezione dei duescaloni monumentali sembra risalire a un’e-poca più tarda, la stessa a cui appartiene anchelo scalone della Pilotta a Parma, realizzato nel1610 da Moschino (a sua volta ispirato algrande scalone del monastero di S. Lorenzodell’Escorial terminato nel 1583), importan-te precedente per la progettazione dello scalo-ne monumentale della rocca di Scandiano,sempre dell’Aleotti. Cfr. B. Adorni 1974,
12. F. BUONANNI. Scala doppia delpozzo di Antonio da Sangallo a Orvieto(da “Numismata PontificumRomanorum”, tomo I, 1706, p. 192).13. ANTONIO DA SANGALLO. Pozzodella scala doppia a Orvieto.
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 84
Serlio, Palladio e Vignola, innovando Bramante, introdussero la scala a chiocciola ovale e lafuga di scalini a sbalzo fuori del muro, senza alcun supporto sul lato libero. Serlio, erede delPeruzzi, con le sue “quattro maniere” di costruire geometricamente l’ovale, andò a costitui-re in un certo senso la base pratica della sua applicazione in architettura29, mentre Palladio(1508-1580) codificò il tipo delle scale ovate nel Primo Libro del trattato, con il capitolo“Delle scale, e varie maniere di quelle, e del numero, e grandezza de’ gradi” (1570):
“Le scale a lumaca, che a chiocciola anco si dicono, si fanno altrove ritonde et altrove ovate, alcunavolta con la colonna nel mezo et alcuna volta vacue. Nei luoghi stretti massimamente si usano perchéoccupano manco luogo che le diritte, ma sono alquanto più difficili da salire. Benissimo riescono quel-le che nel mezo sono vacue, perciocché ponno avere il lume dal di sopra, e quelli che sono al sommodella scala veggono tutti quelli che saliscono o cominciano a salire, e similmente sono da questi ve-duti. Quelle c’hanno la colonna nel mezo si fanno in questo modo, che, diviso il diametro in tre par-ti, due siano lasciate ai gradi et una si dia alla colonna, come nel disegno A; overo si dividerà il dia-metro in parti sette, e tre si daranno alla colonna di mezo e quattro ai gradi […] Ma nelle vacue si di-vide il diametro in quattro parti: due si danno ai gradi, e due restano al luogo di mezo […] Le ovateancor esse vanno divise nel medesimo modo che le ritonde. Sono molto graziose, e belle da vedere:perché tutte le finestre, e porte vengono per testa dell’ovato e in mezo, e sono assai comode”30.
Fondamentale è l’apparato delle illustrazioni nel quale trovano posto, accanto alle immaginidei principali tipi spiraliformi (figg. 17, 18), incluse le varianti più complesse e monumentalicome quella di Chambord (fig. 19) 31, le descrizioni degli edifici dell’architetto – molti dei qua-li comprendenti scale ovate come palazzo Thiene a Vicenza, il monastero della Carità a Venezia,e la Villa Corner a Piombino Dese – contribuendo enormemente alla loro divulgazione.La predilezione palladiana e vignolesca, pur derivata da Peruzzi e Serlio, per forme e spazi ova-li compresi quelli di tipo spiraliforme, sembra essere stata condivisa anche da Pirro Ligorio.Nel 1565 l’architetto iniziò a edificare, nel sito dell’odierna torre Pia in Vaticano, un grandevano che avrebbe dovuto racchiudere una scala ovale con nicchie diagonali, collegata a unarampa rettilinea. La morte del committente, papa Pio IV, e l’elezione del successore Pio V, ten-denzialmente contrario a soluzioni che si discostassero da esempi più classici, provocò l’al-lontanamento di Ligorio, l’interruzione dei lavori e la destinazione dell’involucro murario del-la scala ovale, appena cominciata, a “contenitore” di tre cappelle sovrapposte32.
Le scale coclidi di Borromini 85
14. J. BAROZZI DA VIGNOLA. Scala diVilla Giulia a Roma.15. J. BAROZZI DA VIGNOLA. Scaloned’onore di Palazzo Farnese aCaprarola.
In basso16. G. VALVASSORI. Sezione delloscalone d’onore di palazzo Farnese aCaprarola del Vignola (disegno; daPortoghesi 1996, tav. XXXII).
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 85
A dimostrazione dell’indiscutibile entusiasmo che si creò intorno alla forma ovale in archi-tettura nella seconda metà del secolo, vanno ricordate anche le pagine di Giovan VettorioSoderini (1526-1596) nel Trattato sull’Agricoltura33. Dilettante d’architettura e amico diGiovanni Antonio Dosio (1533-1609), Soderini era dominato da due ossessioni architetto-niche, quella per la forma “ovata” impiegata per le tipologie più diverse, e quella per le scale.Alcuni disegni del corpus di Dosio agli Uffizi, sono stati attribuiti al Soderini34. Le interes-santi esercitazioni su complessi schemi aggregativi35 fanno trasparire la conoscenza di dise-gni o temi già descritti da Peruzzi e in ogni caso l’influenza del Serlio36. A Palladio e all’ambito di Vignola va ricondotta soprattutto la stabilizzazione di un tipoimpegnativo e cioè la scala elicoidale con rampa pensile, che il maestro vicentino speri-menta con soddisfazione nello scalone ovale della Carità a Venezia (fig. 20) affermando diessersi ispirato a un’opera “del Clarissimo Signor Marc’Antonio Barbaro Gentil’huomoVenetiano di bellissimo ingegno”37. La fuga scultorea delle lastre marmoree a sbalzo dellascala veneziana, incastrate nel muro e senza supporti nel lato interno protetto da un rin-ghiera in ferro battuto, fece una grande impressione su Inigo Jones che la riecheggerà nel-la Tulip Staircase della Queen’s House di Londra (1616-1629) 38. Palladio scavò e alleggerìle pareti della scala con nicchie decorative che forse prevedeva di completare con figure,come vengono raffigurate da Giacomo Leoni (1686-1746) nella traduzione inglese deiQuattro Libri39. Dall’opera eseguita, in particolare dalla disposizione irrisolta delle buca-ture rispetto alla rampa e al fronte esterno, traspare tuttavia la difficoltà ad attenersi ai cri-teri enunciati nel trattato (armonia, simmetria), a dimostrazione del fatto che molto do-veva ancor essere perfezionato della tipologia. Vincenzo Scamozzi seguì la tipologia palladiana riproposta fedelmente in Villa Corner, det-ta il “Cornaron”, a Poisolo, Castelfranco Veneto, 1588 (fig. 21). Lo imitarono più tardi, nelSeicento, Baldassarre Longhena e Giuseppe Sardi con la scala all’Ospedaletto di Venezia40.Tra i primi esempi di chiocciola ovata a pozzo aperto e senza sostegni intermedi, vanno ri-cordate, ancora in Italia settentrionale, quella di palazzo Boncompagni-Contrari a Vignola(fig. 22) realizzata da Bartolomeo Tristano su probabili suggerimenti di Jacopo Barozzi41, equella più tarda di palazzo Cusani a Milano, forse attribuibile a Pellegrino Tibaldi42.Nell’ambito del Vignola si evidenzia anche la diffusione del parapetto verso il pozzo centra-le in sostituzione del cordolo in pietra di ascendenza medievale (figg. 22, 23, 30).Le scale rotanti in ovato senza perno centrale, dagli indubbi valori spaziali e notevoli effettiscenografici, possono certamente considerarsi saggi di preludio alla libertà e dinamicità del
86 PARTE SECONDA
pp. 48-69; Id. 1989; L. F. Schianchi 1996;Diego Cuoghi 2003, pp. 121-143.33 G.V. Soderini 1902, la parte riservata al-l’architettura è alle pp. 260-276. Cfr. F.Quinterio 1989.34 A. Morrogh 1985.35Disegni Uffizi n. 3887 Av, 3881 A, 3878 A,3879 A. Sul Dosio si veda L. Wachler 1940.36 Si vedano in particolare le suggestioni da S.Pietro in Vaticano. Confronta a riguardo ildisegno attribuito a G.V. Soderini, Uffizi,3881 A, con il disegno Uffizi, U 10 A diBaldassarre Peruzzi per S. Pietro “secondo laoppenione di Messer Antonio Della Vallecomputista di palazzo”. 37 Nel Libro I del trattato (ed. 1980, p. 85), alcapitolo XXVIIII “Delle scale, e varie manieredi quelle, e del numero, e grandezza de’ gradi”,Palladio aveva ricordato: “Oltra le usate manie-re di Scale; n’è stata ritrovata una pure à Lumacadal Clarissimo Signor Marc’Antonio BarbaroGentil’huomo Venetiano di bellissimo inge-gno: la quale ne i luoghi molto stretti serve be-nissimo. Non ha colonna in mezo, & i gradi peresser torti; riescono molto lunghi, & và divisacome la sopradetta. […] Io ne ho fatto una va-cua nel mezo del Monasterio della Carità inVenetia: la quale riesce mirabilmente”. 38 Su Inigo Jones e Palladio nella culturaarchitettonica inglese vedi A. CeruttiFusco 1980, Ead.1983, Ead. 1985. Lascala palladiana del monastero dellaCarità ispirerà a Venezia il Sardi e ilLonghena nella realizzazione della scaladell’Ospedaletto (1664-1666). Tra gliestimatori più tardi della scala ricordiamoil Goethe che affermava: “in tale scala non
17. A. PALLADIO. Scale a chiocciola aimpianto circolare (da “I QuattroLibri…” 1570, Libro Primo, cap.XXVIII “Delle Scale”; “A scala alumaca con la colonna nel mezo / Bscala a lumaca con la colonna e co’gradi torti / C scala a lumaca vacuanel mezo / D scala a lumaca vacua nelmezo e co’ gradi torti”).18. A. PALLADIO. Scale a chiocciola aimpianto ovale (da “I Quattro Libri…”1570, Libro Primo, cap. XXVIII “DelleScale”; segnata con la lettera F, la scaladel convento della Carità).
In basso19. A. PALLADIO. Scala doppia delcastello di Chambord (da “I QuattroLibri…” 1570, Libro Primo, cap.XXVIII “Delle Scale”).
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 86
Seicento. L’ingegnosa soluzione strutturale è affrontata nel tardo Cinquecento a Roma daGiacomo della Porta nella realizzazione delle scale, ancora circolari, progettate daMichelangelo per i pilastri di S. Pietro43, e da Mascherino in una scala ovale nell’ala est delcortile del Belvedere Vaticano 44.Nella seconda metà del Cinquecento i criteri progettuali per le scale vanno progressivamen-te conformandosi ai nuovi ideali raccomandati dal Vasari nell’edizione del 1568 delle Vite45,contribuendo al diffondersi degli esempi con un ruolo cerimoniale: le scale pubbliche nondovevano essere solo ampie, spaziose, ben illuminate e comode nel salire, ma ciascuna parteavrebbe dovuto mostrare un’aria di magnificenza. Gli sviluppi successivi sono strettamentilegati al complicarsi del cerimoniale e alle nuove esigenze di rappresentatività46.
Le scale coclidi di Borromini 87
ci si stanca mai di salire e scendere” (Cfr.Elena Bassi 1971).39 La prima edizione della traduzione inglesedi Giacomo Leoni dei Quattro Libridell’Architettura risale al 1715. 40 Sulle scale ovate di ispirazione palladiana ve-di R. Cevese 1980, p. 245; G. BordignonFavero 1980. Sulla loro diffusione nel Seicentoin Veneto vedi anche l’esempio anonimo del-la scala di palazzo Maffei a Verona. Sulla scaladi Scamozzi vedi F. Barbieri, G. Beltramini2003, pp. 266-267, scheda n. 24. Nel secoloXVIII lo studio delle forme palladiane con unateorizzazione delle scale ellittiche venne pro-posto, in chiave razionalistica e neoclassica, dalcenacolo di Jacopo Riccati di CastelfrancoVeneto. Il figlio Giordano, matematico e ar-chitetto, pubblicò nel 1780 la Nuova manieradi costruire le scale ellittiche con la messa a pun-to di un metodo geometrico per ovviare ai di-fetti che si riscontravano nei disegni e nella ge-neralità delle costruzioni ellittiche.41 Sul lascito del Vignola in Emilia vedi B.Adorni 2002, il quale attribuisce a un altro al-lievo del maestro, Gian Francesco Testa, la sca-la a chiocciola sorretta all’interno da colonnedi palazzo Soragna Tarasconi a Parma (vedianche B. Adorni 1974, pp. 115-120).42 G. Denti 1988.43 Vedi al riguardo Vasari nelle Vite… (ed.Firenze 1856, vol. XII, p. 229): “ Finalmentefu dal papa aprovato il modello che aveva fat-to Michelagnolo, che ritirava San Pietro a mi-
20. PALLADIO. Scalone ovale delmonastero della Carità a Venezia(1560 c.).21. V. SCAMOZZI. Scala ovale in villaCorner, Castelfranco Veneto (1588).
In basso22. B. TRISTANO. Scalone di PalazzoBoncompagni Contrari a Vignola(1560 c.).23. J. BAROZZI DA VIGNOLA. Scala diservizio in Palazzo Farnese a Piacenza.(da Frommel, Ricci, Tuttle 2003).
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 87
Tra il 1583 e il 1585 Ottaviano Mascherino, già autore della citata scala nel Belvedere, rea-lizzò per Gregorio XIII sul Quirinale una villa con facciata a portico e loggia collegate inter-namente da una splendida scala ovale elicoidale (fig. 24), nella quale, come è stato osservato,si riversarono i risultati cinquecenteschi e si concretizzò il proseguimento delle ricerche delVignola, con lo sviluppo di alcune sue idee, in particolare il motivo dei balaustri alternati acolonne binate disposte al centro della rampa: “in questa opera la suggestione della prece-dente geometria circolare dello scalone di Caprarola, saldata su quella ovale della S. Anna deiPalafrenieri, si apre in una trama spaziale pienamente barocca con l’avvitarsi della strutturanello spazio verticale della salita”47. L’architetto bolognese risolve la maggiore complessitàdella lumaca a impianto ovale, aggiungendo due pianerottoli di riposo ai due estremi del-l’asse maggiore laddove si sarebbe verificata una concentrazione radiale di pedate nonché unmaggiore sviluppo in altezza della spirale. L’architetto contribuì notevolmente – anche at-traverso il ruolo svolto nell’Accademia di San Luca e la sua mediazione tra Milano, Bolognae Roma – alla diffusione degli impianti ovali per le scale, quasi una costante nei suoi elabo-rati grafici, con l’elaborazione di nuove e interessanti varianti48.Le scale ‘aperte’ in Vaticano e a Montecavallo sono citate come realizzazioni esemplari daEgnatio Danti49 nell’appendice finale alla sua edizione di Le due regole della prospettiva pra-tica di Messer Iacopo Barozzi da Vignola (1583), opera pubblicata e commentata a dieci annidalla morte di Vignola, fondamentale nella storia dell’applicazione della prospettiva.L’aggiunta, dedicata alle scale, è illustrata da due schemi costruttivi – “due esempi delle sca-le a lumaca doppie”50 – uno dei quali, segnato Z, mostra una particolare variante di scala co-clide a pozzo ‘vacuo’ con doppia rampa a intreccio e sostegni intermedi costituiti da pilastriin sostituzione dell’ordine architettonico (figg. 26, 29). A questa tipologia costruttiva, sebbene ridotta all’utilizzo di una sola rampa, possiamo ri-condurre la straordinaria scala realizzata da Onorio Longhi nel 1615 nel palazzetto in-compiuto di Francesco Pelliccia in Parione (figg. 27, 28)51. L’intervento rientrava nell’o-pera di ristrutturazione e inglobamento di una casa ceduta nel 1585 al padre di Francesco,Pellegrino Pelliccia, da Girolamo Giustini52. La scala, incardinata in uno snodo angola-re, presenta requisiti di monumentalità e decoro insoliti per la tipologia edilizia in cui èinserita, e fu probabilmente intesa, in origine, a valorizzare e distribuire due case preesi-
88 PARTE SECONDA
nor forma, ma si bene a maggiore grandezza,con satisfazione di tutti quelli che hanno giu-dizio, ancora che certi che fanno professioned’intendenti (ma in fatti non sono) non loaprovano. Trovò che quattro pilastri principa-li fatti da Bramante e lassati da Antonio daSangallo, che avevono a reggere il peso dellatribuna, erano deboli; e’ quali egli riempiè, fa-cendo due chiocciole, o lumache da lato, nel-le quali sono scale piane, per le quali somari visalgono a portare fino in cima tutte le materiee parimente gli uomini vi possono ire a caval-lo infino in sulla cima del piano degli archi”.Per l’inserimento delle scale a chiocciola diMichelangelo e Della Porta nei pilastri dellabasilica di San Pietro si vedano le notazionitecniche di F. Bellini 2000, p. 395.44 Sull’opera del Mascherino (Bologna 1536-Roma 1606) vedi in generale J. Wassermann1966.Sulla scala mascariniana al Vaticano ve-di J. S. Ackermann 1954, fig. 35. Sui rappor-ti fra il Vignola e il Mascherino vedi W. Lotz,1997, nota 150; Vignola 2002, ad indicem;M. Fagiolo 2007, ad indicem. In quanto bo-lognese e protetto di papa Gregorio XIII, an-ch’egli di Bologna, è possibile che Mascherinoabbia avuto contatti con Vignola già prima ditrasferirsi a Roma. Sui rapporti fra il Vignola eGiacomo Della Porta si veda W. Lotz 1981. 45G. Vasari 1968, I, p. 92, “Introduzione alletre arti del disegno, cioè architettura, pittura escoltura”, cap. VII dell’Architettura: “Come siha a conoscere uno edificio proporzionato be-ne, e che parti generalmente se li convengono[…] Vogliono le scale publiche esser commo-de e dolci al salire, di larghezza spaziose e d’al-
24. Ottaviano Nonni detto ilMASCHERINO. Scala elicoidale nelPalazzo del Quirinale (da Wasserman1966).25. F. PONZIO. Scala ovale in PalazzoBorghese a Roma.
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 88
Le scale coclidi di Borromini 89
26. E. DANTI. Schema costruttivo discala ‘lumaca’ doppia con sostegniintermedi pilastrati (da Le dueregole…1583; segnata ‘Z’).27. O. LONGHI. Scala ovale nelpalazzetto di Francesco Pelliccia in viadel Teatro Pace, particolare.
In basso28. O. LONGHI. Scala ovale nelpalazzetto di Francesco Pelliccia in viadel Teatro Pace, particolare dellabalaustra.29. E. DANTI. Schema costruttivo discala ‘lumaca’ doppia con rampe senzasostegno centrale (da Le dueregole…1583; segnata ‘X’).
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 89
stenti affiancate. La struttura, di impianto ovale, parte dal piano sotterraneo con un’ani-ma cilindrica e prosegue nei due livelli superiori con pilastrature nude raccordate da aper-ture arcuate. L’opera, caratterizzata da licenze sintattiche e irregolarità innescate dall’ac-centuato schiacciamento della circonferenza interna della rampa e dalla diseguaglianzadelle altezze dei tre piani, sembra riflettere l’animo inquieto dell’autore ed è ricca di spun-ti creativi. L’angusto vestibolo comunicante con l’esterno non è altro che un ampio ‘ri-poso’ della rampa che riparte sul lato opposto con uno straordinario scatto verticale perraggiungere il primo e il secondo piano nobile. Lo slancio dinamico imposto alla strut-tura dal progressivo innalzamento delle pedate degli scalini arriva a deformare elastica-mente la cimasa in peperino del parapetto e a stirare in modo abnorme in altezza i pila-stri fino al ‘punto critico’ puntellato da una trave di contraffortatura caricata sul murod’ambito. Lo schiacciamento dell’ovale impedisce la disposizione dei ripiani sull’asse mag-giore con il loro spostamento laterale verso l’arco di maggiore curvatura. Il passo irrego-lare della rampa elicoidale è risolto da scalette rettilinee che immettono ai piani; notevo-li sono le accortezze nell’intaglio dei gradini con riseghe e spianature di raccordo. OnorioLonghi raggiunge nella discrasia linguistica – vedi il contrasto del parapetto classicistacon la brutalità dei pilastri – effetti scenografici di grande efficacia53. Le specifiche competenze degli scalpellini viggiutesi, di cui poterono avvalersi prima Onorioe poi il figlio Martino Longhi il giovane, contribuirono notevolmente alla qualità artisticadelle scale longhiane due delle quali sono considerate tra i migliori esempi realizzati a Romae dintorni nel XVII secolo (vedi di Martino le scale a rampe rettilinee di Palazzo Caetani alCorso e Palazzo Ginnetti a Velletri) 54. Nel contratto stipulato da Francesco Pelliccia con il mastro lapicida Francesco Lucchesini perla fattura degli scalini, dei balaustri e delle modanature in peperino della scala in Parione vie-ne indicata come modello per la realizzazione l’opera che lo scalpellino Girolamo Falcioni ave-va fatto precedentemente nella casa di Marco Antonio Toscanella sotto Trinità dei Monti55.La segnalazione archivistica è di un certo interesse perché il patrizio Toscanella è conosciutodagli storici come il nuovo proprietario del palazzo incompiuto di Federico Zuccari a Trinitàdei Monti (sede oggi della Biblioteca Hertziana) 56. Dopo l’acquisto nel 1609 il Toscanella af-fidò il completamento della fabbrica a Girolamo Rainaldi. Lo scalone d’onore, che sappiamoeffettivamente essere stato molto più largo e luminoso di quello attuale (il palazzo è stato mo-dificato nel 1904), sarebbe stato concepito, secondo il documento, simile a quello di OnorioLonghi in Parione. Francesco Pelliccia si riferiva però evidentemente solo alla fattura degli sca-
90 PARTE SECONDA
tezza sfogate, quanto però comporta la pro-porzione de’ luoghi. Vogliono oltre acciò, es-sere ornate e copiose di lumi, et almeno sopraogni pianerottolo, dove si volta, avere finestreo altri lumi; et insomma vogliono le scale inogni sua parte avere del magnifico, attesochémolti veggiono le scale e non il rimanente del-la casa. E si può dire che elle sieno le braccia ele gambe di questo corpo; onde, sì come lebraccia stanno dagli lati dell’uomo, così deo-no queste stare dalle bande dell’edificio. Né la-scerò di dire che l’altezza degli scaglioni vuoleessere un quinto almeno, e ciascuno scaglionelargo due terzi, cioè come si è detto, nelle sca-le degli edifici pubblici, e negli altri a propor-zione; perché quando sono ripide non si pos-sono salire né da’ putti né da’ vecchi, e rompo-no le gambe”. Nelle versioni precedenti del1550, Vasari semplicemente raccomandavascale che fossero funzionali e non pretenziose.46 A. Jarrard 1997.47 S. Benedetti 1997, pp. 176-177. La scalacentralizzata e l’uso di doppie colonne deriva-no direttamente dalla scala di Caprarola. Il suoallungamento in un ovale appare un contri-buto di Mascherino, essendo questa la formache ricorre frequentemente nel suo lavoro.L’architetto aveva intenzione di decorare lavolta della scala con un disegno alternato diovali e losanghe bisezionate longitudinalmen-te da un’ampia fascia. La decorazione, am-messo sia stata eseguita, non esiste più. Vedi alriguardo G. Zander in S. Benedetti, G.Zander 1990, p. 432 e segg.: “Il Mascarino[…] amico di famiglia di Jacopo e di GiacintoBarozzi da Vignola […] sviluppa con squisitafinezza e con ricca originalità di ricerca talunipensieri del Vignola, e rielabora la tematicadelle forme ovali, che aveva nelle scale dise-gnate dal Palladio nei Quattro libri e nel trat-tato di Sebastiano Serlio bolognese alcuni de-gnissimi spunti. […] Non è chi non pensi al-
30. J. BAROZZI DA VIGNOLA. Scaladel palazzo comunale di Grotte diCastro.31. F. BORROMINI. Scala del conventodi San Carlino alle Quattro Fontane.
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 90
lini e dei balaustri perché il rilievo che l’architetto Lorenzo Possenti fece di palazzo Zuccarinella prima metà del XVII secolo mostra uno scalone a rampe rettilinee57.A cavallo del Seicento, nell’ambito della comunità viggiutese romana, venne ripreso anche, do-po Vignola e Mascherino, il modello più classico, di ascendenza bramantesca, dello scalone d’o-nore a chiocciola con colonne intermedie58. Martino Longhi il Vecchio, padre di Onorio, ne di-segnò uno a impianto circolare per il completamento di palazzo Zambeccari (poi Alessandrino)59, mentre il suo conterraneo e parente Flaminio Ponzio realizzò la prima scala ovale romana co-lonnata del nuovo secolo (1605) in fondo al cortile di Palazzo Borghese (figg. 25, 56). Il legame tra le comunità dei viggiutesi e i cosiddetti ticinesi a Roma era molto stretto sia nel-la vita pratica che nel mestiere.Uno scalone a impianto ovale a pozzo vacuo con colonne centrali fu riproposto un venticin-quennio più tardi da Borromini nell’ala est di palazzo Barberini in contrapposizione a quelloberniniano a pianta quadra nell’ala ovest. La combinazione in palazzo Barberini di due scalemonumentali – con funzione e significati diversi, ma tra di loro complementari – offrì agli ar-chitetti un importante modello distributivo ispirato al principio della varietas: le due scale, en-trambe accessibili dall’esterno, servivano due ali opposte dell’edificio con appartamenti indi-pendenti saldati da un salone in comune; l’una a rampe rettilinee, utilzzata anche come per-corso cerimoniale, l’altra a rampa spiraliforme, riservata a una circolazione più privata. Nel 1634 Girolamo Rainaldi, certamente stimolato dallo scalone barberiniano, sottopose aFrancesco I d’Este, per il quale elaborava un piano di ampliamento del palazzo ducale diModena, il modello di una “scala lumaca doppia” illustrata dall’architetto in una lettera in-viata da Parma al duca:
“La detta scala ha due entrate e diverse uscite, non solo quelle delli ripiani, ma anco da entrare, in mezzani, e altri camerini da ogni banda, e il suo pozzo vacuo riceve il lume da cima per una cuppo-la, circondata da fenestre, serverà anco da tirare con le taglie, li mobbili alla guardarobba, questo mo-dello fu fatto alla proportione di braccia 20 d’altezza sino al piano nobile, si potrà ridurre alle brac-cia di 17 di cotesta fabbrica” 60.
Il documento contribuisce a chiarire il sistema di copertura a cupola o a lanternino, il più ricor-rente allora per questo tipo di scale, che rispondeva meglio del tetto alla tipologia d’impianto e al-le esigenze di monumentalità, risolvendo anche l’illuminazione laddove spesso mancavano aper-ture nelle muraglie d’ambito61. Queste strutture, certamente, quando estradossate e visibili al-meno da particolari punti di vista elevati, conferivano inoltre una varietà ai profili degli edifici, og-gi quasi del tutto perduta per i numerosi rifacimenti che hanno nascosto quelle soluzioni di co-pertura. Un altro aspetto rilevante riguarda la specializzazione funzionale che attribuiva a questotipo di scale un carattere più intimo e riservato rispetto allo scalone d’onore a impianto quadro62.Con Borromini, architetto attento a conciliare l’apparato decorativo con le esigenze economi-che e funzionali, il corpo scala diventò parte rilevante dell’organismo architettonico. Lo scalo-ne d’onore a chiocciola – in quanto architettura di movimento – incarnava uno dei modelli del-
Le scale coclidi di Borromini 91
l’esempio della scala a lumaca del Bramantenel cortile vaticano del Belvedere; e tutti ri-cordano il più pertinente e prossimo motivovignolesco della scala nel palazzo di Caprarola;come anche si è pensato alle “lumache” dellabasilica di S. Pietro, dove i gradini non spor-gono del tutto a sbalzo dal muro cilindricoesterno a direttrice ovale; e si è citato sempreun disegno edito da Ignazio Danti, ne Le dueregole della prospettiva pratica di J. Barozzi daVignola, del 1583. Senonché ben più facile èla ‘lumaca’ a pianta circolare, ben più difficilela lumaca a impianto ovale, dove siano inoltrericavati pianerottoli di riposo ai due estremidell’asse maggiore, e molto giuste sono le os-servazioni del Borsi (1973) sull’accortezza ma-nifestata dall’architetto nell’inserirli – egli spie-ga – ‘dove cioè si sarebbe verificata una speciedi concentrazione radiale delle pedate, e unmaggiore sviluppo in altezza della spirale’”.Sull’attività del Mascherino al Quirinale, cfr.J. Wassermann 1963, pp. 205 sgg.; H.Hibbard 1971, pp. 194 sgg. e fig. II; K.Schwager 1968, pp. 253 sgg.; F. Borsi 1973,pp. 52-54; F. Quinterio1991, pp. 115-200; ein particolare sulla scala ovale, H. Hibbard1962, p. 59, nota 52. Sull’inserimento di sca-le ovali nei progetti di Mascherino per palazzie ville, vedi la monografia sull’architetto di J.Wassermann 1966.48 Sull’importante ruolo svolto dall’architettoall’interno dell’Accademia di San Luca si ve-dano le interessanti osservazioni in S.Kummer 1977. 49 Egnazio Danti (al secolo Carlo PellegrinoRinaldi, 1536-1586), frate domenicano diPerugia, cosmografo, cartografo, maestro digeometria e prospettiva, fu anche biografo delVignola. Nel 1583 pubblicò, a dieci anni an-ni dalla morte dell’architetto, Le due regole del-la prospettiva pratica di Messer Iacopo Barozzida Vignola, opera commentata fondamentalenella storia dell’applicazione della prospettiva,sia per la sua diffusione, sia per considerevolianticipazioni delle conclusioni cui prevennepiù tardi Guidobaldo del Monte. Il passo a cuici si riferisce è a p. 145: “Il disegno X, è di quel-le scale aperte, che si reggono senza haver nelmezo posamento nessuno, essendo gli scalinifermati con la testa nel muro, & messi tal-mente l’un sopra l’altro, che un regge l’altro,& gli stessi scalini fanno volta alla scala: dellequali n’è fatta una tonda & scempia, moltobella & alta, nella fabbrica di San Pietro, chevà da alto a basso, con li scalini di travertino,da Iacopo della Porta prestantissimoArchitetto di detta fabbrica. Un’altra similescala scempia aperta nel mezo con li scalini ditravertino, che fanno scalino, & volta, s’è fat-ta in forma ovata per salire da Belvedere alla
32. F. BORROMINI. Scala che scendenella chiesa inferiore di San Carlinoalle Quattro Fontane.33. F. BORROMINI. Progetto in piantaper la facciata di S. Carlo alle QuattroFontane, con l’adattamento degli spazicontigui. Particolare con lo studio diuna scala ovale con gradini curvilinei(1666-1667; disegno; Vienna; Alb. AzRom 176).
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 91
la tradizione rinascimentale che meglio si prestava per le sue caratteristiche alla trasfigurazionedinamica operata dal linguaggio borrominiano, offrendo nuove possibilità compositive63.Nel Rinascimento il tema dello scalone elicoidale era legato perlopiù a quello del grande palaz-zo o della villa suburbana: lo scalone bramantesco era stato costruito sul fianco della villa diInnocenzo VIII per offrire un accesso diretto all’area museale del complesso del Belvedere a chiproveniva da nord senza passare attraverso il palazzo papale, mentre lo scalone del Vignola aCaprarola era stato progettato per un grandioso palazzo feudale di campagna e quello diMascherino per una villa papale sul colle del Quirinale64. Sulla scorta degli esempi cinquecente-schi Borromini ricorre a modelli monumentali all’interno di grandiose fabbriche civili, senza tra-scurare l’adattamento semplificato nelle fabbriche religiose. Nella sua opera la scala elicoidaleviene infatti piegata alle più diverse esigenze: vedi la scala segreta di minuscole dimensioni rica-vata negli spazi di risulta e attorcigliata attorno al nastro del parapetto nei complessi conventua-li di S. Carlino alle Quattro Fontane e dell’oratorio dei Filippini, o la scala cordonata con noc-ciolo centrale di palazzo Carpegna, o la scala monumentale con sostegno colonnare intermediodi palazzo Barberini, o la scala con gradini pensili e pozzo centrale dell’ala est di palazzo Spada. La ripresa dello scalone d’onore elicoidale raggiunge poi nei disegni progettuali di Borrominisviluppi scenografici purtroppo solo in minima parte realizzati.
2. Scaloni elicoidali nell’opera borrominiana
I disegni progettuali di Borromini rivelano una speciale preferenza per le scale del tipo a spi-rale studiate nelle possibili varianti strutturali e nella diversa utilizzazione, sia come scale diservizio sia come scaloni d’onore. Quelle più piccole vengono sovente ricavate laddove gliinconsueti spessori della sezione muraria, opportunamente svuotati, ne consentono l’inse-rimento, seguendo una pratica piuttosto comune. La loro compattezza risolve sciaveri e spa-zi irregolari creati dall’organizzazione planimetrica e da vincoli posti dalle preesistenze (ve-di ad esempio i denti delle riseghe determinate dall’adeguamento ai lotti). Ma in particolarmodo si addice all’opera di scavo dell’involucro murario, tipicamente borrominiana, e quin-di ai pieni e ai vuoti ottenuti nei cantoni delle sale rispettivamente con angoli convessi oconcavi o anche a quelle sacche aperte nelle murature che, seguendo il singolare processoanamorfotico che informa alcune planimetrie, sembrano contrarsi o dilatarsi tra l’espan-dersi del vano principale e il confine rappresentato dal perimetro esterno (vedi gli innestiangolari nella pianta di S. Carlino o di S. Ivo alla Sapienza) (figg. 32, 33, 35). Sebbene relegate alla funzione secondaria di collegare direttamente ai vari livelli gli apparta-menti privati o di semplificare la rete distributiva, queste scale testimoniano, nei loro inseri-menti più inusuali, la virtuosa capacità di rielaborazione di un sintagma fin troppo consue-to del linguaggio architettonico (prima del Rinascimento le scale a chiocciola che occupava-no il minimo spazio possibile costituivano la regola) all’interno di un’ipotesi costruttiva to-talmente rinnovata alla luce dei nuovi studi sull’antico65. L’inserto di una scala a chiocciolanello spessore del muro può diventare occasione per soluzioni totalmente inedite.
92 PARTE SECONDA
Galleria fatta fare da Nostro Signore PapaGregorio XIII nel Vaticano, da OttavianoMascherini, che è riuscita molto bella, alla cuisimiglianza ne fa al presente un’altra nel palaz-zo, che per sua Santità fabbrica a Monte ca-vallo, la quale è aperta, & ovata, mà si regge insu le colonne, simile à quella fatta da Bramantein Belvedere”. Forse potrebbero essere ipotiz-zate influenze di alcuni modelli francesi cono-sciuti attraverso il Vignola. La scala doppia in-serita da Egnazio Danti nel trattato delVignola presenta notevoli similitudini con al-cuni esempi realizzati nel Cinquecento inFrancia: si veda, come confronto significativo,la scala del castello di Oiron. 50 I. Barozzi da Vignola 1583, p. 143.51 La scala, al civico numero 38 di via delTeatro Pace, collega oggi i tre livelli dell’HotelPace.52 Ringrazio per la segnalazione AloisioAntinori, autore di un saggio su OnorioLonghi corredato da una cronologia critica edal catalogo delle opere (2001). Sulla scala ve-di G.L. Masetti Zannini 1988. 53 Sulla sintassi architettonica longhiana vediM. Vitiello 2002.54 Sulla famiglia dei Longhi provenienti daViggiù vedi J.L. Varriano 1971; A. Pugliese, S.Rigano 1972; M. Fagiolo 1982a; G. Lerza2002. Sulla rete delle loro relazioni professio-nali vedi anche M. Fratarcangeli 1999; L.Sickel 2002; A. Antinori 2005.55 Contratto stipulato l’11 aprile 1615 traFrancesco Pelliccia, figlio di Pellegrino roma-no, e il mastro lapicida Francesco Lucchesini,figlio di Andrea romano. “[…]In primis det-to signor Francesco Pelliccia dà e concede, det-to mastro Girolamo presente, a fare la scala alumaca et scala grande di peperino della casadi esso signor Francesco posta nel rione diParione disegnata dall’Illustrissimo signorHonorio Longo architetto, quale disegno det-to mastro Francesco disse haverlo visto, et benconsiderato, et detta scala la debba fare, si co-me detto mastro Francesco promette a tuttasua opera, et spese, et robba, et questa operadetto mastro Francesco promette di farla nelmodo che si dirà abasso, et perché dall’altraparte detto signor Francesco Pelliccia promet-te pagargli per ciascuno scalino, cioè l’uno perl’altro a raggione di scudi tre l’uno, et le cima-se, et base, et balaustri per rata di quel pressoche mastro Girolamo Falcioni scarpellino hafatto con il molto illustre signor MarcoAntonio Toscanella per una scala simile nellasua casa posta sotto la Trinità de’ Monti, ha-vendosi però riguardo et consideratione allaqualità et grandezza di dette basi, et cimasi, et
34. F. BORROMINI. Scaletta nellastanza da letto dei cardinali della casadei Filippini alla Vallicella (da P.Portoghesi 1967a).35. F. BORROMINI. Progetto in piantadella chiesa di S. Ivo alla Sapienza.Particolare della facciata con le duescale a chiocciola gemelle (ASR,Università di Roma, vol. 198, f. 122).
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 92
Paradigmatico è quello nella stanza da letto dei cardinali della casa dei Filippini che suggeri-sce, all’imposta della volta, uno smusso convesso retto da un pennacchio piano che consen-te alla scala di continuare il suo giro sopra l’estradosso (fig. 34) 66.La tradizione più recente mostrava come la soluzione elicoidale presentasse vantaggi ancheper lo scalone d’onore (che lasciava maggiore spazio agli appartamenti) e riservasse alla pro-gettazione nuove possibilità per alcuni caratteri ancora sperimentali che la tipologia mante-neva all’inizio del Seicento. Scaloni elicoidali ricorrono prevalentemente nei progetti borro-miniani di palazzi o ville: a forma ovale nelle piante dei palazzi Barberini, Carpegna,Pamphilj, Spada, della biblioteca Angelica e di un casino isolato nel verde 67. I numerosi esem-pi proposti – solo in pochi casi realizzati – non sembrano apparentemente discostarsi dai pro-totipi cinquecenteschi e dalla trattatistica. La tipologia ovale presentava come quella circo-lare poche varianti: con anima piena o cava, con tromba aperta totalmente libera cioè a sbal-zo o con rampe sorrette da colonne, con gradini diritti o curvi (secondo la casistica già de-scritta e illustrata da Palladio). La scala di palazzo Barberini del tipo a spirale con colonne intermedie (figg. 36, 37), tradizio-nalmente riferita al Borromini, è secondo Paolo Portoghesi: “una replica con poche varianti diquella costruita dal Mascherino nel palazzo del Quirinale, interpretata con eleganza ma non rias-sunta criticamente come avverrà sempre nei casi in cui Borromini si riallaccia a una tradizione
Le scale coclidi di Borromini 93
36. Roma, Palazzo Barberini. La scalaovale nell’ala meridionale.37. Roma, Palazzo Barberini.Schiacciamento anamorfico deibalaustri all’ultimo livello dello scaloneovale.
balaustri, rimettendosi la considerazione di es-sa al detto signor Honorio Longo […] ” (ASR,Notari Auditoris Camerae, atti Floridi, vol.2920, cc. 580r-581v, 622rv). Citato in G.L.Masetti Zannini 1988. 56 Vedi P. Hoffmann 1981; C.L. Frommel1983, 1991 e 1992.Il Toscanella sopraintese anche al completa-mento dell’altare Colonna in S. Carlo deiCatinari ad opera di Girolamo Rainaldi eFrancesco Peparelli (su progetto di MartinoLonghi). Vedi al riguardo M. FagioloDell’Arco 1994; A. Anselmi 1996. Durante ilpontificato di Paolo V Marc’AntonioToscanella godeva in concessione dallaCamera Apostolica il diritto privativo sui pas-si e transiti dall’una all’altra ripa del Tevere alporto di Ripetta (G. Moroni, LXXXIV, 1841,p. 99); in prossimità del porto, davanti a S.Rocco, aveva la vigna (R.A. Lanciani 1880, p.8). Altre notizie in W. Reinhard 1974, p. 30;J.A.F. Orbaan 1920, p. 220.57 P. Hoffmann 1981, p. 111. Il rilievo diLorenzo Possenti è conservato nel GabinettoComunale delle Stampe. Di Roma.58 Sul diffondersi delle scale ovali a chiocciolanel Seicento vedi P. Waddy 1990, pp. 213-215,
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 93
recente. Solo nel progressivo schiacciamento dei balaustri finali della scala si può cogliere l’ecodi un ragionamento borrominiano, nella manifesta volontà di seguire la virtualità di un tema fi-no alle estreme conseguenze, in questo caso nel portare l’elica della balaustra ad avvicinarsi a quel-la della rampa fin quasi a identificarsi con essa” 68. Il tema che la tradizione costruttiva precedentesuggeriva, viene ripreso ad altissimo livello formale: la scala si snoda intorno alla canna centralecon grande leggerezza e prelude a soluzioni dell’architettura borrominiana in cui è variamenteriproposto l’avvitamento delle cornici e delle balaustre intorno a un perno centrale (cupole di S.Carlino e di S. Ivo). Verso il pozzo, le linee della trabeazione, del parapetto, della cornice, hannocostantemente la direzione elicoidale ascendente senza essere interrotte e divenire orizzontali incorrispondenza dei pianerottoli. L’asse maggiore dell’ovale misura m 9. 40 e il minore m 7.85;la larghezza delle rampe, compresi i parapetti, è di m 2.40. La rampa curva di ciascuna girata èsostenuta da 12 colonne accoppiate di ordine dorico disposte su piedistallo ricavato nell’altezzadel parapetto. La variante più significativa è rappresentata dalla disposizione dell’ordine binatosul perimetro ovale della tromba: due coppie in corrispondenza di ciascuna estremità dell’assemaggiore, ai lati del ripiano, una coppia in corrispondenza dell’asse minore, per un totale di seicolonne su ciascuna rampa, mentre nella scala di Mascherino l’ordine si raddoppia simmetrica-mente rispetto ai due assi per un totale di otto colonne su ciascuna rampa. Nell’esecuzione l’ar-chitetto supera con maestria le difficoltà intrinseche alla distribuzione dei ripiani lungo il per-corso riuscendo a conciliarli coll’andamento del parapetto, che si mantiene di altezza costanteverso il pozzo, come la fascia elicoidale che forma trabeazione al colonnato, quest’ultima neces-sariamente abbreviata nell’intradosso della volta d’appoggio alla rampa. Verso gli scalini il para-petto invece ha altezza variabile, e la differenza di altezza è tutta risolta nell’ambito dello zocco-lo69. Complementare alla scala quadrata che serve l’ala del palazzo riservata a Taddeo Barberini– si noti la coerenza progettuale tra le due scale nell’adozione dell’ordine binato – quella ovaleconduce agli appartamenti designati per il cardinale nipote Francesco e alla “libraria”, aperta an-che agli studiosi, ricevendo luce dal pozzo aperto e dalle finestre all’angolo della facciata70.
94 PARTE SECONDA
38. F. BORROMINI. Studioplanimetrico per Palazzo Barberini(disegno; Vienna, Alb. Az Rom 957).
In basso39. F. BORROMINI. Progetto per lascala ovale di palazzo Barberini(disegno; Vienna, Alb. Az Rom 967).40. Ottaviano Nonni detto ilMASCHERINO. Progetto per la scalaovale al Quirinale, pianta (disegno;Roma, Accademia di San Luca, FondoMascherino, inv. 2469).
nota 21; M. Raspe 2000, p. 121, nota 81.59 Vedi il progetto di Martino Longhi ilVecchio per il piano terreno del palazzoAlessandrino (1585) conservato a Roma,Accademia Nazionale di San Luca, FondoMascherino, inv. 2384. Cfr. M. Fratarcangeli1999, p. 266, cat. n. 141 b.60 Archivio di Stato di Modena, Archivio perMaterie, Arti Belle, Architetti, 9/1 Rainaldi.Cfr. R. Pacciani 1992, pp. 270-271. DiGirolamo Rainaldi si ricorda anche la scalachiocciola che conduce al piano nobile di pa-lazzo Colonna a Marino (1622).61Ricorrenti sono le soluzioni a cupolino nel-le descrizioni dei lavori di esecuzioni di scale achiocciola nel XVII secolo. Un esempio si-gnificativo mai citato, sebbene dimensional-mente scarsamente rilevante, era quello della“lumacha del quarto” conventuale di S.Carlino alle Quattro Fontane originariamen-te coperto a cupoletta estradossata, come reci-tano i documenti, e come sembra mostrare ildisegno progettuale Alb. Az Rom 200 per ilprospetto posteriore del convento verso il giar-dino (vedi la sovrastruttura decorativa in altoa sinistra). 62 Nel Rinascimento, con il passaggio dal ca-stello al palazzo residenziale, si definisce la dif-ferenza fra la scala riservata all’accesso al pianonobile e le scale secondarie e si dà l’avvio allaricerca di forme diverse, ma tutte ugualmentemonumentali, che raggiungono sviluppi econformazioni inusitate e addirittura sceno-grafiche nel Sei e Settecento. 63 Solo negli ultimi decenni del Cinquecentoi trattati codificano i dati tipologici e ubica-tivi. Ancora all’inizio del Seicento le scale achiocciola rimanevano perlopiù relegate a usisecondari. Vincenzo Scamozzi in Dell’Ideadell’architettura universale (1615, ParteSeconda, libro VIII, cap. XII, pp. 312-317)conclude la presentazione di una casisticadelle scale rapportabile a quella moderna inquesto modo: “l’altre [scale] à mandola, e leovali, e ultimamente le rotonde à chiocciola:le quali possono servire per scale secrete; co-sì piene, come vuote nel mezo”. L’architetto,a differenza di Palladio, non mostra esempidi scale ovali inserite in palazzi; ne troviamoperò una nella Parte Prima del trattato, libroIII, cap. XX, p. 317. Cfr. M. Raspe 2000, p.119, n. 22.64 Per quanto riguarda le ville, numerosi sonogli esempi di utilizzo delle scale elicoidali cherisolvono i problemi distributivi sfruttandomeglio lo spazio rispetto a quelle rettilineee:vedi a Roma anche le scale a chiocciola gemel-le di villa Medici. Borromini ne inserisce unanel progetto irrealizzato per la villa “matema-tica” dei Pamphilj al Gianicolo.65Vedi L. B. Alberti sulla pratica costruttiva de-gli antichi (Dell’Architettura Libri Dieci…1833,Libro III, capo VI, p. 76): “ ‘Che e’ si debbonolasciare sfiatatoi aperti nelle mura grosse, da bas-so ad alto […]’/ Gettati i fondamenti, ne segue
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 94
Se confrontiamo l’opera borrominiana con alcuni precedenti cinquecenteschi ci accorgiamodella raffinatezza dell’esecuzione. L’opera borrominiana, confrontata con alcuni precedenti cinquecenteschi, rivela grande raf-finatezza esecutiva. È significativo il confronto con la scala palladiana della Carità elegante-mente inserita in pianta ma scarsamente risolta in alzato, con asimmetrie nella quota e nelladislocazione delle bucature sul prospetto esterno; all’interno una finestra è tagliata a metà daigradini, e non è alla stessa altezza delle altre.Va ricordato che lo scalone barberiniano nel XVII secolo era attribuito a Bernini come so-stanzialmente tutto il palazzo sulla scorta del Baglione (1642) mentre l’attribuzione moder-na a Borromini poggia in prima istanza sulla didascalia di un’incisione di Specchi (figg. 43,44) 71. A tutt’oggi, la vicenda del progetto e della realizzazione di palazzo Barberini rimanemolto complessa per quanto riguarda il ruolo dei personaggi che vi parteciparono a vario li-vello. Seguendo le più recenti analisi critiche, sostanzialmente in accordo con la lettura del-l’edificio fatta da Hibbard (1971), l’apporto di Borromini alla definizione del palazzo, e quin-di anche dello scalone ovale, sembra doversi individuare nella declinazione delle idee gene-rali del Maderno, in base a un consolidato rapporto di collaborazione che, soprattutto nel-l’ultima fase, gli lasciava margini di libertà piuttosto ampi. Questa limitazione progettualedivenne però intollerabile con l’entrata in scena di Bernini dopo la morte di Maderno, con-siderata soprattutto la faticosa assunzione da parte di Borromini, fino ad allora, dell’interaresponsabilità operativa del cantiere72. La contrapposizione fra una scala concentrica e unascala quadrangolare compare fin dai primi progetti per il palazzo quando era ancora allo stu-dio l’idea di un blocco compatto (Stockholm CC1419), mentre la proposta di una scala cir-colare elicoidale non era certamente nuova per il Maderno, che l’aveva proposta ad esempionel progetto per il palazzo di un arciprete di S. Pietro73. Una soluzione di questo tipo si inse-riva perfettamente nella tradizione cinquecentesca. La scala, nel primo dei disegni prepara-tori elaborati da Borromini sotto la direzione di Maderno (Alb. Az. Rom 957) (fig. 38), è an-cora circolare, e le colonne che scandiscono il ritmo ascensionale all’interno sono singole enon binate74; assume finalmente la forma ovale nel disegno Alb. Az. Rom 967 con l’accen-no sperimentale a gradini curvilinei (fig. 39). La struttura fu iniziata sotto la direzione diBernini nell’aprile 1633, quando Borromini aveva lasciato il cantiere75. Se l’ipotesi di colla-borazione fra Maderno e Borromini è valida, la scala elicoidale in palazzo Barberini com-pendierebbe due diverse visioni dell’architettura, in un’ibrida mescolanza di innovazioni ereticenze: la formula piuttosto convenzionale, dipendente dall’esempio tardo-cinquecente-sco, andrebbe attribuita all’acquiescenza di Borromini con il Maderno. Va ricordato che Borromini conosceva bene la scala del Mascherino avendo lavorato comescalpellino sotto Maderno nel palazzo del Quirinale (a partire dal 1626) e che teneva in granconsiderazione l’architetto bolognese, di cui conservava in casa un disegno76. I disegni del codice Spada Vat. Lat. 11257, cc. 192, 193 (figg. 41, 42), con annotazioni attri-buibili al Borromini, rappresentano la pianta e lo spaccato di una scala a chiocciola ovale, do-ve la gradinata si avvolge sostenuta da un sistema di colonne binate. Portoghesi pubblicò perprimo questi disegni, avanzando l’ipotesi che si trattasse di un progetto di scala per palazzo
Le scale coclidi di Borromini 95
di poi il muro espedito. Né qui voglio lasciarein dietro quello che si appartiene sì a riempire ifondamenti, sì a finire ancora tutte le mure.Perciocché negli edifici grandi, dove la mole del-la muraglia ha da essere molto grossa, si hannoa lasciare nel mezzo delle grossezze delle mura,dai fondamenti insino al disopra, sfogatoi aper-ti, e spiramenti non molto lontani l’un dall’al-tro, per i quali possino liberamente esalare sen-za alcun danno della muraglia, i vapori che sifossero generati e ragunati sotto il terreno, se al-cuno per sorte ve ne fosse. Gli antichi in certiluoghi simili, sì per amor di questa stessa cosa,sì ancora per la comodità, acciò si potesse salireda basso ad alto dell’edificio, e forse ancora perspendere manco, vi facevano entro una scala achiocciola”. 66 Cfr. P. Portoghesi 1967a, p. 381, schemagrafico a p. 385. Interessante è anche la solu-zione delle minuscole scale di collegamento apianta triangolare studiate per la BibiotecaAlessandrina; vedi a riguardo Si. Benedetti2008, p. 72, fig. 8.67 Per il casino vedi P. Portoghesi 1967a, tav.CVII. 68 P. Portoghesi 1967a, p. 38. Su palazzoBarberini e l’attribuzione controversa dei varicontributi progettuali vedi: A. Blunt 1958, pp.256-287; H. Thelen 1967, pp. 54-78; H.Hibbard 1971, pp. 80-84; P. Waddy 1976; G.Magnanimi 1983a; Eadem 1983b, pp. 167-192; F. P. Fiore 1983; P. Waddy 1990, pp. 177-271; C. L. Frommel in R. Bösel, C.L.Frommel 2000, pp. 96 e sgg.; C.L. Frommel2004, pp. 93-103; M. Bevilacqua 2006; P.Waddy 2007. Sullo scalone vedi M. Raspe2000; uno studio approfondito sta per esserepubblicato da A. Gallo Curcio nella rivistaPalladio. 69 Sulle difficoltà costruttive delle scale achiocciola, vedi il teorico dell’architetturaneoclassica F. Milizia 1972, p. 228: “Le scalea lumaca, o spirali, tutte le circolari, le ellitti-che, le triangolari e di tante altre bizzarre for-me non debbono mai aver luogo nella buonaarchitettura che nei casi di una inevitabile ne-cessità. Questa razza di scale sono tutte in-commode; primieramente essendo gli scalinilarghi da una parte e stretti dall’altra, ciascu-no va a tenersi dalla parte più larga, né si famai uso di tutta la loro lunghezza; onde perquanto queste scale compariscano spaziose,sono in pratica sempre anguste. […] La co-modità e la sicurezza richieggono assoluta-mente le rampe rettangole cogli scalini sem-pre rettangoli e paralleli, malgrado l’autoritàdel Palladio e di tanti altri insigni architetti,che hanno messo in opera scalini centinati,incavati, convessi”.70 Cfr. P. Waddy 1990, pp. 213 sgg.71 Per l’incisione di Alessandro Specchi raffi-
41-42. F. RIGHI per FrancescoBorromini (?), Progetto di uno scaloneovale, pianta e alzato (disegno; Roma,BAV, Vat. Lat. 11257, foll. 192, 193).
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 95
Pamphilj in piazza Navona77. Secondo M. Heimbürger Ravalli si tratterebbe invece di pro-poste per la nuova scala nell’angolo sud-orientale di palazzo Capodiferro, o più credibilmen-te per la scala che venne edificata successivamente nell’ala occidentale 78. Non è stato osserva-to finora che le dimensioni dello scalone in pianta, ricavabili dalle annotazioni sul foglio inpalmi romani, sono molto vicine a quelle dello scalone mascariniano desumibili dal progettopubblicato da Wassermann, così come la disposizione colonnare delle sedici colonne, il chefarebbe pensare a un disegno teorico, sulla base del rilievo dell’opera cinquecentesca (fig. 40),sebbene l’ovale di quest’ultima sia leggermente più bombato e il pozzo meno ampio79. Dal confronto col disegno del Mascherino emerge la difficoltà, intrinseca all’utilizzo della for-ma ovale, di accordare la radialità dei plinti dell’ordine architettonico con la radialità degli scali-ni della rampa, problema che i due progettisti risolvono in modo diverso. Il primo, Mascherino,scegliendo come fulcri di irradiazione per gli elementi disposti secondo i due archi di cerchio mi-nori costituenti l’ovale i relativi centri lungo l’asse maggiore, e per gli elementi lungo gli archi dicerchio maggiori punti intermedi tra i suddetti centri, secondo uno schema geometrico chiaroe perfettamente controllato. Il secondo, l’anonimo estensore della pianta del codice spada (for-se Francesco Righi), scegliendo quattro fulcri lungo l’asse maggiore dell’ovale per l’ordine e solidue fulcri ravvicinati al centro di intersezione degli assi dell’ovale per gli scalini, innescando unadiscordanza tra le radialità che aggiunge un effetto di maggiore dinamismo. La raffinatezza funzionale e geometrica della scala al Quirinale certamente piacque aBorromini, che preferì comunque nei suoi progetti il modello con sostegno intermedio con-tinuo (muro dell’anima) scavato da nicchie o finestrati o, in contrapposizione, quello conrampa libera a sbalzo senza perno centrale. Come ha dimostrato Arnaldo Bruschi discutendo del prototipo bramantesco, il tema dellascala elicoidale con sostegni intermedi (colonne o pilastri) nasconde un viluppo inestricabi-le di problemi. Al risultato estremamente ambiguo ottenuto usando differenti ordini nei di-versi piani in una scala a spirale continua, si aggiunge la contraddizione in termini geome-trici tra ordine retto e inclinazione obliqua della rampa:
“Le colonne, elementi verticali di sostegno, si appoggiano sul bordo del nastro inclinato e continuodella rampa e sostengono un elemento, parimenti inclinato e continuo, in funzione di trabeazione.Ma le parti terminali delle colonne (base, capitello) sono, per loro natura, conformati in modo adat-
96 PARTE SECONDA
gurante la scala elicoidale sul lato est di palaz-zo Barberini vedi D. De Rossi 1702, tav. 42.Secondo alcuni, la didascalia potrebbe esserestata condizionata dalla tendenza, in queglianni, a rivalutare l’apporto di Borromini in se-guito alla scrittura dell’opera biografica (vedii manoscritti delle vite, l’uno dovuto aGiambattista Passeri, scritto entro il 1679 mapubblicato postumo nel 1772, e l’altro al ni-pote Bernardo Castelli, intorno al 1685, perl’opera biografica di F. Baldinucci 1681-1728). La scala divenne un tema ricorrentenella formazione accademica degli architetti aRoma nel XVIII secolo. Tra le copie parzialidell’incisione di Specchi, si veda il disegno diGirolamo Toma (1738 circa – post 1795)conservato al Gabinetto Comunale delleStampe di Roma (M.R. 16522r). Cfr. M.Kahn-Rossi, M. Franciolli 1999, p. 251; E.Kieven 1991.72Hibbard (1971), riportando l’attenzione sulruolo di Maderno nel progetto di palazzoBarberini, seguiva puntualmente gli spuntipresenti nel saggio di A. Blunt (1958) e nelladisamina dei disegni borrominiani di H.Thelen (1967). Le ricerche e i contributi cri-tici successivi, a partire dagli scritti dellaWaddy (1976, 1990 e 1992), hanno ulterior-mente ampliato la conoscenza del quadro ge-nerale di riferimenti. Sul carattere del rappor-to tra Maderno e Borromini, vedi in partico-lare H. Thelen 1967; H. Hibbard 1970, pp.499-503; Idem 1971, pp. 88-92; P. Waddy1992, pp. 194-223. F.P. Fiore 1983, p. 205,riassegna dubitativamente la scala a Berniniche avrebbe modificato la pianta circolare pre-vista inizialmente da Maderno e Borromini.Sull’entità della partecipazione di Borrominial progetto del palazzo vedi per gli aggiorna-menti critici più recenti: schede di T. Manfrediin M. Kahn Rossi, M. Franciolli 1999, pp.251-255; schede di C.L. Frommel, T.Manfredi, K. Wölfe, in R. Bösel, C.L.Frommel 2000, pp. 87-105.73H. Hibbard 1971, pl. 93a. 74 Cfr. P. Waddy 1990; C.L. Frommel in R.Bösel, C.L. Frommel 2000, p. 99 scheda V.16.Una scala ottagonale con pozzo centrale scan-dito da colonne singole compare nel grandio-so progetto di Pietro da Cortona riferito a pa-lazzo Barberini (R. Wittkower 1972) databileagli inizi degli anni Trenta. 75 F. P. Fiore 1983, p. 198 e nota 26. Il contri-buto analizza puntualmente i registri di can-
43-44. A. SPECCHI. La scala ovale diPalazzo Barberini (incisioni; da DeRossi 1702).
In basso45. Ph. DELORME (attr.). Disegno discala elicoidale (Louvre, Cabinet desDessins, n. 11114; da Potié 1996).
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 96
to a connettersi, a terra e in alto, solo con altri elementi orizzontali. È necessario trovare un terminedi raccordo che risolva, praticamente e sintatticamente, il problema. In ogni caso il risultato non po-trà non apparire ambiguo se non sarà possibile eliminare la sensazione, che, contro ogni apparenzadi naturalismo e logica strutturale, le trabeazioni “scivolino” sulle colonne, verso il basso, attrattedalla forza di gravità. L’originaria funzione portante della colonna, pur qui riaffermata nelle sue strut-turali modalità di impiego, dovrà nello stesso tempo essere contraddetta dall’apparenza visiva di unrisultato ambiguo nel quale la firmitas vitruviana sembra vacillare equivocamente” 80.
Philibert Delorme nel diciannovesimo capitolo del suo trattato – scritto a più di vent’anni didistanza dal soggiorno romano – non aveva risparmiato critiche alla scala a chiocciola delBramante, senza tuttavia fare il nome dell’architetto81. Una delle obiezioni mossa all’opera,apprezzata in termini generali, riguardava appunto l’uso di basi e capitelli orizzontali per le co-lonne, non appropriati all’inclinazione della base d’appoggio e della trabeazione soprastante.Le colonne dovevano essere collegate da una sorta di archi rampanti obliquando la trabeazio-ne mentre l’intradosso della rampa doveva essere decorata con modanature. Delorme, intro-ducendo il problema della stereotomia, criticava anche l’uso del laterizio per la realizzazionedella volta raccomandando, secondo la tradizione francese, l’adozione della pietra82. Il disegno Louvre 11114 (fig. 45) per una scala a spirale rappresenta forse la proposta corret-tiva di Delorme alla scala del Belvedere. Basi e capitelli sono obliqui, e la copertura è costitui-ta da una volta a botte in pietra, decorata con cassettoni: tutte le correzioni suggerite daDelorme sono dunque presenti, a meno degli archi rampanti. L’obliquazione degli elementiterminali dell’ordine ritornò di estrema attualità nel secolo seguente durante il pontificato diAlessandro VII quando Bernini lavorava alla scala Regia e al progetto della piazza vaticana cioèquando vennero formulati anche sul piano teorico i principi della cosiddetta “architetturaobliqua”. Autore della riflessione teorica indirizzata a fondare una “nuova arte” dell’obliquo,contrapposta all’architettura “retta” vitruviana, era il vescovo spagnolo Juan Caramuel deLobkowitz, teologo probabilista stimato dal pontefice ma censurato dalla Chiesa per la sua in-cauta apertura all’ipotesi copernicana, autore di Architectura civil recta y obliqua (1678) 83.Come scrive Filippo Camerota, “l’architettura obliqua è indicata come l’arte delle trasfor-mazioni geometriche che genera ‘ellissi dai cerchi e corpi ovali dai globi’ quando viene a man-care la condizione di ortogonalità propria dell’architettura retta. Quando l’orizzonte si in-clina, come nelle scale, o il piano si incurva, come negli impianti circolari o ellittici, l’ordinenon può restare invariato ma deve seguire senza pregiudizi la natura geometrica dello spazio.A partire da uno stato iniziale retto, quindi, l’architettura può subire obliquazioni che coin-volgono necessariamente ogni aspetto della sua sintassi morfologica” 84.
Le scale coclidi di Borromini 97
tiere, prima sfuggiti alla critica, provenientidall’archivio di S. Andrea della Valle, ma giàsegnalati dalla G. Magnanimi 1975 e 1983. 76 Per l’inventario dei beni redatto dopo lamorte di Borromini vedi M. Del Piazzo 1968,pp. 163-176.Una pianta inedita del Quirinale di CarloMaderno è stata pubblicata da E. Kieven(2005).77 P. Portoghesi 1958a. 78M. Heimbürger Ravalli 1977, p. 138. BAV,Vat. Lat. 11257, f. 192, penna e matita, 41 x27 cm (foglio doppio); ibidem, f. 193, pennae matita, stesse dimensioni del precedente.Sull’attribuzione dei due disegni alBorromini, va registrata la perplessità di J.Connors 1979, 2, pp. 193-196. 79 Il progetto di Mascarino per la realizzazio-ne della scala a spirale (1577-85) è conservatoall’Accademia di San Luca, FondoMascherino, inv. 2469 (vedi J. Wassermann1963). Possiamo ricavare dal foglio le misuredegli assi dell’ovale di impianto corrisponden-ti approssimativamente a palmi romani 48 x40 (metri 10.72 x 8.93); l’altezza della coppiadi colonne doriche di travertino di palmi 12(m 2.68). Le misure ricavabili dal disegno Vat.Lat. 11257, f. 192, sono: lunghezza totale del-lo scalone (asse maggiore dell’ovale) palmi 48= m 10.72; larghezza totale dello scalone (asseminore dell’ovale) palmi 39 ½ = m 8.82; lun-ghezza tromba (asse maggiore dell’ovale) pal-mi 22 ½ = m 5; larghezza tromba (asse mino-re dell’ovale) palmi 13 ¾ = m 3.07; diametrodelle colonne palmi 2 1/3 = m 0.52; ampiez-za della rampa palmi 10 ½ = m 2.3; sviluppodella rampa, 40 gradini compreso il ripiano.80 A. Bruschi 1969, p. 431.81 Su Philibert Delorme (1500/1515-1570)vedi innanzitutto P. Potié 1996, A. Blunt1997, J. M. Pérouse de Montclos 2000.Delorme era particolarmente interessato allatipologia delle scale a spirale e nell’Architecture(1648) dedica vari capitoli alla descrizione del-le diverse forme che esse possono assumere, di-mostrando la capacità di coniugare la tradi-zione costruttiva medievale con le conoscenzegeometriche del XVI secolo. Le strutture pre-se in esame sono in gran parte medievali, e inalcuni casi l’autore lo afferma esplicitamente:
46. F. BORROMINI. Rampa elicoidaledi Palazzo Carpegna.
In basso47. F. BORROMINI. Progettoirrealizzato per la Biblioteca Angelica(disegno; Alb. It. Az Rom 88).
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 97
Borromini era certamente consapevole – come i contemporanei – degli imbarazzanti quesi-ti che poneva l’adozione dell’ordine colonnare su rampe85. Un disegno per la scala elicoida-le progettata in San Martino al Cimino riferibile a Virgilio Spada, probabilmente influenza-to da Borromini, mostra un chiaro tentativo di obliquazione dell’ordine (fig. 59) 86.Borromini sembra però eludere il problema preferendo concentrarsi sull’articolazione del-l’anima continua o discontinua. La scelta di sottrarsi al confronto con un tema certamenteinsidioso, va probabilmente attribuita alla precoce datazione dello scalone barberiniano, cioèben prima che il dibattito sulle obliquazioni divenisse argomento emergente. Lo scalone ovale borrominiano più noto è quello di palazzo Carpegna (fig. 46). La spirale,definita da lui stesso “magnificha”87, fu costruita tra il 1646 e il 1649 e si svolge continua acordonata liscia: il nucleo interno segue l’andamento della rampa e si ravviva di una serie dinicchie incavate nella parete continua curva. Tra le varie soluzioni progettuali Borromini sperimentò anche quella con l’ingresso allascala sull’asse maggiore, quindi in corrispondenza del minor sviluppo della figura88. Il
disegno Alb. Az. Rom 1038 (parte I. fig. 31), identificato in questo volume come pro-babile studio irrealizzato per lo scalone ovale da farsi nell’ala di palazzo Spada su vicolodel Polverone, mostra una struttura compatibile con il proporzionamento dello scaloneCarpegna, immaginando però, in una delle varianti disegnate sovrapposte, una rampacompletamente aperta, all’esterno con una successione continua di finestre (“luci”), al-l’interno del nucleo con una chiostrina aperta (“aria”), o completamente a guisa di bal-cone, o con due finestre secondo l’asse minore. La novità più interessante del disegno èrappresentata dalla configurazione dell’anima estremamente allungata con due nucleimurari semiovali posti all’estremità e scavati da nicchie; i piloni sono inscrivibili in qua-drati, 8.6 palmi (m 1.92) di lato. È interessante immaginare come Borromini avrebbe articolato l’alzato, l’alternarsi dei pie-ni e dei vuoti dell’anima, e soprattutto la configurazione della volta elicoidale89. Lo scattoin avanti notevole rispetto agli esempi descritti è rappresentato dall’ideazione di un tipototalmente nuovo a doppia rampa, tromba aperta e doppio nocciolo (anima costituita dadue nuclei) 90. L’idea di uno scalone elicoidale con anima finestrata potrebbe essere stataispirata in parte dal pozzo di S. Patrizio di Antonio da Sangallo il giovane. Per quanto ri-guarda la configurazione plastica dei due nuclei murari (trattati come una sorta di organi-smi muscolo-scheletrici) ricordiamo l’influenza esercitata sul Borromini dall’architetturatardo-antica. Borromini sembra ispirarsi alle rovine di villa Adriana a Tivoli dove Bernardino Spada ave-va una residenza estiva. Il tipo non sembra tener conto comunque di esempi italiani moder-ni, rinviando piuttosto – per l’insistita articolazione volumetrico-spaziale dell’anima – a rea-lizzazioni medievali e rinascimentali d’oltralpe91.Che alla fine degli anni Cinquanta Borromini fosse incline a riproporre le forme dello scaloneprogettato circa un decennio prima in palazzo Carpegna è confermato dalla sua più significati-va proposta per la sistemazione dell’ala del convento verso la piazza della chiesa di S. Agostinorappresentata dai disegni Alb. Az. Rom 88, e 89. Il primo disegno (fig. 47) mostra uno scaloneovale d’ingresso alla Biblioteca Angelica con anima a parete continua cava all’interno, scavata da
98 PARTE SECONDA
48a/48b. Roma, Palazzo Spada. Scalacircolare nell’ala ovest su vicolo delPolverone, due vedute della cannacentrale.
In basso49. Roma, Palazzo Spada. Scalacircolare nell’ala ovest su vicolo delPolverone. Veduta dall’“entrone”.
ad esempio quando, a proposito delle scale aspirale coperte da volte a botte, loda la Vis deSaint Gilles del XII secolo come il miglioreesempio nel suo genere. Tra le numerose scaleda lui costruite, quella nel palazzo delleTuileries, con ampio pozzo al centro e rampea scalini curvilinei, viene descritta nel XVII se-colo da François Blondel e da Sauval come lapiù ammirabile del mondo. 82 Sull’arte della stereotomia, dalla tradi-zione pratica medievale dei “Compagnonsdu Devoir” al valore e significato della co-struzione in pietra nella contemporaneità,è stata recentemente dedicata una mostra acura di Claudio D’Amato e GiuseppeFallacara (Veronafiere, Cittadella diMarmo Arte Cultura, Palaexpo, 15-19 set-tembre/29 settembre-2 ottobre 2005-09-
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 98
otto nicchie. La soluzione è simile a quella di palazzo Carpegna. Se poi consideriamo nello stes-so disegno la variante con le nicchie (tre su ciascuno dei lati maggiori, una su ciascuno dei latiminori) appena delineate ma chiaramente visibili all’interno della gabbia esterna campita contratteggio, ci accorgiamo che coincide con una delle possibili soluzioni leggibili nel disegno Alb.Az. Rom 1038 e cioè quella con anima a parete continua e gabbia esterna scavate da nicchie 92. La scala a chiocciola circolare nell’avancorpo aggiunto a ovest del prospetto tergale di palaz-zo Spada (figg. 48, 49), realizzata dopo il ripensamento del cardinale in sostituzione di unaovale appena iniziata (1658), è ricordata dalla critica, nella laus vacui che la caratterizza, co-me bellissima che “anticipa nella soluzione strutturale la tecnica del cemento armato” (PaoloPortoghesi) 93, ed è un “capolavoro d’ingegneria, montato su quattro pilastri privi di qual-siasi ornato” (Paolo Marconi) 94, che “come per la rampa di palazzo Carpegna, ha alla sua ori-gine la meditazione sull’esempio michelangiolesco nei pilastri di San Pietro” (ManfredoTafuri) 95. Secondo Marcello Fagiolo “i pilastri brutalmente nudi, travolgendo le piccole di-mensioni, hanno una energia addirittura titanica e senza pari nella Roma Barocca” 96. È passata finora inosservata la sorprendente somiglianza del nocciolo centrale pilastrato conquello della scala (segnata Z) raffigurata in una delle due tavole aggiunte da Egnazio Dantia Le due regole della prospettiva pratica, opera postuma del Vignola (1583). Il frate domeni-cano, come detto sopra, illustra in appendice “due esempi delle scale a lumaca doppie” 97. Sitratta delle scale a elica le cui rampe non si incontrano, come quelle del castello di Chambord:
“Delle quali la prima è la segnata Z, & è simile al pozzo di Orvieto, eccetto che questa è fatta con liscalini, & quello è senza, cavato nel tufo per via di scarpello. Di così fatte scale se ne veggono gl’e-sempi appresso de gl’antichi, & delle scale chiuse che girono attorno una colonna: & queste aperteson molto commode ne’ mezi de gl’edifici, dove non si può haver lume da’ lati, & ci bisogna torlo disopra; come ha fatto il Buonarroti nelle quattro scale che fece nella fabbrica di S. Pietro, le quali dal-l’apertura di sopra hanno tant’aria, che sono luminosissime. De simili se ne veggono antiche qui inRoma ne’ Portici di Pompeo. Ma queste doppie, se bene hoggi non habbiamo esempio nessuno degl’antichi, sono nondimeno molto comode” (figg. 26, 29) 98.
La scala doppia segnata Z mostra in corrispondenza del nocciolo nudi pilastrati simili a quel-li dell’elica semplice di palazzo Spada (parte I. Figg. 54, 56).La costruzione della scala, intrapresa nel 1660 quando Borromini aveva abbandonato il can-tiere, fu avviata secondo un modello circolare a rampa libera autoportante con il vuoto nelmezzo. L’interruzione del cantiere per la rovina di quaranta scalini che non erano stati op-portunamente incastrati dal capomastro nella muraglia d’ambito costrinse l’artefice(Francesco Righi direttore dei lavori o forse Vincenzo Della Greca, abile costruttore, chefirmò la perizia effettuata in seguito all’incidente) 99 ad aggiungere in fretta le protesi strut-turali di rinforzo, forse rifacendosi proprio all’immagine del Danti, dove costruttivamente ilparapetto funziona come costola sinusoidale verticale formata dall’incastro sovrapposto deisingoli elementi a gradino.Alcuni anni prima, sotto la direzione di Borromini, era stata realizzata senza problemi labella scala ovale all’interno del blocco cinquecentesco del palazzo, con la rampa che si avvi-ta intorno a uno stretto pozzo libero da sostegni, con una ringhiera in ferro battuto comeparapetto (parte I. figg. 21, 22). La struttura elicoidale, sostenuta nel contorno esterno daun cilindro murario, fu inizialmente progettata per l’ala sud orientale dell’edificio, e poisuccessivamente realizzata nella parte più interna verso il cortile 100. Uno studio progettua-le inedito per la sua realizzazione può essere identificato nel foglio borrominiano Alb. Az.Rom 1036 (parte I. fig. 18). Borromini, che fece eseguire un modello in legno da AndreaBattaglini 101, rielaborò in questo caso il modello preferito da Palladio e Vignola, secondouna versione già proposta brillantemente da Carlo Maderno intorno agli anni Venti nel pa-lazzo Vecchiarelli di Rieti (fig. 50). L’incarico di accorpare e trasformare le vecchie caseVecchiarelli in una nobile residenza risale alla fine del XVI secolo quando l’architetto eraspesso di passaggio in città come esperto di questioni idrauliche. La realizzazione si protrassefino al 1618 e oltre. Con fare grande Maderno si svincolò dai forti dislivelli che caratteriz-zavano la profondità del lotto realizzando un organismo unitario con la straordinaria fac-ciata su via Roma e l’ampia corte gettata su una maglia di strutture voltate sotterranee cheuniformano le quote e incorporano un vicolo sottostante, e sulla quale venne creato il nuo-vo affaccio del retrostante nucleo di fabbrica cinquecentesco (con le finestre ora ridotte aportali) 102. La scala elicoidale a impianto ovale risolve ingegnosamente il collegamento ver-
Le scale coclidi di Borromini 99
16). Vedi anche sull’argomento C. Trevisan2000.83 Vedi la ristampa anagrafica dell’opera di J.Caramuel de Lobkowitz (1678) a cura di A.Bonet Correa 1984. Sulle applicazioni dellateoria dell’architettura obliqua vedi D. DeBernardi Ferrero 1965, A. Guidoni Marino1973; J.F.S. Ortiz-Iribas 2005; F. Camerota1987, 2000b e 2006. Sull’obliquazione deibalaustri nelle scale vedi in particolare J.Connors 1990, pp. 217-236, ed in particola-re l’appendice The Lathe and Caramuel’sTheory of Architettura Obliqua. Una delle prin-cipali osservazioni che si possono ricavare dalcontributo di Connors è che Borromini traes-se ispirazione dalla cultura della tornitura. Lostudioso cita a riguardo (pp. 221-222) unadelle più splendide collezioni del Seicento,quella raccolta dal grande virtuoso milaneseManfredo Settala (1600-1680). Il famosomuseo comprendeva molti pezzi lavorati conil tornio tra i quali una “scala a chiocciola conmolta bizzarria di arte lavorata” all’interno diuna colonna in avorio due palmi alta, con fi-gure ascendenti e discendenti come nella sca-la di Giacobbe, con una grotta ed una monta-gna in cima dove era un cavallo in atto di uc-cidere un drago.84 F. Camerota in R. Bösel, C.L. Frommel2000, pp. 317-318.85 Che Borromini conoscesse il trattato e l’o-pera di Delorme e che in alcuni casi potesseaverne ricavato addirittura ispirazione è statoipotizzato da alcuni studiosi. Vedi ad esempioJ. Connors (in R. Bösel, C.L. Frommel, 2000,p. 123 scheda VI. 26), che segnala alcune so-miglianze tra la chiesa di S. Carlino alleQuattro Fontane e la cappella di Anet costrui-ta dall’architetto francese tra il 1547 e il 1555,forse nota a Borromini dalla stampa di J.A. DuCerceau (1515 ca.-1585 ca.). Vedi anche M.Raspe 1999, p. 87.86 Disegni BAV, Vat. Lat. 11257, f. 10v, f.22v. Vedi a riguardo F. Camerota 1987,2000b, 2006. J. F.S. Ortiz-Iribas 2005, pp.137-165 attribuisce i disegni all’architettoMarc’Antonio De Rossi, che comunque la-vorava sotto la supervisione di VirgilioSpada, seguendo M. Heimbürger Ravalli1971, pp. 7-26 e 1977, pp. 259-270.87 Da un’iscrizione nel disegno Alb. Az. Rom1021. 88 Su palazzo Carpegna vedi G. Giovannoni1934; M. Tafuri 1967; P. Marconi 1974; I.Salvagni 2000; F. Bellini 2004, pp. 104-108.89 Su Borromini che infrange, talvolta, le re-gole della statica vedi F. Bellini 2004, pp. 33-62. 90 L’attenzione sperimentale di Borromini è di-mostrabile anche in un disegno eseguito per lascala a pianta rettangolare di palazzoGiustiniani che mostra un’anima traforatapunteggiata da sostegni. Cfr. F. Borsi 1989.91Cfr. l’escalier…1985, vedi apparato fotogra-fico.92 Nonostante l’esistenza di alcuni disegni re-lativi a diverse soluzioni architettoniche per laBiblioteca Angelica, la critica non ha stabilitoancora fino a che punto l’intervento diBorromini abbia influito sull’aspetto dellanuova ala del convento verso la piazza, di cuioggi non rimane più traccia, essendo stato de-molita verso la metà del XVIII secolo da LuigiVanvitelli. Da un confronto tra i progetti bor-rominiani e il libro di cantiere, è possibile af-fermare che essi guidarono la realizzazione sol-tanto durante la costruzione delle fondazioni.In questa fase furono apportate modifiche alprogetto nel tentativo di rispondere ai diversiinteressi delle forze in campo. Si ritiene che ilprogettista dell’edificio costruito sia statoFrancesco Righi, l’architetto che seguì i lavori,che fu costretto a terminare la fabbrica il piùvelocemente possibile. Cfr. R. Samperi 1993,1998 e 2000; Ead. 2000; M. Carusi 1998. 93 P. Portoghesi 1964 (ed. consult. Roma1982, p. 172); Id. 1967a, p. 171, figg. 134,135.
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:45 Pagina 99
112 PARTE SECONDA
Se si considera la forma stereometrica elementare del “motivo ornamentale” che corona il tem-pietto della lanterna borrominiana ci accorgiamo infatti che questo consiste in una coclide; i gra-dini sono smussati per formare una rampa continua verso l’alto, che si avvolge intorno a un fu-sto centrale con un raggio che va restringendosi162 (fig. 72). Il camminamento esterno percorri-bile della copertura di Sant’Ivo può essere letto come rampa ascendente, espressione simbolicadel difficile cammino che l’uomo deve percorrere verso la Divina Sapienza (o Provvidenza a se-conda delle interpretazioni). Come osserva M. Fagiolo la sovrapposizione di gradinata e spiralericonduce alla figurazione della “Filosofia” nell’edizione del 1603 dell’Iconologia del Ripa: comematrona che regge libri e uno scettro, con un manto dove è effigiata una scalinata a spirale163.
5. La ‘coclea’ come forma naturale
... circuendo si arriva al centroGIORDANO BRUNO
Il gusto di Borromini per le strutture spiraliformi è testimoniato anche dalle raccolte di oggettiinventariati alla sua morte: tra questi figuravano due conchiglie a “lumaca”, una delle quali mon-tata su piedistallo di ottone ovato secondo la moda espositiva delle Wunderkammern dell’epo-ca. Il modello naturalistico, alquanto in voga tra Cinquecento e Seicento (figg. 73, 73a-b), sti-molò la fantasia e l’interesse dell’architetto che volle studiarne le applicazioni connesse agli esi-ti di una specifica e originale formulazione architettonica.Sull’ispirazione organica delle scala a chiocciola ha scritto belle pagine Paolo Portoghesi in-centrate sul nesso stretto tra natura e architettura (1999).Certamente fu anche congeniale al Borromini, sensibile ai richiami simbolici, l’influenzadella filosofia della natura di Giordano Bruno: “La natura in eterno crea, senza accrescereo diminuire la sua capacità. L’anima è a ciascuno intima forza plasmatrice ed essa stessa co-me materia determina se stessa dall’interno, come la chiocciola per un proprio impulso siallunga, si agglomera su se stessa in una massa compatta e non offre così alcuna immaginedi sé (…) così lo spirito artefice del seme, che muove dal profondo centro, la natura effi-ciente, l’artefice della materia presente, il trascinatore, il modellatore, l’ordinatore non so-no altro che l’intimo motore” (De immenso et innumerabilibus, seu de universo et mundis).
6. Osservazioni sulla costruzione geometrica degli scaloni ovali borrominiani.
Coerentemente con la prassi borrominiana, nel disegno la geometria diventa elemento di con-trollo della genesi spaziale, strumento operativo per la stesura del progetto anche in vista del-la sua esecuzione 164.L’architetto certamente dedicò una particolare attenzione progettuale alla risoluzione dei pro-blemi connessi alla statica di uno scalone elicoidale a pianta ovale. La ricerca del migliore com-
lazzo Spada – l’una ovale nell’ala est, l’altracircolare nell’ala ovest – hanno entrambe igradini incastrati nel muro della gabbia. Sullastruttura delle scale in muratura, e sulla di-stinzione tra scale a collo e scale a volo, utileper la comprensione dell’argomento qui di-scusso, vedi soprattutto: G.A. Breymann1849-1885, pp.; Il Costruttore…1886, vol.VI, pp. 59 sgg.; D. Donghi 1906, vol. II, pp.657-659; L’escalier 1985, pp. 73 e sgg.; C.Gambardella 1993; M. Bonavia 1997, pp.157-164; G.A. Breymann 2003. Scale a col-lo sono quelle in cui i gradini sono appoggia-ti per i loro estremi, oppure incastrati per unloro estremo nel muro della gabbia di scala eper l’altro capo sono liberi, e cioè sporgonodal muro a guisa di mensole (a sbalzo). Scalea volo sono invece quelle i cui gradini non so-no incastrati, ma poggiano su volte rampantia botte o a crociera che si impostano ai muridella gabbia o ai pilastri: tale struttura per-mette di dare alle branche una larghezza chenon si potrebbe ottenere altrimenti. 156 Sul restauro della scala vedi L.C. Cherubini2007; A. Gallo Curcio 2008.157 G. P. Lomazzo 1584. 158 L. Keller 1966, P. Portoghesi 1988; A.Furgone 1990; J. Connors 1996b.159 Sulle interrelazioni con il progresso scienti-fico nel XVII secolo vedi R. Bösel, C.L.Frommel 2000, pp. 25-32 (con contributi, tragli altri, di F. Camerota e R. Bösel).160 Ne cito alcuni: M. Fagiolo 1970-72a; M.Malmanger 1978; J. Beldon Scott 1982; J.Connors 1996c; S. Macioce 1990; L. Rice2000; M. Raspe 1999, p. 89; B. Azzaro 2008. 161 Per i disegni del Montano vedi G. Zander1958 e 1962; L. Fairbairn 1998, pp. 541-734.162 Sulla congenialità della forma a spirale alBorromini vedi quanto scrive M. Raspe 1999,pp. 89-92.163M. Fagiolo 2006, p. 40.164 Cfr. A. Bruschi 1978. Sulla metodica geo-metrica del Borromini, vedi i pioneristici P.Portoghesi 1964 e 1967a. Tra i contributi piùrecenti vedi W. Oechslin 1999, pp. 107-117;Id. in M. Kahn-Rossi, M. Franciolli 1999, pp.445 e sgg.; J. Wolfgang 2000; P. Portoghesi2001, pp. 7-9, 121-148; M. Simona 1999; E.
70. F. BORROMINI. Progetto per lalanterna di S.Ivo alla Sapienza conuna scala a chiocciola all’interno(Vienna, Alb. 512).71. G.B. MONTANO.Tempietto conscaletta coclide (da G. Zander 1958).
In basso72. FRANCESCO BORROMINI.Prospetto e sezione della lanterna di s.Ivo alla sapienza (Alb. Az Rom 510).
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:46 Pagina 112
Le scale coclidi di Borromini 113
73. P. LIGORIO. Disegno in cui laforma delle lumache di un “vivaro”antico viene evocata dall’inserto diuna scala ovale a chiocciola (Archiviodi Stato di Torino, codice ligoriano18, f. 93: “Vivari, erano più sorte d’edificij,scoperti et delli coperti, et accostatialli luoghi delle ville, con qualchecommodità piacevole di fabrica. Glicoperti erano quelli di conservare lelumache che i latini dicono coclee,onde cochlearum Vivaria leggemopresso di plinio nel libro nono al cap.o cinquantasei. Ove dicenell’intitulatione de cochlearumvivarijj, che lo primo che l’ordinò fuFulvio Lippino, altramente Hirpinocognominato, et tali vivari dichiocciole fece nel paese deTarquiniesi, poco innanzi alla guerracivile tra Caesare e il magno Pompeio,et de per se teniva varia spetie diquelle, per che in alcuno luogo tenevale bianche, che nascono nel paese diReate ne sabini. Altrove teneva quelled’illiria, le quali sono molto grandi.Altrove l’africane, le quali sono moltofeconde. Altrove le solitarie (…)L’Altri vivarij presso al mare eranofatti per conservare de pesci per ognitempo, et ostreghe. Or dunque la petied’essi edificij sono varij: et de similiforme si trovano ch’erano Bagni, etVivari, come fu questo nel paeselatino circa a Roma, lo qual è statospianato per edificare vigne”).Ringrazio per la segnalazioneMarcello Fagiolo.
In basso73a-73b. F. BUONANNI. Frontespizioe coclee (da Ricreatione dell’occhio edella mente nell’osservation’ dellechiocciole…, Roma 1681).
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:46 Pagina 113
portamento strutturale sembra potersi leggere fin nella particolare scelta del tracciamento del-la curva policentrica chiusa che non coincide con quelli indicati dalla trattatistica (fig. 74) 165.Se gli ovali di Vignola e del Palladio dipendevano dai quattro modi del Serlio, quelli diBorromini – ci riferiamo esclusivamente alle piante di scale e non alla tipologia chiesastica –sembrano il risultato di una precisa scelta progettuale volta ad assicurare un migliore compor-tamento funzionale e strutturale. Ricordiamo che per l’ovale il tracciamento è quello stesso del cerchio, con la differenza che i cen-tri e i rispettivi raggi di curvatura sono più d’uno e il loro numero in funzione degli archi che de-scrivono la curva166. L’ovale ha curvatura costante che cambia, tuttavia, bruscamente, quandocambia il centro dell’arco che lo compone. Gli archi risultano perfettamente saldati, poiché nelpunto di saldatura ammettono una comune tangente, il che si ottiene facendo sì che, in quelpunto, coincidano i raggi dei due cerchi componenti. Questi archi di cerchio, tuttavia, possonoessere composti nei modi più vari, alcuni semplici, come quelli a quattro centri che appartengo-no alla trattastica rinascimentale e alla prassi borrominiana167. Le costruzioni dell’ovale a quat-tro centri pubblicate dal Serlio – le più diffuse tra gli architetti – sono in tutto quattro. La cur-vatura dell’ovale è determinata dalla particolare configurazione dei triangoli generatori.Nella prima costruzione, Serlio fissa quattro rette che, intersecandosi con angoli di 60 e 120gradi, determinano i vertici di due triangoli equilateri, coincidenti con i centri degli archi checompongono l’ovale. In questa costruzione non è indicata la dimensione di alcuno dei rag-gi, quindi gli ovali che si possono disegnare sono infiniti e concentrici. Nella seconda costruzione, basata sull’intersezione di tre circonferenze, viene fissata sia la posizio-ne dei centri, disposti su rette che si intersecano a 90 gradi, sia la dimensione del raggio dell’arco dicerchio minore, quindi, di fatto la lunghezza dell’asse maggiore dell’ovale. La dimensione dell’asseminore è determinata di conseguenza e l’ovale così costruito ha un rapporto tra gli assi fisso. Lo stes-so può dirsi per l’ovale della terza costruzione con due quadrati che, come la seconda, ha le rette checontengono i centri che formano con l’asse minore dell’ovale un angolo di 45 gradi. Nella quartacostruzione, basata sulla intersezione di due circonferenze, le rette cui appartengono i centri for-mano un angolo con l’asse minore di 30 gradi, ed essendo determinata la misura del raggio si de-finisce di conseguenza la dimensione dell’asse maggiore dell’ovale e si ricava la dimensione del-l’asse minore. Come in quest’ultima, anche negli ovali determinati con la prima costruzione l’an-golo tra l’asse minore e le rette dei centri incidenti è di 30 gradi. Tra gli infiniti ovali generati dal-la prima costruzione, uno solo corrisponde a quello della quarta, quello in cui il raggio dell’arcominore è uguale alla distanza fra i due centri contigui sull’asse maggiore.La forma dell’ovale muta in sostanza al variare dei triangoli generatori determinati dallaposizione dei centri degli archi che definiscono la curva (la variazione dei triangoli iso-sceli costruiti sulle rette che contengono i centri dipende ovviamente dall’angolo di inci-denza tra i due lati uguali e l’asse minore). Serlio dimostra in sostanza come si possanoottenere ovali più o meno schiacciati allontanando o avvicinando i centri rispetto al pun-to di intersezione degli assi. Per il tracciamento degli ovali di impianto degli scaloniBorromini utilizza preferibilmente costruzioni che gli consentono di ottenere delle figu-re quasi assimilabili al cerchio o al rettangolo. Nel primo caso (Alb. Az. Rom 967, Alb.Az. Rom 1035) (figg. 76, 77), sfrutta al massimo la curvatura dei due cerchi minori avvi-cinando ulteriormente, rispetto alla IV costruzione del Serlio, i relativi centri sull’assemaggiore (i due archi di cerchio diventano quasi delle semicirconferenze). Borrominisembra così tener conto del fatto che la struttura sollecitata di uno scalone ovale tende acomportarsi, nel tentativo di raggiungere un equilibrio statico attraverso il bilanciamen-to delle forze in contrasto, come quella di una a pianta circolare. Nel secondo caso, al-lontana i centri di curvatura degli archi di cerchio maggiori posti sugli assi minori, otte-nendo degli ovali oblunghi (Alb. Az. Rom 289, Alb. Az Rom 88) (fig. 87). Altri ovali bor-rominiani apparentemente tondi od oblunghi sono illusivi perchè saldati in realtà sul-l’asse minore da un tratto rettilineo (con il punto di fuga delle rette generatrici esternoalla figura e spostato all’infinito; vedi Alb. Az Rom 1036). In un solo caso vediamo adot-tata la prima costruzione del Serlio e cioè nel disegno teorico Vat. Lat. 11257, f. 192 (fig.41), peraltro non direttamente attribuibile al Borromini. Felice della Greca, nella “BreveRelatione…”, dimostra l’ovale dello scalone Barberini con la seconda costruzione geo-metrica di Serlio168. La trattazione è però intesa a una riflessione più ampia sulla tipolo-gia: infatti la pianta dimostrativa non è un rilievo e non corrisponde all’opera realizzatasia nel dimensionamento del pozzo, più ampio, sia nel numero di coppie di colonne bi-nate che sono 10 e non 6 (fig. 75).
114 PARTE SECONDA
Alonso Garcia 2001; R. Bösel 1999 e 2001;C. Baldoni 2002; F. Bellini 2004, pp. 21-28;A. Borgomainerio 2006.165 Vedi M. Simona 1999 che arriva, sebbeneper vie diverse, alle stesse conclusioni.166 La policentrica è una curva (non necessa-riamente chiusa) composta da archi di circon-ferenza. L’ovale, policentrica particolare, è unacurva chiusa che delimita una regione conves-sa, avente due assi di simmetria.Sulla costruzione gemetrica degli ovali vedi F.Ragazzo 1995; R. Migliari 1995; G. Pagnano1993; R. Migliari 1995; Il Colosseo (1999); E.Dotto 2000; M. Biraghi 2000. Sulla ricadutanella costruzione dell’architettura vedi O.Zerlenga 1996. 167 Altri modi di comporre l’ovale, molto piùelaborati, sono posteriori, come quelli otto-centeschi di Breymann.168 G. Curcio 1978, pp. 110, 111.
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:46 Pagina 114
Per quanto riguarda l’ovale del pozzo interno si tendeva generalmente a mantenere costantela larghezza dei gradini, utilizzando la stessa costruzione, che consentiva, attraverso il trac-ciato di ovali concentrici, di ottenere anche il progressivo schiacciamento della curvatura ri-spetto all’asse maggiore169.
7. Analisi geometrica del disegno Albertina Az. Rom 1038
“Nella scrittura del Cav.re Borromino […] la melodia delle voci è appoggiata a’ numeri; come in misura la bellezza delle fabbriche […] pretende, nascer parimenti da numeri, e che tutte le parti habbino una tale proportione, che un[a sola] apertura di compasso
– senza mai muoverlo – le misuri tutte”. VIRGILIO SPADA170
I disegni di scale elicoidali a pianta ovale sembrano testimoniare in Borromini la ricerca diun metodo geometrico in grado di stabilire una relazione tra i vari elementi architettonici co-stitutivi, in particolare tra sviluppo longitudinale e trasversale della rampa e ampiezza dell’a-nima. Il disegno Alb. Az. Rom 1038 costituisce una tappa fondamentale di questa ricerca esi presta a interessanti osservazioni di carattere geometrico. L’ovale oblungo di progetto è co-struito da triangoli generatori che hanno i vertici sull’asse minore fuori dell’ovale. La figurasi avvicina fortemente a uno pseudoovale, inteso come forma composta da un quadrato di-latato trasversamente da due semicerchi 171. In un suo recente contributo lo storico Amelio Fara ha sostenuto che, per intendere l’essen-za geometrica dell’architettura di Francesco Borromini (e di Guarino Guarini), occorre ri-percorrere le progettazioni delle sue architetture alla luce della costruzione düreriano-gali-leiana del pentagono e ha applicato tali principi alle piante di San Carlino alle QuattroFontane e di Sant’Ivo alla Sapienza172. La costruzione del pentagono divulgata da Albrecht Dürer è di rapida esecuzione perchési può procedere unicamente con la seste e la riga, mentre nella costruzione euclidea oc-correva servirsi di un misuratore di angoli (figg. 78, 79). Anche rispetto alle costruzionidel pentagono di Tolomeo e Leonardo, quella di Dürer sembra più adatta agli architetti,perché impostata sull’apertura costante del compasso (ogni circonferenza passa per i cen-tri delle altre) 173. Nel 1620, il bolognese Pietro Antonio Cataldi (1548-1626), lettore delle scienze matemati-che nello Studio di Bologna, pubblicò un trattato geometrico dove si esaminava “il modo diformare il pentagono sopra a una linea retta, descritto da Alberto Durero”174.Galileo descrisse la costruzione düreriana nelle due versioni note del suo trattato di architet-tura militare. Riportiamo qui la descrizione fornita nella prima versione (1592-93):
Le scale coclidi di Borromini 115
169 Per fissare il tracciato dell’ovale interno delpozzo ci si poteva avvalere nella pratica di can-tiere della forma di una pietra scolpita posta alpiano di partenza della scala come quella di pa-lazzo Riccardi a Firenze che reca infisso un fer-ro a segnare le intersezioni degli assi e l’inci-sione dell’asse minore, e come sembra dimo-strare la presenza del piedistallo ovale nella sca-la di palazzo Vecchiarelli a Rieti. 170 ASR, FSV, vol. 494, int. 3, c. non numera-ta (c. 42r), 7 ottobre 1656, Minuta di unalettera di Virgilio Spada a Cesare Rasponi. Documento segnalato da K. Güthlein 1981,p. 210. Nel 1614, a Leipzig, era stato pubbli-cato con il titolo “Musica mathematica” un li-bro di Abraham Bartolus, nel quale si propo-neva l’estensione del compasso di proporzio-ne anche alla musica. Sull’interesse di Virgilioper gli aspetti fisico-aritmetici della musica ve-di G. Finocchiaro 1999, p. 25. 171 Lo pseudovale compare nelle sperimenta-zioni di Baldassarre Peruzzi, ad esempio neldisegno per una “cappella per il vescovo teati-no in monte Pincio” (W. Lotz 1997, nota 57).Nell’opera di Palladio la figura compare nel-l’impianto delle scale gemelle di villa Cornaro(M. Bourke 2006). Sull’‘ovalizzazione’ dellepiante rettangolari in Borromini vedi R. Bösel2001.172 A. Fara 2002, pp. 102-189. Lo studioso ri-chiama la geometria della fortificazione diffu-sa da Albrecht Dürer e la cultura militare cheGalileo Galilei (1564-1642) aveva appreso daOstilio Ricci, il quale nel 1586 svolgeva le fun-zioni di matematico al servizio del granducaFrancesco de’ Medici, quando BernardoBuontalenti veniva considerato uno dei piùgrandi architetti militari dell’Occidente.173 Sul tema geometrico del pentagono co-struito con aperture di compasso vedi le eser-citazioni, forse attribuibili a Gregorio Spada,nel codice BAV, Vat. Lat. 11258, fol. 205r.174 Ricordiamo che nel 1620 il bolognesePietro Antonio Cataldi (1548-1626) pub-blica un trattato sulla costruzione dürerianadel pentagono. Sul tema geometrico del pen-tagono costruito con aperture di compassovedi le esercitazioni, forse attribuibili aGregorio Spada, nel codice BAV, Vat. Lat.11258, fol. 205r.
74. Quattro modi per costruire unovale secondo Serlio.
I
III IV
II
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:46 Pagina 115
75. FELICE DELLA GRECA.Dimostrazione geometrica dello scalonedi Palazzo Barberini (da Curcio1978).
In basso76. Analisi geometrica del progettoAlb. Az Rom 967 per lo scalone ovaledi Palazzo Barberini.77. Analisi geometrica del progettoAlb. Az Rom 1035 per lo scalone ovaledi Palazzo Pamphilj.
“Il modo di descrivere il pentagono lo piglieremo da Alberto Durero: e sarà tale. Prima tireremo lalinea AB, secondo la lunghezza che ci piacerà che sia il lato del pentagono. Di poi sopra i due centriA, B si descriveranno due cerchi, secondo l’intervallo di essa linea AB, tra le communi intersezionidei quali si tirerà la linea GL; e circa il punto G, col medesimo intervallo, si descriverà l’arco EAIBF;e per i due punti E, I si tirerà la linea EIC, e similmente per i due punti F, I si tirerà l’altra linea FID.Di poi, fermando l’asta del compasso ne i due punti D, C con la medesima apritura, secondo la lun-ghezza della prima linea AB, si farà l’intersecazione, come si vede al punto H; dal qual punto si tire-ranno le due linee HD, HC, tirando in oltre le due DA, CB: e sarà descritto il pentagono HDABC.Avvertendo, che tutta la costruzione di questa figura si potrà far occulta; eccetto però che i lati delpentagono”175.
Nel voler verificare la tesi di Amelio Fara attraverso applicazioni, ci accorgiamo che la co-struzione che Galileo riprende da Albrecht Dürer, soddisfa pienamente lo sviluppo geome-trico-compositivo del progetto di scalone a pianta ovale oblungo rappresentato nel disegnoAlb. Az. Rom 1038. Borromini non è ovviamente interessato alla figura del pentagono cherimane invisibile sul foglio – e di cui suggeriamo anche una possibile lettura simbolica – ben-
116 PARTE SECONDA
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:46 Pagina 116
Sovrapponendo la costruzione al disegno Alb. Az. Rom 1038 vediamo che essa individua unaserie di punti e linee: la linea AB, come si è visto, corrisponde alla lunghezza interna dell’a-nima; il segmento II’ individua la larghezza dell’anima; la linea CD corrisponde alla larghezzadel rettangolo (gabbia strutturale) che circoscrive la rampa ovale; i due cerchi di centri A e Bindividuano lo sviluppo longitudinale dell’ovale (asse MN) 177.Procedendo nella costruzione di due pentagoni aventi in comune il lato AB e ricordando che ABpuò naturalmente rappresentare anche il lato comune degli esagoni inscritti nelle circonferenzei cui angoli al centro siano di sessanta gradi, ci accorgiamo che le rette coincidenti con i lati deisuddetti poligoni individuano i punti necessari alla distribuzione degli elementi architettonici.Lungo le rette fondamentali di costruzione dei due semipentagoni e dei due semiesagoni(F’I’G, E’I’H, EIH’, FIG’) aventi il lato comune in AB e inscrittibili nelle circonferenzedi centri C e D, si trovano distribuiti i punti che determinano prima la posizione delle nic-chie scavate nell’anima e lungo il perimetro ovale interno della gabbia strutturale le aper-ture delle quattro camere di luce laterali o in alternativa gli assi delle nicchie. Borrominiripete il procedimento fin qui esposto, prendendo questa volta, come apertura di com-
118 PARTE SECONDA
80. Roma, San Carlino alle QuattroFontane. Ferro portalampada a formadi pentacolo sormontato da una piccolacroce nell’anello della cupola, sudisegno di Francesco Borromini(riproduzione moderna).81. Ricostruzione del pensieroborrominiano per la determinazione,partendo da una misura data l,dell’ampiezza interna dell’anima delloscalone Alb. Az Rom 1038.
In basso82. Ricostruzione geometrica delprogetto di scalone ovale Alb. Az Rom1038 secondo la costruzione dürerianadel pentagono.
FAGIOLO TABARRINIULTIMO���.qxp:2015 LODARI Giardino lago.qxd 10-02-2009 15:46 Pagina 118