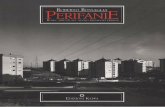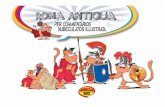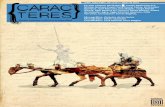tultepec.- lopez lopez leticia eugenia, ayala bernal alejandro ...
Azcue Brea, Leticia, \"Roma e la Spagna, mecenatismo reale e privato di scultura nel’Ottocento...
-
Upload
museodelprado -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Azcue Brea, Leticia, \"Roma e la Spagna, mecenatismo reale e privato di scultura nel’Ottocento...
Roma fuori di RomaL’esportazione dell’arte modernada Pio VI all’Unità 1775 -1870
a cura diGiovanna CapitelliStefano GrandessoCarla Mazzarelli
Campisano Editore
Nessuna parte di questo libropuò essere riprodotta o trasmessain qualsiasi forma o con qualsiasimezzo elettronico, meccanicoo altro senza l’autorizzazionescritta dei proprietari dei dirittie dell’editore.
Progetto grafico di Gianni Trozzi
© copyright 2012 byCampisano Editore Srl00155 Roma, viale Battista Bardanzellu, 53Tel +39 06 4066614 - Fax +39 06 [email protected] 978-88-88168-90-6
L’editore è a disposizione degli aventidiritto per quanto riguarda le fontiiconografiche e letterarie non individuate.
a cura di
Giovanna CapitelliStefano GrandessoCarla Mazzarelli
introduzione
Liliana Barroero
postfazione
Christoph Frank
Campisano Editore
Roma fuori di RomaL’esportazione dell’arte modernada Pio VI all’Unità (1775-1870)
Volume realizzato con il contributo del Prin 2008(Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante InteresseNazionale) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università edella Ricerca per il progetto Per una storia del mercatodell’arte. Da Roma all’Europa e al Nuovo Mondo, tra laseconda metà del secolo XVIII e la fine del XIX. Coordinatorescientifico: Liliana Barroero (Università Roma Tre,Dipartimento di Studi storico-artistici, archeologici e sullaconservazione), coordinatori di unità: Giovanna Capitelli(Università della Calabria, Dipartimento di Archeologia eStoria delle Arti), Fernando Mazzocca e Rosanna Sacchi(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di beniculturali e ambientali)
e con il contributo dell’Istituto di storia e teoria dell’arte e dell’architettura, Accademia di architettura,Università della Svizzera italianaDirettore: Christoph Frank
I curatori desiderano ringraziare i direttori e il personaleamministrativo dei Dipartimenti coinvolti nella ricerca equanti hanno contribuito alla realizzazione di questo volume. La nostra riconoscenza va innanzitutto agli autori per lapreziosa collaborazione, ad Annalia Cancelliere per lagenerosa e paziente cura redazionale e a Graziano Campisanoche ha creduto in questo progetto. Siamo grati per i consiglie l’aiuto in particolare a Giulio Archinà, Hannah Baader,Gianluca Berardi, Ombretta Bracci, Anna Bruno, StefanoCapitelli, Stefano Cracolici, Tiziano Casartelli, EnricoD’Andrassi, Marco Della Torre, Michela di Macco, Elena diMajo, Margaret English Di Salvo, Marco Fabiano, FiorellaFoglia, Marta Galli, Alba Irollo, Maggiorino Iusi, JohannaKostylo, Matteo Lafranconi, Alberto Laudi, Francesco Leone,Pierluigi Mattera, Bruno Mantura, Monica Molinai, AntonelloNegri, Christian Omodeo, Raffaele Perrelli, Susan Russell,Simonetta Sergiacomi, Federica Foscarina Simone, AntoineTurner, Anna Villari, Carlo Virgilio, Paola Zatti
In copertinaBertel Thorvaldsen, Le tre Grazie, particolareCopenaghen, Thorvaldsens Museum,fotografia: Giulio Archinà
Indice
pag. 9 IntroduzioneLiliana Barroero
13 Antefatti e prospettive di ricercaGiovanna Capitelli, Stefano Grandesso, Carla Mazzarelli
LA CIRCOLAZIONE DELLE OPERE: FONTI, STRUMENTI E CASI DI STUDIO
19 Roma «capitale delle arti». Fonti per la fortuna di un topos storiografico nell’OttocentoSusanne Adina Meyer
31 Note sulle fonti ufficiose e ufficiali per la storia della circolazione delle opere e degli artisti (1787-1844)Serenella Rolfi Ozvald
51 Esportazioni di opere d’arte nelle pagine del «Giornale delle Belle Arti» e delle «Memorie per le Belle Arti», 1784-1788Ilaria Proia
69 «Opera d’arte destinata a figurare in terra straniera»: notizie di esportazioni nella pubblicistica romana tra 1846 e 1870Maria Saveria Ruga
87 Esportare quadri nella Roma di Pio VI (1775-1799): le inclinazioni estetiche di Brownlow Cecil, nono conte di ExeterPaolo Coen
103 Il soggiorno romano dei duchi di Curlandia nel 1785 e gli acquisti sul mercato artistico per la collezione di Schloss Friedrichsfelde a BerlinoChristoph Frank, Angela Windholz
128 La corrispondenza romana di Heinrich von Offenberg (1785-1796)Christoph Frank, Angela Windholz
191 Gaspare Santini: console russo e agente artistico a RomaSergej Androsov
197 Camillo Domeniconi, artista e mediatore d’arte tra Roma e il SudamericaFederica Giacomini
209 Achille Vertunni e Mariano Fortuny: Roma tra arte e mercato nella nuova stagione internazionaleEugenia Querci
LE FORMULE AULICHE DELLA SCULTURA E DELLA PITTURA: FORTUNA E DIFFUSIONE
229 Modelli e fortuna della scultura ideale: la declinazione della ‘grazia’ nel soggetto di PsicheStefano Grandesso
249 La scultura romana in Polonia tra tardo Settecento e primo Ottocento Katarzyna Mikocka-Rachubowa
265 Roma e la Spagna: mecenatismo reale e privato di scultura nell’Ottocento (fino al 1873)Leticia Azcue Brea
285 Gli scultori russi pensionnaires a Roma. 1823-1846Lina Tarasova, Sergej Androsov
293 Il cammino a ritroso: Schorn, Creuzer e il significato della scultura nel «Kunst-Blatt»Alexander Auf der Heyde
307 «American Art from American subjects». La ricezione delle opere romane diThomas Crawford in America e la sfida ‘anti-romana’ di Henry Kirke BrownPierpaolo Racioppi
323 Displaying the Traslatio Imperii: Roman Art and Iconography between Portugal and Portuguese America in late 18th centuryAndré Tavares
335 Gli allievi catalani di Tommaso MinardiCarolina Brook
349 I processi di straniamento: la Roma di Jean-Léon Gérôme Olivier Bonfait
363 Artisti dissidenti tra prima e seconda Repubblica RomanaIlaria Sgarbozza
379 Quadri romani in Sicilia tra Sette e OttocentoGioacchino Barbera
389 Il mercato globale dell’arte sacra romana nell’Ottocento. Pratiche, committenze, intermediari, artistiGiovanna Capitelli
419 L’Arte di Roma nel Cile del XIX secolo. Un elemento delle strategiedi rappresentazione dell’identità nazionale. Il caso degli altariFernando Guzmán
I MODELLI DEL GUSTO DALL’ARCHITETTURA ALLE ARTI APPLICATE
433 Urbi et Orbi. Riflessioni sul Settecento e l’AnticoSandra Pinto
451 Lo stile, la parte, l’intreccio. Il disegno architettonico dall’antico come modello di ‘gusto’ nella seconda metà del XVIII secoloLetizia Tedeschi
465 Collezionare la scultura lontano da Roma. Scultura antica e moderna a confronto. Il caso delle British Country Houses (1780-1820)Barbara Musetti
477 The fortune of the Borghese Dancers in the early nineteenth-century European art and decorationAdriano Aymonino
493 Circolazione di modelli tra Italia, Inghilterra e Germania: copie romane di gusto inglese a WörlitzChiara Teolato
509 ‘Old masters’ da exempla a souvenir: note sulla fortuna dell’Aurora Rospigliosi di Guido Reni tra Settecento e OttocentoCarla Mazzarelli
529 «Pour naturaliser en France les arts de l’Italie»: la Calcografia Piranesi da Roma a Parigi (1799-1810)Valeria Mirra
541 La pittura e la scultura moderne nella glittica romana dell’OttocentoLucia Pirzio Biroli Stefanelli
555 Parigi - Roma, Roma - Boston: la formazione della collezione di stampedel cardinale Tosti attraverso Calamatta e MercuriRosalba Dinoia
569 PostscriptChristoph Frank
573 Roma fuori di Roma nel XVIII e XIX secolo: disegni, bozzetti e fotografie nelle collezioni di Palazzo Braschi
APPARATI
626 L’arte moderna esce da Roma: regesto delle licenze d’esportazione dal 1775 al 1870a cura di Alessandra Imbellone
727 Indice dei nomia cura di Annalia Cancelliere
Roma e la Spagna, mecenatismo reale e privato di scultura nell’Ottocento (fino al 1873)Leticia Azcue Brea
Roma fu la Mecca degli scultori, destinazione che tutti raggiunsero ‘in pelle-grinaggio’ durante il XIX secolo 1. Scopo di questo saggio è di riflettere sullaqualità degli artisti spagnoli attivi a Roma e sull’elevato livello della commit-tenza che li impegnò attraverso una strategia che assume un forte significatoculturale, così come aggiornare i riferimenti bibliografici che la riguardano 2.
Il re di Spagna Carlo IV di Borbone – che regnò tra il 1788 e il 1808, data incui ebbe inizio la Guerra d’Indipendenza – e suo figlio Ferdinando VII di Bor-bone – che Napoleone Bonaparte chiamò a Bayona, dove si trovava Carlo IV inesilio, affinché rinunciasse alla Corona spagnola, e che durante gli anni dellasuccitata guerra visse recluso a Valençay, e tornò in Spagna dove regnò dal 1814e il 1833 3 – furono, nel primo trentennio del XIX secolo, la fonte principale de-gli incarichi per i pensionati artistici (d’ora in poi ‘pensionati’) della Città Eter-na. Gran parte di costoro ricevette in seguito il titolo di Scultore di Camera aMadrid, il che significò un maggior numero di incarichi fino a quando questacarica venne abolita nel 1866.
I pensionati spagnoli a Roma dimostrarono la propria lealtà ai monarchi du-rante la succitata guerra e parteciparono in segno di ringraziamento a progettifunerari effimeri sia a Madrid che a Roma 4. Questi scultori furono inoltre ingran parte nominati Accademici di Merito dell’Accademia Reale di San Fer-nando e alcuni di loro riuscirono a ottenere incarichi di responsabilità in que-sta istituzione madrilena. Giunse a Roma anche un gruppo di scultori pensio-nati dalla Giunta di Commercio di Barcellona, in larga parte allievi della Scuo-la della Llotja 5.
In parallelo, le commissioni reali portate a termine dagli Scultori di Camera,in particolar modo quelle relative ai ritratti segnati dal neoclassicismo assorbi-to a Roma, cominciarono a entrare nelle collezioni del Real Museo de Pinturasdi Madrid già nel 1826 6. Questo museo, fondato nel 1819, cambiò il nome inReal Museo de Pintura y Escultura, scelta che si rivelò fondamentale per gli ar-tisti viventi, oltre ad essere uno shock positivo nel mondo della scultura, inquanto la scultura ottocentesca, eseguita a Roma per gran parte in marmo diCarrara, veniva esibita nelle gallerie della più importante istituzione musealespagnola. D’altro canto lo Stato, dal 1856 in avanti, svolse le funzioni di ‘mece-nate’ nei confronti dei pensionati a Roma, poiché le loro opere premiate nelleEsposizioni Nazionali passarono al Museo.
Sia i pensionati del Re che quelli della Giunta di Commercio ricevetterocommittenze private da parte di viaggiatori spagnoli 7 tra cui si annoverano,all’inizio del XIX secolo, il Cardinale Despuig e, nel secondo decennio il XIVDuca d’Alba, il quale cominciò un progetto di mecenatismo nei confronti diun’Accademia privata a Roma. Più avanti, altri collezionisti, come il Marchesedi Salamanca o la Casa Ducale di Osuna, compreranno loro delle opere, comepure faranno nobili italiani come il Torlonia o stranieri, come la Duchessa diSuther land.
Gli insegnamenti dell’Accademia Reale di San Fernando a Madrid, fondatanel 1752, avevano decretato la città di Roma come una tappa imprescindibileper il completamento della formazione artistica, nonché il luogo ideale per vi-vere un’esperienza cosmopolita. Ciononostante, l’esperienza di vita nella stra-grande maggioranza dei casi fu terribile, dato che gli incarichi reali venivanopagati con un certo ritardo e il saldo delle pensioni giungeva in maniera irre-golare. I pensionati vissero così in una situazione di scarsa protezione, trascu-rati lungo tutto il secolo dall’Ammministrazione Reale della Corte di Madrid.
L’euforia del soggiorno romano era così spesso offuscata dallo sconforto edalle ristrettezze dovute ai ritardi nei pagamenti, situazione deplorevole di cuisi diede notizia sulla stampa spagnola e che fece nascere in alcuni scultori unprofondo risentimento nei confronti della città 8.
Dal XVIII secolo in avanti emerse l’aspirazione dello Stato spagnolo di di-sporre di una sede fissa a Roma, a lungo anelata, un luogo che avrebbe reso lavita più semplice agli artisti ma che tardò ad arrivare. In età di Restaurazione, ipensionati poterono contare sulla direzione degli scultori Antonio Solá, dal1831 al 1855, e José Vilches dal 1858, i quali, oltre a farsi garanti della loro forma-zione, li aiutarono nella ricerca di alloggio e atelier. Diversamente da altri pae-si, per ragioni gestionali e di ordine economico, la sede dell’Accademia spa-gnola a Roma non occupò un edificio fino al 1873 9.
Vari scultori e pensionati che non avevano intenzione di tornare in Spagnacercarono l’appoggio di privati o di un ente che finanziasse il loro soggiorno aRoma: Ponciano Ponzano per esempio, dopo aver ricevuto la pensione a Ro-ma dal 1832 al 1836 e avere stretto rapporti d’amicizia con Thorvaldsen, ottennel’appoggio del Conte di Toreno e tornò in patria nel 1841. Alcuni trascorsero aRoma il resto della propria vita, cosa che permise loro di scolpire opere di uncerto spessore grazie agli insegnamenti ricevuti nell’ambiente artistico e il con-tatto con i maestri neoclassici. A causa di queste pratiche si diffusero opinioniassai critiche in seno all’Accademia Reale su un investimento, quello della for-mazione di pensionati, dal mancato ritorno economico in Spagna 10.
L’Accademia aveva stabilito nel 1789 di non stanziare più pensioni a Roma,ritenendo l’investimento non proficuo e apportando a sostegno di ciò il fattoche possedeva già una cospicua gipsoteca sulla quale lavorare. Per questa ra-gione non vedeva di buon occhio le pensioni reali, sebbene alla fine le ripro-ponesse in veste istituzionale nel 1832 11. Per questo motivo, i soggiorni romanidi Solá o Álvarez vennero ignorati dall’Accademia, poiché i pensionati del Renon solo non appartenevano alla Corporazione, ma perdipiù avevano abbon-
266 LETICIA AZCUE BREA
dantemente superato il tempo di permanenza di una pensione pensata «per l’i-struzione dei più giovani». Ecco il motivo per cui l’Accademia mostrava unacerta resistenza ad accoglierli al loro ritorno da Roma, sebbene voci più mode-rate 12 rammentarono a quest’istituzione che vista l’esosa inversione da un latoe il riconoscimento da parte di istituzioni straniere come l’Accademia di SanLuca dall’altro, era logico che gli artisti richiamati in patria dovessero essereguardati come «artisti ricchi di fama e reputazione quali erano».
Il XIX secolo iniziò con l’assegnazione delle pensioni concesse dal re CarloIV a José Álvarez Cubero 13, a Ramón Barba 14 e a Valeriano Salvatierra 15 e dallaGiunta di Commercio di Barcellona a Francisco Bover 16, a Damián Campeny 17
e ad Antonio Solá 18, quest’ultimo pensionato anche del monarca. Tutti costorocercarono alloggio nei pressi del Palazzo di Spagna, con l’Ambasciata spagno-la, prossima alla Santa Sede, come punto di riferimento e persino sede d’espo-sizione di opere personali, e completarono poi la propria formazione pressol’Accademia di San Luca, partecipando alle sedute della Scuola del Nudo delCampidoglio 19.
Nel 1805 il re Carlo IV diede l’incarico ad Antonio Canova di decorare unastanza della Real Casa del Labrador (letteralmente la Casetta Reale dell’Arato-re, un palazzetto dedicato allo svago) ad Aranjuez 20. Sebbene Canova non sot-toscrivesse l’accordo – e infatti il progetto non venne realizzato – lo scultoreveneto-romanizzato propose al monarca che le quattro sculture destinate allenicchie venissero realizzate dai giovani scultori che ricevevano la pensione delre a Roma e che Canova conosceva bene. Barba scolpì per questo progetto unMercurio nel 1806, che firmò incassandone i proventi e inviandolo al re. Álva-rez scolpì un Apollo nel 1806, che gli venne pagato ma che egli non mandò almonarca, vendendolo durante la Guerra d’Indipendenza (1808-1814).
In questo periodo a tutti venne revocata la pensione in quanto non riconob-bero Giuseppe I Bonaparte come re di Spagna. Per loro questo gesto com-portò conseguenze pesanti: il carcere presso Castel Sant’Angelo, da dove furo-no liberati per intercessione di Canova 21. Neanche Solá inviò la sua Psiche rea-lizzata nel 1806, che vendette poi nel 1812 per ragioni di mera sussistenza 22. Álvarez realizzò anni dopo un secondo Apollino che vendette a Ferdinando VIIsenza fare menzione all’impegno preso nel 1806. Nel 1817 anche Solá inviò almonarca una nuova versione di Cerere del 1815, insieme a un ritratto di Pio VIIsperando gli venisse concessa una pensione reale in vista della scadenza diquella che stava ricevendo dalla Giunta di Commercio. Queste opere di Bar-ba, Álvarez e Solá sono conservate al Museo del Prado. Della Diana di Cam-peny non si conosce invece l’attuale ubicazione.
Nel frattempo, già nel 1803, Campeny aveva modellato in gesso ed inviato aBarcellona la scultura di Lucrezia morta e nel 1804 scolpì in terracotta partendo– come poi Álvarez avrebbe fatto più avanti – dall’interpretazione delle matro-ne romane, con estrema naturalezza ed eleganza, anche se purtroppo il valoredell’opera non fu pienamente compreso in quel momento e la fusione in bron-zo risale solo al 1934. Più avanti l’artista realizzerà una serie di allegorie e faràritorno a Barcellona nel 1806 dove la sua carriera sarà costellata di successi 23.
ROMA E LA SPAGNA, MECENATISMO REALE E PRIVATO DI SCULTURA NELL’OTTOCENTO 267
268 LETICIA AZCUE BREA
1. José Álvarez Cubero La Difesa di Saragozza, Roma, 1826, marmo di Carrara, Madrid, Museo del Prado. © Museo del Prado
ROMA E LA SPAGNA, MECENATISMO REALE E PRIVATO DI SCULTURA NELL’OTTOCENTO 269
2. Ramón Barba. Re padre Carlo IV seduto, 1817, marmo di Carrara, Madrid, Museo del Prado,in deposito a Palazzo Reale, Madrid. © Museo del Prado
In Italia si può vedere a Parma il gran dessert La tavola dell’Ambasciatore, cheCarolina Brook ha pubblicato e che fu al centro di una mostra temporanea nel1999 24.
Álvarez visse a Roma quasi tutta la vita ma morì a Madrid nel 1827: in qua-lità di Scultore di Camera lavorò su incarico e la maggior parte delle opere sitrova attualmente al Museo del Prado 25. Fra queste il ritratto seduto di Isabelladi Braganza, seconda moglie di Ferdinando VII, o il capolavoro de La Difesa diSaragozza (fig. 1), commissionato dal re Ferdinando VII: un omaggio alla Guer-ra d’Indipendenza contro i francesi che ebbe luogo nella città spagnola. In es-so si può vedere quello che lo scultore imparò da Canova. Gli artisti spagnoliavreb bero cercato altri incarichi: per esempio, i ritratti di Jérôme Bonaparte, redi Westfalia e Catherine di Wurtemberg 26. Poiché si muoveva nell’ambito cul tu -rale romano, l’artista eseguì il ritratto di Rossini: i rapporti erano molto stret tifra gli spagnoli e dobbiamo tener conto che la prima sposa di Rossini era spa -gnola. Álvarez fece anche altre opere come un Giovane con il cigno.
Barba realizzò il ritratto a figura intera ‘all’eroica’ del Re padre (fig. 2, tav.XVI), mentre in contemporanea Álvarez Cubero faceva a Roma il ritratto a fi-gura intera della Regina madre, sposa di Carlo IV, Maria Luisa di Parma, per ilquale usò il modello di Agrippina e quello della madre di Napoleone del Ca-nova, oggi in deposito in due palazzi reali di Madrid 27.
Barba tornò malvolentieri a Madrid nel 1822: lì fu Scultore di Camera e la-vorò alla decorazione degli esterni del Museo, realizzandovi i sedici medaglio-ni con i ritratti degli artisti più importanti della storia dell’arte spagnola – ar-chitetti, scultori e pittori – con la grande novità che fra gli scultori scelti si in-cludeva il neoclassico Álvarez Cubero, morto soltanto quattro anni prima, co-me uno dei grandi artisti nella storia dell’arte, ed eseguì anche il grande rilie-vo sopra la porta principale del Museo, con un’allegoria delle Belle Arti e il reFerdinando VII, che sarebbe stato poi completato da alcuni collaboratori, einaugurato nel 1840 28. L’incarico reale includeva dodici sculture allegoricheche erano state realizzate da Valeriano Salvatierra, scultore formatosi a Roma,e risulta assai evidente che le fonti da cui trasse ispirazione erano in quellacittà (fig. 3).
Solá visse e morì a Roma nel 1861 e si recò a Madrid unicamente nel 1831 perportare al re Ferdinando VII l’innovativo insieme scultoreo di Daoiz e Velarde,dal significato politico (fig. 4) 29. La sua assoluta dedizione gli venne ricono -sciuta a Madrid e a Roma con la carica rispettivamente di Direttore dei Pen-sionati nel 1831 e a Roma dell’Accademia di San Luca nel 1837 30. Entrò poi a farparte della Congregazione dei Virtuosi del Pantheon. La vicenda di Solá fu pa-radigmatica del sistema di convivenza tra le diverse nazionalità che vigeva al -l’interno dell’Accademia romana con Finelli, Albacini, Canova o Thorvaldsenai quali fu unito da una relazione di grande prossimità. Furono Thorvaldsen,Albacini e Laboureur a proporre Solá come Accademico di Merito il 3 marzodel 1816. Egli passò subito ad essere, insieme al suo promotore Thorvaldsen,Consigliere per la Scultura nel 1824 31. Nonostante la sua dedizione, il 3 ottobredel 1841 inviò un rapporto all’Accademia di San Fernando «sull’utilità di man-
270 LETICIA AZCUE BREA
ROMA E LA SPAGNA, MECENATISMO REALE E PRIVATO DI SCULTURA NELL’OTTOCENTO 271
3. Valeriano Salvatierra, Allegoria della Simmetria, 1830-1836, pietra de Colmenar,Madrid, Museo del Prado © Museo del Prado
272 LETICIA AZCUE BREA
4. Antonio Solá, Daoiz e Velarde, Roma 1830, marmo di Carrara, Madrid, Museo del Prado, in deposito presso il Comune di Madrid, Plaza del Dos de Mayo. © Museo del Prado
tenere a Roma un direttore, utilità che veniva sancita dagli statuti e dal regola-mento del 1830 secondo la risposta dell’Accademia», lamentandosi con ama-rezza. Tuttavia, per questioni di bilancio, nel 1855 32 il governo eliminò la figuradel Direttore dei Pensionati a Roma, e a quel punto Solá richiese il pensiona-mento. Fortunatamente l’incarico venne ripristinato nel 1858 e attribuito alloscultore José Vilches.
Tra i committenti di Solá, l’incarico di due opere da parte dei Torlonia per illoro palazzo di piazza Venezia 33 spinse la Duchessa di Sutherland a ordinareuna nuova versione della Cerere ideata per i Torlonia che poi portò con sé inIn ghil terra 34. Diversi tra questi scultori lasciarono, inoltre, opere loro commis-sionate alla chiesa spagnola di Monserrato a Roma 35.
Come già indicato, a partire dal 1832, giunse la prima generazione di pensio-nati dell’Accademia Reale di San Fernando – Sabino de Medina e PoncianoPonzano – e nel 1833 si unirono ad essi dei pensionati straordinari della Giuntadi Commercio di Barcellona, tra i quali lo scultore Manuel Vilar 36.
Rispetto al mecenatismo spagnolo nell’ambito della scultura a Roma, furo -no pochi i nobili e gli eruditi che si interessarono in maniera specialistica aquest’arte. Fin dagli inizi del XIX secolo, il più importante collezionista di scul-tura fu il maiorchino Cardinale Antonio Despuig (1745-1813) 37 che, con una raf-finata formazione artistica, mise insieme una raccolta di opere di archeologiaclassica oggi dispersa, attribuì incarichi a scultori italiani come Francesco Laz-zerini 38 e assunse lo scultore neoclassico aragonese Pascual Cortés (metà delsecolo XVIII-1814) 39, cui era stata concessa la pensione dal re Carlo III a Roma,città in cui aveva risieduto per più di vent’anni, affinché questi si occupasse didirigere il restauro della sua collezione maiorchina acquistata in Italia.
Cortés collaborò a Roma alla decorazione del Palazzo di Spagna, oltre chead Aranjuez nella decorazione del Palazzetto dell’Aratore. Fu legato al collezio-nista privato spagnolo di scultura classica più importante della fine del XVIIIsecolo, José Nicolás de Azara, di cui fece il monumento funebre. Fu inoltreAccademico di San Fernando e Scultore di Camera Onorario.
In Spagna la nobiltà emulò i gusti reali e mise insieme importanti collezionidi pittura, sebbene furono pochi coloro che si orientarono sulla scultura di ar-tisti viventi. Per i collezionisti risultò più facile riunire opere pittoriche e stam-pe per questioni di reperibilità, prezzo, soggetti e materiali.
Lo scarso mecenatismo privato incentrato sulla scultura contemporanea nelprimo trentennio del XIX secolo fu capitanato da Carlos Miguel Fitz-JamesStuart y Silva, VII Duca di Berwick, XII Duca di Huéscar e XIV Duca d’Alba(Madrid, 1794 - Sion, 1835) 40, uno dei grandi collezionisti europei che realizzò ilGrand Tour e acquistò tante opere d’arte da finire quasi sul lastrico. La sua as-sidua passione per l’arte gli valse il titolo di Accademico d’Onore dell’Accade-mia di San Luca a Roma, di Accademico Corrispondente a Firenze e di Acca-demico d’Onore delle Belle Arti di San Fernando 41.
Carlos Miguel iniziò il suo primo viaggio in Italia nel luglio del 1814, accom-pagnatovi dalla madre, la Marchesa di Ariza, che morirà a Firenze nel 1818. Inquesto viaggio contrasse matrimonio a Roma il 15 febbraio 1817 con la siciliana
ROMA E LA SPAGNA, MECENATISMO REALE E PRIVATO DI SCULTURA NELL’OTTOCENTO 273
Rosalia Ventimiglia. Alla ceremonia, tra gli invitati selezionatissimi, assistetterogli scultori Álvarez Cubero e Solá 42 che egli frequentò in diverse serate e con iquali intrecciò un fitto carteggio. Nel 1818 fece ritorno in Spagna da cui ripartìper l’Italia, dove rimase dal dicembre del 1819 al maggio del 1823, come scrissein un diario che purtroppo non vide mai le stampe 43. La sua vita sociale fu si-mile a quella di altri blasonati che intrapresero il Grand Tour, ma senza acqui-sire un carattere pubblico – complici una certa timidezza e discrezione nonchéuna salute cagionevole – nonostante il vincolo che lo legava a grandi persona-lità come la prozia, la Contessa d’Albany, il cui salotto vide passare la crèmedella società del momento.
Nei suoi diari racconta le visite allo studio di Bartolini a Firenze o di Canovae Thorvaldsen a Roma e i suoi incontri con i pensionati Álvarez Cubero eSolá 44, a cui commissionò diverse opere. Si sa che acquistò sculture che non fuin grado di portare con sè a causa della spesa eccessiva in opere d’arte e, persi-no, che fu costretto a vendere diversi pezzi per migliorare la sua precaria situa-zione economica. Avviò un progetto innovativo per finanziare le pensioni di ar-tisti spagnoli a Roma, della cui gestione fu incaricato lo scultore Álvarez Cube-ro 45, cui si fa menzione nel «Giornale Arcadico» 46. Secondo questo progettoCubero doveva occuparsi degli oltre venti pensionati tra il 1818 e il 1821, inviar-ne i lavori a Madrid e selezionare tra loro il destinatario del premio 47. Il Ducapensava di portare a Madrid le opere acquistate nel corso dei suoi viaggi, operedal valore complessivo di due milioni di reali 48 e diede l’incarico nel 1825 di unprogetto di «Galleria di Belle Arti per il Palazzo di Liria» (fig. 7) all’architettoneoclassico di formazione romana Isidro González Velázquez (1765-1840) conla ristrutturazione di un «parcheggio per carrozze» nel giardino del palazzo 49.
Il duca impegnò Álvarez per diversi incarichi ora conservati presso il Palaz-zo di Liria a Madrid. In omaggio alla madre, Mª Teresa de Silva y Palafox,Mar quesa di Ariza, gli commissionò una Testa della Marchesa e nel 1819 un al-tro Ritratto a figura intera, chiaramente legato al modello delle matrone roma-ne e senza dubbio a quello messo a punto da Canova per il ritratto della ma-dre di Napoleone, e un tondo-medaglione del 1817 con il ritratto di profilo del-la Marchesa – più vicino a quello che realizzerà Giuseppe De Fabris per il dilei monumento funerario presso la chiesa di Liria a Valenza. Realizzò inoltre latesta di sua moglie Rosalia verso il 1817-18, una Venere e Cupido che le toglieuna spina nel 1817 e una Venere accovacciata tratta dal modello classico. Gli vie-ne attribuita una copia della testa di Paolina Bonaparte, che però sembra piùprossima al circolo del Canova che alla sua mano. Gli studi specifici degli ulti-mi anni su queste opere sono presenti nella bibliografia più recente segnalatain nota. Vi sono prove che lo scultore lavorò a due progetti non compiuti: ilSepolcro di Bernardo di Cabrera, XVII Conte di Modica 50 e la Statua colossale delMaresciallo di Berwick 51.
Fra gli acquisti di scultura, vanno ricordare le varie opere commissionate aLorenzo Bartolini, come, per esempio, una testa di sua moglie Rosalia (fig. 6),busto che appare in un dipinto di Giuseppe Patania, esposto presso la Galle-ria Carlo Virgilio nel 2009, con l’effigie del primo figlio Jacobo, opera che è
274 LETICIA AZCUE BREA
ROMA E LA SPAGNA, MECENATISMO REALE E PRIVATO DI SCULTURA NELL’OTTOCENTO 275
7a-b. Isidro González Velázquez, Progettoper la Galleria di Belle Arti in unedificio dietro il Palazzo Liria, 1825,Madrid, Museo de Historia
stata rintracciata e catalogata da Stefano Grandesso 52.Quanto agli incarichi del Duca a Solá, fra questi spicca la magnifica statua
di Meleagro (fig. 5, tav. XV) 53. Tra altri incarichi privati che realizzò Solá vi fu-rono il Monumento funerario al Cardinale Pedro de Quevedo, del 1835, nella Ca-tedrale di Orense, il monumento funerario presso la Certosa di Bologna per ilRettore del Collegio di Spagna a Bologna deceduto nel 1821, Simón RodríguezLasso. L’artista scolpì inoltre il Monumento a Manuela Gutiérrez Estrada nellaCattedrale di Mérida in Messico e il mausoleo del «Marchese Buttori» pressola Certosa di Ferrara 54. Sia Solá che Valeriano Salvatierra ricevettero incarichidi altri nobili in Spagna: tra di essi, presso Boadilla del Monte a Madrid, Soláportò a termine verso il 1839 il Sepolcro del Duca di San Fernando di Quiroga 55
e Salvatierra quello della cognata, la Contessa di Chinchón, deceduta a Pariginel 1828 56. Salvatierra – intermediario in alcuni acquisti dell’infante Don Seba-stián Gabriel verso il 1830 – aveva già scolpito nel 1824 la figura in preghiera diun altro cognato, il Cardinal Luis Mª de Borbón y Vallabriga, presso la Catte-drale di Toledo, un’opera molto vicina ai modi canoviani 57. Come altri nobiliviaggatori per l’Italia, il Duca incaricò a Firenze Santarelli di diversi ritrattiniin cera: di sé (fig. 9), della madre e della sorellastra, dei quali esistono altre ver-sioni a Firenze 58. Inoltre, e fra altre sculture, la moglie del Duca commissionòa Caniglia un ritratto del suo primo figlio come Cupido, una formula iconogra-fica di ritratto assai ricorrente nella ritrattistica contemporanea.
ROMA E LA SPAGNA, MECENATISMO REALE E PRIVATO DI SCULTURA NELL’OTTOCENTO 277
5. Antonio Solá, Meleagro, 1818,marmo, Madrid, Fondazione Casa di Alba, Palazzo di Liria © José Luis Municio
6. Lorenzo Bartolini. RosaliaVentimiglia, sposa del XIV Duca di Alba, 1819, marmo, Madrid,Collezione dei Duchi di Alba © José Luis Municio
Un altro dei mecenati privati spagnoli certamente degno di nota, che com-prò ed esibì con orgoglio l’opera di scultori ottocenteschi spagnoli e italiani, fuJosé de Salamanca, Marchese di Salamanca (1811-1883), forse l’imprenditore el’uomo politico più ricco del secolo in Spagna, un personaggio che emulò lanobiltà acquistando centinaia di opere d’arte per i suoi palazzi a Madrid e aCarabanchel, dove amava celebrare feste lussuosissime e dove era ospitata unaspettacolare collezione di scultura classica e dell’epoca. Questi acquistò operea Roma, dove possedeva una residenza, e durante le vendite di eredità giacentidi nobili spagnoli, sculture della bottega del Canova, di Scipione Tadolini, diPietro Tenerani ecc. o di spagnoli attivi a Roma come José Vilches 59.
All’interno del panorama del collezionismo spagnolo, sebbene in un quadrodi rapporti che coinvolgono anche scultori italiani e francesi, va segnalata an-che la figura di Alejandro Mª Aguado, Marchese (de las Marismas) delle Palu-di del Guadalquivir (Siviglia 1784 - Gijón 1842), uno dei banchieri più ricchidell’Europa del momento, francese d’adozione, che acquistó nel 1839 la primaversione della Maddalena penitente del Canova nell’asta della collezione Som-mariva, acquistata dopo la sua morte dai Duchi di Galliera 60.
278 LETICIA AZCUE BREA
8. Jerónimo Suñol, Dante,Roma, 1864, bronzo,Madrid, Museo del Prado© Museo del Prado
A partire dal 1832 giunse a Roma la prima generazione di pensionati dell’Ac-cademia Reale di San Fernando che comprendeva artisti come Sabino de Medi-na e Ponciano Ponzano, operanti sotto la direzione di Antonio Solá. Secondole prescrizioni accademiche i pensionati dovevano inviare ogni anno dei lavoriobbligatori, e ho scelto quest’invio di Sabino di Medina del 1836 Euridice mor-sa dalla vipera che senz’altro è stato ispirato ai maestri, in questo caso a Loren-zo Bartolini. Dal 1858 José Vilches diviene Direttore dei Pensionati, e sarà lui ascolpire la Tomba di Antonio Solá nella chiesa di Monserrato in Roma 61.
Dal 1856 lo Stato prese a svolgere la funzione di “mecenate” dei pensionati aRoma, poiché a partire da quell’anno si convocò l’esposizione nazionale diBel le Arti a Madrid e, con cadenza biennale, le diverse generazioni dei pen-sionati poterono presentare le proprie creazioni in gesso; si trattava delle con-segne di rigore degli ultimi anni del pensionato che non erano più copie diopere classiche, bensì composizioni originali. Le sculture premiate in questicertamen – opere dei pensionati così come sculture premiate di altri artisti –passavano ad essere realizzate nel materiale definitivo, entrando poi nel MuseoReale di Pittura e Scultura dove venivano esibite in sale specificamente dedi-
ROMA E LA SPAGNA, MECENATISMO REALE E PRIVATO DI SCULTURA NELL’OTTOCENTO 279
9. Giovanni Antonio Santarelli,Carlos Miguel Fitz-James Stuart,XIV Duca de Alba, 1818, ritrattinoin cera, Madrid, FondazioneCasa di Alba, Palazzo di Liria© José Luis Municio
280 LETICIA AZCUE BREA
10. José Álvarez Cubero, Giovane con il cigno, 1808-1817, marmo di Carrara, Madrid, Museo del Prado
cate alla scultura 62. Molte delle opere eseguite a Roma che vinsero il premio edoggi appartenenti al Museo parteciparono in seguito a diverse esposizioni in-ternazionali. Grazie a questo meccanismo di acquisizione, praticamente tuttele generazioni di pensionati a Roma sono rappresentate con diverse operepresso il Museo 63, a riprova che le sale del diciannovesimo secolo al Museo delPrado sono, in realtà, una panoramica sul lavoro romano trasportato a Madrid.
NOTE
1 U. PESCI, I primi anni di Roma capitale (1870-1878), Firenze 1907, pp. 441 e 447. «Numerosa erala colonia degli artisti spagnoli, perché anche prima di aver costruito l’edifizio dell’Accademia di Spa-gna al Gianicolo, il governo di Madrid pagava a vari giovani sulle rendite degli stabilimenti spagnoli aRoma delle pensioni di 3 o 4000 lire, più 1000 lire d’indennità di abitazione... I pensionati spagnoliperò, anche prima della costruzione della nuova Accademia potevano sempre disporre di alcune saledel Palazzo di Spagna per le esposizioni collettive ed anche individuali dei loro lavori». B. CACCIOTTI,Il ruolo dell’Accademia di Spagna nel milieu internazionale del Gianicolo, in Intorno a Villa Sciarra.I salotti internazionali sul Gianicolo tra Ottocento e Novecento, Atti del convegno, Roma, 3-5 marzo2005, a cura di C. Benocci, P. Chiarini, G. Todini, Roma 2007, pp. 109-127.
2 A causa del limitato spazio a disposizione si omette la maggior parte dei riferimenti d’archivioche si possono trovare nelle ultime pubblicazioni citate nel testo, così come la bibliografia meno ag-giornata. Desidero ringraziare Federica Foscarina Simone per il suo aiuto nella traduzione in italiano.
3 Carlos IV (Portici, Napoli, 1748 - Roma 1819) andò in esilio a Roma in 1812 dove visse e morì.Carlos IV Mecenas y coleccionista, catalogo della mostra a cura di J. Jordán di Urries de la Colina, J.L.Sancho, Madrid, Palacio Real, 23 aprile - 19 luglio 2009. Ferdinando VII (El Escorial, Madrid 1784 -Madrid 1833). Napoleone nominò re di Spagna suo fratello Giuseppe che vi regnò come José I fino al1813.
4 Cito, a titolo d’esempio, il cenotafio della seconda consorte di Ferdinando VII sul quale interven-nero diversi pensionati, cfr. G.A. GUATTANI, Pompa Funebre per le solenni esequie di Maria Isabella diBraganza Regina delle Spagne, e delle Indie fatte celebrare in Roma da S.M.C. l’Augusto Consorte Ferdi-nando VII, Roma 1820, p. XIII.
5 A. Riera i Mora, La formació dels escultors catalans: l’ensenyament de l’Escola Gratuïta de Dibuix iels pensionats a Madrid i Roma (1775-1815), Barcellona 1994. Tesi inedita.
6 Tra il 1826 e il 1831 entrarono le opere dei pensionati romani Álvarez, Barba e Solá; Barba e Sal-vatierra tra gli altri ricevettero incarichi per la decorazione dell’edificio del Museo. I. ROSE-DE VIEJO,La primera exposición de esculturas celebrada en el Real Museo de Pinturas, in «Archivo Español de Ar-te» LXXVIII, 309, 2005, pp. 59-69. L. AZCUE BREA, El ornato exterior del Museo del Prado. Un pro-grama escultórico inacabado, in «Boletín del Museo del Prado», 2012 (in corso di stampa).
7 L’idea di Firenze: temi e interpretazioni nell’arte straniera dell’Ottocento, Atti del convegno,Firenze, 17-19 dicembre 1986, a cura di M. Bossi, L. Tonini, Firenze 1989, p. 9. Nell’introduzioneFrancis Haskell ignora completamente la Spagna: «Quei viaggatori che, nel corso del XIX secolo,vennero in Italia dalla Francia, dall’Inghilterra, dalla Germania, dagli Stati Uniti, per trascorrervi po-che settimane o per stabilirvisi per il resto della loro vita». M. BARRIO OGAYAR, Relaciones culturalesentre España e Italia en el siglo XIX. La Academia de Bellas Artes, Bologna 1966.
8 L. AZCUE BREA, Roma y la escultura del siglo XIX en el Museo del Prado. La odisea de los pensio-nados, in El Taller Moderno. I Congreso internacional de Museos con colección de escultura, Atti delconvegno, Valladolid, 3-5 maggio 2010, Valladolid 2012, pp. 218-222.
9 M. BRU, La Academia Española de Bellas Artes en Roma, (1873-1914), Madrid 1971. L. AZCUEBREA, La escultura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Catálogo y Estudio, Madrid1994, capitolo introduttivo. AZCUE, Roma en la scultura... cit.
10 C. BROOK, Storia di una presenza: gli artisti spagnoli a Roma nella prima metà dell’Ottocento, in«Ricerche di Storia dell’Arte» 68, 1999, pp. 17-30.
11 Documentazione raccolta presso l’Accademia di San Fernando, compilata da M. Barrio Ogayar,Antonio Solá y la Academia de Bellas Artes, Madrid, 1966, tesi di dottorato inedita, pp. 9, 14 che ana-lizza i precedenti del ruolo di Solá come Direttore dei Pensionati artistici.
12 Madrid, Archivio dell’Accademia di San Fernando (d’ora in poi ASF), 50-3/2, y 48-2/1. Barrio,
ROMA E LA SPAGNA, MECENATISMO REALE E PRIVATO DI SCULTURA NELL’OTTOCENTO 281
Antonio Solá... cit., p. 52. E. NAVARRETE, La Academia de Bellas Artes de San Fernando y la pintura enla primera mitad del siglo XIX, Madrid 1999, p. 278. José Aparicio li difese in uno scritto del 22 giu-gno del 1816.
13 (Priego, Córdoba 1768 - Madrid 1827). BROOK, Storia di una presenza... cit. Si vedano le schededi L. Azcue Brea, in El siglo XIX en el Prado, catalogo della mostra, a cura di J.L. Diez, J. Barón, Ma-drid, Museo del Prado, 30 ottobre 2007 - 20 aprile 2008, pp. 338-401, 466-467. R. FERNÁNDEZ, JoséÁlvarez Cubero, figura cumbre de una saga de alarifes, escultores, Córdoba 2011, pp. 57-430.
14 (Moratilla, Murcia 1767 - Madrid, 1831). E. PARDO CANALÍS, Estancia en Roma del escultorRamón Barba, in «Revista de Ideas Estéticas» 97, 1967, pp. 45-64. J.L. MELENDRERAS, Dos escultoresmurcianos en la Corte: Alfonso Giraldo Bergaz y Ramón Barba Garrido, in «Anales de la Universidadde Murcia», 43, 1984, pp. 247- 260. AZCUE, El ornato exterior... cit.
15 (Toledo, 1788 - Madrid, 1836). «Memorie enciclopediche romane sulle belle arti, antichità etc.»,IV, in Catalogo degli artisti stabiliti, o attualmente dimoranti in Roma..., p. 151: «Salvaterra Valeriano.Opere diverse». G. HUBERT, La sculpture dans l’Italie Napoléonienne, Paris 1964, p. 218. M.C. EGEAMARCOS, Valeriano Salvatierra: vida, obra y documentos sobre un escultor neoclásico, in «Anales de laUniversidad de Murcia», XLI, 1983, pp. 1-79. AZCUE, El ornato exterior... cit. Questi sarà uno degliscultori, autore delle figure allegoriche delle nicchie della facciata del Museo del Prado.
16 (Santa Mª de Corbera, 1769 - Barcelona, 1831), pensionato a Roma tra il 1790 e il 1796, ricevetteincarichi della Giunta di Commercio per la decorazione dell’edificio della Llotja.
17 (Mataró, 1771 - Barcelona, 1855). C. CID PRIEGO, La vida y la obra del escultor neoclásico catalánDamià Campeny i Estrany, Barcelona 1998.
18 (Barcelona 1780 - Roma 1861). Barrio, Antonio Solá... cit.; M. BARRIO OGAYAR, Un escultorespañol en Roma: Antonio Solá, in «Archivo Español de Arte», XXXIX, 1966 pp. 51-84, E. PARDOCANALÍS, La casa y biblioteca del escultor Antonio Solá, in «Revista de Ideas Estéticas», XXV, 1967,pp. 249-272. La Bellesa ideal. Antonio Solà (1780-1861), escultor en Roma, catalogo della mostra a cu-ra di A. Riera i Mora, Barcelona, Museo Frederic Marés, 29 maggio - 8 settembre 2009, prima mostramonografica dedicata allo scultore e che ne ricostruisce la biografia.
19 Almanach aus Rom für Künstler und Freunde der bildenden Kunst, Leipzig 1810, ristampa 1984.«Memorie enciclopediche romane sulle belle arti, antichità etc.», III, p. 145, IV, p. 148. G. BRANCA-DORO Notizie riguardanti le accademie di belle arti, e di archeologia esistenti in Roma ...: opera compila-ta ad uso degli stranieri e degli amatori delle belle arti, Roma 1834, p. 54, «Sola spagnuolo ... sua abita-zione via della Frezza nº 56, Studio 54». C. BROOK. Canova e gli scultori spagnoli del primo Ottocento.La figura di Antonio Solá artista ‘romanizzato’, in Il primato della scultura. Fortuna dell’antico, fortunadi Canova, Atti della 2ª Settimana di studi canoviani, Bassano del Grappa 2000, a cura di M. PastoreStocchi, Bassano del Grappa 2004, pp. 293-308.
20 Madrid, Archivio Storico Nazionale, Sezione Stato, leg. 5768, C-3. Incarico a Canova del 16 gen-naio del 1805. Madrid, Archivio del Ministero degli Affari Esteri. Santa Sede, Leg. 734, exp. 11, eMemoriale del 14 aprile del 1827. Madrid, Archivio Generale di Palazzo, fascicoli personali, cassa63/3, trascritto da E. PARDO CANALÍS, Escultores del siglo XIX, Madrid 1951, pp. 211-212. RIERA, LaFormació dels escultors... cit., pp. 739-748. G. PAVANELLO, Antonio Canova per il re di Spagna, in «Ar-te Veneta», 46, 1994, pp. 72-78. J. JORDÁN DE URRIES, La galería de estatuas de la Casa del Labradorde Aranjuez: Antonio Canova y los escultores españoles pensionados en Roma, in «Archivo Español deArte», 269, 1995, pp. 56-70. ID., La Casita del Príncipe de El Escorial, Patrimonio Nazionale 2006. Sivedano varie schede di Azcue in El siglo XIX en el Prado... cit., pp. 388-390. L. AZCUE BREA, Panora-ma del coleccionismo de escultura moderna en España en el primer tercio del siglo XIX, in Il XIV Ducad’Alba collezionista e mecenate di arte antica e moderna, a cura di B. Cacciotti, Roma, 2011, pp. 41-58.AZCUE, Roma en la scultura... cit.
21 M. MISSIRINI, Della vita di Antonio Canova, Prato 1824, II, p. 233. «Li giovani pensionati spa-gnuoli che trovavansi in Roma nell’anno 1809 essendosi mostrati renuenti al giuramento di fedeltà algoverno, che essi stimavano illegittimamente stabilito nella capitale della loro patria, furono dall’armifrancesi fatti prigionieri nel castello di Sant’Angelo. Il Canova infiammato di quel vivo zelo che lo ani-mava a proteggere gli innocenti, e specialmente compagni dell’arte, si recò dal generale governatoreMiollis, e [...] reclamó la loro liberazione, e si espose egli stesso garante per quelli. Li spagnuoli furo-no liberati». FERNÁNDEZ, José Álvarez Cubero... cit. pp. 191-222.
22 «Memorie enciclopediche romane sulle belle arti, antichità», IV, p. 151, «Solar [sic], Antonio,statua di Psiche». L. AZCUE BREA, Il Cavaliere Antonio Solá, escultor español y Presidente de la Acade-mia romana de San Lucas, in «Boletín del Museo del Prado», 2007, pp. 21-25. La Bellesa ideal... cit.
23 Gran parte della sua produzione si trova presso il M.N.A.C. e presso la Real Academia de SanJordi a Barcellona. M. DOÑATE, C. MENDOZA, Guía del Museo de Arte Moderno del Museu Nacionald’Art de Catalunya. Barcelona 1998. P. VÉLEZ, Catàleg del Museu de Llotja. Reial Acadèmia Catalana
282 LETICIA AZCUE BREA
de Belles Arts de Sant Jordi. II-Escultura i medalles, Barcelona 2001.24 La taula de l’Ambaixador el ‘Triomf de taula’ de Damià Campeny, catalogo della mostra a cura di
P. Vélez, Parma, Galleria Nazionale, 23 settembre 1999 - 23 gennaio 2000, Barcelona-Parma 1999.25 Busto di Fernando VII, Giovane con cigno, Diana Cacciatrice, La Difesa di Saragozza, Amore ad-
dormentato e Ritratti seduti delle regine Mª Luisa di Parma e Isabella di Braganza.26 Si veda la scheda José Álvarez Cubero, La Defensa de Zaragoza di L. Azcue Brea, in El siglo XIX
en el Prado... cit., pp. 223-224, 392-397, FERNÁNDEZ, José Álvarez Cubero...cit., pp. 257-267, 288-330.27 ROSE, La primera exposición ... cit. AZCUE, Roma en el escultura... cit.28 Misura del rilievo 11,53 metri di larghezza. AZCUE, El ornato exterior... cit.29 P.E. VISCONTI, Daoiz e Velarde, gruppo colossale scolpito dal Cav. Antonio Solà, Roma 1830.
L. AZCUE BREA, Solá en el Museo del Prado, in La Bellesa ideal... cit., pp. 208-216.30 AZCUE, Il Cavaliere Antonio Solá... cit., pp. 18-31. Il Prado possiede inoltre un bozzetto di Bla sco
de Garay e la Carità Romana del 1851.31 La Bellesa ideal... cit. analizza tutta la biografia.32 NAVARRETE, La Academia de Bellas Artes... cit.33 Cerere e Minerva, Roma 1839. E. DI MAJO, M. LAFRANCONI, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.
Le collezioni II. XIX secolo, Roma 2006, p. 80. H. LE GRICE, Walks through the Studii of the sculptorsat Rome with a brief historical and critical sketch of sculpture, Roma 1841, pp. 85-87. AZCUE, Il Cava-liere Antonio Solá... cit., p. 24. La Bellesa ideal... cit., p. 170.
34 J.B. HARTMANN, La vicenda di una dimora principesca romana. Thorvaldsen, Pietro Galli e il de-molito Palazzo Torlonia a Roma, Roma 1967, p. 24. Riera, La Formació dels escultors... cit.. La «Revistade Madrid» diceva di questa Cerere nel 1844 «della quale è stata privata la Spagna dalla Duchessa diSutherland». AZCUE, Il Cavaliere Antonio Solá... cit., pp. 24-25 ha rintracciato l’opera nel 1983, dete-riorata a Trentham Hall.
35 M.S. LILLI, Aspetti dell’arte neoclassica: sculture nelle chiese romane, 1780-1845, Roma 1991.36 Cfr. nota 63 che elenca tutte le generazioni di pensionati dell’Accademia.37 Esiste un’ampia bibliografia su questo personaggio, a partire da J.M. BOVER, Noticia histórico
artística de los museos del eminentísimo Sr. Cardenal Despuig, Palma 1845.38 L. PASSEGGIA, Lo studio Lazzerini. Viaggio a Carrara in tre secoli di storia, Carrara 2011.39 J.L. MELENDRERAS, El escultor neoclásico aragonés Pascual Cortés, in «Boletín del Museo Camón
Aznar», LII, 1993, pp. 163-168.40 Il XIV Duca d’Alba... cit. che raccoglie tutta la bibliografia, e in particolare il saggio dell’autrice
Note sulla vita di un collezionista, pp. 79-102. Come collezionista di scultura L. AZCUE BREA, Unaaproximación a la colección de escultura de la Casa de Alba, in Colección Casa de Alba, catalogo dellamostra a cura di V. Muñoz, I. Hermoso, Siviglia, Museo de Bellas Artes, 15 ottobre 2009 - 10 gennaio2010, Sevilla 2009, pp. 176-217. L. AZCUE BREA, Catalogo de esculturas modernas, in Il XIV Ducad’Alba... cit., pp. 317-342.
41 B. CACCIOTTI, Viaggiatori spagnoli in Italia. I Diari di viaggio di don Carlos Miguel, VII Duca diBerwick e XIV d’Alba, in Turismo culturale in Italia fra tradizione e innovazione, Atti del convegno,Roma, 6-8 novembre 2003, a cura di A. Pasqualini, Roma 2005, pp. 119-140. Si veda la scheda diB. Cacciotti, Fitz James Stuart y Silva, Carlos Miguel, in Diccionario biográfico español, Madrid 2011.Il XIV Duca d’Alba... cit.
42 Archivio della Duchessa d’Alba, Palazzo di Liria, Madrid (d’ora in poi A.D.A.), C. 345-11 e 345-9, p. 42.
43 Le fonti per conoscere i suoi interessi e le acquisizioni sono i suoi diari: Diario de los viajes porEuropa del duque Carlos Miguel 1814-1818 e Diario de los viajes del duque don Carlos Miguel porFrancia, Italia, España, 1818-1823.
44 A.D.A., C 345-10 y C 345-12. L. AZCUE BREA, La escultura italiana del siglo XIX y el coleccioni-smo privado en Madrid (I). A. Tadolini y L. Bartolini, in «Boletín de la Real Academia de Bellas Artesde San Fernando», 106-107, 2008, pp. 83-129, in particolare p. 86: «andò allo studio di Antonio Ca-nova il 24 maggio e l’11 ottobre del 1815 a quello di Álvarez, si recò poi all’atelier romano di Thor-valdsen il 21 giugno del 1817 e il 20 febbraio del 1818 visitò gli studi degli ‘artisti cui aveva incaricatodelle opere a Napoli’, e si trovò di nuovo a Roma con gli scultori Canova, Álvarez e Solá il primo mar-zo del 1818. Il 24 dicembre del 1819 andò a Roma agli ‘studi di tutti gli artisti che conoscevo che ave-vano delle opere per me’ e il primo aprile del 1820, un Sabato Santo, andò ‘a vedere gli artisti che la-vorano per me’. A Firenze il 2 ottobre del 1817 entrò, probabilmente per la prima volta, nell’atelierdello scultore Lorenzo Bartolini che poi visitò in diverse occasioni». L. AZCUE BREA, I contatti di Bar-tolini con la Spagna e il Portogallo, in Lorenzo Bartolini, scultore del bello naturale, catalogo della mo-stra a cura di F. Falletti, S. Bietoletti, A. Caputo, Firenze, Galleria dell’Accademia, 31 maggio - 6 no-vembre 2011 (prorogata all’8 gennaio 2012), Milano 2011, pp. 97-109.
ROMA E LA SPAGNA, MECENATISMO REALE E PRIVATO DI SCULTURA NELL’OTTOCENTO 283
45 A.D.A., 197 20, Duque de Alba, Discurso del Señor Duque de Berwick y de Alba leído en su recep-ción en la Real Academia, Madrid, 1924, p. 70: correspondenza tra i due datata 30 novembre 1821[tradotto dello spagnolo]: « Mio carissimo Álvarez, allo scopo di promuovere lo studio delle Belle Ar-ti i giovani che menziono nell’ordine allegato, ho deciso di istituire una sorta di pensione o accade-mia, della quale sono certo Lei avrà la bontà d’incaricarsi di dirigere e pagare, prelevando mensilmen-te dal mio banchiere l’ammontare di 26 scudi che distribuirà a ciascun borsista secondo quanto dettail presente comunicato. La ringrazio anticipatamente in nome dell’amicizia che mi lega a Lei. IL DU-CA».
46 J. GARCÍA SANCHEZ, El proyecto museográfico del Duque, in Il XIV Duca d’Alba... cit., pp. 201-210.47 Nel novembre del 1821 erano pensionati a Roma diversi giovani pittori, scultori e incisori e nel
suo progetto di Accademia, intendeva «proteggere i concittadini che sentissero il desiderio di perfe -zionarsi nella formazione in Belle Arti», Duque De Alba, Discurso... cit., pp. 12-13.
48 A.D.A. C. 196.17. Fitz, 1924, p. 12 e 14. AZCUE, Una aproximación... cit., pp. 191-192 e incisione.49 Isidro Velázquez, 1765-1840: arquitecto del Madrid fernandino, a cura di P. Moleón, Madrid 2009,
pp. 512-513. Dibujos en el Museo de Historia de Madrid: Arquitectura Madrilena de los siglos XIX yXIX, a cura di C. Priego, Madrid 2010, pp. 50-53. GARCÍA, El proyecto... cit. FERNÁNDEZ, José ÁlvarezCubero... cit. Il disegno intitolato Galeria de Bellas Arts sobre las traseras del Palacio de Liria, con dueparti, Secciones y alzado al jardín bajo y plazuela de Palacio e Alzado al jardín alto y a la Casa del Duen-de si trova nel Museo di Storia, Madrid, e presenta la facciata decorata nelle nicchie e rifinita consculture.
50 A.D.A 197.44, Nota, 1817: «en poder del Sr Josef Albarez, escultor de Camara de S.M.».51 A.D.A. C. 159-1, Inventario de Estatuas: «Rome 19 Juin 1817 Modele de la Statue du Grand Ma-
rechal de Berwick (pour être coulée en bronze)». A.D.A 197.44, Nota sobre las estatuas, 1817, «in po-tere del Sr Josef Albarez, Scultore di Camera de Sua Maestà... Il modello della Statua colossale delMaresciallo di Berwick in gesso, per lo stesso [Solá], 30.000 rs vn».
52 Si veda la scheda di S. Grandesso in Quadreria 2009. Dalla bizzarria al canone: dipinti tra Seicen-to e Ottocento, catalogo della mostra a cura di G. Capitelli, Roma, Galleria Carlo Virgilio, aprile - giu-gno 2009, pp. 58-59. Gli altri incarici a Bartolini in AZCUE, I contatti di Bartolini ... cit. e J. GARCÍASANCHEZ, I circoli artistici e la collezione di dipinti e sculture, in Il XIV Duca... cit., pp. 131-196.
53 La Bellesa ideal... cit., p. 162.54 Il primo in Ibid., p. 164. Il secondo in J. VILLALBA, Viaje artístico por Italia en 1819-1820, in «La
España moderna», 22 agosto 1910, p. 101. C. TOMASI, Cimitero di Ferrara, 1892, (tomba di Buttori diSolá?).
55 Joaquín José Melgarejo si sposò con Ma Luisa, una figlia dell’Infante Luis Antonio di BorboneFarnese, fratello del re Carlos III.
56 Un’altra figlia dell’Infante don Luis di Borbone fu Ma Teresa Josefa de Borbón y Vallabriga, XVContessa di Chinchón, moglie di Manuel Godoy. EGEA, Valeriano Salvatierra... cit.
57 Altri busti dello scultore in AZCUE, La escultura en la Real Academia... cit., pp. 396-399.58 AZCUE, I contatti di Bartolini... cit. p. 98.59 L. AZCUE BREA, La escultura italiana del siglo XIX en Madrid y el Coleccionismo privado. II, in
«Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando», 108-109, 2009, pp. 141-192, in parti-colare pp. 150-161, «antigua colección del Marqués de Salamanca».
60 AZCUE, Panorama del coleccionismo... cit., pp. 54-58, ne studia la vita e le collezioni di scultura,non di molto estesa ma di altissimo interesse.
61 E. TORMO Y MONZÓ, Monumentos de españoles en Roma, y de portugueses e hispano-americanos.I, Madrid 1942. J. FERNÁNDEZ ALONSO, S. Maria di Monserrato (Le chiese di Roma illustrate, 103),Roma 1968, pp. 103-106. ID., Una realtà nazionale composita: comunità e chiese «spagnole» a Roma, inRoma capitale (1447-1527), Atti del IV convegno di studio del Centro Studi sulla Civiltà del TardoMedioevo, San Miniato (Pisa), 27 - 31 ottobre 1992, a cura di S. Gensini, Ospedaletto (Pisa) 1994,pp. 473-491.
62 L. AZCUE BREA, Los orígenes de la colección de escultura del Museo del Prado. El Real Museo dePintura y Escultura, in El Taller Moderno... cit., pp. 225-234.
63 AZCUE, Roma en la escultura... cit. Vi sono opere di Sabino de Medina e di Ponciano Ponzano,che ricevettero il pensionato artistico nel 1832, di José Pagniucci e Andrés Rodríguez, pensionati nel1848, di Felipe Moratilla, pensionato nel 1855 sebbene fosse a Roma già da due anni, di José Vilchesche viaggiò a Roma con mezzi propri diventando poi Direttore dei Pensionati, di Juan Figueras, cheottenne due pensioni, una nel 1858 e l’altra nel 1873, di Elías Martín Riesco pensionato nel 1861, diJerónimo Suñol pensionato dalla Giunta di Barcellona en 1864 (fig. 8), o Ricardo Bellver nel 1870.Nel 1881 venne inaugurata la sede permanente del Gianicolo.
284 LETICIA AZCUE BREA