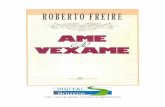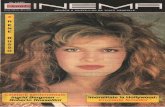Roberto Bossaglia e Roma. Periferie / Peripheries
Transcript of Roberto Bossaglia e Roma. Periferie / Peripheries
ROBERTO BOSSAGLIA
PERIFANIE ROMA: APPUNTI SUL NUOVO PAESAGGIO URBANO
SCRllTI DI
FRANCESCO FAETA, MARINA Ml RAGLIA, FRANCESCO M OSCHINI
o EDIZIONI MPPA
Design & Editing: Studio Mariano
Volume realizzato con il contributo dell'lsli tuto Italiano di Cultura di Edinburgo in occasione della mostra fotografica «Peri fanie» curata da Onofrio Speciale, e tenutasi presso la sede dell 'Istituto dal 26 luglio al 15 settembre 1995 nel programma delle manifestazioni espositive per il Festival di Edinburgo.
Traduzioni di Brian Phillips
© Copyright per le fotografie Roberto Bossaglia
© Copyright 1995 by Edizioni I<appa, Piazza Borghese, 6 - Roma - Te/. 06 /6790356-273903 ISBN 88-7890-180-6
INDICE
CONTENTS
) PREMESSA
FOREWORD
7 I MMAGINE E REALTÀ, UN EQUILIBRIO INSTABILE
lMACE AND REALITY: AN UNSTABLE EQUILIBRIUM MARINA MIRAGLIA
LE ARCHITETTURE E IL CIELO. IMMAGINI DI UN SITO POST-MODERNO
ARCHITECTURE AND THE SKY. lMAGES OF A POSTMODERN SITE FRANCESCO FAETA
2 ) PERIFERIE
PERIPHERIES FRANCESCO MOSCHINI
f l) REGESTO
REGESTES
7 B IOGRAFIA
BIOGRAPHY
PERlFERlE
PERIPHERlES
FRANCESCO M OSO·IINI
l testi sulla periferia sono quasi sempre stati, solitamente, un esclusivo genere di contributi della cultura architettonica e storica ai problemi della costruzione e della definizione della ciltà e della sua periferia. Ma è forse opportuno sottolineare come certi modelli urbani, si pensi alla megalopoli teorizzata da Gottman, si siano scontrali con una realtà meglio interpretata dalla leneraLura, e più ancora dai mass media, che non dall'urban istica come disciplina. Ciò dipende dai presupposti (normativi, istituzionali, ecc.) nell'ambito dei quali questa disciplina si muove e, insieme, dalla frattura stabili tasi tra pian ificazione e progeuazione dello spazio fisico. Caduti i presupposti ideologici dei «piani» tradizionali, la strada oggi più realisticamente praticabile ci sembra quella suggerila dall'Idea di Venezia per come viene interpretala e letta nel dibattito più recente. La strategia sottesa a questo dibattito in corso, indica un diverso metodo di lavoro «libero da ogni specie di pregiudizio o schematismo precostituito, capace di mobilitare e organizzare su questioni insieme concretissime e cU grande respiro culturale forze di diversa estrazione e competenza». (Massimo Cacciari). li panorama che sembra delinearsi appare più articolato di quanto vorrebbe la consolante suddivisione in «centro» e «periferia». È forse opportuno poi distinguere, nell'ambito della vasta leueratura che meue a fuoco caraLteristiche e problemi della periferia, quei testi (istitutori) che la «fondano» in quanto luogo fisico, da quelli (commentatori) che ne riOeuono l'esistenza in quanto data come oggettiva e, quindi, indiscutibile rappresentazione della realtà. Tra i primi ritengo debba rientrare una serie limitata di opere, sia leuerarie sia sociologiche, che si sono trovate a indagare un fenomeno di crescita urbana del tuuo originale e a proposito del quale già ai primi del Novecento è pos-
25
Studies of city perip/1eries have nearly always been exclusively devoted lo the consideration in architectural and historical terms of problems concerning building and the definilion of cities and their outskirts. But il is perhaps worth pointing out thal certain urban models (e.g. the megalopolis as the0tised by Gottman) have come up againsl a realily which has bee11 beller interpreted by literalure - and better stili by the mass media - than by lhe discipline of planning. This is partly because of the assumplions (regulalions, inslitulional factors etc.) on which planning is based, and also because of the spliL which has occurred between planning and design in relalion lo the physical spaces concemed. Now thai the ideologica/ assumplions underlying tradilional "plans" have been abandonecl, il seems that the most praclical ancl realistic route to Jollow is that suggested by the "Idea of Venice", as il has been unclerstooc/ and interpretec/ in most recenl discu.ssions. Underlying the currenl debate is a strategy which points Lo a differenl method of work: one whiclt is 'free of any hind of preestablishecl prejudice or Jormalism, and ccm gather together and apply elements Jrom a variety of sources and disciplines lo qu.eslions which are both very concrete ancl of broad cultura/ significance" (Massimo Cacciari). The picture wltich we are beginning lo discern is thus more complex than the convenienL subdivision into "centre" ancl "periphery" woulcl suggesl .. Within the sphere of Lhat vast literature which Jocuses on Lhe characterislics and problems of pe,ipheries, il is perhaps worth mahing a dislinclion between 'founding" texts which establish the physical existence of the periphe,y and "comme11ta1ies" which assume its existence c,s an objective fact and hence c,s an incontrovertible representalion of reality. The first of Lhese, in my opinion, must include that limitecl group of litera,y and sociologica/ works which sou.ght Lo investigate what was a quite new phenomenon in urban
sibile parlare di «metropoli» secondo l'auuale accezione. Per quanto riguarda i secondi, invece, si tratta di un filone narrativo che si esaurisce agli inizi del Novecento, per riaffiorare nel secondo dopoguerra sulla base di altre drammatiche istanze. In questo secondo gruppo di testi si analizzano le carauerisLiche della periferia, indagandone i parametri spaziali e temporali, senza metterne in discussione la già avvenuta concettualizzazione. La città, declinata in ogni sua fo rma, diviene il «paesaggio» nell 'ambito del quale si collocano queste narrazioni . La leuura storicizzata della periferia, che trovava la propria legittimazione nel pensiero positivista, non è più idonea a rappresentare la silllazione contemporanea. li tema della città per pani, che tanto interesse aveva destato nel corso degli anni Sessanta-Settanta, da ipotesi progeuuale si trasforma in metodologia analitica: da un lato, parzializzato è l'intero territorio, dall 'altro, tale frantumazione si manifesta anche all'interno di più limitate e circoscritte aree metropolitane. La non-linearità dell'abitare metropolitano, già esplorata attraverso la rouura dell'unità di tempo in un'opera come Mrs. Dalloway di Virginia Woolf, così come dell'unità di spazio, che, per esempio, costringe Karl Rossmann a rimanere a New York (dove «c'erano molte cose che [gli I ricordavano la sua patria», benché, nonostante la sua permanenza, «di tuua la ciuà non avesse quasi veduto altro che una strada»), sposta la riHessione sulle nuove relazioni spazio-temporali che definiscono e condizionano l'esperienza metropolitana. Dove «metropoli » è comunque un vocabolo che già non distingue più tra «centro» e «periferia». L'inadeguatezza, non solo critica, ma anche e soprattutto operativa, di quelle analisi che ancora ricercano, nell 'articolazione per aree detemtinate del territorio, la possibilità di mantenere in vita e porre in opera modelli classici di razionalità, emerge particolarmente qualora s i consideri che lo stesso termine «metropoli», che sembrava ipotizzare una crescita infinita culminante nella megalopoli, non appare oggi più convincente. Ciuà, metropoli, megalopoli rimandano infaui, ancora, a una dimensione tradizionale dell'abitare, fondata sui concetti della polis greca e della civilas romana. Sono piuttosto alcune figure retoriche, le forme possibili dell'esperienza metropolitana, la struttura discontinua, e dunque pumiforme, della ciuà, il venir meno dell'esperienza estetica (estatica) a definire le coordinate del nuovo discorso sulla città, che non si vu ole qui esanùnare dal pumo di vista filosofico, quanto seguire auraverso i segni che, nel Sistema dell 'arte, dalla leueratura alla foLOgrafia , imerpretano i fatti esterni, poiché «noi non abbiamo alcun potere di pensare senza segni» (Carlo Sini). la città moderna non è più esprimibile auraverso il disegno
expansion, but one in relation lo which lhe lerm "melropolis" could a/ready be appliecl in ils modem sense as early as the beginning of this century. The seconcl type, on lhe other hand, involves a narrative lradition which d,ied up in lhe early 20th century only lo reappear afte,· the Second World War as a resull of qui te differenl dramatic impulses. This second group of worhs analyses the characleristics of peripheries cmd invesligales Lheir spalial and tempora/ paramelers, but wilhout casling any doubl on the establishecl concepl of the periphe,y The city in ali its forms becomes lhe "landscape" wilhin which lhese narratives are situated. The historical inlerpretalion of pe1iphe1y, however, as legitimised in positivisl lhoughl, is no longer appropriate lo convey the contemporary situalion. The lheme of the cily subclivided inlO various parts - which aroused so nwch interesl in the Si.xlies anci Seventies - now progressed from planning hypothesis Lo analytical methodology. On the one hand, the whole lerritory was seen as divided into parts, and on the other lhis subdivision was also seen as applying to more limited and circumscribecl city areas. The non-linear nature of cily habilalion had already been invesligated using lhe disruplion of the unily of time in worhs lihe Virginia Woolfs Mrs. Dalloway, as il was a/so through that of lhe unity of piace; Jor il was lhe laller which, Jor example, obliged Karl Rossmann to remain in New Yorh ("where there were many things which reminded [fiim] of his own count,y", a/though, in spi te of his residence there, "he lwcl scarcely seen more lhan one slreet in lhe whole cily'). This non-linearity redirected attenlion Lo lhe new space-lime relalionships which defined and conditionecl the experience of living in a metropolis. Bul in this contexl the term "metropolis" a!ready ceases lo dislinguish belween "centre" and "peliphery". The inadequacy in criticai and especially in practical terms of lhose analyses which subdivide territo,y into clifferenl hincls of area but stil! seeh to preserve and apply ralional models of a classica/ lype, becomes parlicu!arly clear when one recalls thal lhe very lerm "melropolis", whicl1 seemed lo suggesL permanenl growth leading lo a megalopolis, is now no longer salisfacto,y. City, metropolis and megalopolis are in Jact terms which rej)ecl a traditional view of habilation, basecl on Lhe concepl of the Greeh polis a nel lhe Roman civitas. The co-ordinates of Lhe new view of lhe cily are rather lo be Jound in certain rhelo1ical figures, in ali the possible Jorms of che metropolitan experience, and in the disconlinuous and therefore punctiform slruclure of the city. Il is not my intenlion here to examine lhese matters Jrom a philosophical poinl of view, but rather lo lrace them through those signs which are used wilhin art systems,Jrom literature lo pholography, to interpret external Jacts -Jor "we have no power to thinh wilhoul signs" (Carlo Sini). 11 is no longer possible lo convey the moclern cily by lracing its topography. lnslead one has lO use mnemonic subclivisions of its Jorm· "the city only appears to be uniform. Even ils name sounds differenl in
26
dei suoi luoghi (lOpografia), bensì attraverso una mnemonica articolazione per punli ; «la città uniforme soltanto in apparenza. Perfino il suo nome assume suoni differenti nei diversi quanieri» (Walter Benjamin). Ed è proprio quanlo sembrano suggerire le rolOgrafie di R. Bossaglia nella sua ricerca sui bordi estremi della città di Roma, in cui prendono corpo quei patetici giardinetti attrezzati, quegli elementi di misurazione del paesaggio costiLUiti dai pali e dai fili della luce, quegli eccessi visivi daLi dai prorompenti Labelloni pubblicitari, la ripetizione seriale dei cassonetti che s i moltiplicano all'infiniLo, i rarefalli segni di un ordine civile e urbano costituiti dalle rare strisce pedonali, quei ricettacoli della solitudine costituiti dalla virtualità domestica delle porte dei campi di calceuo appena tracciati nell'aria da esili tralicci senza nemmeno le spoglie della rete, quei grappoli di case che divorano il verde apparentemente incommensurabile ma già invece Lutto compromesso dalla caoùcità di quei pochi spettrali alberi colti nella loro pura struttura osteologica o dai grovigli di una disordinata segnaletica e dalle improbabili ed inquietanti presenze di panchine per la seduLa, divani abbandonati, cancelli che né aprono né chiudono, roulottes per impossibili viaggi che non si sposteranno mai da lì. Pochi gli elementi di figura e di misura che diano il senso di una vagheggiata magnificenza civile come nostalgia della città: qualche rudere archeologico, qualche reperto della modernità, laconici silos e presuntuose recinzioni, maniloquenli pennoni e relaLive bandiere che sottraggono alle ferventi gru della «città che sale» e agli arei Lralicci dell'alta tensione il decoro a festa di una festa che comunque non si consumerà mai. L'idea di limite , così univocamente determinata nella città classica, come pure nell'urbanistica moderna, diviene, da luogo fisico, esperienza; «in nessuno luogo - se non nei sogni - il fenomeno del confine può essere esperito in forma così originale come nella città [ .. . I. Come soglia il confine passa attraverso le strade, il nuovo territorio ha inizio come un passo nel vuoto» (W. Benjamin). In questo senso «pensare il moderno è pensare il limite» (Franco Rella). La città topologica non è una città per parti , ma una città frammentaria nella quale ogni frammento è una monade chiusa in se stessa. Se lo spazio, come il tempo, è discretum, l'unica sintesi possibile è il racconto, la mediazione narrativa. La città si rappresema attraverso figure. D'altra parte l'evoluzione tecnologica nel settore dell'elaborazione e trasmissione d i in formazioni interessa ed esalta la città topologica, fornendole lo statuto scientifico. A questa condizione corrisponde la perdita del concetto di «luogo» e dunque ha termine ogni possibile rappresentazione, nel senso che la cosa
ils differenl districts" (Walter Benjamin). And that is precisely what Bossaglia's photographic invesLigation of the outer edges of the city of Rame seems to suggest. Here we find pathetic little well-equipped gardens, power lines ancl poles which measure out the lanclscape, the visual excesses of brash adverlising hoardings, Lhe endless rows of public rubbish bins, the occasionai signs of civil ancl urban arder provided by rare pedestrian crossings, those repositories of solitude Lo be found in homely mini-football fields where slender goalposts rise inlo the air wit/10ut a shred of nelling, groups of houses devowing a green landscape wlwse apparently endless expanse is in f acl cornpletely undermined not only by a disorderly scattering of skeletal trees conveyed in ali their osteologica! structure buL a/so by clumps of disorderly road signs and the unlikely and disturbing presence of benches Lo sil on, abandonecl divans, gates thal cannot be opened or closed, and caravans far impossible journeys that will never leave the spot they stand on. Items to provide a measure and sense of yearnedfor civic grandeur and a nostalgia far the city, are few i.n number: a few archaeological remains, a few signs of modernity in the f orrn of laconic slorehouses and presumptuous fencing, grandiose Jlagstaffs and Jlags that deprive the "rising city's" bustling cranes and lofty power pylons of festive dignity far a festive occasion - which in any case will never actually occur. In the classica/ city, the idea of border is conveyed unequivocally, but here il ceases to be a physical enlity and becomes an experience: "nowhere - excepl in dreams - can the phenomenon of border be found in such an 01iginalform as in the city [. .. J Like a threshold, the border crosses roads, and tlte new territory begins like a step into the unknown" (W. Benjamin). In this sense "to thinh about the modern is to thinh in Lerms of border" (Franco Rella). The topological city is nota city of different parts, but a f ragmentary city in which each fragmenl is a self-conlained monad. lf space and time are discrete, the only possible synthesis of the two lies in stories, in the mediation of narrative. The city has to be represented figuratively. On the other hancl, Lechnological clevelopments in the processing and dissemination of informalion involve and exalt the topologica/ city, providing il with a scientific justification. Such a state of affairs coincides with the loss of the concepl of"place" and so brings to an end any possible representalion of il, in the sense that things as such become subordinate lo the relationships between them, and time takes on Lhe expression of passage as its p1imary function: "What is importanl is not this appeal of the hour, which strikes at the same moment far eve,yone, but the relationship which Lhe various protagonists establish with the signs of Lime" (Paul Ricoeur). The telematic city is thus an invisible city, a visi.on of angels. Only abstract points in it can be identified,Jor it is malhematical, not geometrica I. "lt is nol a matter of a real techno-city, because the Lechno-city is no longer representable. True technology travels th rough non-represenLaLion, that is Lo say
17
viene posLa in secondo piano rispeuo alle relazioni che legano le cose fra loro e aLLribuisce al Lempo una funz ione primaria in quanto ne esprime il Lrascorrere; «l'imponame non è questo richiamo dell 'ora, che suona contemporaneamente per Lutti, ma il rappono che i d iversi protagonisti stabiliscono con i segni del Lempo» (Paul Ricoeur). La città telematica è allora la ciuà invisibile, la visione degli angeli, deUa quale è possibile individuare solo punti astratli, ciu à matematica e non geometrica. «Non si traua della tecno-city reale, poiché la Lecno-ciuà non si rappresenta più. La vera tecnologia passa auraverso la non-rappresentazione, vale a dire aLtraverso le reti, i computer , i term inali video, ecc.» (Bernard Huet). Il progeuo architeLtonico si trova a operare in una dimensione dell 'arbitrario che «quando ci si riferisce alla città [ ... ] si trova in un s istema che è quello del senso comune, quello della convenzione, quello della riproduzione, vale a dire la riproduzione tipologica» (B. Huet). È forse necessario precisare che la crisi della rappresentazione è crisi della vis ione centrale, per cui «noi siamo abituati all 'esperienza urbana, quella di uno spazio definito in centri e periferie, che non riusciamo nemmeno a cogliere» (Gianni Vattimo); ciò impone quello che Calvino definisce il ri fiuto della visione direua, che non è rifiuto della realtà del mondo. Niente meglio della «leggerezza» descrive il sentimento di fronte al fauo che il mondo sembra oggi reggersi su entità sottil issime; «la costruzione della ciuà è una realtà che sfugge completamente alla dimensione dell'architetto» (B. Huet). È d 'altra parte quanto accadeva nel racconto poliziesco che nasce sullo sfondo della Parigi ou ocentesca carauerizzato dalla forma del pensiero anal iLico-deduttivo. Esso si muove a panire da «tracce», spesso insign ificanti; «non è più dato attendersi «l'avventura>> , ma chi vive un'esperienza p uò seguirne la traccia» (W. Benjamin). Al raccomo del percorso mentale seguito dal protagonista de l delitti della Rue Morgue (E. A. Poe) si accompagna la descrizione dei luoghi della città auraversati, e non è forse casuale la rievocazione di Leibniz, della sua «smagliame, anche se ingenua» ragione proprio all'inizio de L'uomo della folla (E.A. Poe), «simbolo e genio stesso del delitto». Alla freudiana costruzione della psiche corrisponde la costruzione dei luoghi nell 'esperienza, ma anche, allora, la soggeuività stessa di questa costruzione. L'attuale modello legislativo, normativo, ma anche e soprattutto etico e rappresentativo, che presiede alla costruzione dello spazio edificato, appartiene propriamente e intrinsecamente a una ideologia urbana nella quale ogni riferimento, ogni anelito, ogni invocazione a realtà «altre» sembrano piuttosto porsi come la denuncia di un'assenza. Oggi lo spazio fisico si pone
through networks, compulers, video Lerminals etc." (Bemard HueL). Archilectural projecls turn out lO be operating in an arbitra,y dimension such Lhal "when lhe city is involved [. .. / one finds oneself in a system which depends on common sense, convention, and reproduclion in a typological sense" (B. Huel). li is perhaps necessa,y lo poinl out that Lhe crisis in the represenLation of Lhe city is ac,isis in one's centrai vision of it, as a resu/t of which "ou r habitual urban experience is one of a defined space consisling of centres and peripheries, buL we are neverthe/ess qui te unable to grasp il" (Gianni Vallimo). This imposes upon us whal Calvino calls Lhe rejecLion of direCl vision, but that is noL a rejecLion of lhe real world. When f aced with the f acL thai the world of today seems to stand on the Jra ilesL of fou11da1ions, we feel a sense of ils "insubstantiality": "the way a city is constructecl is somell1i11g which lies completely beyond the grasp of the archilect" (B. Huel). This is exactly whal happens in Edgar Allan Poe's detective story The murders in the Rue Morgue, set in nineteenth centwy Paris. The detective's reasoning is characterislically analytical and deduclive, and his starting point lies in "clues" which are often apparently insignificcmt. ("an 'advenlure' can no longer be expected, buL anyone who lives through cm experience can follow its tracks" W. Benjamin). The narralion of the hero's sequence of thought is accompanied by a descriplion of Lhose parls of Pa,is through which he passes, and it is perhaps no coinciclence Lhat Poe menlions the "vivici yet candid reason" of l..eibniLz al the ve,y beginning ofThe man of the crowd, as "Lhe type and the genius of cleep cri me". T11ere is a para/lei between the freudian co11struction of che psyche arid the construclion of piace wiLhin experience, Logether with ils ve,y subjectivity. The legislative ancl regulatory, but also and above ali Lhe ethical and represenlalive aspects of the present-day model which regulates consLruclion in building areas belong properly and inLrinsically to an urban ideology in which eve,y reference to "other" realities, every urge towards lhem and eve,y invocalion of them seem raLher lo take the Jorm of acknowledging Lhal something is absenl. Nowadays, every physical space is increasingly regarded as an inslilutionalised space, and tliere is a Lendency Lo substitute adminisLrative proceclures far market forces, while plcmning lies somewhere between che colleclive imaginaLion and the market. "In our counlly, building and planning policy have often been used lo salve problems which arose in other parts of Lhe economie, socia/ and politica/ system. Hence the building and plcmning seclors were allotted tasks which perhaps wenl beyond their principal pu rposes, lay outside them, and may have run counter lo them. In other words, building and planning policy Look on the aspect of a large-scale allego1)1: in speaking of them, reference was in Jact being made to something different, though noL necessa rily less imporLant" (B. Secchi).
28
sempre più come spazio istituzionalizzato, nel quale si tende a sostituire il mercaLo con provvedimenti amministrativi, mentre l'urbanisLica si colloca tra immaginario collettivo e mercato. « Tramite la politica ed ilizia e quella urbanistica nel nostro paese si è spesso cercato di risolvere i problemi che si rormavano in altre parti del sistema economico, sociale e poliLico. Con ciò edilizia ed urbanistica venivano caricate di compiti rorse eccessivi , in pane diversi, eventualmente contraddittori, a quelli principali. Detto in a lui termini , la politica edilizia e quella urbanistica assumevano i contorni d i una grande allegoria; parlando di loro si intendeva parlare di altro, non per questo di cose meno importanti». (B. Secchi). Oggi il concetto stesso di ciuà come «entità sociale autonoma» viene discusso e quasi dissolto. Nell'Europa occidentale, in cui la massima pane della popolazione è urbanizzata e, per una serie di motivi sociali e tecnologici. l'integrazione città-campagna è già avvenuta o rapidamente si compie, riesce diffici le o almeno anacronistico parlare non solo di aULonomia ma, in qualche misura d i specificità del l'elemento «urbano». E infaui si parla di sistema urbano, di gerarchia delle ciuà,. di aree metropolitane, di sistemazione del territorio, cli aggregati regionali. Se la disciplina urbanistica nel mondo moderno si pone come puro strumento tecnico e amministrativo, privo di fondamento storico, che elabora inoltre una propria figura professionale (lo stesso termine urbanistica si deve a lldef onso Cerdà che nel 1859, in occasione della redazione del Piano di Barcellona, lo coniò con riferimemo a lla urbs romana) e che è soggetta a una rigida struttura di controllo burocratico-amministrativa e costretta nel letto di Procuste di una normativa quantitativamente ast ratta, diventa tangibile l'esistenza di que lla dicotomia tra la città, considerata nella sua totalità, e il singolo oggetto architettonico, che fatica a mantenere e instaurare rapporti fisici e storici con il contesto. Nel caso particolare, ma bisogna sottolineare che si tratta di un caso del tutto inLemo alla logica complessiva della cillà, dei nuovi insediamenti , quesLi si pongono ormai come realtà autonome, legate da vincoli solamente spaziali ai centri urbani nella cui orbita gravitano, ed estranei del tutto a quella dialettica città-campagna che, ancora fino a qualche anno fa, sembrava mantenere una sua forza polemica e contemporaneamente sottolineare un'assenza. D'altra parte solo la presunta autonomia delle discipline sembra poter salvaguardare dalle contaminazioni con il reale, così come dalle ingenuità che tenderebbero a stabilire una sorta di identità etico-estetica di ginnasiale memoria. La regolarizzazione è il concetto fondamentale in base al quale viene teorizzata la città a partire dall'affermarsi della cultura
Nowadays, Lhe ve,y concepl of the city as an "autonomous socia/ enlily" is much debated and has almosl disintegrateci. In western Europe, where mosl of the populalion have been urbanised and,for a whole series of socia/ and Lechnological reasons, town and counlly have already been integrated 0 1' are in the process of l1eing so, iL is clifficult or al least c11wchro11islic noL only Lo speah of autonomy but even Lo use Lhe tenn "urban" in any specific sense. We in facl speah of urban systems, city hierarchies ancl metropolilan arcas, Lerritorial organisation ancl regional aggregalions. lJ in the moclern world the discipline of urban planning is regarclecl purely as a lechnica/ ancl aclminisl ralive tool, wilhouL historical fou ndations, capable of worhing out iLs own professional physiognomy (Lhe Lerm "urbanistico" was coined by Ildefonso Cerda in 1859 Jrom the Latin urbs, when the Planfo r Barcelona was drawn up), subject wc1 slrict buret1ucratic and administrative contro/ structure, and squeezecl into a becl of Procrustes by a set of largely abstract regu lations, then there can be no doubl aboul the existence of a clichotomy between the city, considered as a toLality, and Lhe individuai archiLeclural objecl, which has clifficulLy in establishing and mainlaining a pliysical ancl historical relationship wiLh ils context. In the parlicular case we are considering - but il musL be emphasised that il is a case w/1ich lies cntircly within Lhe generai logie of cilies old and new - these architectural objecls can now be seen as lwving an aulonomous existence, as being linhed solely in a spatial sense to the urban centres in wlwse orbil they belong, and as being entirely extrcmeous lo the town-counlly dialeclic which, unti/ afew years ago, seemecl lo mainlain a certain polemicalforce and at the same Lime lO emphasise the absence of something. Furthermore, only the presumed autonomy of the discipline seems capable of preserving il Jrom conLaminaLion by conlClct with the real world, as well asfrom Llwse ingenuous ideas which woulcl tenei Lo establis/1 that hincl of idenlificalion of Lhe ethical wiLh the aesthelic which we rememberfrom our school-clays. Regularisation is the basic concepl uncler/ying theo,ies of the city Jrom the time when bourgeois culture begins lo Jlou rish. Haussmann was the f irsl lo lreal the city as an instrument. Jt was precisely in the sphere of bourgeois cullure and Lhe inclustrial sodely Lhat the concepl of periphery as a Jorm of urban expansion looh hold, in opposilion to a postulcued concept of centrality of a specifically historical hind. A city cenlre was such because il was a histo,ical, politica/ ancl economie point of reference. The lerm "historical city cenlre" enterecl the argument precisely as an antonym of the past. for al Lhe ve,y momenl when it affirmed the supe,iority of the pasl over Lhe present ancl hence ils own inviolability, il emphasisecl even more profoundly a detachmentfrom ils own hislory, thereby inclicaling a cliscontinuity which allowed no adclilions to or manipulation of whal hacl previously existed. On the contrary, il made necessary the conslruction of new ancl more ralional
2()
borghese. Haussmann è il primo a trallare la città come uno strumento. È proprio nell 'ambito della cultura borghese e della società industriale che si afferma il concetto di periferia, quale forma dell 'espansione urbana contrapposta a una postulata centralità che è dichiaratamente storica. li centro è tale in quanto punto di riferimento swrico, politico, economico. li «centro storico» si pone in discorso proprio in quanto antinomico rispetto al passato: proprio nel momento in cui afferma la superiorità del passato rispeuo al presente, e, con ciò, la propria imoccabilità, sottolinea, ancora più profondamente, il distacco da quella stessa storia. Si traua dell'affermazione di una discontinuità che non permeue né integrazioni né manipolazioni delle preesistenze e impone invece la costruzione di nuovi più razionali strumenli di riorganizzazione e gestione, non solo politica, della città. C'è insomma una sorta di ambiguità nella dialettica stessa che si è instaurala tra i termini inscindibili della questione, ma è un'ambiguità dovuta piuu.osto al trasformarsi del concetto nel corso della storia. Se infatti la periferia aveva una sua ragione d'essere. e con ciò anche una forma fisica, rispetto a un centro (non necessariamente storico: anzi si è trattato, almeno fino all'Ottocento, di un cemro innanziLullo politico , di potere, per cui periferia stava a indicare regioni, territori, imere ciuà soggette a un potere centrale), oggi rappresenta la forma stessa della costruzione della città moderna, che non si riconosce più nella storia congelata nel suo centro storico, e conserva l'accezione negativa che allude a una popolazione socialmente inferiore. Cercando di articolare concettualmeme il termine «pe1i feria», per distinguere i suoi contenuti ideologici, culturali, architettonici , urbanistici, va subilo ch iarito che il problema centrale non è rappresentalo dalla periferia in quanto tale, ma dalla specializzazione dei settori urbani , conseguenza della volomà di razionalizzazione volta a consentire un migliore uso della città stessa. Esistono quindi due, e forse più periferie: quella della «città-giardino», dove la collocazione intermedia tra ciLLà e campagna permeue il godimemo di entrambe le condizioni; quella delle borgate, caratterizzate dal degrado prima economico e sociale e solo poi, come conseguenza, ambientale. Si traua di una condizione perpetuatasi fino a quello che Bernardo Secchi definisce terzo «stile» della piani ficazione, che carauerizza la più recente politica di investimenti urbani e nell'ambito del quale il conceuo di periferia sta perdendo le proprie qualità di contrapposizione al centro per articolarsi e strutturarsi in forma di continuità con il complesso delle situazioni urbane, per essere destinato a scomparire definitivamente. ln sostanza è praticamente impossibile definire la periferia in
inslrumenLs Jor lhe reorganisalion and management of the city - and noLjusL in a politica/ se11Se. ln other words, Lhere was a sort of ambiguily in the ve,y dialectic which had developed between the essential Lerms of the question, but il was an ambiguity whic/1 was principally due lo the tra11SjormaUon of the concept in the course of histo,y. Far ifa pe1iphe1y ha.cl iLs raison d'etre a11d hence iLs physical existence in relati on Lo a city centre (not necessarily a historical city centre: al least unti/ the 19th ce11twy , in Jact, il was prima,i/y a centre of politica/ power, so that periphe,y mea11t regions, terrilories or even whole ci ties which were subject to a centrai power), il represenis nowadays the very Jorm in which a modem city is constructed. Il can no longer be seen as relating lO the f rozen histo,y of iLs historical cenlre, and preserves those negative overtones which associate il with a socially infelior population lJ one is allempling a conceptual analysis of the term "periphery" in order lo identify its ideologica/, culture,/, architecLural and planning elements, il lws to be recognised al once thaL the centrai problem does rwt lie in the peliphery as such, but in certain urban sector specialisations which are theconsequence of a desire lO ralio11alise i11 arderlo put the city itself lo beller use. There are thus lwo or even more types of periphe,y. There is the "garden city" suburb, whose inLermediale posilion between town and counuy mahes il possible LO enjoy boli, types of situalion; and there is the slum suburb, typified by its economie and socia/ deprivation, leading later on to environmental decay. This situalion persisLs unti/ one reaches what Bernardo Secchi calls the third "style" of planning, which is characterislic of the most recenl urban investment policy Here the concepl of periplwy is in the process of losing its sense of co11lrast with centre and acquiring a jlexible ancl articulated structure where il blends into the totality of the urban silualion, ancl will in the end pennanently disappear. lt is in Jact practically impossible lo define periphe,y in formai, and parlicularly architectural terms, precisely because il coincides with wlwt cannot be represented in the city (in architectural and planning terms and hence in photographic lerms as well). On tfie one hand il reflects the requiremenLs of urban expansion, while on the other its conlent va,·ies according lo the different ways the periphery is utilised, and only rarely is il subjecl lo planning policies which tahe account of its hyperurban reality. lt is indeed the case that al a supe,ficia/ leve/ peiiphe,y is characteristically a border area of a city which continuously thrusts against the limits imposed on il noi so much by its own physical extent as by regulalions. Il is no acci.dent that zoning - a system Jor subdividing territo1y for specialised purposes - is the one instrument whic/1 has been exerting an increasingly preponderant in}luence both inside and outside the debate on architeclure and the modem city, and which, qui te apart ]rom ideologica/ concerns, has been the principe,/ Jactor i.n determining the Jorm of time urban areas. As Bossaglia's photographs seem to emphasise, what contrasts and
termini formali e in particolare archilellonici, proprio perché essa coincide con l'i rrapresentabile (in termini archilellonici, urbanistici, e quindi anche foLogra fici) della cillà. Mentre essa da un Lato corrisponde alle esigenze di espansione urbana, dall 'altro esprime contenuti differenziati sulla base delle utenze, e solo raramente è souoposta a politiche urbanistiche che Lengono conto della sua realtà iperurbana. Il fauore superficialmente caratterizzante la periferia è bensì quello di rappresentare la zona di margine della città che una continuamente contro i propri limiti fisici e, soprattullo, normativi. Non a caso lo strumento che più prepotemememe si è andato affermando dentro e fuori del dibauilo sull 'architeuura e la ciuà del moderno e che, al di fuori delle ideologie, più di ogni altro ha carauerizzato la formalizzazione di quesle aree urbane è lo zoning, lo strumento di suddivisione specializzata del territorio. la periferia si contrappone e si differenzia dal centro per la sua miseria come sembrano soltolineare le foto di R. Bossaglia, miseria che è dala dalla pressoché tolale assenza delle stratificazioni, s ia sLoriche che funzionali, che invece determinano la complessità del centro. l a miseria della periferia è d unque nel suo essere la costruzione, urbanistica e architeuonica, della ciuà-strumemo , della città da usare, piuttosto che da conoscere. Non si tratta di fauori estetici ma sociali, non d i buona o cattiva architeuura, quanto piuuoslo d i un'organizzazione del lavoro e del Lempo libero che, affermando la propria cenlralità, definisce di conseguenza un luogo altro, socialmente meno importante e determinante, che è la periferia. 11 discorso sulla periferia , nei suoi aspeni problematici, interessa proprio i grandi centri urbani, dove la parcellizzazione e la specializzazione della vita agisce a lutte le scale, dal soggetto collettivo a quello individuale, espropriandolo del proprio tempo così come dell'uso dello spazio. Socialmente emarginato, il momento della residenza va a occupare le aree marginali, spesso abbandonate alla peggiore speculazione edilizia. Se la periferia non è necessariamente espressione culturale di degrado, essa rappresenta piunosto l'espressione di un tentativo di razionalizzazione e strumentalizzazione della cillà che ha ormai oggi raggiunto un punto critico, dovuto alla compresenza di due condizioni: da un lalo la difficoltà d i gestire istituzionalmente, e in modo freddamente normativo, le trasformazioni urbane, dall'altro, e conseguenza della prima. una progeuazione architettonica rigidamente subordinata alla pianificazione; né credo che la sola arch itettura, cosl ridotta ad ancella dell'urbanistica, possa Lrasformare un degrado sociale agendo unicamente sul piano dell'immagine. Un'ultima considerazione riguarda la possibilità d i sopravvi-
31
differentiates periphery and cenlre is the f orrner's poverly - a poverty characterised by the a/most complete absence of Lhose hislo1ical or funcliona l stratificalions which deterrnine the complexity of the city centre. The essence of the poverty found in the periphery, then, lies in the planned and architectural nature of its construction as a town-asinslrumenl, a town lo be used rather Lhan a town Lo be familiar wilh. lL is a matter of socia/ rather than aesthetic f actors. 1t is a queslion nol so much of good orbad architecture as of givingsuch a centrai position to the organisalion of work and leisure time, that the pe1iphe1y becomes an "other" piace, of minor socia/ importance and significance. The problematic aspects of any consideration of pe1iphe1y involve large urban centres, where !ife is sectionalised at ali levels according lo special criteria, from Lhe collective Lo the individuai, thereby dep1ivi11g the individuai of contro! over his own time and use of space. He is subject to socia/ dep1ivation, and for habitation purposes occupies border areas where the worst hind of building speculation has often been given free rei 11.
The periphery is not necessa,ily a cultura! expression of decay. lt is rather the expression of an allempt to ralionalise and exploit the city aL a criticai stage in its development, resullingfrom the simultaneous exisLence of two conditions: on the one hand there is the difficulLy of conlrol/ing urban development by inslitutional means and the application of impersonai regulations; and as a consequence of this one finds Lhat architectural projects are rigidly subjected Lo planning requirements. And I do not think that architecture on ils own, when reduced in this way to Lhe status of servant to planning, can get rid of soci al deprivati on simply by operating al tl1e leve/ of image. One fin.al consideralion concerns tlie possibility of survival, not so much of the periplmy and the city as physical entities, as of the abstract entily which they represent. Alongside the crisis in the model of the megalopolis, other ways and means of using urban space are being founcl. The telematic city increasingly lends to involve new social relationships and new ways of organising worh, thus pointing to a topologica/ model in which mobility is drastically reduced unti! il reaches a hypothelical poinl of complete eliminalion, and the organisation of work on totally decentralisecl lines is adumbrated. Contempora,y architectural discussions have indeed already ceased to dislinguish between periphe,y and city, looking instead towards complementary equilibriums. To see this, one only has to look, for example, at the shrewclest and most apposite current projects: namely those which came into being precisely out of a clesire to establish a continuity of method and image between established city and area for expansion. They pay due allention to the complex 11atu re of the image of peripheral areas, and introduce inlo their projects both a representalion of the conflicl between classica I form, characterised by the fact that in terms of typology uniformity prevails over variety, and
venza stessa, non tanto della periferia e con essa della ciuà in q uando luoghi fis ici, quanto piuuosto dell'entità astraua che esse rappresentano. Contemporaneamente alla crisi del modello megalopolitano, s i vanno infatti definendo altri modi e forme d'uso dello spazio urbano. La città telemalica tende sempre più a configurare nuovi rapporti sociali e nuove forme cli organizzazione del lavoro , che prefigurano un modello (topologico) in cui la mobilità è drasticamente ridotta, fino all'ipotetica totale eliminazione della mobilità stessa, per ipotizzare un'organizzazione del lavoro atomizzata. Il dibauito architellonico contemporaneo già infatti non distingue più tra periferia e cillà , mentre ipotizza al contrario equilibri complementari. Si vedano, per esempio, i progeui più accorti e pertinenti auualmente, quelli cioè costituiti proprio dalla volontà di stabilire una continuità, di percorsi e d i immagini, tra città consolidata e aree di espansione, mettendo a fuoco anche la complessità dell'immagine dei luoghi periferici , introducendo, nel progetto, la rappresentazione del conllitto tra la forma classica, caratterizzata dal prevalere della costanza tipologica sulla sua variazione, e la pluralità del moderno che non riconosce unità di tempo né di spazio. Se in tal modo si ribadisce l'irmzione del teatro nella metropoli, e dunque la sua vera e propria messa in scena, questo, d'altra parte, assume, rispello al dibattito condono dalle avanguardie storiche, un carauere manierista, che esaspera le tematiche già affrontate dai maestti dell'architettura moderna rispetto ai quali i progeuisLi più accorti mantengono un atteggiamento di voluta continuità, cui si aggiunge una sona di accelerazione nei modi e nelle forme di precisione dell'immagine architettonica propria del contemporaneo. Il malessere (intendiamo la malattia nel senso nietzschiano) è sonolineato dal potenziamento degli elementi di corruzione e dal predominio del divenire. La «malattia» nasce allora dal luogo in cui opera il progetto architettonico, in posizione intermedia tra U proprio dovere (voler) essere e il rapido consumo (culturale e materiale) cui è sottoposto. La recente restituzione fotografica delle periferie di Roberto Bossaglia sembra registrare Lutto ciò e non è più quella di uno spazio assoluto bensì di uno spazio relativizzato, i cui multiformi aspeui ritrovano nella sintesi fotografica, una loro legittimazione, che si radica nel «nuovo umanesimo» che caratterizza in questi ultimi lavori la sua ricerca. Emergono , da queste immagini, presenze, ora furtivamente introdotte come ombre ora intuitivamente presenti in una atmosfera d'attesa. Non si tratta più o soltamo, semplicemente, di foto di architettura, e in questo senso la sua fotografia tende ad un propria aULonomia arilstica, svincolandosi dai limiti tematici, per rap-
$2.
ihat plural aspect of the modem which does not recognise the unity of lime or piace. While this is indicative of theatre bursling in upon Lhe meLropolis anci so effectively subjecling il lo stage management, the Lheatre Jor its part takes on a mannerisL quality in relation Lo the clebate conducteci by the historical avant-garde. This quality intensifies Lo the point of exaggeraLion those themes a/ready aciopted by the masLers of modem archilecture, in relation LO whom the sfirewdest designers preserve an c1Llitude of deliberate willingness Lo collaborate, Lo which one must add a sorL of acceleraLion in the ways and means used Lo clarify the pa rlicular a rchiteclu ral image proper Lo the contemporary world. This unease (by which we mean disease in the Nietzschean sense) is unclerlined by the clevelopmenl of elements of corruption and the preciominance of change. The "clisease" Lhus comes inLO being where ihe archilectura/ projecL operaLes, in an i11Lem1ediale posilion between its own neeci (wi/1) lo exisL and the rapid cultura/ and materiai consumption LO which it is subjecL. All this seems lo be recorcied in Roberto Bossaglia's recenL photographic survey of peripheries. What we see is 110 longer an absolute space buL rather a relativised space whose multiform llCILure finds in the pl10tographic image a juslification rooted in the "new humanism" which is characteristic of the inves Ligalions underlying his mosL recenl work. One becomes aware in these images of figures which are someLimes JurLively inLroduced as shaciowy Jorms and somelimes intuiLively present in an atmosphere of expectalion. These are more than just photographs of architecture, Jor Bossaglia's photography tencis Lo have ils own aulonomous arlislly . /Lgoes beyond the limits of ils own subject matLer Lo represent Jonns in the absolute. He takes pleasu re in emphasising details, but above ali he capLures Lhe essential nature of space. Within this space, relalio11sl1ips are not necessarily given outward expression: they may simply be suggested anci imply Lhat some evenL is impending. This is achieved partly by using harsh anci aggressive contrasts but especially by revealing traces of human activity in materiai objects. On Lhe one hand we have the empliness of De Chilico's metapl1ysical squares,Jrom whic11 the camera lens parLly removes the sense of sorrow, and on the other a sorl of hyper-realism which takes pleasure in the shacies of grey, and out of which bu.rsL memo1ies of distant existences. IL has Lo be emphasised, nevertheless, thaL photography cannot ciescribe architecture: ali il cando is grasp l10w architecture al.ters the space in which iLs presence predominaLes. The recliscovered centrai importance of man's work of "anthropisation" within Lhe arc/1iLectural landscape leads Lo a rediscovery, Lhrou.gh architeclure, of urban space, the views of which abandon a centrally arranged perspective in Javour of anglecl viewpoints which give the impression Lhat actor and observer are ideally identica/. The images are arLiculated according to the photographer's percepLion and thus refer us Lo the historical con-
presemare l'assoluLo delle forme soLLolineando e compiacendosi dei deuagli, ma cogliendo, dello spazio, il suo essere innanzituuo, spazio di relazioni non necessariameme espresse e, più spesso, soltamo suggerite in cui comunque qualcosa deve accadare. Ciò avviene auraverso la durezza e l'aggressività dei contrasli, ma soprallullo nella scoperta delle Lracce della presenza umana che la materia esibisce, da un laLo il vuoLo del le piazze metafisiche di De Chirico, cui l'obiellivo fotografico toglie in pane il cordoglio, dall'altro una sorta di iperrealismo, che si compiace delle scale dei grigi, e amaverso il quale irrompono memorie di esistenze lontane. Comunque, sempre con la sottolineatura che l'Architeuura non può essere descritta dalla fo to ma si può soltanto cogliere, con la foto ciò che la presenza dell 'Architettura può modificare nello spazio in cui si fa incombente presenza. La riscopena centralità del lavoro di antropizzazione dell'uomo nel paesaggio architeuonico tende a riscoprire, att raverso le architetture, lo spazio urbano, le cui visioni abbandonano la centralità prospetLica per privilegiare le vedute «d i scorcio» che simulano una ideale identificazione tra attore e lettore. Le immagini articolate secondo la percezione intendono così rimandare alla continuità storica degli ambienti ripresi, piuuosLo che alla loro frantumazione. La fot0grafia di R. Bossaglia occupa dunque territori intermedi, tra quelle operazioni «minimaliste» che puntano unicamente sul dettaglio e quelle leuure, invece, panoramiche del paesaggio urbano. Egli mentre ricostruisce e reimerpreta l'oggeuività del contesto, conduce questa operazione a partire dalla quantità minima di una strada, di un marciapiede, di un viadouo o di un lampione, ritrovando la memoria d i una originaria appanenenza al luogo, la dimensione di un abitare piuttosto che non di un oltrepassare i luoghi. «L'immagine, nella sua semplici tà, non ha bisogno di un sapere, essa è la ricchezza di una coscienza ingenua, nella sua espressione è il linguaggio giovane. li poeta, nella novità delle sue immagini, è sempre origine di linguaggio» (G. Bachelard). li carattere originario dell 'immagine fotografica r isiede contemporaneamente nel suo superamento di ogn i dato della sensibilità e ne lla condizione, che essa impone, di rivivere i luoghi, in modo totalmente nuovo, nello spazio della rappresentazione, nel quale si intrecciano reale ed irreale. Per questa ragione le architetture tendono a farsi più rarefalle, piuttosto elementi di volumi in lontananza che non definizioni rinesse nella misura e nella geometria: si tratta di uno spazio vissuto nelle sue possibilità così come nella sua parzialità, ricostruito , e offerto all'immaginazione, attraverso il gioco lecorbuseriano della luce; la ricerca e la scoperta di quella luce particolare che
Linuity of t/1e arcas photograpl1ed rathcr tlian lo their breakdown. Bossaglia's plwtography tlius occupies the middle ground between those "minimalisl" works which concentrate solely on detail, and panoramic interprelalions of the urban landswpc. In re-establisliing eme/ reinlerpreling the o~jeclive aspecls of the contexl, his poinl of cleparture is something CJUilc snw/1: c1 streel, a stretch of pavement, a viaducl or a lampposc; and he Jinds a memo,y of originai belonging W lhc piace, a sense of habitalion ralher than of passage. "An image, in ils simplicily, has no neecl of knowledge. lts value lies in one's ingerwous awareness of il, and il expresses itself in a new /anguage. The originalily [!{ che poel's images always leads lo thc crealion of language" (G. Bc1chelard) Tlie originai nature of a photographic image lies bolli in che way ilgocs beyond the e/ala of the senses, e.md in the way it reciuires one 10 re-expe1ience places in a completely new way, within the intenvoven real arid unreal elemenls of the space representecl. For this rec1son, architectural elemenls Lend lO take on a more rarefiecl appearance. Tliey are more lihe elements of distant volwnes than definitions r~µected in measurement and geomelly. Space is experienced both as the possible cmd the parlial. Il is reconstructed anc/ offered to the imagination by means of a play of lighl such as one might find in Le Corbusier. That special lighl is sought after and discovered which inlensifies volume, bursts Jorth Jrom. amongsl houses, and sets out the contrasl belween inside and outside, darlrness and light. To belong to a piace, then, is Lo rediscover the nature of one's inhabiling il, and lo have the possibility of evohing dream-lihe inlinwcies. But LO inlwbit a piace is LO recliscover in il tlie co111rnclic10ry signs of memo,y, histo1y and the present. Il mecms rediscovering one's own myste,y, Lahing as a point of cleparture some element whic/1 is meaningless in ilself but acquires meaning cmd value through its socia/ and private connotalions. And finally, since it cannol be encapsulated in any lheory or concepl, il remains permanently "open" lo change, in spi te of the chronological fi.xily of the image. Bossaglia's photograpliy, then, offers a represenLation of non-archilecture, of something which is less and al the same Lime more than architecture, and precisely al the momenl when il displays the greatest degree of pholographic objeclivity it also increases its ability lo express a multiplicily of meanings. Il must be poinled ou t tlwl while the theme of nostalgia is parlicularly evident in the worh of G. Basilico - and Heidegger's concepl of the poetry of habitation has been mentioned in co1111ection wit/1 his invesligations - Bossaglia's approacl1 to matt.ers of daily /ife and in particular lo the theme of urban life, is completely pragmatic in nature. The lones ofhis images are more crudely based 011 contrasts of blach and white, and they are suggestive of a pragmatic Jonn of rationality which never inclu!ges in any kind of mystic overtones, even
esalta i volumi., che irrompe Lra le case, che disegna il contraLO tra interno ed esterno, tra buio e luce. Appartenere ad un luogo è allora questo ritrovare la dimensione del nostro abitarvi , la possibilità di evocare intimità oniriche. Ma abitare i luoghi è questo ritrovarvi i segni contradditori della memoria, della storia e dell'attualità; è ritrovarvi il mistero proprio a partire da un elemento privo di significato, che assume significaLO e valore in quanlo patrimonio sociale o privato; infine perché non è possibile circoscriverlo in alcuna teoria o concetto, ma esso resta permanememente «aperto», pur nella fissità cronologica dell 'immagine, al divenire. Dunque le fotografie di R. Bossaglia, come la rappresemazione di una non-architettura , di qualcosa che è meno e insieme più dell 'architettura, che, proprio nel momento in cui ne ostenta il massimo di oggettività ne esalLa la capacità di farsi espressione del molteplice. Occorre dire che se in G. Basilico il tema della nostalgia è particolarmente presente, e si è parlato a proposiLo della sua ricerca, della poetica dell 'abitare di heideggeriana memoria, l'approccio di R. Bossaglia al quotidiano, ed in parLicolare al tema urbano, è assolULameme laico. I toni delle sue immagini impostate più crudamente sui. contrasti di bianco e nero, rimandano ad una razionalità laica che non si abbandona ad alcuna suggestione misLica, neanche nel senso benjaminiano. Eppure il laico Bossaglia e il poetico Basilico si incontrano nel luogo della perdita, e non perché banalmeme in entrambi manchi una qualsiasi presenza umana, ma per il peso che questa assenza assume nella composizione. La ricerca complessiva di R. Bossaglia, e ci riferiamo più in generale a tutta la sua opera, sembra costantememe porsi di fronte all'oggetto con l'obiettivo di riscoprire l'aura di ciascun luogo, salvaguardandone l'unicità e l'irripetibilità: una operazione questa da ani.sta , segno pertanto nettamente contrario a quella indicata da Walter Benjamin come espressione del carattere rivoluzionario della tecnica fotografica; mentre infatti il filosofo tedesco anribuiva alla fotografia la capacità, distruggendo l'aura della cosa di reperire l'uguaglianza anche nell 'irripetibile, R. Bossaglia sembra perccorrere una strada opposta, rintracciare l'irripetibile nell'uguale. L'aura è ritrovata in quella particolare rappresentazione del tempo, che fissato nell 'istante, rende statuarie le rare presenze, o riduce a simulacri le «tracce» ineliminabili ciel moderno , come , per esempio, i sempre presenti e invadenti pali della segnaletica che finiscono quasi per assumere una qualità mitica. Si mette in scena allora una sorta di conni.uo fra i tempi, come se passato e presente entrassero in collisione: alla misurata ci ttà in lontananza si so-
in Walter Benjamin's sense of the term. Bul in spile of Lhe pragmalic approach of Lhe one ancl the poeticism o.f lhe other, Bossaglia ancl Basilico are alone in expressing a sense of loss, nol jusl because of the lach ~{ any human presence in the worh o.f both, but because of the importanl ef.fect thal absence has on Lhe composilion. Tahing his photographic worh as a wlwle, il seems that Bossaglia's generai intent is lo approacf1 his subject matler in such a way as to iclenti.fy the aura o.f each piace, while preserving its unique ancl oliginal nature. This is an arlistic approach, ancl one which runs directly counter lo what Walter Benjamin sees as Lhe way Lhe revolutiona,y quality in photographic lechnique is expressecl; for while Benjamin thought that photography was ab/e lo deslroy the aura o.fa thing and reveal its similalily to other things even in its unique qualily, R. Bossaglia seems lo .fol/ow lhe opposi te path by identi.fying the unique in lhe similar. The aura o.fhis photographs derives.from Lhe particular way in which he represents time by freezing il al a parlicular i.nslant. This lencls a staluesque quality to the rare human .figures, a nel recluces LO t/1e status o.f phantoms Llwse i nevi tabi e "traces" o.f the modem such as lhe ever-present a nel intrusive roacl signs whicl1 in Ll1e end tahe on an almost mystic qualily. In lhis way Cl sort o.f tempora/ conflicl is created, as tl10ugh pasl and present were in collision: superimposecl on the distant orderly city is the chaotic, and therefore disquieting, presence o.f the contemporary. Nor is thal ali, far while the urban photographic images tend lo mahe up an e.,'(pressive sequence lwving physical and psychic continuity, the road signs, on the other hancl, lihe al/ 1hose visual "accidents" alreacly re.ferrecl Lo, are so violently intrusive that they breah up lhe rhythm. IL would be ingenuous lo suppose tlwt objeclivity is the photographer's aim, ancl yet we have lo recognise thal this singula r art is one which tahes the Jon11 o.f an inexpressible ancl inclissoluble mi.xture of objectivity (aver which the photographer cloes nol have complete contro/) a nel subjectivily, the laller being inherent in lhe choice of shot, or al any rate in Lhe selection of this or lhal elemenL or situalion lo w11ich significance is atlributed. That is what determines the particular ancl characle1istic ambiguity of Lhe photographic image, far consciously or olherwise il has to .f ace Lhe problem o.f its own "clouble", withouL Lhere being any direclion in which il can looh .fora solution. ln other worcls, t/1e pholographic image .fincls itse(f in the position of being ab/e Lo mahe only partial choices, ancl then only wilhin suicl limils. Bossaglia's photographs often begin by tahing a single element, which is then studied in consiclerable depth ancl clevelopecl in such a way as to proceecl lo the generai a nel universal. /11 this procedure, an essenti al partis played by memo1y;for memory is responsible far se/ecting the signi.ficanL element a nel presenting it in a succinctancl al the same time symbolic way. Il can be clearly seen that memo,y is also a ceni ral concern in conveying the .fragmenlary nature o.f reality,Jrom the way
vrappongono le presenze caoliche, e penanto inquietanti, del contemporaneo. Non solo, ma mentre l'immaginario fotografi co urbano tende a comporre una sequenza espressiva della conùnuità fisica e psichica, invece, i segnali stradali, così come tutti quegli «accidenti» visivi fin dall'inizio elencati, irrompono con una violenza tale da spezzarne il ritmo. Sarebbe ingenuo ritenere oggeuivo l'obiettivo del fowgrafo, e tuuavia bisogna riconoscere che quesla arte singolare si offre come un ineffabile ed indissolubile miscuglio di oggettività, non interamente controllabile dall'operatore, e soggettività inerente alla scella di una particolare inquadratura o comunque di quella parte o situazione ritenute in qualche modo significative. Questo aspetto determina la singolare ambiguità che caratterizza l'immagine fotografica che, con maggiore o minore consapevolezza, si ritrova a dover affrontare il problema del proprio «doppio» , senza che essa sia in condizione di risolverlo in una qualunque direzione. In allre parole essa è essenzialmente posta nella condizione di poter scegliere solo in parte, entro ben precisi limiti la fotografia procede spesso in R. Bossaglia dal particolare, studiato, approfondito e sviluppato fino a 1isalire al generale, all'universale. Gioca un ruolo essenziale, in questo procedimento, la memoria; è infatti proprio la memoria a selezionare quell'elemento significativo ed a riproporlo nella sua carica sintetica ed, insieme, simbolica. la centralità ciel terna della memoria, anche per quanto riguarda la restituzione della natura frammentaria del reale, appare evidente nella stessa costruzione dell 'immagine fotografica, nella quale l'architettura è sottolineata in quanto volume pur in queste immagini in cui il volume è quasi sempre, salvo rare eccezioni, una pura eco in lontananza. Tuttavia, in modo diametralmente opposto alla leueratura, la fotografia di R. Bossaglia, nell'isolare il particolare, lo decontestualizza e lo pone quale puro oggeuo, privato cli ogn i eccesso di stratificazione cli significati, presentato come mistero, proprio nella sua insigni ficanza, racchiuso in modo definitivo nel tempo del suo isolamento. Perché è l'insignificanza a rendere misterioso l'oggetto, a tendere verso la molteplicità di significati ivi racchiusi. Infatti proprio a partire dalla messa a fuoco di una particolare condizione o situazione prende le mosse il racconto: dall'intuizione del «mistero» si innesca quel processo immaginativo e creativo che muove dal particolare all'universale.
35
in which lhe photographic image is conslructed,Jor while lhe solidily of the architecture represented in it is underlined, there are only rare exceptions lo the generai rule that solidity is purely a dislant echo. Bossaglia's pholography is completely differenL Jrom li terature, however, in that when he isolates a single element, he decontextualises il and presents iL as pure object, without any excessive layers of meaning. Il is presented in ali its myste1y and insignificance, permcmently encapsulaled in lhe time of its isolalion. For il is insignificance which renders an object myste1ious and leacls us towarcls the multiplieity of meanings enclosed within il. Focusing on a parlicular condilion or siLuation is indeed Lhe point of departure in his narrative, far the imaginative and creative process which /eacls Jrom the particu/ar lo the universal is lliggered by lhe inluilion of the "mysle1y".