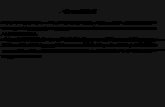Pantanella ai Cerchi. Roma
Transcript of Pantanella ai Cerchi. Roma
55
Il mercato centrale aI cerchI e la stazIone al cIrco massImo
IpotesI d’uso dI una zona archeologIca neI prImI annI dI roma capItale
donatella cIalonI
L’area di fronte al Circo Massimo, vicina al nucleo originario ed ai resti della fonda-zione della città di Roma ed alla più im-
portante ed estesa zona archeologica ancora vi-sibile, conserva tracce e memorie di importanti preesistenze di età antica.
Situata alle pendici del Palatino ed a pochi passi dal guado del Tevere, utilizzata sin dalla preistoria per lo sbarco delle derrate alimentari dal fiume, accanto al Portus Tiberinus, fu a lungo centro della vita cittadina
Destinata essenzialmente al commercio - vi si tenne anche il Foro Boario - ed ai servizi in genere, i lavori di scavo, eseguiti sin dall’ini-zio del sec. XVIII, hanno evidenziato diversi livelli di insediamento e varie strutture, dalla fase arcaica al tardo Impero, che non hanno trovato tutte concorde attribuzione, data anche la complessa topografia della zona, soggetta ad inondazioni e ricostruzioni1 (fig.1).
Attualmente visibile, alla quota originaria, una platea di tufo dove venne scavata la cripta della chiesa di Santa Maria in Cosmedin, iden-tificata da molti con il podio dell’Ara Massima sacra ad Ercole, la cui leggenda è da tempi an-tichissimi legata alla zona, e resti di un isolato adiacente al Circo Massimo.
Per questo ultimo complesso di ambienti, ca-ratterizzato da pavimenti pregiati e scale impo-nenti, che portavano almeno ad un piano supe-riore, si pensa ad un edificio pubblico, databile al
1 F. CASTAGNOLI, Roma Antica , in F. CASTAGNOLI, C. CECCHELLI, G. GIOVANNONI, M. ZOCCA, Topografia e Urbanistica di Roma, in Storia di Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, vol. XXII, Bologna 1958, pp. 3-186; G. CRESSEDI, Il Foro Boario e il Velabro, in Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, LXXXIX,2, 1984, pp. 249 -296.
II sec. d.C., probabilmente il tribunale citato da Cassiodoro; su quel lato inoltre si trovavano i car-ceres del circo2. In alcuni locali invece, intorno alla metà del III sec., venne inserito un grande mitreo, operando adattamenti in ragione delle esigenze del culto3.
Le fonti riportano, per altro, anche notizie di alcuni santuari nelle immediate vicinanze, le cui origini si perdono nel nei tempi, ed il Crescimbe-ni in particolare ricorda di come la basilica fosse praticamente “seppellita” dalle rovine ancora alla fine del IX secolo, ai tempi di papa Adriano I 4.
Tra questi templi uno, circolare, di cui resta un disegno descrittivo di Baldassar Peruzzi, era cer-tamente dedicato ad Ercole. Danneggiato nell’in-cendio neroniano, ma conservato per secoli fino alla distruzione operata da Sisto IV, conteneva probabilmente la nota scultura di Ercole Vincitore conservata nel Palazzo dei Conservatori al Cam-pidoglio, rinvenuta poco distante5.
All’interno di S. Maria in Cosmedin trovia-mo inoltre tracce di un ambiente preesistente, un edificio porticato rimaneggiato intorno al IV
2 P. BIGOT, Recherches des limites du Grand Cirque, in Bul-lettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, 1908, fasc. IV, pp. 241-253, tavv. X -XV.
3 C. PIETRANGELI, Il mitreo del palazzo dei Musei di Roma, in Bullettino della Commissione Archeologica del Governatorato di Roma e Bullettino del Museo dell’Impero Romano, LXVIII, 1940, pp. 143 -173.
4 G.M. CRESCIMBENI, Stato della basilica diaconale, col-legiata, e parrocchiale di S. Maria in Cosmedin di Roma, nel presente anno MDCCXIX descritta da Gio. Mario Crescimbe-ni arciprete della medesima, Roma 1719, Libro I, p. 15. 5 R. LANCIANI, Forma Urbis Romae, Milano 1894-96; L. BORSARI, Topografia di Roma Antica, Milano 1897, pp. 360-367; F. COARELLI, Il Foro Boario, dalle origini alla fine della Repubblica, Roma 1988 ; R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma, Roma 1989, vol. I, pp. 94-95, 101; F. COARELLI, Roma, Bari 2008.
56
sec. d.C., forse in origine direttamente collegato all’Ara Massima, da cui proverrebbero alcune co-lonne murate nella chiesa6.
Nel corso degli scavi più recenti vennero rilevate nell’area strade, condotte, murature, blocchi di tufo, lastroni di travertino, poligoni di selce e di lava basaltina e fondazioni di edifici, lungamente discussi quanto ad orientamento e possibili usi, ipotizzando diversi spazi di culto, granai, saline, magazzini ed altre pertinenze, la statio annonae con un tribunale, meglio identifi-cabile con la Schola Graeca, oltre ad importanti resti della cinta “serviana”7.
Nei secoli successivi, come viene evidenziato nella cartografia su Roma e nelle mappe catastali fino alla metà dell’Ottocento, troviamo in alzato principalmente casupole, granai, fienili e giardini di varia consistenza, tra cui spicca, nel Settecento, la grande proprietà degli Androsilli, già di Bruto della Valle nel ‘400 e di Ottavio Gracchi a fine ‘500, sul cui perimetro verrà poi costruito il “Pa-lazzo dei Musei di Roma”8.
Significativo invece l’imponente convento dei Benedettini, sorto sui resti di una residenza di Niccolò I (858-867), ristrutturata ed ingrandita successivamente fino a farne un grande palazzo diaconale, che comincia però ad andare in rovi-na all’inizio del Cinquecento, quando Leone X (1513-1522) allontana i frati della chiesa9.
Le condizioni ambientali del luogo, paludo-so e pericoloso anche per la presenza di cavi-tà nel terreno e di un laghetto poco distante, lo rendono praticamente disabitato fino all’età di Alessandro VII (1655-1667), che prosciuga l’area intorno alla basilica10.
Accanto, tra l’altro, vi correva la Marrana, che attraversava l’antica valle Murcia e sfocia-va al Tevere, e contribuiva all’insalubrità del posto; all’inizio del ‘700 il fiumicello forniva
6 G.B.GIOVENALE, La basilica di Santa Maria in Cosme-din, Roma 1927.
7 G.B. DE ROSSI-G. GATTI, Miscellanea di notizie bi-bliografiche e critiche per la storia dei monumenti di Roma, in Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, serie III, 1889, pp. 351-365, in part. 358-360 sulla Sta-tio Annonae; G.B. GIOVENALE, La basilica…., op. cit.;G. CRESSEDI , Il Foro Boario…, op. cit.
8 R. LANCIANI, Storia…, op cit., pp. 165-166.
9 G.B. GIOVENALE, La basilica…., op. cit.
10 G.M. CRESCIMBENI, Stato …, op. cit., libro I.
acqua al grande orto ai Cerchi ed a diversi mu-lini dislocati lungo il suo percorso, tra cui due del capitolo di S. Maria in Cosmedin, la Mola Greca e la Mola chiamata Pozzo o Verità, situa-ti nelle immediate vicinanze11 (figg. 2-6)
A metà Ottocento la ditta, che si trasformerà poi nell’importante Società Anglo Romana per il Gas, costruisce i suoi impianti nel Circo Massimo che, nonostante la notorietà, era ancora lambito da vigneti e non isolato nel suo perimetro12.
Gli stabilimenti vengono ingranditi negli anni ’70, e restano in uso fino al 1910, e nel 1886 il ge-rente della società , Adolfo Pouchain, vi colloca anche la prima centrale elettrica della città, sede
11 G.M. CRESCIMBENI, Stato…., op. cit.,Libro III.
12 P. BIGOT, Recherches…, op. cit.; P.CIANCIO ROSSET-TO, Gli interventi nella zona del Circo Massimo, in La Ca-pitale a Roma “Città e arredo urbano” I870 –I945, catalogo della esposizione a cura di L. CARDILLI e A. CAMBEDDA, Roma, Palazzo delle Esposizioni, 2 ottobre- 28 novembre I991, pp. 164-165.
Fig. 1 - Il Foro Boario in età repubblicano-imperiale (da COARELLI 1988)
57
Fig. 2 - L’area nella pianta del Du Pérac (1577) (da P.A. FRUTAZ, Le piante di Roma, Roma 1962, vol. II, 249)
Fig. 3 - L’area nella pianta del Tempesta (1593) (da P.A. FRUTAZ, Le piante di Roma, Roma 1962, vol. II, 267)
Fig. 4 - L’area nella pianta del De Paoli (1623) (da P.A. FRUTAZ, Le piante di Roma, Roma 1962, vol. II, 301)
Fig. 5 - L’area nella pianta del Maggi (1625/1774) (da P.A. FRUTAZ, Le piante di Roma, Roma 1962, vol. II, 316)
Fig. 6 - L’area nella pianta del Nolli (1748) (da P.A. FRUTAZ, Le piante di Roma, Roma 1962, vol. III, 369)
58
della Società Edison Italiana13 . Inoltre è nota la presenza di magazzini, capannoni ed altre piccole strutture per le derrate alimentari nella zona, di cui si riconosce la posizione fortunata, ma che non aveva una precisa destinazione d’uso nella fase pre-unitaria.
Sappiamo poi che il Governo Pontificio esegui-va decapitazioni ed impiccagioni nelle vicinanze e che vi era una piccola cappella per i condanna-ti, ora scomparsa ed accanto una postazione della Guardia di Finanza14.
Quanto alla sovrabbondanza di fienili, che occupavano quasi ogni resto di murature antiche alle falde del Palatino “di estremo interesse per l’archeologia”, interviene direttamente il Muni-cipio Romano con un tassativo divieto in merito a tale uso15 (fig. 7).
Nei vari progetti di studio per lo sviluppo della
Capitale non si trova uno specifico riferimento al settore. Probabilmente l’orientamento generale per la realizzazione di una zona industriale a Testaccio,
13 Le scienze e le arti sotto il pontificato di Pio IX , Roma 1860; cfr. R. MAIOCCHI, Il ruolo della scienza nello sviluppo industriale italiano, in Storia d’Italia. Annali.3.Scienza e tec-nica nella cultura e nella società dal Rinascimento ad oggi, a cura di G. MICHELI, Torino 1980, pp. 865-993, in part. p. 897.
14 Il Messaggero, domenica 11 febbraio 1900, Il suicidio di Tommaso Pantanella.
15 Archivio Storico Capitolino, Tit. 62, prot. 6288/1866.
proposta dalla Commissione Camporese nel 1870 e ripresa nel disegno di P.R.G. del Viviani del 187316, unito ad un limitato interesse per le vestigia antiche presenti nella zona, nonostante ne fosse nota l’e-strema importanza, determina l’ipotesi di destinar-lo a strutture di servizio.
Le esalazioni del fiumicello della Marrana ed i fumi del Gas ne rendono per altro poco idonea
16 Lavori e studi che confluiscono nella redazione della Relazione sono stati già esaminati altrove (D. CIALONI, Roma nel XX secolo, Roma 2006, p. 35 ss., con riferimenti bibliografici) e la tavola è datata 12 giugno 1873.
Fig. 7 - L’area intorno alla metà degli anni ’80 ( Archivio Storico Capitolino,I.E., prot.801/1914)
Fig. 8 - Case per la classe operaia
59
la destinazione residenziale; quella parte di Roma viene considerata adatta al massimo alle abitazioni degli operai17 (fig. 8 ).
Viviani colloca comunque in pianta, nell’iso-lato in esame, un nuovo mercato oltre a quello già esistente, un altro edi-ficio con uso non meglio specificato e la demolizio-ne dei fabbricati presenti su via della Greca, tra cui si trovava anche l’opificio di Michele Pantanella, in esercizio dall’agosto 1870, chiamato stabilimento meccanico di mola a grano e fabbrica di pasta a vapo-re, che aveva già una certa consistenza con 17 vani al piano terra, altri 14 tra il primo ed il secondo piano e due nella soffitta e nei sotterranei18; tutta l’area comunque è destinata ad essere espropriata, esclusa la bella basilica (fig. 9 ).
Nella zona le analisi e le stime per gli espropri iniziano già nel ‘73 e prose-guono ancora all’inizio del Novecento19 (fig. 10).
Spazioso e centrale, quel settore del centro storico suscita in ogni caso interesse nell’am-ministrazione romana, che riflette sulla sua possibile utilizzazione, a partire dall’idea di impiantarvi la stazione d’arrivo della ferrovia da Civitavecchia nel 1879, passando da Porta Latina, con un tronco di servizio destinato al traffico commerciale, fino al progetto, lunga-
17 Archivio Storico Capitolino, Tit. 54, prot 728/1874, auspicando comunque lo spostamento del Gazometro e di organizzare il passaggio del fiumicello all’interno di una condotta sotterranea. Lo sbocco al Tevere viene imbrigliato nel 1886, cfr. F. BECCHETTI, L’Acqua Mariana, in F. BRIZZI, Il Tevere. Un secolo di immagini, Roma 1989, pp. 245-270, risolvendo solo in parte il problema delle inondazioni. Va per altro ricordata la voce contraria dell’ Associazione Artistica tra i Cultori di Architettura, che apprezzava la storia e la bellezza del corso d’acqua che attraversava il luogo, in La zona monumenta-le di Roma e l’opera della Commissione Reale, Roma 1914.18 Archivio di Stato di Roma, Catasto Gregoriano Urbano, Rione X, Aggiornamenti.
19 Archivio Storico Capitolino, Rip. V. Direzione, Tit. 24, b. 66, fasc. 2.
mente perseguito, di sistemarvi il grande mer-cato centrale20 .
Quella dei mercati è una questione molto dibat-tuta a partire dagli anni ’7021.
La legge governativa per il concorso dello
Stato al finanziamento delle opere edilizie per lo sviluppo della città di Roma del 14 maggio 1881, n. 209, prevede infatti la realizzazione di un grande mercato centrale, e nel P.R.G. del 1883 il Viviani ne propone la possibile localizzazione nella zona di Testaccio, vicino al fiume ed alla stazione ferroviaria di Trastevere.
Peraltro l’autore dichiara esplicitamente che avrebbe preferito mantenere la distinzione mer-ceologica e la dislocazione in diverse aree della città, conservando il mercato del pesce alla Boc-ca della Verità, realizzato da Gioacchino Ersoch nel 187822, quello delle erbe, legumi e frutta ai Cerchi, che si teneva regolarmente e rivestiva
20 Ibidem.
21 Archivio Storico Capitolino, Piano Regolatore, Pos. 7, fasc. 71;Tit.48, prot.64898/1880; Tit. 54, prot. 1691/1882 e prot. 13432/1881.
22 Deliberato nel 1878 ed in attività dal 1879; vedi P. BOC-CACCI, G. Ersoch: metodologia, ideologia, tecnologia e lin-guaggio nei progetti per le infrastrutture della distribuzione, in Bollettino della Biblioteca della Facoltà di Architettura, 1978, n. 19-20, pp.27-39, in part. p.34.
Fig.9 - Piano regolatore della città di Roma, del I2 giugno I873
60
una certa importanza e si voleva ampliare, e fare inoltre supportare da un binario ferroviario fino alla Bocca della Verità e quello delle carni con il Mattatoio, assieme a quello dei vini, grani, car-boni e liquidi infiammabili a Testaccio23.
L’ipotesi del mercato centrale ai Cerchi, che sembra essere a lungo l’unico autorizzato alla vendita delle derrate all’ingrosso, affian-cato anche da un omonimo viale proveniente dal rione Campitelli24 viene abbandonata co-munque solo con il Piano Regolatore Gene-rale del 1909 e con la scelta definitiva di via Ostiense, probabilmente anche per la defini-zione della Zona Archeologica Monumentale, grazie alla legge 14 luglio 1887 n.. 4730 per la tutela dei monumenti antichi della città di Roma, che - pur con ripensamenti e modifiche del perimetro - comincia ad interessare il per-corso attorno al Circo Massimo.
Ma l’evento che segnerà a lungo la vicen-da dell’area sarà lo sviluppo di una piccolo stabilimento alimentare.
Michele Pantanella arriva Roma senza grandi capitali, anzi vendendo pane e pizzet-te a piazza Montanara, pare diventando ricco durante la carestia di metà secolo, e compra un forno poco distante25.
Ma troviamo altre sue proprietà nelle vi-cinanze a partire 186126. Tra queste, una casa con un impianto per la panificazione a vicolo della Fontanella27 ( fig. 11) ed un fondo tra via della Greca e vicolo della Marrana composto
23 Piano regolatore e di ampliamento della città di Roma. Relazione della Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 dicembre 1881, Roma 1882, pp. 40-44; Rip.V, Direzione, Tit.24, b.66, fasc.224 Piano regolatore…, op. cit., p. 123. Intanto, nel 1887 viene concessa in uso gratuito al sig. Martini una vasta area per realizzare un mercato generale nella zona di San Paolo e tre appezzamenti per la vendita al dettaglio, in P. BOCCACCI, G. Ersoch…, op. cit., p. 84.
25 Il Messaggero, op. cit.; su Michele Pantanella, vedi E. SERINALDI, Molitura e panificazione a Roma. La “Panta-nella” 1865-1914, in Innovazione tecnologica ed industria in Italia, cinque realtà emblematiche, 1860- 1940, a cura di D. Brignone, Roma 1993, p. 127 ss.
26 Archivio di Stato di Roma, Catasto Gregoriano Urbano, Rione X, XII, Aggiornamenti.
27 Archivio Storico Capitolino, Tit. 62, prot. 6239/1867 con richiesta successiva di ampliamento, ivi, Tit. 54 , prot. 40541/1871.
da case, fienili e giardini, al cui interno inizia a collocare il primo nucleo dello stabilimen-to di fabbricazione della pasta e macinazione del grano28 (fig. 12), un appezzamento con tre fabbricati aggiudicato ad un’asta nel 187429, l’acquisto della proprietà limitrofa di Antonio Cortesi nel 1878 ed una permuta di aree con il Comune (fig. 13), ancora incerto su forma, dimensione e ampliamento del mercato centra-le fino a diventare proprietario di quasi tutto l’isolato in esame30.
Nel 1878 presenta il progetto di uno stabi-limento per la pasta con dieci forni, nell’antico magazzino dei selci su via dei Cerchi, richie-sta sostanzialmente accolta, nonostante alcune timide obiezioni degli uffici preposti all’esame della pratica, dato che l’edificio influenzava la visuale del Circo Massimo - e non sembrava compatibile con l’importanza dell’area - e le os-servazioni e gli appunti della Commissione Ar-cheologica che, considerando la distanza dalle carceres, cercava tracce del tempio e dell’Ara Massima di Ercole e voleva seguire da vicino i lavori ed i possibili ritrovamenti31.
“Il Sig.Pantanella fin dall’ Aprile di questo anno richiese il permesso di edificare nel suo terreno un vasto panificio a vapore per dieci forni, che, atti-guo all’altro ch’egli possiede sul lato opposto del Vicolo della Marrana, costituirebbe un importante Stabilimento di questo genere. Ma si sospese di accordare la licenza nel riflesso che l’ubicazio-ne del nuovo edificio poteva recare imbarazzo all’impianto dei Mercati centrali nelle adiacenze della Bocca della Verità, e poiché una commissione speciale studiava appunto l’argomento dei Merca-ti fu interpellato chi occupavasi della parte tecnica perché esaminasse se e in quanto avrebbe potuto annuirsi alla richiesta del Sig. Pantanella. Fu così che si venne nella persuasione che per non arreca-re imbarazzo all’impianto dei Mercati , secondo lo studio fattane dalla Commissione, conveniva far modificare il progetto al Sig.Pantanella in modo che la fronte dello Stabilimento si ponesse in ritiro
28 Archivio Storico Capitolino, Tit. 54, prot 9802/1870 (forno all’interno di 4 appartamenti- sopraelevazione di un piano del fabbrica già esistente).
29 E. SERINALDI, Molitura, op. cit., p. 127 ss..
30 Archivio Storico Capitolino, Tit. 48, prot.64898/1880. 31 Ibidem.
61
Fig. 10.1 - il mercato centrale a via dei Cerchi.
Fig. 10.2 - il mercato centrale a via dei Cerchi.
62
Fig. 10.3 - il mercato centrale a via dei Cerchi.
Fig. 10.4 - il mercato centrale a via dei Cerchi.
63
Fig. 11.3 - casa di Michele Pantanella
Fig. 11.2 - casa di Michele PantanellaFig. 11.1 - casa di Michele Pantanella
64
Fig. 12.1 - stabilimento del pane di Michele Pantanella
Fig. 12.2 - stabilimento del pane di Michele Pantanella
65
di qualche metro dalla linea attuale della sua pro-prietà lungo la Via dei Cerchi”32.
Tra i tempi della permuta, la modifica dell’alli-neamento stradale, valutazioni sulle diverse quote di livello che lo spostamento di linea comportava, e discussioni in consiglio comunale, vi furono no-tevoli ritardi, ma alla fine, il 3 marzo 1879, Pan-tanella ricevette l’autorizzazione alla costruzione del pastificio33 (fig. 14).
Nel corso dell’ultimo quarto dell’Ottocento la fabbrica arriva alle dimensioni attuali con varie modifiche e ristrutturazioni e, nonostante ci si trovi all’interno di quella che oramai era stata considerata area monumentale, vengono consentite persino sopraelevazioni al di sopra della norma34 (fig. 15).
32 Ibidem
33 Ibidem
34 Archivio Storico Capolino, I.E. , prot . 5029/1889 , prot. 2965/1890, prot. 2154/1899, prot.4021/1899.
L‘impianto era ormai diventato una industria di indubbio rilievo nel panorama romano, e si estendeva anche lungo via dei Cerchi con dei ma-gazzini presso Sant’Anastasia35 e con un altro for-no, sembra gestito dal figlio Tommaso, alla Bocca della Verità36 (fig. 16).
La facciata principale sulla piazza conserva-va l’aspetto di un palazzo con abitazioni, mentre l’interno era costituito solo da una struttura por-tante con arcate in ferro e solai in legno a vista, caratteristici degli stabilimenti di produzione merci in genere.
Anonimo invece e privo di caratteri formali il fianco del fabbricato lungo via di Santa Sabina, con finestre rettangolari seriali e coronato da un alto cor-
35 Archivio di Stato di Roma, Catasto Gregoriano Urbano, Rione XII, Aggiornamenti; Archivio Storico Capitolino, Tit. 48, prot. 48989 /1880; Piano Regolatore, pos. 21, busta 321894/5( ricostruzione per il nuovo percorso strada-le).
36 Archivio Storico Capitolino , I.E. prot. 5613/1898.
fig 13 - permuta di aree
67
Fig. 15 - sopraelevazioni
Fig. 16 - forno di Tommasso Pantanella
nicione centrale scandito da aperture circolari; prati-camente un anonimo stabilimento di scarso interesse per la storia dell’archeologia industriale (fig. 17).
Un grave incendio aveva già distrutto parte del pastificio nel 1881, che era quindi “risorto a nuova vita” ed era stato anche “ampliato, ristrutturato e rie-dificato”, e dotato di una colossale macchina a vapo-re, ma purtroppo si era verificato un nuovo rogo nel 1892, che aveva interessato il primo ed il secondo piano con il conseguente crollo del tetto. Erano ac-corsi, in quella circostanza, persino il re Umberto I, Rattazzi ed il generale Pallavicino37.
Nel 1896 la società, fortemente esposta con il Banco di Roma, e gravata da ipoteca su tutta la pro-prietà si era fusa, anche allo scopo di evitare una inu-tile concorrenza, con la Società dei Molini e Magaz-zini Generali diventando Società Anonima Molini e Pastificio Pantanella.
Il nuovo gruppo, che aveva già acquistato altri mulini lungo via Flaminia e fuori porta Maggiore, operava quindi praticamente in regime di monopolio sul mercato della Capitale e si estendeva anche a Na-poli dove poteva inoltre usufruire dell’utile sbocco marittimo per i suoi commerci.
Viene quindi realizzato un altro complesso su via Casilina, e negli stabilimenti iniziano i lavori per la differenziazione delle produzioni38.
L’edificio ai Cerchi perde via via importanza39 , e sappiamo che nel 1926 era praticamente disabitato.
Nel 1928 sarà acquistato dall’amministrazione comunale per dislocarvi nuovi uffici, servizi, una scuola e due musei, scartata l’ipotesi, suggerita al Segretario Generale dalla Commissione Archeologi-ca, e lungamente perseguita, della demolizione totale del fabbricato, compreso nella Zona Monumentale e da tempo soggetto ad esproprio40 (fig. 18).
37 Il Messaggero, Cronaca di Roma, 8 febbraio 1892; La tribuna Illustrata, 14 febbraio 1892
38 Sullo stabilimento a via Casilina e la sua recente ristruttu-razione si veda: Mulino Pantanella. Il recupero di una arche-ologia industriale romana, a cura di F. AMENDOLAGINE, Venezia 1996.
39 Notizie sull’immobile si trovano anche nell’archivio della Conservatoria del Patrimonio, Comune di Roma, pos. 889, via della Greca. Per anni si discute con l’Amministrazione per la realizzazione di una rampa di accesso alla piazza per superare il forte dislivello, in Archivio Storico Capitolino, I.E. prot 189/ 1916 e 13013/1922, e vengono fatti piccoli inter-venti ; cfr. Archivio Storico Capitolino, I.E., prot. 20440/1928 (ingresso per operai lungo via di Santa Sabina).
40 La Zona Monumentale…, op. cit.; nel Piano Regolatore
68
Fig. 17 - Società Molini e Pastificio Pantanella, Stabilimento ai Cerchi
Il problema della mole imponente dello stabi-limento, su cui svettava ancora l’alta ciminiera, impensieriva non poco i relatori del progetto di sistemazione del Foro Boario e del Velabro, Gu-stavo Giovannoni e Vincenzo Fasolo, incaricati dalla Amministrazione Comunale di studiare la sistemazione dell’area.
Era stato infatti da più parti proposto di copri-re con alberi e piccole costruzioni la facciata del fabbricato, che veniva criticato da molti anni per l’aspetto e le dimensioni41.
della Città di Roma, Variante Generale, Roma 1925 vengono confermate le disposizioni di legge vigenti in materia, che risalivano al I909, tra cui il vasto perimetro.
41 Già nel 1908 l’Associazione Artistica tra i Cultori di Ar-chitettura aveva creato una commissione stabile per lo studio dell’area della Bocca della Verità, promossa da Giulio Ferrari con progetti e rilievi di Aldo Barbieri per il restauro del tem-pio della Fortuna Virile, di cui facevano parte anche Bazzani, Caravacci, Cirielli, Finzi, Giovenale, Lanciani, Magni, Dilani,
La ex Pantanella si presentava invadente e squilibrava l’armonia della piazza, e veniva defi-nita “enorme, altissima, orrenda”, in disaccordo stridente con l’ambiente circostante, auspicando senza arrivare ad un pronunciamento definitivo una ulteriore riflessione sul suo possibile futuro e sulla sua utilizzazione42.
Diverse le ipotesi in campo, e intanto si pro-cede all’acquisizione dell’isolato da parte del
Nogara, Piacentini, Botto ( in Annuario, 1908-9 ), che presen-ta successivamente un progetto, pubblicato ne Il tempio della Fortuna Virile e la zona del Foro Boario in Roma. Relazione della commissione, in Associazione Artistica tra i Cultori di Architettura, Roma, Annuario dall’anno XXI-MCMXI all’anno XXV-MCMXV, Roma 1916, pp. 57-74, a firma di G. Giovannoni, R. Lanciani, A. Barbieri, L. Botto, A. Caravacci, C. Caroselli, V. Fasolo, G. Ferrari, G.B. Giovenale, P. Finzi, G. Magni, B. Nogara, M. Piacentini.
42 G. GIOVANNONI, La sistemazione del Foro Boario e del Velabro, in Capitolium, II, 1926,V, pp. 516-530.
69
Fig. 18 – L’area del Circo Massimo e le Officine del Gas (IGM 1924) (da P.A. FRUTAZ, Le piante di Roma, Roma 1962, vol. III, 592)
Fig. I9 – Ex Pastificio Pantanella
Fig. 20 – Museo dell’Impero: piano primo
70
Governatorato, il 28 luglio 1928 ( fig 19), non senza ribadire le perplessità generali in merito al suo aspetto e decidendo intanto l’immediato abbattimento della ciminiera e la ristrutturazione della fabbrica per adibirla, almeno in parte, a sede museale.
I lavori di restauro vengono affidati ad Anto-nio Muñoz, direttore del servizio di Antichità e Belle Arti del Governatorato, in collaborazione
con l’ufficio comunale Architettura e Fabbriche, che si occupa della realizzazione dello scalone interno di marmo ed della sostituzione dei telai lignei con quelli più robusti in ferro, mantenendo la struttura a piloni ed arcate originarie43.
L’impianto generale praticamente si sovrap-pone all’antico pastificio, con alcuni adattamen-ti del corpo interno a sede espositiva e dei lavori al II piano, mentre qualche altro locale del com-plesso viene utilizzato per ampliamenti ancora nel 1933 e nel ’3544 ( fig.20).
Nel “Palazzo dei Musei di Roma” viene alle-stito il Museo dell’Impero Romano, proveniente dall’ex convento di S. Ambrogio al Ghetto ed aperto al pubblico in questa sede il 19 giugno 1929, ed il primo nucleo del Museo di Roma,
43 A. BIANCHI, La sistemazione di Piazza Bocca della Verità e del Velabro, in Capitolium, VI,1930, pp. 573-591.
44 Conservatoria del Patrimonio, Comune di Roma, pos. 889, via della Greca, usando locali dell’Ufficio Piano Regolatore (già occupati dalla Società Nazionale per la Storia del Risor-gimento).
Fig. 21.1 - Studio per il magazzino delle scene del Teatro dell’Opera
Fig. 21.4 - Studio per il magazzino delle scene del Teatro dell’Opera
Fig. 21.2 - Studio per il magazzino delle scene del Teatro dell’Opera
Fig. 21.3 - Studio per il magazzino delle scene del Teatro dell’Opera
Fig. 21.5 - Studio per il magazzino delle scene del Teatro dell’Opera
71
istituito nel 1929 ed inaugurato il 21 aprile 1930.La facciata su via dei Cerchi, che presenta-
va un prospetto decoroso, sarà arricchita da un piccolo portico con un timpano di coronamento ornato da fasci littori.
Abbattuto il vecchio ricovero per mendican-ti che occupava parte della strada, ed iniziate le demolizioni lungo la via del Mare e l’isola-mento dei templi di Vesta e della Fortuna Virile, vediamo inoltre nei progetti, rimasti su carta, di Giovannoni e di Clemente Busiri Vici delle idee di sistemazione di piazza Bocca della Verità con quinte arboree, diversamente elevate, per armo-nizzare e ridurre l’imponenza del complesso45.
Un altro settore della Pantanella, con affac-cio sul Circo Massimo e sull’ex vicolo della Marrana, sarà invece adibito a magazzino del Teatro dell’Opera, probabilmente sulla base del progetto “Studio per il magazzino delle scene del Teatro dell’Opera”, firmato dall’ing. Carlo Pelizzani, degli stessi anni46 ( fig 21 ).
Vengono creati vasti ambienti idonei ad ac-cogliere le scenografie, altri con depositi per i costumi, una lavanderia, servizi vari, un grande montacarichi, un’ampia terrazza e locali sotter-ranei47, mentre si comincia a parlare di creare ed inserire in questi stessi spazi il Museo del Teatro Reale dell’Opera.
Chiuso nel 1939, a causa della II Guerra Mon-diale, il “Palazzo dei Musei di Roma”, le raccolte troveranno più ampia ed organica sistemazione nelle sedi attuali all’Eur ed a Corso Rinasci-mento e praticamente tutto l’ex-pastificio sarà trasformato in uffici; lo stato attuale dell’isolato sembra dovuto ad un importante intervento di ri-strutturazione generale riferibile alla metà degli anni ’50 del Novecento, con successive recenti modifiche di scarso peso.
45 A. BIANCHI, La sistemazione…., op cit.
46 Conservatoria del Patrimonio, pos.889, via della Greca ,con un verbale di consegna del 1 aprile 1932 ed un sollecito del 22 dicembre 1933, dove si parla del Museo del Tea-tro dell’Opera, per cui si cercano ancora altri locali nel 1934.
47 Nel corso dei lavori venne scoperto il mitreo, uno dei più importanti e meglio conservati della città; cfr C. PIETRAN-GELI, Il mitreo…, op.cit..