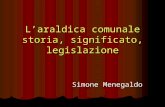INTRODUZIONE AI MEDIA DIGITALI
Transcript of INTRODUZIONE AI MEDIA DIGITALI
1
INTRODUZIONE AI MEDIA DIGITALICAPITOLO 11.L’ambiente digitaleNelle nostre società i media digitali sono diventati strumenti persuasiviche influenzano la sfera sociale, così come quella economica, del lavoro, politica e comunicativa. I computer sono diffusi in tutte le attività umane: agricoltura, telefonia, insegnamento, produzione del sapere e molto altro.I cambiamenti innescati dalla diffusione delle tecnologie digitali stannotrasformando profondamente il modo in cui produciamo e distribuiamo informazioni e conoscenza.I media digitali hanno iniziato a diffondersi intorno agli anni 80 del XXsecolo con la messa in commercio di computer pensati per un mercato di massa, per poi diffondersi sempre più negli anni 2000 con l’emergere del web collaborativo , cioè di software e piattaforme on-line che permettono agli utenti di produrre e distribuire contenuti in prima persona, e delle tecnologie mobili come smartphone e tablet, che hanno trasformato l’esperienza della rete da quotidiana a totale.Si è creta una sorta di ecologia dei media, ricca di nuove strategie come: isocial network che forniscono servizi gratuiti in cambio dei dati degli utenti, i partiti politici utilizzano la rete per sperimentare nuove forme di comunicazione e per accumulare consenso e tutto questo insieme di relazioni e interazioni forma l’ecosistema digitale.I media però sono anche territorio di scontri tra diverse visioni del mondo: da un lato sono dipinti come portatori di democrazia, giustizia, uguaglianza e come mezzi per superare la rigidità delle società industriali e dall’altra, come minaccia all’ordine sociale, come potenziali distruttori di equilibri, come strumenti di sfruttamento e di abuso del potere.2. Media digitaliI media digitali, o nuovi media, sono un insieme di mezzi di comunicazione basati su tecnologie e caratteristiche comuni ai mezzi di comunicazione precedenti, si sono diffusi a fine del XX secolo affiancandosi ai “vecchi” media tradizionali, come televisione, giornali,radio.Questi non li sostituiscono, ma bensì li integrano o li modificano, senzaperò farli estinguere: così come l’introduzione della tv non ha portato la scomparsa del giornale, l’introduzione del tablet non causa la scomparsa del libro.Sono:
2
- Digitali: trasportano informazione rappresentata da una sequenza numerica che è poi rielaborata. I codici digitali sono basati su unità particolari, il codice binario che è basato su 2 simboli: 0 e 1 e i codici analogici che sono continui. Grazie a questa caratteristica, le tecnologie digitali possono trasportare molto rapidamente quantità immense di informazione e i media digitali possono trasformare i codici analogici in digitali e viceversa (es.una fotocamera digitale trasforma un segnale analogico come la luceche entra nell’obbiettivo in un codice digitale come l’immagine stoccata dentro la fotocamera, o al contrario un lettore mp3 trasforma un codice digitale cioè il file mp3 in un segnale analogico come la musica). Le tecnologie digitali sono formate da hardware e software;
- convergenti: contengono diversi tipi di contenuti (scritti, sonori,visivi) che convergono in un unico dispositivo, come ad esempio il computer è una macchina in cui convergono televisore, macchina da scrivere, radio, telefono e molto altro. Un unico dispositivo è anche in grado di produrre oltre che a condividere dei contenuti;
- ipertestuali: l’ipertesto è un testo che non può essere stampato informa cartacea perché ha una struttura complessa, fatta di rimandi ad altri testi o contenuti. I media digitali permettono di fruire dei contenuti in modo lineare grazie al sistema dei link un utente può personalizzare il proprio percorso di fruizione;
- Distribuiti: i mass media tradizionali sono centralizzati e unidirezionali (l’informazione viene trasmessa da una struttura centrale come la redazione di un giornale), i media digitali invecesono caratterizzati da un modello distribuito di gestione delle tecnologie dell’informazione basato su 3 punti:- diffusione di microprocessori a basso costo: computer, smartphonee tablet;- diffusione della possibilità di accedere ad internet e al World Wide Web;- i software e le piattaforme che permettono agli utenti di creare contenuti e da qui la produzione e la distribuzione dell’informazione non sono più centralizzati ma bensì sono in mano a milioni e milioni di persone.
- Interattivi: nell’ambiente digitale gli utenti hanno la possibilitàdi interagire direttamente con i contenuti, modificarli, produrli eperciò possono: selezionare le informazioni che ricevono senza subirle passivamente (al contrario della tv) e possono anche commentare e votare i contenuti;
3
- Sociali: i social network o media sociali come Facebook, Youtube o Twitter permettono agli utenti di potersi creare un profilo personale pubblico, permettendogli di entrare in contatto con altriutenti e condividere con colo contenuti e dar vita a nuovi tipi di interazioni, dando così vita a nuove comunità (gruppi di Fb) Questiservizi sono basati sulla gestione e sulla formazione di reti sociali.
- Mobili: le tecnologie mobili di rete, come cellulari, tablet, rendono pervasivi i media digitali perché permettono agli individuidi accedere alla rete per scrivere, pubblicare contenuti e ricercare informazioni da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Le tecnologie mobili sono importanti perché oltre per il ruolo economico, anche per la loro capacità di modificare ed estendere lereti sociali.
Internet è un sistema di comunicazione che non si basa su un unico centro:
- Internet ha una struttura a rete distribuita, che significa che le informazioni che lo compongono sono posizionate su migliaia di computer chiamati server, ai quali altrettanti computer si collegano per richiedere le informazioni desiderate;
- Internet è una rete ridondante: le informazioni vengono smontate inpacchetti che possono separarsi e viaggiare su percorsi diversi;
- Internet è un sistema aperto, poiché chiunque abbia accesso a una linea telefonica o a banda larga può accedervi.
I media digitali sono composti da 3 livelli:- 1° livello fisico: le infrastrutture tecnologiche che formano
l’ambiente digitale: personal computer, server, cavi, satelliti;- 2° livello logico: composto da software, dagli standard e dai
protocolli su cui si basano le reti;- 3° livello dei contenuti: le informazioni in linguaggio umano che
sono prodotte e scambiate in rete, come i 140 caratteri di un tweet, un’immagine.
3. Tecnologie e societàIl determinismo tecnologico dice: le tecnologie sono fattori indipendentiin grado di determinare lo sviluppo delle società umane, le caratteristiche dei media digitali determinano il modo in cui gli individui interagiscono tra loro, creando forme particolari di organizzazioni sociali, comunità o sono responsabili di cambiamenti nellastruttura economica o politica di una società (ad esempio le rivoluzioni arabe sono state causate da Facebook).
4
Le tecnologie hanno il potere di strutturare i rapporti di produzione (ilmulino a braccia dà origine a una società di tipo feudale, la macchina a vapore produce una società di tipo capitalistico industriale).La prospettiva deterministica è uno dei principali odi per interpretare la dimensione sociale ed economica dei media digitali. Queste tecnologie (come la ruota) di mezzi di comunicazione sono strumenti in grado di influenzare lo sviluppo delle società umane.Troviamo anche una prospettiva opposta a quella deterministica, quella della costruzione sociale delle tecnologie, in base alla quale la struttura e il successo di una tecnologia dipendono dalla forza, dai bisogni e dai valori del gruppo sociale che la promuove. Per questa teoria le tecnologie non sono naturali ma dipendono dai processi sociali.
Queste tecnologie possiedono però delle possibilità e dei limiti, e vengono descritti in sociologia con il termine affordances. Le tecnologie possono offrire soluzioni e rendere possibili nuove forme di azioni, ma allo stesso tempo possono farlo all’interno dei confini della tecnologia stessa. Un esempio è la possibilità offerta da Twitter per aggregarsi e seguire un evento pur non conoscendosi, limitata però dai suoi 140 caratteri dei tweet.Imprese che gestiscono servizi come Youtube, Facebook, Google sono le stesse a utilizzare la parola “piattaforma” per ribadire la loro neutralitàe apertura agli utenti, dove i servizi si basano proprio su di loro. Infatti, le strategie economiche di questi servizi si basano sulla partecipazione diretta di masse di utenti che creano, pubblicano o condividono contenuti come foto, video, testi.Presentarsi come piattaforme per la libera espressione degli utenti è quindi funzionale agli obbiettivi economici delle imprese degli utenti è quindi vantaggiosa dal punto di vista funzionale agli obbiettivi economici delle imprese che gestiscono questi servizi.
4. La dimensione del cambiamentoIl rapporto tra tecnologie digitali e cambiamento sociale è un’interazione dinamica. È una reazione a catena: alcuni interessi nati all’interno di contesti specifici hanno portato alla nascita di una nuovatecnologia (società industriale ottocentesca ha portato alla nascita dei primi calcolatori meccanici), in questo modo sono state generate soluzioni tecnologiche per decenni, a loro volta, hanno avuto conseguenzedel tutto inaspettate, come contribuire a cambiare le dinamiche sociali, generando nuovi interessi in un ciclo continuo.
5
Tra i cambiamenti legati alla diffusione dei media digitali, vi sono i processi di globalizzazione. Questo fenomeno ha portato l’abbassamento del prezzo delle merci di consumo e ha cambiato anche le dinamiche di potere. Esempi sono il declino del potere contrattuale della classe operaia e l’ascesa negli ultimi decenni dei nuovi paesi produttori: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.La globalizzazione ha anche un risvolto culturale. Dagli anni 80 la globalizzazione dei mercati televisivi, facilitata dalle tecnologie, ha generato una cultura globale composta dagli stessi format televisivi, brand, film e canzoni. La diffusione di massa di internet ha accelerato questo fenomeno, mettendo a disposizione degli individui di tutto il mondo un patrimonio culturale economico.
CAPITOLO 21.La società dell’informazioneNella società dell’informazione le tecnologie informatiche sono pervasivee influenzano i processi produttivi, sociali, identitari e politici. La capacità di produrre, manipolare e distribuire informazioni diventa il fattore principale di ricchezza e potere ed è terreno di scontri.Le tecnologie per la produzione, la gestione e la distribuzione dell’informazione sono caratterizzate da costi decrescenti e dalla disponibilità sempre più universale, per lo meno nei paesi ricchi, dove le famiglie possono accedere a una connessione internet.Il concetto di <società dell’informazione> si cominciò a diffondersi negli anni’90 amplificata dalla diffusione di internet.Si può parlare della nascita della società dell’informazione come di una terza rivoluzione industriale: la prima è quella della macchina a vapore,la seconda quella dell’elettricità e la terza sarebbe quella basata sulletecnologie di gestione e trasmissione dell’informazione. Queste tecnologie proprio come le altre portano a dei mutamenti, dal settore agricolo a quello industriale, alla vendita di prodotti. Proprio come la rivoluzione industriale ha cambiato l’agricoltura con l’introduzione di macchinari agricoli, fertilizzanti chimici, allo stesso modo la rivoluzione dell’informazione trasforma l’industria, introducendo nuove possibilità di gestione dei processi produttivi.
2. Economia dell’informazione e globalizzazioneNell’economia dell’informazione, la produttività, la competitività e la redditività dipendono dalla capacità di generare e gestire le informazioni e la conoscenza.
6
L’informazione è un bene intangibile, differente dai beni materiali e perciò deve essere regolato da forme di proprietà apposite come le imprese tecnologiche o quelle dell’industria culturale che si tutelano con brevetti e diritti d’autore. Le risorse principali di queste imprese sono: i brand, brevetti, la capacità di gestire reti e distributori, fornitori, design e marketing.Un esempio concreto sono Nike e Apple che non possiedono le fabbriche dove vengono prodotti scarpe o gli smartphone, ma la produzione dei beni materiali è in appalto a produttori esterni (spesso in Asia), mentre le imprese madri possiedono la proprietà intellettuale, brevetti, gestisconoil marketing, la comunicazione, le reti commerciali e altro. Il capitale investito in informazione rende più di quello investito nella produzione materiale, diventando sia materia prima sia prodotto finale. Nell’economia globale, le componenti centrali hanno la capacità istituzionale, organizzativa e tecnologica di operare su scala globale.Con la società dell’informazione, la globalizzazione diventa uno dei fenomeni economici principali: si affermano multinazionali che usano i media digitali per controllare i processi produttivi e organizzativi complessi e transnazionali. Così nasce una cultura di consumo globale in cui merci, stili di vita e forme di consumo si diffondono in tutto il mondo, ma poi vengono adattati in contesti locali diversi (come la musicahip hop nata in America successivamente importata in Eu, Africa, Asia, dando vita a una pluralità di stili).Si affermano anche mercati finanziari globali, che vengono gestiti tramite media digitali e tecnologie di rete come: il trattato libero commercio Nafta (accordo commerciale tra Messico, Stati Uniti e Canada negli anni ’90, la Banca Mondiale, L’unione Europea).Nascono reti di imprese formate da fornitori, subfornitori, produttori, distributori e reti commerciali, e anche questo sviluppo lo si deve all’impatto delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che hanno reso le reti più efficienti e competitive.I media digitali rendono possibile un’organizzazione dal basso, a forma di rete, con un numero maggiore di attori che non corrispondono a una gerarchia piramidale, ma hanno una parziale autonomia di decisione (es. negli Stati Uniti è la cosiddetta agricoltura comunitaria tipo San Crispino).
3. Storia delle tecnologie informaticheL’evoluzione della società dell’informazione è in relazione molto strettacon le modalità di produzione e di distribuzione del sapere che si affermano con la diffusione dei computer prima, e di internet poi.
7
La prima definizione di computer viene attribuita al matematico inglese Turing che lo definisce come: una macchina capace di imitare tutte le altre macchine (dal lettore dvd, alla fotocamera, calcolatrice, consolle…).Invece il primo computer potrebbe essere invece considerato il telaio Jacquard, ancora utilizzato nell’industria tessile, anche se in forma diversa. Il telaio utilizzava un rotolo di carta perforata (simile a quello utilizzato nei pianoforti automatici) che conteneva un programma di istruzioni per l’esecuzione di un particolare modello; cambiando il rotolo di carta (programma) si poteva cambiare il modello di pizzo prodotto.Il telaio Jacquard e altri progetti dell’epoca erano orientati ad aumentare l’efficienza della produzione industriale e del controllo e della gestione di organizzazioni complesse come le ferrovie . I primi passi verso i moderni computer furono fortemente legati ai processi di industrializzazione e all’espansione della complessa burocrazia e delle amministrazioni.Si sviluppa così, un atteggiamento scientifico che viene applicato allevicende umane e da questa nuova mentalità scientifica ha origine l’idea che la società possa essere misurata e che gli avvenimenti sociali ed economici possano essere calcolati e in una certa misura programmati. È un effetto a catena, infatti, questo modo di pensare fu fortemente rinforzato dallo sviluppo della statistica la quale misurava e controllava gli avvenienti sociali da parte degli stati: - la creazione di eserciti di leva rendeva indispensabile sapere da quanti soldati potevano essere forniti da ciascun paese o regione e quindi avere informazioni attendibili sul tasso delle nascite, della mortalità o dellemalattie; - la nuova economia che si stava sviluppando intorno al XVIII secolo rendeva necessarie misurazioni economiche più precise.Nei secoli successivi la statistica generò una forte pressione per lo sviluppo di nuovi metodi di calcolo e di nuove macchine calcolatrici. La macchina più diffusa fu quella di Hollerith, inventata per risolvere il problema del censimento americano. Questa funzionava sullo stesso modellodi quella di Jacquard e diffuse la sua company diffuse i primi computer a schede perforate nella maggior parte delle amministrazioni statali e delle grandi società commerciali; successivamente la compagnia di Hollerith assunse il nome di Ibm: International Business Machines.La produzione divenne progressivamente automatizzata, e macchine programmabili come il telaio Jacquard potevano aumentare la produttività dei lavoratori industriali e semplificarne il lavoro da qui, gli operaiqualificati tendevano a essere anche politicamente attivi, l’automazione
8
permetteva di sostituirli con immigrati appena arrivati dalle campagne. Il reclutamento si operai provenienti dal sud Europa fu alla base della linea adottata dalle fabbriche Ford.Nacquero nuove discipline come il marketing, le ricerche di mercato, ilmenagement, la contabilità e quindi la domanda di macchine di calcolo fornite dalla Ibm che era l’azienda leader.La Seconda guerra mondiale diede impulso ulteriore alla sviluppo dei calcolatori e dei computer che oggi conosciamo, questo perché i computer vennero usati per differenti scopi, dalla balistica al Progetto Manhattan, cioè il progetto per la costruzione della bomba atomica alle telecomunicazioni che furono di un importanza strategica, così come la crittografia ( per decifrare i codici dei tedeschi).Però il computer aveva un costo proibitivo oltre che le dimensioni di unastanza e la necessità di grandi risorse di energia, oltre a risultare incomprensibile per chi non fosse un laureato in matematica e quindi era quasi inaccessibile.Tuttavia le innovazioni tecnologiche del dopoguerra mutarono rapidamente le prestazioni del computer: sia Ibm che l’italiana Olivetti, lanciarono una serie di prodotti destinati alle medie imprese e all’amministrazione statale, Intel inventò il microprocessore e questa innovazione rivoluzionò il mercato dei computer, riducendo drasticamente il prezzo e dimensioni migliorando le prestazioni.La maggior accessibilità portò la diffusione del computer nelle organizzazioni e nelle imprese ed ebbero un impatto crescente sull’organizzazione economica. A fine anniì70 si poteva parlare dell’emergere di una nuova società dell’informazione basata sui computer.Negli anni’60 negli Stati Uniti si era formata una cultura di giovani ingegneri e studenti informatici, che si sentivano vicini alle controculture che dominavano i campus americani e sarebbero sfociate nel 68: le prima comunità di Hacker.Queste persone vedevano i sistemi gerarchici e il rigore formale che circondava i computer nelle grandi università e nei centri di ricerca come una sfida da contrastare. Essi proponevano un utilizzo diverso da quello per cui era stato costruito, infatti furono loro gli artefici dei primi videogiochi.Cercavano di sovvertire i sistemi tecnoeconomici tramite interventi di manipolazione tecnologica. Il loro primo bersaglio fu la rete telefonica americana monopolizzata, nella quale riuscirono a trovare il modo per effettuare telefonate gratuite e avere conversazioni di gruppo.
9
Dal matrimonio fra hacker e controculture tecnologiche nacquero i primipersonal computer destinati a un uso familiare. Da luoghi come la SiliconValleyai fondatori di Apple, emersero nuovi linguaggi di programmazione come il Basic di Microsoft e Apple II, lanciato nel 77 il primo computercon un sistema operativo interfaccia grafica basato sull’uso dei mouse e diretto dal mercato di massa.I personal computer cominciavano a entrare nelle piccole imprese, ad essere utilizzati da professionisti e artigiani.Sistemi operativi come Mac, Windows e Microsoft Office aumentarono il potenziale dei computer per famiglie.La trasformazione del computer da tecnologia burocratico-militare a elettrodomestico e centro di intrattenimento per le famiglie fu quindi ilfrutto dell’appropriazione e della riconfigurazione delle nuove tecnologie da parte di attori come hacker, attivisti del movimento del 68 e imprenditori della Silicon Valley. Interne ha una storia simile.
Negli anni’50 e ’60 si cominciò a pensare al computer come uno strumento non più per fare solo calcoli, ma anche per comunicare.il progetto di comunicazione fu intrapreso per la prima volta dall’antenato di internet: la rete Arpanet, che collegava i supercomputerpresenti nelle università e in alcuni centri militari. Arpanet si basava sulla tecnologia packet switching, che scompone ogni messaggio in una serie di pacchetti che trovano la loro strada nella rete indipendentemente dagli altri. Si tratta dunque di un’architettura distribuita dove non esiste un nodo centrale e lo spegnimento di un singolo computer non pregiudica il funzionamento della rete. Il progetto lanciato dall’agenzia di ricerca militare Arpa era partito come competizione alla tecnologia dell’Unione Sovietica dopo il lancio dello Sputnik (il primo satellite).Anche nel caso della rete si può identificare una linea parallela e convergente con quella militare-industriale. Arpanet era stata pensata inorigine come un canale di comunicazione militare da usare per coordinare le comunicazioni dell’aeronautica e solo successivamente i ricercatori delle università statunitensi ne influenzarono lo sviluppo e ne cambiarono la destinazione.Oltre ad Arpanet troviamo anche altre reti, che trasformarono la rete da una semplice tecnologia per connetter i computer alla possibilità di far comunicare e propagare contenuti.Negli anni’90 alcune innovazioni diedero vita alla rete che conosciamo oggi:
- furono resi noti i linguaggi e gli standard del World Wide Web;
10
- il sito info.cern.ch fu il primo sito a basarsi sull’Html (Hyper Text Mark-Up Language:usato per mettere on-line documenti ipertestuali, tag, inserendo etichette, potendo cambiare colori, dimensioni, link…);
- escono gli Url (Uniform Resourch Locator), cioè indirizzi riconoscibili che identificano un contenuto presente su un server epermettono ad un pc che ne faccia richiesta di accedervi; il sistema Url rende i siti indipendenti dalla collocazione fisica ad esempio: una web page può avere un Url italiano (.it) ma essere collocata fisicamente su un server a Hong kong;
- il protocollo http (Hyper Text Transfer Protocol) è il sistema di trasmissione delle informazioni utilizzato sul web.
Berners-Lee decise di rilanciare queste innovazioni senza restrizioni, inmodo tale che chiunque potesse utilizzarle. Questo facilitò la diffusionedi una nuova rete di siti linkati fra loro, il World Wide Web (www).Gli standard e i linguaggi del Www e la diffusione dei protocolli aperti come il Tcp/Ip , permisero l’unificazione delle varie reti in internet: la rete delle reti.Alla diffusione delle reti e alla nascita del web contribuirono anche scelte politiche: nel corso degli anniì80 gli operatori telefonici conoscono una prima ondata di liberalizzazioni che aprono alla concorrenza in un mercato tradizionalmente monopolistico. SuccessivamenteAmerica ed Eu lanciano politiche per la costruzione di infrastrutture tecnologiche per l’informazione e per la deregolamentazione ulteriore delmercato delle telecomunicazioni.Tra le altre innovazioni troviamo il Digital Millenium Copyright Act che protegge i diritti degli autori. Un esempio l’impedimento do copiare dvd o usarli al di fuori delle zone in cui sono stati comperati. Queste ealtre legislazioni hanno tutelato i grandi produttori di contenuti come le case discografiche o cinematografiche stimolando il loro interesse peril web come possibile piattaforma di business.Sempre negli anni’90 il web si diffonde e comincia a rappresentare un’industria in espansione, nascono le cosiddette <dot-coms>, cioè portali commerciali come Amazon o Ebay è la cosiddetta new economy. Alla fine del millennio qualsiasi attività online avrà il suffisso <.com>(che sta per commerciale) e sarà in grado di attirare investimenti spropositati , nuove proposte di business, spesso irreali e basate su aspettative gonfiate che, in termini finanziari si chiamano bolla speculativa , cioè un aumento sconsiderato dei costi delle azioni delle aziende di commerci online, con una mole di investimenti finanziari di dimensioni troppo elevate rispetto al valore reale della azienda. Lo
11
scoppio di questa bolla, avvenuto negli anni 2000 portò al fallimento di gran parte delle aziende della rete.
4. Il futuro della società dell’informazioneLe nuove tecnologie informatiche hanno avuto alcune conseguenze sociali fondamentali.Nella produzione industriale rendono possibile l’automazione e l’organizzazione della produzione in reti globali di piccole fabbriche connesse tra loro. Questo tende a diminuire sia il costo della produzionemateriale, sia il potere contrattuale della classe operai, mentre la produzione di beni immateriali come innovazioni, organizzazione e brand diventano più importanti.Si diffondono forme di organizzazione sociale a rete diversa dal mercato e dalle organizzazioni gerarchiche.Sembra essere sconfitta l’ipotesi della natura egualitaria della nuova società dell’informazione; dalla metà degli anni 70 si assiste una crescente disuguaglianza salariale, con la discesa della classe operaia industriale e la sua sostituzione con il nuovo proletariato dei servizi concentrato nei call center, nelle vendite e nei servizi alla persona.Vi è anche una disuguaglianza globale, con l’accentuarsi della divisione del lavoro tra le regioni che producono materie prime o beni materiali e quelle che gestiscono i processi di innovazione.Il futuro della società dell’informazione dipende da molte variabili e lo sviluppo tecnologico è solo una tra le tante; un campo altrettanto importante è quello delle politiche pubbliche a livello nazionale e sovranazionale riguardante le regolamentazioni sulle telecomunicazioni, sull’architettura della rete e i diritti sulla proprietà intellettuale.
CAPITOLO 3Cooperazione sociale online1.Web collaborativo e contenuti generati dagli utentiTra le trasformazioni tecnologiche, economiche e organizzative della società dell’informazione, un posto di rilievo è occupato dai fenomeni dipartecipazione attiva e cooperazione alla produzione dei contenuti e informazioni prodotta dagli utenti della rete e che hanno avuto ripercussioni su tutti i settori, dalla produzione culturale, alla produzione di software e marketing.Gran parte dei servizi presenti sulla rete sono infatti interattivi e permettono la partecipazione degli individui o addirittura si basano su forme di produzione affidate completamente agli utenti, come ad esempio
12
le piattaforme, semplici da usare perché non richiedono competenze tecniche specifiche e si basano su processi di cooperazione.Strumenti come blog, wiki, sistemi di tagging e di condivisione di informazione sono alla base di questa trasformazione e di queste piattaforme. Le nuove forme cooperative di comunicazione si caratterizzano per offrire ai clienti di formare loro i contenuti, in prima persona. Gli esempi di questo fenomeno esploso a partire dagli anni 2000 sono molti e basta aver la possibilità di esser connessi ad una rete per potervi accedere e creare.Il passaggio da forme più statiche e unidirezionali di comunicazione al web collaborativo, che oggi viene dato per scontato e appare e viene datoper acquisito, ha cambiato in profondità i media e l’industria culturale.I media broadcast, come la televisione e la stampa, sono diretti da un centro che invia il messaggio a molti ricevitori, qui il pubblico può scegliere quali contenuti leggere o guardare, ma non può contribuire a fornire feedback e produrre contenuti, al contrario avviene in queste piattaforme.Oggi il livello di interazione è maggiore tra gli utenti e il servizio stesso, l’utente assume un ruolo centrale.I blog sono diari o giornali online, che danno vita alla blogosfera, cioèun ambiente a rete formato da blog in comunicazione dove troviamo anche isocial network.Produrre un sito web personale non richiede competenze informatiche specifiche dato che può farlo chiunque ed è molto easy. La pubblicazione online non è più riservata soltanto agli informatici, giornalisti o scrittori ma a tutti gli utenti. Troviamo anche i wiki, software di scrittura collettiva, che permettono a più persone di lavorare contemporaneamente a uno stesso testo o documento, l’esempio più concretoè Wikipedia, allo stesso modo troviamo anche Youtube anche se in forma differente.Il successo di questi servizi è dovuto oltre che all’uso di software collaborativi, anche alla diffusione di strumentazione a basso costo cometelecamere o macchine fotografiche.Altri servizi commerciali sono Ebay, Amazon, Google Maps o sistemi di rating (trip Advisor) dove poter votare o recensire ristoranti o altri servizi.Questo nuovo mondo, il web collaborativo è formato da utenti che sono i primi a formare contenuti, a svincolarsi dalla dinamiche canoniche dell’industria culturale. Il pubblico che prima riceveva i messaggi passivamente, veicolati dai broadcast si trasforma in pubblico attivo,
13
passano da solo consumers a prosumers, cioè da produttori/consumatori (adesempio sono i remake dei videoclip di artisti famosi, reinterpretati daifan o da semplici utentifandom).
2. Software liberoAll’interno dei fenomeni legati all’affermazione della rete collaborativasi sono espanse le pratiche di cooperazione e le scienze sociali che si sono interessate a questo fenomeno si sono soffermate sulla peer production, o meglio la produzione sociale basata sui beni comuni.Nei progetti di produzione sociale online, molti individui possono collaborare in forma coordinata, ma non organizzata in forme di gerarchietradizionali. Appunto per questa si parla di <gestione orizzontale>, in cui le decisioni sono prese con la partecipazione di tutti gli utenti.Alla base della peer production vi sono delle premesse:
- la nascita di un ambiente digitale in rete caratterizzato dalla rimozione dei vincoli fisici;
- costo marginale della produzione di informazione tende allo zero: una volta creato un contenuto digitale, il costo affrontato per produrre una copia è molto basso;
- la diffusione ubiqua (capacità di trovarsi in più luoghi nello stesso momento) dei computer connessi alla rete, che permette a milioni di utenti di collaborare a distanza;
- l’emergere di strategie non proprietarie della gestione dell’informazione, cioè forme alternative di copyright, che danno vita ai beni comuni informazionali;*
- la diffusione di produzione non a scopi commerciali ma per valore d’uso, servizi gratuiti e accessibili a chiunque.
*L’esempio più noto di forme alternative di copyright è il copyleft, sono licenze del Creative Commons (Cc).Il termine <copyleft> nasce da un gioco di parole tra <right> e <left>, infatti di tratta di una forma di copyright alternativo che in italiano si potrebbe definire con permesso d’autore invece di diritto di autore.. questo tutela l’autore di un’opera ma allo stesso tempo permette a chiunque di compiere alcune azioni senza chiedere permesso o pagare royalty, in modo da eliminare gli ostacoli alla diffusione e condivisione delle informazioni creati dal copyright. Il copyleft è statocreato da Stallman che permise la diffusione del software Gnu, e le maggiori licenze sono state fatte dal Cc.Chi decide di proteggere la sua opera d’ingegno, come ad esempio una canzone o un libro, con una licenza Cc permette a chiunque di riprodurre,
14
distribuire e rappresentare l’opera stessa, combinando però in diverse forme le 4 clausole principali:
- clausola attribuzione (by): chi esegue o redistribuisce l’opera deve indicare l’autore e riconoscerne la paternità;
- clausola non uso commerciale (nc) non è consentito l’utilizzo ai fini economici;
- clausola non opere derivate (nd) impedisce di modificare l’opera;- clausola condividi allo stesso modo (sa) chi redistribuisce l’opera
in una versione modificata deve pubblicarla secondo le condizioni di licenza scelta dall’autore.
Una metafora che è stata usata per descrivere la produzione sociale è quella del peer-to-peer (P2P).Le reti P2P sono reti di computer usate per scambiare file e hanno la particolarità di non avere dei luoghi centralizzati in cui risiedono le informazioni, ad esempio un server. Ogni computer del P2P funziona graziealla sua ridondanza: il contributo di molti computer individuali fa si che anche lo spegnimento dei un nodo della rete non ne comprometta il funzionamento, dato che le stesse informazioni sono disponibili su molte macchine e possono viaggiare seguendo percorsi alternativi.Una metafora per descrivere queste forme di produzione di cultura e informazione è quella del <bazar> contrapposto alla <cattedrale>, quest’ultima ha bisogno di un progettista e a sua volta dei coordinatori e altri lavoratori per esser costruita, abbiamo quindi una struttura centralizzata e piramidale al contrario del bazar dove la produzione e ladisposizione è decentralizzata e orizzontale, ricca di progetti, flessibile e dinamico.La peer production è complementare ai processi produttivi di tipo commerciale e pubblico perchè questi seguono le logiche di mercato, non lasciano autonomia e azione agli individui , proteggono le informazioni ei contenuti dei prodotti tramite i diritti di proprietà intellettuale, impedendo agli utenti di usarli e modificarli liberamente.Il caso più conosciuto di creazione cooperativa di informazione è quello del software libero, è in particolare il sistema operativo Gnu/Linux. Questo software nato per mano di Stallman alla fine degli anni’80 è basato su licenze che permettono a chiunque di usarlo, modificarlo e redistribuirlo, a differenza dei software proprietari come Microsoft Windows, il software libero mette a disposizione di chiunque il suo codice sorgente , cioè il testo del programma scritto nel linguaggio di programmazione. Questo permette agli utenti di poter studiare e modificare il programma.
15
Tuttavia <libero> non significa che questi programmi possano essere usatiin modo indiscriminato, dato che sono soggetti a licenze copyleft. Il free software deve garantire 4 <libertà fondamentali>:
- libertà (0) di eseguire il programma, per qualsiasi scopo;- libertà (1) di studiare come funziona il programma e la possibilità
di modificarlo in base alle proprie necessità. L’accesso alla sorgente è dunque un prerequisito;
- libertà (2) di redistribuire copie in modo da aiutare il prossimo;- libertà (3) di migliorare il programma e distribuire pubblicamente
i miglioramenti dall’utente in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio.
I sistemi operativi basati su questi programmi sono in grado di competerein un campo commerciale con sistemi operativi quali Microsoft e Apple. Oggi i sistemi operativi basati sul copyleft rappresentano la maggioranzanel settore dei server e ancora solo una piccola fetta, ma in crescita, in quello dei personal computer.
3. Open sourceDall’esperienza del software libero è nato l’open source, un movimento che dalla fine degli anni ’90 ha cercato di rendere appetibile per le imprese commerciali il modello aperto rappresentato dal copy left.È stato un successone e molte imprese informatiche hanno adottato principi open source per i loro prodotti: un esempio su tutti è Ibm.L’innovazione basata sui diritti di proprietà intellettuale alternativi, partecipazione aperta e disponibilità del codice sorgente è stato applicato in svariati settori, da quello automobilistico, scienza, musicaal design.Il caso più noto è quello della condivisione delle risorse di calcolo.SETI@home che è una sorta di <computer virtuale> (dove installando il software SETI@HOME su un personal computer, quest’ultimo viene inserito in una rete di processori che lavorano l’analisi di segnali radio provenienti dallo spazio. Ogni utente che installa questo programma concederà parte della propria potenza di calcolo del suo pce l’aggregazione di migliaia di utenti risulta in grado di competere con i computer normalmente utilizzati per questi calcoli).Naturalmente una caratteristica importante della peer production è la suacapacità di intercettare motivazioni individuali che spingono le persone a dare contributi o che hanno progetti simili. Altre caratteristiche sonola modularità e la granularità, cioè rispettivamente la possibilità di suddividere il progetto in più parti, appunto moduli che possono essere sviluppati indipendentemente dalle altre parti (in un sistema operativo ci si può concentrare solo sul <modulo scheda video> o qualsiasi altro) ela possibilità di dividere il compito in parti, anche molto piccole che
16
invoglia tutti gli utenti a dare un contributo, anche se piccolo (come adesempio su Wikipedia dove qualunque persona può modificare una voce e persino una virgola).Queste forme di partecipazione aumentano il controllo individuale sui processi produttivi e la produzione sociale online aumenterebbe anche l’efficienza dei processi produttivi grazie ai bassissimi costi di transazione e la capacità di coinvolgere un numero elevato di individui.L’open source è diventato anche un fenomeno commerciale: sempre più imprese dei media digitali aprono le porte del loro sistema di innovazione e sviluppo al contributo degli utenti della rete tramite strategie di coinvolgimento dei clienti o di attori esterni al fine di migliorare i propri prodotti. Ad esempio, creano piattaforme online in cui gli utenti possono suggerire innovazioni al prodotto o modifiche che sarebbero opportuno apportare e creare soluzioni nuove che successivamente l’azienda userà nel processo produttivo.Questo fenomeno chiamato crowdsourcing, cioè di esternalizzare un processo produttivo alla “folla”, permette di risparmiare denaro ma soprattutto diraccogliere suggestioni ed idee che sarebbero difficili se non quasi impossibili da sviluppare in azienda.Un particolare esempio molto vicino a noi lo troviamo nel mondo della telefonia mobile, con la Apple e il suo iPhone che ha permesso a chiunquedi sviluppare applicazioni secondarie come giochi, servizi, screensaver. Tuttavia la vendita e la distribuzione delle applicazioni stesse vengono controllate dall’azienda stessa. La risposta di Google è stata Android.L’innovazione con metodi open source è applicabile alla progettazione e al design di qualsiasi oggetto materiale e non e in alcuni settori, queste soluzioni cominciano ad avere un ruolo commerciale.
4. Il futuro della cooperazione onlineL’espansione della produzione orizzontale basata sui beni comuni, corrisponde a un obbiettivo democratico:
- la peer production e le culture di cooperazione favorirebbero la redistribuzione di potere e ricchezza, in quanto gli individui non hanno solo a disposizione i mezzi di produzione (computer connessi alla rete), ma anche la possibilità di controllare fli input e gli output del processo produttivo;
- l’emergere di questi processi porterebbe ad un aumento di autonomiae libertà individuale, alla dissoluzione delle gerarchie e maggioreflessibilità;
- la peer production sarebbe parte integrante di una nuova sfera pubblica in rete, non più basata sui mass media ma su forme di
17
comunicazione orizzontale e svincolate dal controllo tipico dei media e di chi li possiede (sarà la comunicazione di massa a formare l’opinione pubblica);
- la produzione sociale e non commerciale risponde agli obbiettivi digiustizia e sviluppo svincolata dal controllo delle aziende e dei governi.
Tuttavia, questi fenomeni hanno causato un’ondata di critiche riguardantil’efficacia della produzione sociale basata sui beni comuni, sollevando dubbi, mettendo in discussione la loro affidabilità, se confrontata al sapere prodotto di esperti nel settore, istituzionalizzati e tradizionali.
CAPITOLO 4SFERA PUBBLICA,POLITICA E POTERELe trasformazioni della società dell’informazione portano dei cambiamentioltre che sul sistema dei media anche sulla politica. La sfera pubblica (componente delle democrazie moderne) si è aperta a nuove pratiche e a nuovi attori. Il potere ricade sul sapere e sulle capacità di informare, gestire e utilizzare le reti di comunicazione.1.Il pubblico attivoIl pubblico è attivo, riceve un messaggio ed è in grado di interpretarlo,valutarlo e rispondere in forme differenti. Con l’arrivo dei media digitali il pubblico si diversifica ancora di più e acquista un ruolo sempre più importante e diretto anche nella stessa produzione e distribuzione dell’informazione.I media broadcast sono poco accessibili, hanno una struttura gerarchica, da uno a molti, il controllo economico e politico dei canali mediatici è assunto da un solo gruppo di persone se non da una sola persona (Berlusconi) .I media digitali modificano radicalmente questa situazione. L’effetto principale della rete è appunto la nascita di un sistema più complesso e diversificato, accessibile ad attori non commerciali e non statali, è decentrato e distribuito. I media hanno 2 caratteristiche che rendono possibile la transazione verso la sfera pubblica:
- l’accessibilità: il costo dell’apertura di un canale di comunicazione, così come la produzione e distribuzione stessa è ormai quasi a 0. Strumenti come blog, giornali online, forum, social network e piattaforme ne sono un esempio, hanno un bastissimo costo, sono facilmente accessibili da parte di attori non dotati di mezzi finanziari necessari per aprire un’attività nel campo dei mass media.
18
- la struttura distribuita: si passa da una struttura di tipo gerarchico, centralizzata dei mass media commerciali, all’architettura distribuita e non gerarchica della rete, dove l’informazione può circolare senza passare da un centro di distribuzione.
Dai media broadcast (da pochi a molti) si passa così ai media narrowcast (da pochi a pochi) a quelli webcast e infine ai socialcast (da molti a molti).Le caratteristiche delle informazioni condivise in rete sono la persistenza, replicabilità, scalabilità, ricercabilità. Le informazioni, o commenti, le immagini condivise sono persistenti in quanto vengono conservate nei database, sono replicabili perché qualsiasiutente può copiarle e redistribuirle, sono scalabili perché possono raggiungere una platea di persone molto ampia e infine sono ricercabili perché i motori di ricerca permettono di reperire le informazioni perduteo sconosciute (esempio di Twitter e dei suoi hastags).
2. La nuova sfera pubblica in reteGrazie ai nuovi media digitali un numero sempre maggiore di persone ha lapossibilità di partecipare direttamente alla produzione di sapere e conoscenza aumentando così il pluralismo.Le piattaforme e il web partecipativo cambiano in profondità il ruolo degli intermediari nell’industria culturale, dal giornalista alla comunicazione politica, certe figure vengono scalfite a favore di un allargamento della platea.Qui troviamo la <sfera pubblica> che è il luogo dove avvengono le mediazioni tra società e stato nelle società moderne. Non nasce con i media digitali, essa viene trasformata in profondità ed è un luogo dove èpossibile radunarsi e agire insieme per negoziare e creare le regole di vita comune, è indipendente dai poteri statali, è una dimensione in cui gli individui che compongono la società sono liberi di criticare ed elaborare temi politici senza subire la direzione dell’autorità, si formal’opinione pubblica.Nelle società liberali moderne, l’opinione pubblica è essenziale per la democrazia.La concentrazione di potere nelle mani dei produttori di informazione (ilcosiddetto quarto potere) fa si che i mass media controllino i flussi di informazione, con la possibilità di filtrarlo e dirigerlo secondo i loro benefici e scopi politici. In questo senso i media digitali, come ogni nuovo media, hanno trasformato il funzionamento della sfera pubblica.La rete diversifica le fonti di informazione. Gli individui hanno accessoad una molteplicità di fonti, anche indipendenti da quelle alternative
19
dei mass media, che possono essere difficilmente controllate dalle autorità statali o dalle grandi imprese di informazione. Troviamo nuove forme, più accessibili e trasparenti da cui attingere informazioni.Nei processi di trasformazione della sfera pubblica dell’era digitale troviamo vari fenomeni:
- la disintermediazione: cioè l’aumento di indipendenza da figure professionali che storicamente hanno avuto un ruolo di intermediaritra il pubblico e l’informazione. Grazie alle tecnologie digitali, gli individui hanno accesso diretto a duna mole immensa di informazioni che prima erano nelle mani di pochi esperti. Questo fenomeno ha trasformato anche il mondo del giornalismo, soprattuttonella produzione e distribuzione dell’informazione. La diponibilitàdi pubblicare contenuti da chiunque e in maniera semplice ha portato alla nascita di nuovi fenomeni di produzione di informazione quali news, che hanno arricchito l’ecologia dei media;
- il citizen journalism: è la produzione e la distribuzione di notizie da parte di individui che non sono giornalisti professionisti e che simuovono su canali alternativi da quelli istituzionalizzati dai broadcast. Uno degli strumenti principali è il blog, ma troviamo anche i siti di informazione e quest’evoluzione ha portato cambiamenti nei giornali tradizionali che si sono dovuti adattare al cambiamento, aprendo sezioni online, cambiando strumenti (siti web, edizioni per smartphone e tablet) e portando l’interazione con i lettori al centro dell’attività comunicativa. I giornali integrano le news online con sistemi di interazione con i lettori, come blogging, rating, commenti agli articoli e uso dei social network.Questi strumenti e queste pratiche hanno modificato in profondità il sistema con cui le notizie vengono prodotte e distribuite.
- il gatekeeping: cioè il potere da parte dei principali giornali (o broadcast) di selezionale quali notizie rendere visibili al pubblico e quali no. Ora il gatekeeping non è più così saldamente nelle mani di questi colossi dell’informazione, ma è piuttosto distribuita nelle mani degli utenti;
- anche il ruolo dei mass media è cambiato, da detentori di agenda setting: cioè la capacità di dettare l’agenda del dibattito pubblico scegliendo le notizie su cui si parlerà. Ora le notizie più rilevanti emergono dalla blogosfera, dai social network fino a raggiungere le grandi testate online o i mass media.Secondo Benkler, la sfera pubblica di rete è in grado di garantire i filtri di attendibilità e rilevanza un tempo riservati ai mass
20
media che oggi non sono più gli unici intermediari tra cittadini e informazione.Questa visione però non tiene conto del ruolo di nuovi gatekeepers come i motori di ricerca o le imprese che controllano i social network. Ad esempio, Google ha sistematicamente censurato, per gli utenti cinesi informazioni relative alle manifestazioni e alla successiva repressione avvenuta in Piazza Tianamen del 1989.
(Un esempio da riportare è WikiLeaks)Le persone che occupano posizioni influenti sui media sociali spesso hanno notizie di rilievo nel sistema dei media tradizionali: ad esempio iblogger più quotati sono i giornalisti di punta nei quotidiani tradizionali.L’ambiente di rete no garantisce la nascita di una sfera pubblica obbiettiva, completamente orizzontale slegata dalle dinamiche di potere già esistenti. I blog hanno un grado elevato di omofilia, cioè tendono a linkare fonti di informazione del solo proprio campo politico senza introdurre quelli di opposizione, soffocando il confronto e il dibattito fra orientamenti e prospettive diverse che caratterizzano la sfera pubblica virtuosa (esempio della blogosfera politica americana che è fortemente polarizzata: chi legge i blog di orientamento repubblicano generalmente non legge quelli democratici).
3. Politica e movimenti socialiL’attività politica è profondamente influenzata da media e sistemi di gestione dell’informazione. Le pratiche politiche dipendono molto dalla capacità di analizzare l’elettorato con tecniche derivate dalle scienze sociali al fine di produrre strategie di marketing politico mirate su diversi media (ad es. negli Stati uniti i partiti repubblicano e democratico utilizzano database contenenti informazioni su decine di milioni di potenziali elettori: dati sulle caratteristiche demografiche,sui comportamenti di voto e persino di acquisto come abbonamenti o riviste).Tuttavia non sostituiscono il ruolo dei media broadcast tradizionali, anche se hanno effetti sulla partecipazione politica, dato che la rete abbatte i costi.Un esempio dove sono state sfruttate a 360° le capacità dei media digitali applicate alla politica, lo troviamo con le primarie del partitodi democratico e la successiva vittoria di Barack Obama. Obama è stato ingrado di sconfiggere gli avversari sul numero di persone coinvolte direttamente nella sua campagna , il suo punto forte è stato appunto la strategia basata sul mettere in comunicazione le persone che lo
21
sostenevano; ha aperto un suo sito: my.barackobama.com che ha avuto un ruolo cruciale , ha sfruttato persino le forme di comunicazione virale come ad esempio i video postati su YouTube : Yes we can.La creazione di un sistema informativo basato sui media digitali alternativi è uno delle principali armi contro le dittature ed è stato usato ampiamente in Medio Oriente: si è parlato così di Twitter revolution in Iran e nel corso della Primavera araba*. Nel mondo occidentale degli esempi sono stati organizzati su Fb che è stato il promotore del No Berlusconi Day.La maggior parte degli utenti della rete si limita però a mettere in campo attività come slackvism (gioco di parole tra pigro e attivismo) comepostare commenti o foto di significato politico (dalla satira a quant’altro) o firmare petizioni online e aderire a gruppi. Tuttavia i media digitali si rivelano non sostitutivi alla mobilitazione di piazza oa qualsiasi altra forma di attivismo, i media sociali non sono sufficienti per creare mobilitazione di massa ma sono utili per far viaggiare informazioni.La primavera arabaNel 2010 uno studente-fruttivendolo si diede fuoco in pubblico per protestare contro il regime del presidente tunisino. Questa data segna l’inizio della primavera araba, una serie di sollevazioni popolari che hanno rovesciato i regimi autoritari in Tunisia, Egitto e Libia, portandoa scontri vilenti in Siria, Yemen e in altri paesi del Medio Oriente, all’occupazione nello stato spagnolo e Occupy Wall Street.Molti dei partecipanti coinvolti nelle rivolte utilizzavano le piattaforme dei media sociali come simboli di democrazia e liberta; in piazza al Cairo, uno die luoghi simbolo delle proteste, alcuni manifestanti arrivarono al punto di brandire insegne con la scritta <Facebook>. Questa è stata definita una nuova forma di partecipazione politica chiamata <azione connettiva> sostituendo l’<azione collettiva.Gli stremisti sostengono che i media sociali come Twittere e Fb furono lecause della protesta, si è arrivati persino a parlare di Twitter revolution. Questi media sociali hanno rivestito un ruolo essenziale, sono un mezzo per la mobilitazione rapida e la comunicazione virale, una fonte di informazione alternativa sia localmente, sia per gli osservatoristranieri che circola nonostante i tentativi dei governi dittatoriali di bloccare e censurare le notizie (infatti i tweet durante le rivolte in Iran erano scritti in inglese e quindi diretti alle persone al di fuori del paese per far conoscere la loro situazione). I maggiori eventi che hanno caratterizzato la rivoluzione in Egitto sono stati preceduti da discussioni e decisioni prese su facebook.
22
Il ruolo di queste piattaforme però non deve sovrastare l’importanza relativa delle tecnologie mobili come smartphone, tablet che contribuiscono all’evoluzione e che permettono di connettersi ai social media (ruolo essenziale nei paesi in via di sviluppo quale l’Asia).Egualmente importanti sono le politiche legate ai problemi di accesso e trasparenza dell’informazione. I governi mettono in atto iniziative per controllare l’informazione, azioni poco trasparenti, utilizzando filtri censure o provvedimenti che limitano la libertà di espressione. Governi invece non democratici come quello cinese arrivano persino a un controllostretto e una censura a 360°, come ad esempio il Great Firewall of China, un software che impedisce il passaggio di alcuni tipi di informazione agli utenti di particolare zone del paese (esempio di storia del giornalismo).La libertà di espressione e il diritto all’informazione non possono essere dati per scontato e per rispondere alle restrizioni alcune parti del mondo, come l’Islanda ha approvato una proposta di legge l’ Icelandic Modern Media Initiative (Immi) scritta in collaborazione con Julian Assange diWikileaks, incorpora anche le leggi di Svezia e della Norvegia per tutelare la libertà di espressione e la trasparenza di informazione. L’Islanda si pone così di diventare un porto franco che protegga giornalisti, utenti della rete ed editori di tutto il mondo. Questa leggeha anche lo scopo di attirare imprese giornalistiche, database e providerinternet.
4. Cultura civica e politica onlineL’emergere di forme di organizzazione politica tramite strumenti e piattaforme online ha fatto parlare della nascita di una nuova cultura civica. Si sottolinea che il coinvolgimento civico delle popolazioni occidentali è in declino da decenni e le organizzazioni, i sindacati hanno sempre meno partecipanti, sempre meno persone votano alle elezioni o partecipano alla vita attiva dei partiti politici. Parte di questo è dovuto al consumo televisivo, parte alle nuove forme di aggregazione online.I pubblici costituiti da aggregati di persone che attraversano i media digitali si dedicano a perseguire una meta comune, dalla creazione di un software libero, all’elaborazione di uno stile di vita, di un brand o la protesta contro il riscaldamento globale, forniscono un’educazione civicain quanto membri della stessa virtù, condivisione, solidarietà e impegno per una causa comune e spesso queste forme di collaborazione portano allacreazione di opinioni etiche e politiche.Questa forma di attivismo in rete, stimola la formazione di una nuova cultura civica ma d’altra parte tende a togliere l’elemento di dibattito
23
e interazione con persone di idee differenti, il confronto e la diversitàvengono meno e con essi anche la vita politica.D’altro canto stanno mergendo fenomeni politici come il Movimento 5 stelle, in cui le persone con background molto diversi convergono in reteper discutere apertamente di tematiche molto eterogenee; troviamo il Partito Pirata che è un movimento politico guidato dall’interesse per la trasparenza e la libertà di espressione che tutela i diritti degli individui online, promuove la partecipazione politica basata sui media digitali e parte dal presupposto che i partecipanti abbiano opinioni diverse che non devono essere annullate ma invece rappresentate in modo accurato.Molte critiche hanno fatto notare però che la rete non è per sua natura democratica, nonostante la sua architettura distribuita e i suoi protocolli aperti e lo sviluppo della società dell’informazione andrà in direzione di una maggior democratizzazione o meno in base, oltre che aglisviluppi tecnologici, soprattutto a quelli politici e sociali.
CAPITOLO 51. SocialitàLe relazioni sociali sono sempre state influenzate dalle tecnologie mediatiche. Le prime organizzazioni politiche come le città-stato, nacquero in parallelo con la scrittura, senza un mezzo di comunicazione in grado di attraversare le distanze fisiche e conservare le comunicazioni non ci sarebbero i sistemi sociali complessi. Negli anni’60il boom delle culture giovanili andava di pari passi con la tecnologia dei giradischi, la televisione portò la diffusione globale di tendenze e moda (vedi il successo dei Beatles).L’arrivo sulla scena dei <nuovi> media digitali, di internet, e dei telefoni cellulari permette nuove e ulteriori legami tra tecnologie e relazioni sociali.Vi è un legame tra effetti della rete in astratto e relazioni sociali, e qui troviamo 2 visioni contrapposte:
- da un lato, si afferma che essi rappresentano un mondo sociale estraneo alla vita quotidiana;
- dall’altro, che hanno effetti dirompenti sulle forme di socialità.Tuttavia nei media digitali odierni la vita online e quella offline hannopiù barriere distintive. Negli anni’90 le principali piattaforme in uso erano pagine web, mailing list, forum dove si poteva tranquillamente parlare di un’<esperienza virtuale>, un <cyberspazio> dove era possibile nascondere la propria identità reale usando nomi o identità alternative. Oggi invece gli individui in rete tendono a postare sui media sociali
24
contenuti legati alle proprie attività, alle e mozioni o avvenimenti quotidiani.Le tecnologie mobili permettono di accedere ai servizi in una molteplicità di situazioni diverse e tutto ciò fa scomparire la differenza sostanziale tra online e offline: le attività online sono una parte della vita sociale quotidiana e i profili sui media sociali sono una parte dell’identità complessiva delle persone.
2. Media socialiI media sociali sono siti web basati sulla costruzione e sul mantenimentodi legami sociali con altri utenti del servizio. La loro vera e propria esplosione è avvenuta negli anni 2000 e li ha posizionati tra i principali intermediari tra i contenuti della rete e gli individui della rete (Facebook è il medium sociale più grande, ha superato il miliardo diutenti). Esistono numerose piattaforme diverse , usate per organizzare i gruppi sociali più differenti e a trattare qualsiasi tematica.
I media sociali sono servizi web che permettono di:
- creare un profilo pubblico o semipubblico secondo le possibilità e i vincoli offerti dalla piattaforma stessa;
- costruire una rete di contatti (amici, followers) con cui condividere contenuti e informazioni;
- scorrere la lista dei contatti dei propri contatti.Molti media sociali permettono di creare o di aderire a comunità tematiche, gruppi di discussione, permette agli utenti di pubblicare e condividere con i propri contatti i contenuti multimediali più vari, da foto, immagini, canzoni, informazioni e notizie; i contenuti sono pubblicati sulla pagina personale, la bacheca o timeline. Gli utenti possono interagire con i contenuti degli altri utenti, condividendoli, commentandoli, o assegnando loro un rating che esprime un giudizio , come il like di Fb.Molti di questi servizi forniscono chat, instant messaging, email, telefonia e sistemi di commenti. L’integrazione di questi servizi e l’ampia diffusione dei media sociali li hanno resi competitivi con i motori di ricerca gatekeepers. Facebook, ad esempio, viene usato sia per comunicare in forma privata attraverso la sua email e il suo servizio dichat, sia per informarsi tramite i link a contenuti giornalistici. Molte di queste piattaforme sono state sviluppate per facilitare l’organizzazione di relazioni sociali intorno a interessi comuni; ma è anche diffuso il suo uso ai fini di marketing da parte di aziende, partiti politici o associazioni.
25
Oggi media digitali sono per la stra-maggioranza gestiti e sviluppati da aziende private. Queste aziende, hanno sviluppato modelli economici che permettono loro di assicurarsi guadagni a partire dalle informazioni chegestiscono. La maggior parte di questi servizi è gratuita e genera introiti dalle informazioni che gli utenti producono. Questi dati vengonoaggregati da software di profilazione, che permettono di creare profili degli utenti in base ai loro interessi e queste informazioni vengono successivamente raccolte da piattaforme e possono essere vendute a terzi,come ad esempio ad agenzie di marketing che li utilizzano per studiare oa pubblicità. Ci sono anche servizi che sono a pagamento per utilizzare tutte le funzioni e i servizi completi del sito.
3. Identità e nativi digitaliI media digitali, e in particolare le piattaforme sociali, sono strumentiin cui gli individui mettono in atto strategie attive di costruzione della propria identità. I rituali di presentazione del sé, attraverso i quali le persone si rappresentano in pubblico e costruiscono la propria identità comprendono la decisione di che foto caricare, scegliere i propri amici, aderire ad un gruppo, postare le immagini che lo rappresentano politicamente e non, link. Tutto questo crea l’identità dell’utente, rivelando qualcosa di sé o di quello che vorrebbe essere, rivelando il modo di vestirsi, gli hobby, le preferenze musicali e molto altro.Nei media sociali che rendono visibili i legami sociali tra le persone, il contenuto dell’informazione pubblicata può essere meno rilevante rispetto al contesto in cui avviene la comunicazione. Su Facebook ad esempio, l’immagine di una foto al tramonto postata su il profilo di un’amica può essere importante non solo per quello che ritrae ma soprattutto perché ribadisce una relazione e può segnalare un qualcosa.Tuttavia i media sociali non determinano l’identità di una persona, ma bensì la incorniciano.Con la definizione di nativi digitali vengono descritti quei giovani nati a stretto contatto con le tecnologie, con internet, le consolle, propriamente i nativi sarebbero i giovani nati negli anni’2000, mentre i nati negli anni’90 rappresenterebbero una generazione intermedia poiché hanno avuto un’alfabetizzazione digitale precoce ma non immediata. Poi troviamo i migranti digitali, cioè quelle persone che in fase adulta hanno dovuto imparare a utilizzare codici digitali e un linguaggio diverso dal loro, nati prima dell’avvento di internet, in un mondo dominato dalla carta stampata e dalla televisione.
26
4. Individualismo in rete e nuovi pubbliciTroviamo 2 forme di relazioni sociali:
- relazioni comunitarie: caratterizzate da alti livelli di coinvolgimento, di fiducia e conoscenza reciproca. Queste si articolano nella forma della comunità, dove questa viene prima dell’individuo e le norme che regolano la vita sociale sono molto forti e a volte oppressive;
- relazioni sociali: sono tipiche della modernità, caratterizzate dall’importanza di associazioni dotate di regole formali ed esplicite come le organizzazioni burocratiche, i partiti. Il senso di identificazione con la collettività è meno intenso, le forme di interazioni sono meno calde ma anche meno opprimenti, i livelli di solitudine sono più alti. Nella società si è più liberi ma anche più soli che nella comunità.
La diffusione dei media sociali è stata interpretata come la nascita di una terza forma di relazioni sociali, chiamata individualismo di rete è il risultato della coordinazione di una grande quantità di opportunità e scelte individuali abilitate dai media digitali. Qui l’individuo appartiene a una moltitudine di reti sociali, diverse, disconnesse tra loro, e in ogni rete, l’individuo può mostrare o sviluppare un aspetto particolare della sua identità. Non ci sono appartenenze e ognuno agisce in base alla propria scelta personale. Simmel dice che l’esperienza individuale tipica della modernità è caratterizzata dalla contemporanea appartenenza a diverse gerarchie.Facebook, Twitter, i forum, Wikipedia e molti altre forme di socialità basate sui media digitali sono state descritte come pubblici connessi, inveceche comunità. Il termine comunità in sociologia implica una forte densitàrelazionale, i membri di una comunità interagiscono gli uni con gli altri, condividono significati, valori e norme spesso vincolanti. Invece le appartenenze costruite dai media digitali non si possono considerare sempre comunità perché, spesso gli individui non si conoscono direttamente e condividono solo aspetti o comportamenti parziali.Il termine pubblico indica che queste collettività sono meno dense e totalizzanti rispetto le comunità; far parte di un pubblico (come far parte del gruppo delle mamme online) non è un elemento vincolante per l’identità di una persona (come può essere l’essere membro di una comunità religiosa locale). Anche se meno densi e vincolanti per la costruzione delle identità personali, i pubblici offrono la possibilità di identificarsi con una causa comune.La comunità tende a durare nel tempo conservando gli stessi membri, uscire da una comunità può essere difficile a causa dei legami profondi
27
che si creano; al contrario nei pubblici l’ambiente è più fluido e transitorio (come ad esempio il pubblico di Twitter riunito attorno ad unhashtag), è un fenomeno sociale più tranquillo rispetto la comunità.
Nelle comunità premoderne l’identità della persona era dettata dalla tradizione; nelle associazioni moderne invece l’identità dipende in partedalle scelte individuali (appartenere o meno ad un particolare gruppo).Nel caso dell’individualismo in rete l’identità viene costruita tramite una serie di scelte, come i pubblici a cui appartenere, con quale grado di coinvolgimento farne parte.
5. Reputazione e influenzaL’importanza dei media digitali come strumenti di costruzione di relazioni sociali sono intimamente legati alla reputazione personale degli individui.La reputazione è un giudizio sulle qualità di una persona, anche sconosciuta, che viene espressa sulla base di informazioni pubbliche e anche il pubblico stesso fa parte della sua costruzione.I media digitali amplificano e trasformano il modo in cui le reputazioni vengono create e alimentate, e forniscono alla persona nuovi strumenti per gestire la propria reputazione. I membri di un pubblico acquistano reputazione sulla base del modo in cui gli altri membri giudicano i loro contributi, sulla rilevanza, sull’adesione alle loro opinioni, e alle loro azioni rispetto alle aspettative della comunità.Molte piattaforme hanno software per calcolare la reputazione dei proprimembri. Questi sistemi si basano su forme di rating, dove ad esempio gli altri membri possono valutare un altro utente attribuendogli un punteggionumerico o rappresentato da un simbolo. La reputazione garantisce una posizione migliore all’interno del gruppo (es. sono i feedback sulla piattaforma di Ebay, dove chi ha i feedback positivi tende a concludere maggiori transazioni).La natura comunicativa che è alla base della struttura dei media sociali fa si che l’identità di una persona non possa essere semplicemente vissuta ma che debba essere anche comunicata. In questo senso l’individuodeve creare una versione comunicabile della sua identità, una specie di brand personale, diventando così una costruzione ragionata e riflessiva destinata ad essere comunicata sui media sociali.Le comunicazioni sui media sociali sono: persistenti, replicabili, scalabili e ricercabili.La possibilità di maneggiare il proprio brand personale porta al diffondersi dei sistemi di influenza degli individui. Nascono i
28
cosiddetti influencers, individui con una grande impatto che sono in grado di mobilitare un gran numero di utenti grazie alla loro influenza costruita attorno alla propria reputazione. Questi utenti della rete sonoconsiderati risorse cruciali al momento di lanciare una campagna di marketing o una campagna politica.
6. Privacy e controlloLa proliferazione delle appartenenze a diversi ambienti mediatici può avere degli effetti importanti sulla privacy delle persone. Le piattaforme hanno scardinato la concezione della privacy basata sul diritto a una vita privata e non visibile al pubblico, le forme di socialità in rete spingono gli individui a condividere e mostrare informazioni personali e intime.Tuttavia oggi le persone sanno negoziare i livelli di privacy per creare un controllo attivo sulle informazioni che le riguardano, hanno imparato quali aspetti della vita privata possono mostrare.
CAPITOLO 6Economia dell’informazioneLa rete è dominata da nuovi attori economici. Le tecnologie digitali hanno favorito fenomeni di organizzazione della produzione basati su innovazione flessibile e hanno contribuito a trasformare il lavoro e il consumo.
1.Modelli economici del webInternet e i media digitali hanno una grande rilevanza economica:
- da un lato per l’importanza sul mercato delle tecnologie come: personal computer, tablet, smartphone, televisori, che rappresentano prodotti di consumo a livello globale e che sostengono le economie dei paesi produttori di componenti e hardware come i paesi asiatici e nordici e quelle dei paesi che gestiscono i processi di innovazione e marketing, come gli Stati Uniti e la Cina;
- dall’altro perché sui media digitali si basa un economica sviluppata direttamente dalla rete, in termine di servizi venduti epubblicità, delle grandi imprese del web: come motori di ricerca, social network e altro.
Con la diffusione di massa all’accesso a internet avvenuta nella secondametà degli anni’90, si sono scatenate ondate di investimenti a favore delle imprese del web. Le innovazioni tecnologiche hanno portato a
29
numerosi cambiamenti e possibilità alle imprese produttrici di informazioni e conoscenza.Un esempio è la coda lunga, il modello su cui si basa Amazon, e si riferisce alla massa di opportunità marginali che con i media digitali diventa possibile gestire: invece di vendere solo pochi titoli molto popolari, ognuno dei quali viene acquistato da migliaia di persone, Amazon realizza i suoi guadagni vendendo poche copie di moltissimi autoriche rappresentano la <coda> del mercato e non la sua vetta e che sommati formano una massa tale da portare al guadagno dell’azienda.Il successo della coda lunga per le società online dipende dal fatto cheinternet facilita la scoperta e l’integrazione di informazioni (come la ricerca di libri poco conosciuti) e permette all’azienda di accumulare enormi quantità di libri in giganteschi magazzini automatizzati e gestitiper via informatica.In poche parole Amazon riesce a compiere il lavoro di centinaia di piccole librerie che devono sopportare costi amministrativi elevati e nonhanno lo spazio fisico per immagazzinare migliaia di titoli pubblicati ogni anno, ma devono quindi rinunciare ad una grande fetta di loro per concentrarsi su quelli che vendono di più (un altro settore che ha usato il metodo della coda lunga è quello del microcredito come le società finanziarie nei paesi in via di sviluppo come la Grameen Bank in India e in Bangladesh che forniscono crediti limitatissimi a moltissime persone equeste società così facendo riescono ad attirare un volume di affari notevoli senza il bisogno di grandi investitori).L’idea base del web 1.0 era quella dove la rete fosse una sorta di “biblioteca di contenuti” dove gli utenti potevano visionare il materialema non produrlo; l’idea dei content providers, cioè dei fornitori di contenuti, era quindi quella di far pagare l’accesso ai contenuti online.Ma questo settore è diventato sempre meno sostenibile sul mercato di massa e con l’arrivo del web 2.0, con blog, siti come YouTube, Facebook, e molti altri agli utenti è stata data la possibilità di visitare, produrre e distribuire contenuti anche a scapito delle grandi industrie come quelle musicali o cinematografiche.Ma l’avvento di queste nuove tecnologie digitali e dell’uso della rete haanche modificato l’economia di alcuni settori, ad esempio: l’industria cinematografica ha visto crollare i guadagni da ottenuti tramite la vendita di film nei cinema o di dvd a causa dei nuovi siti di sharing e distribuzione come eMule, Utorrents ma questi content providers si sono allo stesso tempo uniti con produttori di altri tipi di contenuti, come ad esempio Matrix non è soltanto una trilogia cinematografica ma è diventato anche un videogioco, cartoni animati, libri.
30
La diffusone di internet ha fatto anche rivedere una rivincita di questi content providers, come ad esempio le app usate sugli smartphone e tabletaprono nuovi canali e contenuti a pagamento. L’editoria stessa si trova davanti ad un enorme cambiamento con gli eBook che stanno conquistando grandi fette di mercato a discapito dei classici libri stampati.
Con il web 2.0 nato all’inizio degli anni 2000, la rete non si fonda più solo su siti che fungono da raccoglitori di contenuti, ma anche su piattaforme che invitano a una maggiore partecipazione da parte degli utenti. I modelli di business del web 2.0 si basano sulla cocreazione da parte degli utenti come ad esempio i siti di rating e dating, da TripAdvisor a Match.com.Un altro ramo dell’economia del web è composto da motori di ricerca. La prima impresa commerciale fu Netscape nata negli anni’90, oggi invece il leader è Google. Alla base di Google vi è un software chiamato page rank che analizza i link visitati dagli utenti per determinare la rilevanza diun sito rispetto ai termini e alle parole chiave cercate dall’utente. Google fornisce quindi una classifica in cui il sito che sta più in alto nei risultati di ricerca è quello più linkato.Google è in grado di offrire servizi gratuiti perché usa le informazioni raccolte sugli utenti, dalle loro ricerche, dalle informazioni prese da servizi di sua proprietà come Gmail, YouTube, Google Maps o Android, per fornire pubblicità personalizzate.Grazie a queste attività di profilazione i software di Google <conoscono> l’età, i gusti, le abitudini di consumo, la città di provenienza e altro dei suoi utenti. Grazie a questo Google può vendere spazi pubblicitari adun alto valore aggiunto, dato che è in grado di inviar le pubblicità ad utenti specifici (un adolescente di NY che fa ricerche su videogames riceverà pubblicità di una nuova consolle, mentre ad un dirigente d’azienda che vive a Milano e appassionato di cucina appariranno annunci di ristoranti costosi della sua città). Google non è quindi solo un fornitore di servizi o un motore di ricerca, ma dal punto di vista economico è la più grande agenzia pubblicitaria del mondo.Gran parte dei siti web e dei servizi gratuiti che popolano la rete dipende dagli investimenti pubblicitari, come i media tradizionali. Tuttavia il mercato pubblicitario del web è profondamente diverso da quello tradizionale. Inizialmente i siti web pubblicavano annunci il cui costo dipendeva dal numero di visitatori del sito, esattamente come accade oggi nell’editoria (costa più una pubblicità sul Corriere della Sera rispetto a uno pubblicato sul Resto del Carlino), oggi invece sono mersi modelli più sofisticati come il click trought, cioè gli
31
inserzionisti pagano sulla base di quanti visitatori cliccano sulla pubblicità e accedono effettivamente ai suoi contenuti e non più su chi visita solo il sito dove è stata pubblicata la pubblicità.Il sostentamento economico del web è quindi la fornitura di servizi gratuiti resi possibili dalla raccolta di introiti pubblicitari.Finora però, poche aziende (Google) sono riuscite ad assicurarsi un sostentamento economico e a guadagnarsi una buona valutazione di mercato tesa ad attirare investimenti pubblicitari.In questo scenario emergono così modelli parzialmente differenti, come quello di LinkedIn, un social network per professionisti che richiede il pagamento di una quota di abbonamento agli utenti che vogliono utilizzarei servizi <premium>, cioè quelli più specializzati; Groupon, che aiuta i consumatori a trovare le migliori offerte e sconti da parte delle impreselocali, trattiene una parte del denaro speso per il bene o servizio acquistati. Infine troviamo il crowdfunding, letteralmente <finanziamento della folla> , è un sistema di raccolta fondi per progetti no profit e per imprese start-up basato su piattaforme online. Qui gli individui possono contribuire con un piccolo finanziamento. Lo stesso Barack Obama ha usato nelle sue campagne elettorali forme di raccolta fondi simili.
2. Prodotti intangibili: BrandNell’economia dell’informazione la creazione di valore si sposta dalla produzione di beni materiali alla produzione di beni immateriali. Nell’economia dell’industria l’attività centrale era la lavorazione e la trasformazione delle materie prime in oggetti materiali (frigoriferi, automobili) destinati ad un mercato di massa; nell’economia dell’informazione questa centralità è occupata dalle risorse intangibili,ciò non significa che non si producono beni materiali, anzi se ne producono di più, ma le maggiori fonti di lavoro diventano attività che richiedono particolari competenze di elaborazione dell’informazione:
- l’innovazione: è la capacità di creare continuamente novità sia tecnologiche, sia design e di stili di consumo (questo è il segretoe il successo di Apple);
- la flessibilità: è la capacità di rispondere rapidamente alla domanda dimercato in modo che il numero pressoché esatto di meri si trovi al posto giusto nel momento giusto (questo è il segreto di Ikea);
- il brand: non è solo il marchio di un prodotto ma piuttosto la capacità di generare la percezione pubblica di una differenza fra prodotto e un altro. (Nike ad esempio è in grado di creare la percezione che le sue scarpe siano radicalmente diverse da altre scarpe da ginnastica).
32
_L’importanza economica del brand è cresciuta con la standardizzazione della produzione; prima della rivoluzione industriale i beni di uso quotidiano erano prodotti localmente e in modo artigianale, il processo di industrializzazione ha standardizzato i prodotti.Diventa dunque importante introdurre tecniche di branding per creare la percezione che esista una differenza tra i vari prodotti, formati a livello industriale: investendo in pubblicità o sponsorizzando eventi da quello sportivo a quello musicale per legare il prodotto venduto ad uno stile di vita, cioè ad un insieme riconosciuto di comportamenti e valori,in modo da creare una distinzione con gli altri prodotti. Il peso complessivo delle risorse intangibili come componente del valore di mercato delle aziende industriali è cresciuto molto rappresentando il 70%del valore complessivo e in questo cambiamento il brand è la parte più importante che ricopre da solo il 30% del valore delle imprese._Il brand è un elemento utile per catalizzare l’attenzione, l’affettivitàe la creatività dei consumatori. La creazione di risorse intangibili comeil brand è sempre più socializzata, negli anniì80 le imprese hanno iniziato a mettere in campo strategie come il customer relations management, cioè la gestione delle relazioni con i clienti, la centralitàdell’impresa si sposta dal valore estetico dell’immagine del brand al livello sociale, cioè le relazioni che la marca è in grado di intrattenere con il cliente (ad esempio le carte fedeltà degli ipermercati, con le quali riescono a generare legami e conoscere i clienti e le loro abitudini).In tutto questo i media digitali hanno permesso di allargare queste pratiche.Oggi i consumatori discutono e si confrontano il rete, su blog, piattaforme, creando delle brand communities create nell’interesse di un brand tipo Apple, Harley Davidson, che possono nascere spontaneamente ed essere osservate dalle aziende per trarne informazioni utili o possono essere le stesse imprese a dar vita a blog e piattaforme per stimolare comunità attorno al proprio brand, per raccogliere informazioni ed idee che possono essere usate nelle campagne di marketing o addirittura nell’innovazione del prodotto, come ad esempio la Barilla che ha lanciatola campagna “nel mulino che vorrei” dove i clienti possono fornire suggerimenti all’azienda, votare e discutere le idee. Queste campagne sono molto importanti quanto rischiose, come il caso dell’Ikea dove una campagna simile alla Barilla è stata invasa da centinaia di commenti negativi riguardanti un problema sui diritti del lavoratori in uno dei suoi magazzini.
33
_Il brand è una risorsa intangibile e non può essere separata dalle proprietà materiali di un prodotto: l’esperienza Apple è inseparabile dall’esperienza touch; come viene presentato e il contesto in cui viene servito ’hamburger fa parte dell’esperienza del McDonald’s. l’innovazioneè inseparabile dal prodotto innovato (la Bmw produce automobili e motociclette, ma più della metà del suo valore di mercato è dovuta al suomarchio, cioè ad un artefatto culturale).
3. Lavoro, consumo e prosumerismoI media digitali sono legati alle trasformazioni nelle dinamiche di lavoro e consumo. Questi cambiamenti sono legati all’emergere di nuovi mestieri e professioni connesse ai media digitali come: web designer, programmatori, amministratori di rete, pubblicitari. Le professioni esistenti sono cambiate grazie all’integrazione dei computer e delle reti di pressoché ogni lavoratore, dal medico che utilizza la rete per verificare una pubblicazione scientifica di un farmaco al magazziniere che organizza il suo lavoro tramite software di gestione delle procedure di carico e scarico del materiale. Lo stesso vale per le attività di consumo, che avvengono sempre più spesso attraverso al rete come i siti di acquisti online che beneficiano di sistemi digitali come carte di credito o sistemi di pagamento come PayPal.Il nuovo lavoratore è un individuo più flessibile, capace di spostarsi daun team all’altro, che ha nuove capacità e competenze, di relazione. Il compito del management diventa non solo quello di comandare e controllare, ma anche di stimolare entusiasmo e passione da parte dei lavoratori. L’azienda viene presentata come un’impresa comune, diretta non semplicemente dal profitto ma anche dal raggiungimento di mete sociali ed eticamente condivisibili.Nasce la classe creativa, che descrive nuove forme di lavoro della conoscenza messe in atto da professionisti urbani che lavorano nelle cosiddette industrie creative legate ai media digitali, cioè alla produzione di brand, comunicazione, eventi e design.
4. Disuguaglianze e sviluppo nella società dell’informazioneNonostante la retorica dell’uguaglianza e della democrazia che circonda imedia digitali, nella società dell’informazione le risorse sono tutt’altro che distribuite equamente.Il digital divide, o divario digitale, è la disparità tra chi ha accesso ai media digitali e chi no; questa disparità non riguarda solamente chi ha o non ha accesso alla rete, ma è più complessa perché vi può essere o
34
meno la disponibilità della banda larga, delle disponibilità di tecnologie mobili.La disuguaglianza nell’accesso ai media digitali è considerata una fonte di disuguaglianza a livello sociale ed economico, dato che incide sulle qualità degli individui e sulla partecipazione mondiale dei paesi sottosviluppati.La disparità più visibile è appunto quella tra i paesi ricchi e quelli poveri (può esserci questo divario anche tra regioni come in Italia Nord/Sud). Oltre alle aree geografiche vi sono altri fattori che determinano un accesso ineguale alle tecnologie digitali:
- ostacoli di natura politica: paesi come Cina e Iran limitano l’accesso a siti e servizi online d’informazione, ritenuti pericolosi per la stabilità politica;
- imposizioni dall’esterno: Il caso di Cuba, che ha avuto un accesso limitato alla banda larga a causa dell’embargo statunitense;
- la capacità di usar le tecnologie: questo deficit è determinato daifattori culturali e di educazione;
- la classe sociale: i ceti meno abbienti hanno meno possibilità di accesso;
- il genere può essere un altro fattore di disparità dato che in alcune aree del mondo le donne hanno meno accesso degli uomini alletecnologie.
Il divario digitale è legato allo sviluppo economico, anche se resta ancora da chiarire il rapporto causa/effetto: se il sottosviluppo è causadello scarso accesso ai media digitali o la mancanza di accesso è causa di mancato sviluppo.Sono state adottate varie strategie per cercare di risolvere il problema e la stragrande maggioranza delle iniziative si basa sul fornire più accesso alle tecnologie di informazione a un paese povero:
- la distribuzione di tecnologie come One Laptop per Child: si proponeva di costruire e distribuire un piccolo computer a un bassocosto ai bambini dei paesi in via di sviluppo, dotato di particolari caratteristiche come ad esempio un sistema operativo open source, software per l’uso scolastico e la collaborazione online, resistente agli urti, e fornito di batteria ricaricabile a manovella (questo progetto e simili hanno avuto un effetto limitato);
- la creazione di notebook, cioè personal computer piccoli e a basso costo sono stati rilevanti nei paesi ricchi.
Secondo alcuni sarebbe molto più importante porre l’accento sull’accesso all’informazione e non solo alle tecnologie. Un eccessivo sviluppo delle
35
proprietà intellettuali, da quelle farmacologiche ai sistemi operativi, alla conoscenza scientifica è sempre stato indicato come una delle problematiche maggiori dei paesi più poveri, che sono dei grandi importatori di informazione e non possono permettersi di pagare le royalty necessarie per avere accesso all’informazione protetta.Soluzioni necessarie sono basate sui beni comuni, che si fondano sull’accesso all’informazione. Un paese che non può permettersi di acquistare licenze Microsoft per sistemi operativi di computer usati per la pubblica amministrazione, dalle scuole o dall’università piò decidere di adattare sistemi operativi open source come Ubuntu, che sono gratuiti e liberamente modificabili.Tuttavia le risposte al problema del divario digitale non sono ancora soddisfacenti.Il digital divide è un fenomeno complesso e stratificato che si compone di differenze economiche, politiche e infrastrutturali, culturali e sociali.
CONCLUSIONII 2 poli sulle tecnologie mediatiche:
- tendono a sovvertire i valori tradizionali, alienare le persone l’una dall’altra e generare solitudine e stupidità, i media digitali abbassano il livello di produzione culturale, tendendo a sostituire l’industria culturale con una massa di contenuti di bassa qualità accumulati su siti come YouTube e promuovendo una nuova società del controllo dove le vite sono soggette a sorveglianza e niente rimane privato;
- le nuove tecnologie sono come un passo verso la modernità che contiene la promessa di risolvere i problemi dell’umanità, portano con sé la promessa di una democrazia più diretta, di nuove forme dimobilitazione politica, di mercati più aperti e democratici e, nuove forme di produzione peer-to-peer e open source, di un modo radicalmente nuovo di organizzare la produzione e di distribuzione di ricchezza.Chi ha ragione? Probabilmente entrambi.
I media digitali stanno cambiando il modo in cui viviamo insieme, ci relazioniamo l’uno con l’altro, la partecipazione politica.Questi cambiamenti sono legati alla distribuzione di valori e forme di vita che molti ritengono cruciali, come la privacy o l’abitudine alla lettura di libri e quotidiani e altri valori a livello di vita.Il potenziale di queste tecnologie è immenso, hanno il potere di guidare il cambiamento sociale, ma l’esito di questi mutamenti dipende da molti
36
fattori e non solo dalle tecnologie stesse ma soprattutto da noi stessi, perché siamo noi ad aver inventato queste tecnologie, siamo noi a governarle e a decidere di quello che sarà, la direzione di quel cambiamento dipende da scelte e decisioni che si esercitano su molteplicilivelli.L’equilibrio tra la capacità di facilitare la vita relazionale e quella di realizzare nuove forme di controllo e sorveglianza che determina l’esperienza di Facebook non dipende solo dal design della piattaforma maanche e soprattutto dalla natura aperta e democratica oppure chiusa e dittatoriale dalla società in cui viene usata l’impatto dei media digitali dipende in gran parte dai contesti sociali all’interno dei qualiqueste tecnologie vengono usate.Le legislazioni e le regolamentazioni che riguardano le aziende che operano in internet, dalla neutralità in rete, alla protezione della privacy sono un altro livello cruciale che modifica l’andamento di questo nuovo mondo.L’architettura aperta di internet è sottoposta a minacce, e la sua neutralità messa in dubbio: mentre le aziende che basano i loro modelli imprenditoriali (piattaforme) sulla facilitazione dell’interazione tra utenti e della produzione e distribuzione di contenuti preferiscono il modello neutrale che ha sempre caratterizzato la rete; i provider che gestiscono le infrastrutture e i produttori di contenuti spingono ad architetture non neutrali. I sistemi di collaborazione aperta realizzano uno dei potenziali economici delle tecnologie digitali, ma le imprese mirano a contenerli.I terreni di proprietà intellettuale (copyright) e la pirateria restano terreni di scontro cruciali, ci sono sempre più pratiche per tutelare consoluzioni tecnologiche e regolamentazione i diritti d’autore.I movimenti per la cultura libera e la diffusione di forme di produzione peer-to-peer basate sui beni comuni dell’informazione cercano di rafforzare un modello di protezione della proprietà intellettuale alternativo (copyleft).Anche la politica globale è un livello di scontro: le nazioni usano la rete e le tecnologie informatiche per motivi bellici o economici. L’uso della rete per scopi politici va al di là degli strumenti organizzative arriva a comprendere forme di mobilitazione sociale facilitate dai media digitali, la diffusione di pratiche hacker nel giornalismo (come il caso di WikiLeaks), o nuove forme di sabotaggio come quelle messe in atto da Anonymus.La rete porta con sé nuovi modelli economici ma influenza anche quelli esistenti.
37
Le politiche antistrust (che caratterizzano il sistema dei media broadcast) è stata rinnovata dall’egemonia e dalla pervasività dei media digitali.Infine c’è il livello tecnologico. Le risorse materiali come l’etere, i cavi sottomarini in fibra ottica o il design delle piattaforme per connettersi alla rete sono un altro campo in cui occorre prestare attenzione a quali tecnologie b vengono sviluppate e adottate. La divisione del lavoro su cala globale affida ad alcuni paesi il ruolo di fornitori dio materie prime e lascia ad altri la possibilità di guidare iprocessi decisionali basati su quelle risorse (vedi caso Apple, in Cina producono le materie prime e il lavoro finito e negli Stati Uniti ci sonoi processi decisionali).La decisione di prendere alcune decisioni e on altre dipendono solo in parte da attori potenti come governi e multinazionali, ma anche da una moltitudine di decisioni e innovazioni provenienti dal basso, da gruppi di programmatori indipendenti o movimenti sociali che sono in grado di creare standard tecnologici che formano nuove visioni della rete. Questa politica dal basso è destinata a mantenere un ruolo di primo piano o addirittura a intensificarsi con l’aumento del numero di individui capacidi programmare e modificare i media digitali. Senza togliere importanza alle decisioni e alle scelte politiche, giuridiche o delle grandi impreseprivate, possiamo ipotizzare che la direzione che verrà presa dalla società dell’informazione con lo sviluppo e la diffusione del web mobile dipenderà in gran parte anche da questa forma tecnopolitica dal basso.