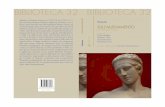Breve introduzione al diritto ecclesiastico pubblico concordatario
Transcript of Breve introduzione al diritto ecclesiastico pubblico concordatario
ACADEMIA HISTORICO – IURIDICO – THEOLOGICA PETRUS TOCĂNEL
Instituti Theologici Franciscani
S T U D I A E T D O C U M E N T A Director: Maximilian PAL
_____________________ 6 ____________________
DANILO CECCARELLI-MOROLLI
BREVE INTRODUZIONE AL DIRITTO ECCLESIASTICO PUBBLICO-CONCORDATARIO
2004
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
2
ACADEMIA HISTORICO – IURIDICO – THEOLOGICA
PETRUS TOCĂNEL
Instituti Theologici Franciscani
Coloana «STUDIA ET DOCUMENTA» Comitetul ştiinţific internaţional: ROMAN: Av. Dr. I. CHELARU; V. CIUCĂ, I. CIURARU; M. DĂMOC;
V.E. DUMITRESCU; A. S. GIURGI; M. PAL; M. POPOVICI ROMA: D.J. ANDRÉS GUTIERRÉZ; � T. BERTONE; O. BUCCI;
D. CECCARELLI-MOROLLI; G. GIROTTI; A. MONTAN Secretariat ROMAN: Marius-Gabriel CĂLIMAN Institutul Teologic Franiscan Str. Ştefan cel Mare, 268/B RO-611040 Roman, jud Neamţ
Tel.: +40-233-742374 Fax: +40-233-741459
e-mail: [email protected] Segreteria di ROMA: Alessandro BUCCI Viale Eritrea, 81 00199 ROMA – ITALIA TEL. E FAX: +39-06-86325625 e-mail: [email protected]
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
3
INDICE
Premessa 4
Capitolo Primo – Alcune nozioni introduttive 5-13
§1. Alcuni concetti di base §2. Il Diritto Ecclesiastico e la scienza giuridica §3. Fonti del Diritto Ecclesiastico Capitolo Secondo – Brevi cenni sui rapporti fra Chiesa e Stato 14-35
§1. Nota introduttiva §2. Chiesa e Impero dalla pace costantiniana all’età carolingia §3. Dalla lotta per le investiture alla formulazione della teoria teocratica §3.1. Cenni sulla dottrina canonistica sul potere pontificio §4. La Chiesa di fronte alla nascita degli stati nazionali: il “regalismo” §4.1. Il Liberalismo nei rapporti fra Stato e Chiesa §5. Cenni sui rapporti fra Stato e Chiesa: i sistemi vigenti Capitolo Terzo – L’Istituto concordatario 36-53 §1. Verso una definizione dell’istituto concordatario §2. Natura giuridica ed effetti giuridici del Concordato §3. Soggetti del Concordato §4. Oggetto del Concordato §5. Forma ed interpretazione del Concordato §6. Cessazione del Concordato e conseguenze giuridiche §7. Cenni sulla storia dell’istituto concordatario Capitolo Quarto – Alcune tematiche 54-93
§1. L’istituto concordatario oggi: breve panoramica sui concordati §2. Cenni sul diritto ecclesiastico italiano e la sua importanza §3. Lo Stato della Città del Vaticano §4. Cenni sulla problematica dei rapporti fra Chiesa e Stato nei paesi islamici §5. Alcune note in merito al modus vivendi stipulato fra la S. Sede e la Tunisia e
lo scambio di note con il Marocco
§6. La S. Sede ed il riconoscimento dello Stato di Israele: breve nota §7. La S. Sede e l’O.L.P.: breve nota sull’Accordo del 2000 §8. I Patriarchi delle Chiese cattoliche orientali e le convenzioni con l’autorità
civili: breve nota
Breve Nota Bibliografica 94-100 Appendici: - Accordi del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la S. Sede - Modus Vivendi con la Repubblica Tunisina del 27 giugno 1964 - Dello Statuto della Chiesa Cattolica in Marocco – Scambio di note (30 dicembre
1983 – 5 febbraio 1984) - Accordo con lo Stato di Israele (30 dicembre 1993) - Accordo di Base con l’O.L.P. (15 febbraio 2000)
101-132
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
4
PREMESSAℵℵℵℵ
Al Rettore del Pontificio Istituto Orientale Prof. HÈCTOR VALL VILARDELL SJ
Il diritto ecclesiastico rappresenta una delle grandi aree di interesse sia per il canonista, che lo considera ius ecclesiasticum externum, che per il civilista, che lo stima come un ramo del diritto pubblico statale.
Nel corso dei secoli della storia cristiana, le relazioni fra Chiesa e potere politico prima, e Stato poi, hanno generato una serie di norme di natura pattizio-concordataria, che sono l’espressione giuridica dei concordati, rappresentando così ciò che si è soliti definire sic et simpliciter diritto ecclesiastico. Pertanto desidero accogliere tale accezione omettendo l’aggettivazione “esterno” – cara per altro alla scienza canonica – al fine di essere il più schematico possibile. Dunque queste poche righe desiderano rappresentare una sorta di breve introduzione – quasi un “farsi un’idea” – circa una così complessa materia.
Desidero pertanto indirizzare questo piccolo lavoro agli studenti della
Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale, al fine di poterli
agevolare, ma anche incoraggiare nel loro studio personale; perciò la struttura
di queste poche pagine tenta – forse maldestramente – di voler “guardare” ad
Oriente o verso Oriente nonostante la materia sia considerata come un settore
disciplinare tipicamente occidentale.
A conclusione di queste brevi parole introduttive, è mio desiderio
esternare l’espressione del mio ringraziamento al Prof. Avv. Alessandro Bucci
ed al P. Prof. Cyril Vasil’ sj – Decano della Facoltà di Diritto Canonico Orientale
– che mi hanno incoraggiato verso tale iniziativa ed a cui va la mia tutta la mia
gratitudine.
ℵ
Elenco delle principali abbreviazioni usate: AAS = Acta Apostolicae Sedis; art. = articolo; ASS = Acta Sanctae Sedis; C. = concordato; c./cc. = canone, canoni; CCEO = Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1990); CIC = Codex Iuris Canonici (1983); CIC* = Codex Iuris Canonici (1917); DDC = R. NAZ, (a.c.d.), Dictionnaire de Droit Canonique, Paris 1935-1967; NDDC = C. CORRAL - V. DE PAOLIS - G. GHIRLANDA, Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, Cisinello Balsamo (Milano) 1993; OCHOA = X. OCHOA, Leges Ecclesiae, Romæ 1967-1980; SCV = Stato della Città del Vaticano; rat. = ratificato.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
5
CAPITOLO PRIMO
ALCUNE NOZIONI INTRODUTTIVE Sommario: §1 Alcuni concetti di base §2. Il diritto ecclesiastico e la scienza giuridica §3. Fonti del diritto ecclesiastico
§1 Alcuni concetti di base
Dare una definizione di che cosa sia il diritto è un vero problema. Tale questione infatti, a seconda di quale angolazione la si guardi, presenta una eccezionale quantità di problematiche. In questa sede non si entrerà pertanto in merito a disquisizioni filosofiche, poiché ciò è compito proprio della filosofia del diritto. Nel corso della storia del pensiero umano molti sono stati i filosofi che diedero proprie definizioni in merito, e – dai Presocratici fino ai nostri giorni – tutte queste potrebbero adattarsi ora ad un momento storico ora ad un altro. Una cosa comunque appare chiara: il diritto non è un qualcosa di isolato ma è intimamente connesso con la morale, con la società e con lo stato; ed è impensabile oggi credere di poter studiare il diritto senza la filosofia, la sociologia, le scienze economiche e tutte le altre discipline ad esso affini e contigue (logica, retorica, linguistica, ecc.). Tuttavia – nonostante le difficoltà di una definizione – è utile, ed allo stesso tempo possibile, accettarne una. Personalmente ritengo appropriata la definizione data a suo tempo da G. DEL VECCHIO, secondo il quale il diritto è: «il coordinamento obiettivo delle azioni possibili tra più soggetti, secondo un principio etico che le determina, escludendone l’impedimento». Dunque il diritto è quel complesso di norme derivate da disposizioni sia di natura legislativa che consuetudinaria, regolanti i rapporti reciproci fra i membri di una comunità e tra una comunità ed un’altra. Ecco quindi
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
6
delinearsi anche il concetto di Stato1, che è dato dalla sommatoria di precisi
fattori quali: popolo2, territorio
3, sovranità
4. Il diritto allora può essere:
oggettivo (cioè l’insieme delle regole che disciplinano in modo astratto la condotta dei consociati (cosiddette normæ agendi) oppure soggettivo (ossia come potere di agire – facultas agendi – che viene riconosciuto ad un soggetto per la soddisfazione di diritti e doveri).
A sua volta il diritto oggettivo è suddiviso in diritto pubblico e privato5.
Il diritto pubblico concerne l’organizzazione della comunità e mira a regolare la struttura dello Stato e dei suoi enti, esso inoltre regola i rapporti fra sudditi e Stato. Il diritto privato, invece, è il complesso di norme che disciplinano i rapporti giuridici tra i membri della comunità, fissando i presupposti ed i limiti agli interessi degli stessi, che vengono in tal modo a trovarsi in condizione di parità giuridica. Intimamente connesso al concetto di diritto è quello di norma giuridica, che è definibile come quella regola mirante a disciplinare la vita di una data comunità-società e che fa parte di quell’insieme sistematico di norme che è il diritto; essa è rispettata sotto la minaccia di una determinante sanzione. La sanzione è infatti la reazione che un dato ordinamento giuridico minaccia nei confronti di chi violi le norme. Caratteristiche, allora, della norma giuridica sono: generalità, l’astrattezza e
1 In generale sul concetto di Stato ed i suoi elementi costitutivi cfr. M. MAZZIOTTI DI
CELSO, Lezioni di Diritto Costituzionale – Parte I, Nozioni generali sul diritto e sullo Stato, Milano 19932, 55-129. 2 Per popolo si intende non già la “popolazione”, ma i cittadini, cioè coloro che hanno – in base alle leggi vigenti – la cittadinanza di quel determinato stato; la popolazione è invece l’insieme dei residenti (cittadini e non cittadini) in quel determinato stato e quindi in quel determinato territorio. 3 Il territorio è formato: dallo spazio terrestre delimitato dai confini territoriali, dallo spazio aereo sovrastante (fino ai 30-40 km che è l’area in cui arriva la navigazione aerea convenzionale), dal sottosuolo ed infine dal mare territoriale (le acque territoriali sono costituite dalla fascia costiera della larghezza di 12 miglia nautiche). 4 Meno semplice è il concetto di sovranità. Jean BODIN, nel 1583, definì la sovranità come «la puissance absolute et perpétuelle d’une république». Lo stato è un ordinamento a fini generali, il cui carattere è originario; tale origniarietà dell’ordinamento definisce la sovranità dello stato. 5 Già i Romani avevano nozione di tale distinguo; affermava infatti CELSO: «(...) Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum jus est quod statum rei publicae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem» (CELSO, I. 1, de just. et de jure).
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
7
l’obbligatorietà6. Quindi, sinteticamente, la norma si compone di due
elementi: il precetto, cioè il comando contenuto nella norma stessa; e la sanzione ossia la minaccia di una punizione (tuttavia esistono norme cd. imperfette, poiché in concreto sono prive di sanzioni). Passiamo ora alla definizione di diritto canonico. Usualmente si è soliti definire il diritto canonico come «l’ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica, cioè l’insieme di fattori che danno alla chiesa la struttura di una società giuridicamente organizzata» (LOMBARDIA). Ossia è quel diritto che regola ed organizza, tramite i canoni
7, la vita e l’opera della Chiesa stessa. L’ordinamento
canonico pur essendo, oggi, racchiuso per lo più nei codici, resta aperto e flessibile, e ciò poiché il primo compito della Chiesa è la “salus animarum” degli “homines viatores”
8. In sostanza l’ordinamento canonico è un complesso
sistematico di leggi divine ed ecclesiastiche con cui la Chiesa ordina la sua specifica attività ed al contempo quella dei suoi membri in quanto tali
9.
Ed ora, un altro “concetto-base”: quello di codice. Per codice s’intende una raccolta di norme giuridiche, organicamente disposte, intese a dare per un intero settore una disciplina chiara, semplice ed uniforme. Il primo vero e proprio codice in senso moderno fu quello emanato e promulgato da NAPOLEONE nel 1804 (e perciò detto “codice napoleonico”). Da allora in poi si innescò nel mondo giuridico un vero e proprio processo di codificazione che contagiò tutti gli stati; tale fenomeno investì anche la Chiesa Cattolica. Infatti avvisaglie di tale tendenza sono già
6 In realtà la teoria generale del diritto, si presenta, ovviamente, più articolata rispetto alla semplificazione di cui sopra. In merito ved.: MODUGNO, Norma (teoria generale), in Enciclopedia del Diritto, vol. XVIII. Esistono infatti norme che non esprimono un obbligo ma sono comunque rispettate; es. art. 1. codice civile italiano «La capacità giuridica si acquista al momento della nascita». 7 La parola “canone” deriva dal greco kanwvn, che significa “norma”, “regola”, da cui il verbo kanonæzw che significa “sottomettersi ad una norma”, “giudicare secondo una regola”. Le norme ecclesiastiche furono dette “kanones” in contrapposizione alle leggi imperiali “nomoi”. Diceva ISIDORO: «canon graece, latine regula nuncupatur» (ISIDORUS, Etymologiarum sive Orig., 1.VI,16). 8 Cfr. J. HERRANZ, Salus animarum, principio dell’ordinamento canonico, in Ius Ecclesiae 12/2 (2000), 291-306. 9 Cfr. A. BUCCI, Diritto delle Chiese e diritto dello Stato nel divenire dell’atto processuale. Un approccio storico giuridico, Sapientia, Iasi, 2003.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
8
da rintracciarsi nel secolo scorso10; e, nonostante le molte polemiche, anche
nella Chiesa Cattolica tale processo ebbe successo. PIO X, nel 1904, istituì una Commissione Cardinalizia col compito di redigere il codice di diritto canonico. Così, dopo soli pochi anni di lavoro, sotto l’egida del Card. GASPARRI, il 27 maggio 1917, Papa BENEDETTO XV, con la Cost. Ap. «Providentissima Mater», promulgò il Codex Iuris Canonici; l’era della canonistica classica era tramontata per sempre e la strada della codificazione aveva fatto breccia, vincendo. A seguito del mutare dei tempi e soprattutto dopo quell’evento di eccezionale portata storica che è stato il Concilio Vaticano II, nacque l’esigenza di rinnovare il CIC; così, dopo anni di lavori, è stato emanato e promulgato da parte di GIOVANNI PAOLO II il “nuovo” CIC. Ciò è avvenuto il 27 novembre 1983 (Cost. Ap. «Sacrae disciplinae leges»)
11.
Parallelamente ai lavori del revisione del CIC, PAOLO VI il 10 giugno 1972 istituiva la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale (che all’epoca era costituito, di fatto, dai soli quattro Motu Proprio di PIO XII). I lavori di suddetta commissione sono durati ben venti anni ed il 18 ottobre 1990, con la Cost. Ap. «Sacri Canones», GIOVANNI PAOLO II ha promulgato il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Inoltre, si è preceduto alla riforma ed alla riorganizzazione della Curia Romana (con la Cost. Ap. «Pastor Bonus» del 28 giugno 1988). Oggi la Chiesa Cattolica ha dunque una legislazione completa
12, “respira” giuridicamente con “i due
polmoni”: quello occidentale e quello orientale. Desidero soffermarsi brevemente su tale questione, che ritengo di non poca importanza. Da quando la Chiesa ha deciso di intraprendere la via della codificazione è trascorso meno di un secolo; tuttavia in questo periodo, che è stato definito come era di “decodificazione” (IRTI), la Chiesa ha raggiunto la completezza giuridica mediante i codici. Oggi il CIC ed il CCEO – con in mezzo la Cost. Ap. «Pastor Bonus» – rappresentano la completezza giuridica della codificazione stessa, e tutto questo si è, di fatto, realizzato sotto il pontificato di GIOVANNI PAOLO II. Tutto ciò non è cosa di poco conto; ora infatti la Chiesa possiede strumenti moderni ed efficaci di diritto, inoltre sia
10 È bene ricordare che la codificazione fu oggetto, in ambito canonistico, di vivaci dibattiti; ed che i canonisti erano divisi in due posizioni opposte. Ved. G. FELICIANI, Le basi del diritto canonico dopo il Codice del 1983, Bologna 1990, 15-20. 11 Ved. J. B. BEYER, Dal Concilio al Codice, Bologna 1984. 12 Cfr. Discorso di S. E. Mons. E. Eid alla presentazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali alla XXVIII Congregazione Generale del Sinodo dei Vescovi il 25 ottobre 1990, in Nuntia 31 (1990), 24-34.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
9
il CIC che il CCEO sembrano essere intrisi dei dettami del Concilio Vaticano II. La Chiesa latina, con il CIC, ha posto rimedio alla obsolescenza del Codice del 1917, e parallelamente le Chiese Cattoliche Orientali hanno un codice completo, ponendo rimedio alle lacune della precedente legislazione che era parziale e costituita da 4 motu proprio di PIO XII
13. La
portata giuridica, e non solo, di tali eventi realizzati sotto GIOVANNI PAOLO II, fa aprire senza dubbio una nuova epoca sia per gli studiosi che per i christifideles! Veniamo ora alla chiarificazione di ulteriori “concetti-base”. Usualmente si è soliti distinguere due tipi di diritto: naturale e positivo. Già i romani avevano nozione di tutto ciò, infatti CICERONE affermava: «est enim unum ius, quo devincta est hominum societas, et quod lex constituit una, quae lex est recta ratio imperandi atque prohibendi, quam qui ignorat, is est iniustuts, sive est illa scripta uspiam sive nusquam»
14. Ad ogni modo è bene ricordare che il concetto
di diritto naturale ha avuto, nel corso del pensiero filosofico-giuridico, tutta una sua evoluzione (e ricordiamo che ciò costituisce uno dei maggiori problemi per la filosofia del diritto). Infatti se per PLATONE ed ARISTOTELE il diritto naturale si presenta come espressione della razionalità della natura umana, per la Scolastica tale autonomia raziocinante è ridotta alla Rivelazione Divina. Potremmo allora dire che il diritto naturale è quell’insieme di norme che sono insite nella natura umana e che esso è contrapposto al diritto positivo
15; concludendo potremmo affermare con
ULPIANO che: «in quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt»16.
Diritto positivo, significa, invece: «diritto posto o approvato dal legislatore, intendendo, “legislatore” nel suo senso più lato, tale da potersi riferire a eventuali ordinamenti giuridici non statali»
17. In sostanza, il diritto positivo
13 L’ordinamento canonico per le Chiese Orientali si basava infatti sui seguenti motu proprio promulgati appunto da PIO XII; essi erano: (i) «Crebrae allatae» del 22.2.1949 (sul matrimonio); (ii) «Sollicitudinem nostram» del 6.1.1950 (circa i giudizi); (iii) «Postquam Apostolicis Litteris» del 9.2.1952 (sui religiosi e sui beni temporali); (iv) «Cleri Sanctitati» del 2.6.1957 (sui riti orientali e sulle persone fisiche e giuridiche). 14 CICERONE, de leg., 1.I., c. 15 (tesi di CICERONE era che il diritto provenisse dalla natura e non dall’arbitrio); ULPIANO diceva, invece, che il diritto naturale è «quod natura omnia animalia docuit» (l. 1 §3 D. de just. 1,1.). 15 CELSO affermava: «quae natura prohibentur nulla lege confirmata sunt» (R. 188, §1); GAIO: «civilis ratio civilia quidem jura corrumpere potest, naturalia vero non utique» (l.8 D. de capite min. 4,5). 16 ULPIANO, 1. 32 D. de J., 50, 47. 17 E. DI ROBILANT, Diritto naturale e positivo, in Enciclopedia Filosofica, I, 1641.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
10
è: «il sistema di norme giuridiche poste o approvate dallo Stato, o da altra istituzione qualora si tratti di ordinamento originario non statuale, per regolare la condotta dei consociati, e munito di coattività» (DI ROBILANT). Qui interessano però soprattutto i due concetti, per altro fondamentali: diritto divino naturale e diritto divino positivo. Infatti per i canonisti il diritto naturale coincide con il diritto divino naturale; e ciò proprio perché uomo e natura sono creazioni divine, quindi non può esistere una natura senza Dio ed un uomo senza l’intervento divino. In merito osserva Lombardia: «il diritto canonico poggia sull’esistenza di un diritto divino, nel quale è dato distinguere un diritto divino naturale e un diritto divino positivo. L’idea di diritto naturale, che è alla base del diritto canonico, si rifà alla concezione della persona umana come essere razionale creato da Dio, la cui dignità richiede in modo vincolante i diritti e i doveri che derivano dalla natura conferitale da Dio, in unione armonica con l’ordine impresso dal Creatore a tutto l’universo» (LOMBARDIA). Pertanto si è soliti definire il diritto divino naturale – seguendo l’insegnamento tomistico – come il complesso dei principi impressi da Dio nella coscienza umana ed aventi valore universale. Sono, in sostanza, quelle norme fondate nella coscienza di ogni singolo uomo, e che sono ricevute mediante la ragione, indipendentemente da qualsiasi formulazione da parte del legislatore; tali norme, immutabili, hanno Dio come autore. Invece il diritto divino positivo è il complesso delle norme contenute nella Sacra Scrittura e nella Tradizione
18; di fatti esso è rivelato
«attraverso gli interventi compiuti da Dio nella storia per rivelare se stesso e il suo disegno di salvare gli uomini»
(FELICIANI).
Dunque, l’ordinamento canonico risulta costituito da tre tipi di componenti normative: il diritto divino naturale, il diritto divino positivo ed il diritto positivo umano.
Orbene, il sistema canonistico è un ordinamento giuridico19 che non
vive in modo isolato, anzi interagisce continuamente con gli ordinamenti di tipo civilistico. Senza dubbio la scienza canonica è la prima disciplina ad essersi posta come scienza con una propria metodologia rispetto
18 “Tradizione” significa trasmissione integrale della Parola affidata da Cristo agli Apostoli ed ai loro legittimi successori (ved. Conc. Vat. II - Cost. «Dei Verbum» I, 47). 19 Si dà qui per scontato il concetto che l’ordinamento canonico sia un ordinamento giuridico vero e proprio (tesi di FEDELE, D’AVACK, DEL GIUDICE ed altri); tuttavia è bene ricordare che tale questione suscitò, tra gli studiosi, non poche diatribe.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
11
all’onnicomprensiva teologia medievale. Tuttavia – come già accennato – il diritto canonico ha dei “contatti” con il diritto civile, e spesso rinvia o fa proprie alcune norme civilistiche; tale fenomeno è detto “rinvio”. Il rinvio può essere di due tipi: (a) rinvio recettizio o canonizzazione, (b) rinvio semplice o formale. Si ha il rinvio recettizio o canonizzazione quando la norma civile diviene canonica, cioè viene ad esser “canonizzata”, quindi incorporata nel canone. Si ha invece, il rinvio semplice o formale, qualora il legislatore canonico si richiami ad una norma civile. Diversi sono gli esempi di rinvio in entrambi i Codici, tuttavia non è questa la sede per tale problematica (per la quale si rinvia ad opere specifiche); abbiamo detto ciò solo per far capire meglio che l’ordinamento canonico non è un qualcosa che vive a sé stante o lontano dalla realtà giuridica contemporanea, bensì è perfettamente integrato in tutto ciò. Ma il diritto canonico è qualcosa di ancora più complesso, è infatti allo stesso tempo sia scienza sacra che scienza giuridica, ed è in perenne contatto con le altre scienze sacre. È soprattutto con la teologia, insieme a tutte le sue branche, che l’ordinamento canonico è in comunicazione, ma esso tiene presente anche le scienza bibliche, quelle storico-ecclesiastiche, ed anche patristiche, apologetiche, ecc. Tant’è che dal 2002 è stato reso obbligatorio lo studio previo delle discipline teologiche prima di poter iniziare il percorso degli studi canonistici (decreto emanato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica). Concludiamo quindi così questa parte, densa di definizioni e nozioni, per altro basilari, per passare allo studio del diritto ecclesiastico pubblico concordatario.
§2. Il diritto ecclesiastico e la scienza giuridica
Se per diritto canonico si può definire «l’insieme delle norme giuridiche, poste o fatte valere dall’autorità della Chiesa cattolica» – norme in virtù delle quali – «la Chiesa è organizzata e che regolano l’attività dei fedeli nel mondo in relazione ai fini propri» (DEL GIUDICE), per diritto ecclesiastico s’intende quel ramo del diritto pubblico che ha per oggetto la regolamentazione della condizione giuridica dei cittadini in quanto appartenenti ad una data confessione religiosa nonché del riconoscimento della condizione giuridica e dell’attività delle istituzioni che sorgono in seno
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
12
a questa o – ancor meglio – studia quella parte dell’ordinamento dello Stato relativo alla disciplina del fattore religioso
20.
Il diritto ecclesiastico è legato al diritto canonico (anzi i canonisti si occupano in modo eguale sia dell’uno che dell’altro); tuttavia esso non coincide con il diritto canonico propriamente detto. Infatti per diritto ecclesiastico esterno s’intende quell’insieme di norme, per lo più di natura pattizio-concordataria, che regolano i rapporti tra Chiesa e Stato, tra comunità ecclesiale e la cosidetta società civile. Dunque è lo studio essenzialmente dell’istituto concordatario e di tutte le problematiche ad esso connesse. All’interno della Chiesa è usualmente denominato “diritto ecclesiastico pubblico-concordatario”. Sostanzialmente il diritto ecclesiastico è quel settore del diritto pubblico dello Stato atto a disciplinare la condizione giuridica dei cittadini in quanto appartenenti ad una confessione religiosa. Dunque da parte della Chiesa Cattolica il diritto ecclesiastico è quell’insieme di norme di tipo concordatario regolanti i rapporti fra Chiesa e suoi membri nei confronti dello Stato; mentre per lo Stato, il diritto ecclesiastico fa parte del diritto pubblico costituendo una serie di norme che regolano la condizione giuridica dei cittadini considerati come fedeli di una confessione religiosa, debitamente riconosciuta dallo Stato, per mezzo di uno specifico accordo (“concordato” per la Chiesa Cattolica).
§3. Fonti del Diritto Ecclesiastico
Anche per il diritto ecclesiastico vale la distinzione in fonti di produzione e fonti di cognizione, tipica di qualsiasi altro diritto
21. Tuttavia data la
peculiarità del diritto ecclesiastico, le fonti di esso sono distinguibili i tre classi: (a) fonti di provenienza unilaterale statale (b) fonti di provenienza unilaterale confessionale, (c) fonti di provenienza bilaterale statale o confessionale.
20 Cfr. L. DE LUCA, Il concetto di Diritto Ecclesiastico nel suo sviluppo storico, Padova 1946, 35 ss., 155 ss. 21 In generale sulla complessa problematica delle fonti del diritto, in particolare nell’ambito civilistico, ritengo fondamentale: P. GROSSI, Considerazioni introduttive per uno studio delle fonti, Roma 20015.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
13
(a) Le fonti di provenienza unilaterale statale sono date dalle: (i) fonti costituzionali, (ii) fonti ordinarie generiche, (iii) fonti ordinarie specifiche. (i) Molto spesso nelle stesse costituzioni abbiamo riferimenti all’istituto concordatario ed ai rapporti fra Stato e Chiesa, p. es. la Costituzione della Repubblica Italiana (ex art. 7 ed 8)
22. Questo tipo di fonte
ha la preminenza su tutte le altre. (ii) Per fonti ordinarie generiche si considerano quelle norme racchiuse nei codici o in altre leggi che abbiano attinenza o riferimento alla sfera ecclesiastica. Ad es. in Italia abbiamo: art. 629 del codice civile (disposizioni in favore dell’anima); art 831 cod. civ. (disposizioni circa i beni ecclesiastici e gli edifici di culto); artt. 402-406, 664, 724 cod. penale (delitti contro la religione), art. 133 T.U. 3/3/1988 n° 383 (sul reclutamento dell’esercito, norme sul servizio in armi dei ministri di culto); legge 222/1985 sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia; legge 898/1970 sullo scioglimento del matrimonio, ecc. (iii) Le fonti ordinarie specifiche sono rappresentate da quelle norme emanate per disciplinare la sfera ecclesiastica in modo specifico. Sono queste le norme dello Stato emanate per es. in Italia, prima dei Patti Lateranensi, oppure anche quelle norme statali emanate dopo un C., atte a interpretare, attuare o integrare le stesse norme concordatarie. (b) Le fonti di provenienza unilaterale confessionale, sono nel caso della Chiesa Cattolica, quelle norme di natura canonica emanate dall’autorità ecclesiastica o racchiuse nel Codice di diritto canonico disciplinanti i rapporti fra Chiesa e Stato. (c) Le fonti di provenienza bilaterale sono essenzialmente le norme di natura pattizio-concordataria.
* * *
22 Art. 7: «Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modifiche dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale». Art. 8 «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
14
CAPITOLO SECONDO
BREVI CENNI SUI RAPPORTI FRA CHIESA E STATO
Sommario: §1. Nota introduttiva §2. Chiesa ed Impero dalla pace costantiniana all’età carolingia §3. Dalla lotta per le investiture alla formulazione della teoria teocratica §3.1. Cenni sulla dottrina canonistica sul potere pontificio §4. La Chiesa di fronte alla nascita degli stati nazionali: il “regalismo” §4.1. Il liberalismo nei rapporti fra Stato e Chiesa §5. Cenni sui rapporti fra Chiesa e Stato: i sistemi vigenti
§1. Nota introduttiva
Data la natura didattica di queste poche pagine, riteniamo doveroso almeno cercare di sunteggiare il complesso panorama storico-politico che viene usualmente inquadrato come i rapporti fra Stato e Chiesa. Occorre tuttavia compiere una precisazione di fondo: ciò che noi intendiamo oggi con il concetto di “Stato” è frutto delle ideologie moderne, sviluppatesi dalla Rivoluzione Francese in poi; dunque per il periodo medievale non ha senso parlare di “Stato” bensì è più corretto parlare di “potere politico” o meglio ancora di impero o semplicemente di rapporti fra la Chiesa ed il princeps. Si può iniziare, invece a parlare di “Stato”, anche se lo si dovrebbe porre tra virgolette, a partire dall’età moderna, cioè allorquando sorgono e si sviluppano le monarchie nazionali; ad ogni modo anche in questo caso sarebbe giusto esprimersi in termini di rapporti fra Chiesa e princeps (ovvero tra Chiesa e monarchia). Comunque, ai fini prettamente scolastici e didattici, per il periodo che va dalla fine del medio-evo fino alla Rivoluzione Francese ed anche oltre, possiamo accettare il vocabolo “stato”, ricordandoci però che esso era concepito come oggetto della sovranità del monarca. Nel corso della storia i rapporti fra Chiesa e potere politico sono stati sempre oggetto di vivaci discussioni scientifiche ma anche politiche; la problematica inerente a tali tipi di rapporti sorge allorquando il
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
15
Cristianesimo, uscito dalle persecuzioni, diviene dapprima religio licita con l’editto Costantiniano del 313 e poi religione ufficiale dell’impero Romano con l’editto di Teodosio del 380. Pertanto ci sembra giusto partire proprio da questi eventi – che sono un po’ il simbolo formale, del mutamento dell’Impero Romano, che diviene così cristiano – al fine di sunteggiare i rapporti tra Chiesa e “Stato”
23.
§2. Chiesa ed Impero dalla pace costantiniana all’età carolingia
L’imperatore TEODOSIO I (379-395) il 27 febbraio 380 proclama la religione cristiana come religione ufficiale dell’Impero. L’editto teodosiano segna una pietra miliare per la storia della Chiesa, ma anche l’inizio dei rapporti fra Chiesa ed Impero in modo ufficiale. Infatti la Chiesa, la sua dottrina e le sue norme vengono ora considerate dall’Impero come parte dello ius publicum; gli imperatori avocano a sé il potere decisionale su questioni disciplinari e dogmatiche
24. L’imperatore è considerato come il
“garante” della Chiesa: convoca e presiede i concili, ne promulga i canoni, è sorveglia sull’ortodossia della fede, combattendo l’eresia e l’apostasia (che vengono considerati ex iure crimini pubblici, come si evidenzia nel Codice Teodosiano ed in quello giustinianeo)
25.
L’Imperator Romanorum – il basileuvò – è considerato come “isapostolos” ed ejpæskopoò tw=n ejktovò, cioè “vescovo per gli affari
23 In generale sui rapporti fra “stato” e Chiesa nell’Impero Romano fino al periodo giustinianeo, si veda la seguente voce (con ampia bibliografia) di P. SINISCALCO, Chiesa e Impero, in Dizionario Patristico e d’Antichità Cristiane, I, 657-661. 24 Circa i rapporti fra “Stato” e Chiesa in epoca patristica si segnala: W.H.C. FREND, Church and State: perspective and problems in the Patristic Era, in Studia Patristica17 (1982), 38-54. Mentre sulla cristianizzazione, in ambito giuridico, fondamentale è P. P. JOANNOU, La législation impériale et la christianisation de l’Empire Romain (311-476), «Orientalia Christiana Analecta» 192, Roma 1972. Ed anche J. GAUDEMET – P. SINISCALCO – G.L. FALCHI, Legislazione imperiale e Religione nel IV secolo, «Sussidi Patristici» 11, Roma 2000. 25 Cfr. M. P. BACCARI, Gli apostati nel Codice Teoeodosiano, in Apollinaris 54 (1981), 538-581; EADEM, Comunione e cittadinanza (a propostito della posizione giuridica di eretici, apostati, giudei e pagani secondo i Codici di Teodosio e Giustiniano), in Studia et Documenta Historiae Iuris 57 (1991), 264-286.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
16
esterni” della Chiesa26. Addirittura il can. 84° della collezione degli 85 canoni
degli Apostoli, celeberrima ed antichissima raccolta canonica orientale27,
asseriva che: «se qualcuno insulta ingiustamente l’imperatore o le potestà pubbliche, sia punito; se è un chierico sia deposto, se è un laico sia scomunicato». Inoltre la Chiesa si inserisce nella compagine dell’Impero Romano, adattandosi alle sue strutture amministrative e ricalcandone in moltissimi casi le stesse istituzioni (cfr. cann.: 17 di Calcedonia, 38 del Trullano, 6 del Niceno). In un tale regime di “cooperazione” tra Impero e Chiesa
28, in cui l’imperatore è considerato il supremo garante degli interessi
– sia spirituali che materiali – della Chiesa, questa si sviluppa e progredisce, ha modo di combattere efficacemente le eresie, assume – in modo più o meno conscio – il diritto romano che viene proprio nel periodo giustinianeo ad essere codificato in modo completo (Codex Iuris Civilis Iustiniani imperatoris). Il legame che si instaura tra norma canonica e norma civile, imperiale, frutto del diritto romano è evidente
29 ed in taluni istituti (come
ad. es. i processi) è manifesto fino ai giorni nostri; tant’è che nei secoli medievali la Chiesa potrà affermare che la lex romana vivit in Ecclesia. Ma un altro grande “vantaggio” è assicurato alla Chiesa: il proselitismo. Così abbiamo una intensa attività missionaria che fu particolarmente favorita dagli stessi imperatori dell’Impero Romano d’Oriente (si pensi alle missioni evangelizzatrici in Nubia, quelle i popoli slavi, ecc.). Da un punto di vista giuridico, progressivamente, nascono e si definiscono le norme della Chiesa, detti appunto kanones, che sono diverse dalle leggi imperiali (nomoi); dall’unione dei nomoi con i kanones nasceranno nel IX sec. delle collezioni giuridiche miste – i “nomocanoni” – che avranno fortuna e diffusione in tutto l’Oriente Cristiano. Dunque da GIUSTINIANO (527-565) in poi non fa 26 Riguardo al ruolo dell’imperatore costantinopolitano segnaliamo alcune pagine di E. MORINI, La Chiesa Ortodossa. Storia - Disciplina - Culto, «Storia e Cultura» 1, Bologna 1996, 35-46. 27 In merito ved. D. CECCARELLI MOROLLI, Alcune riflessioni intorno ad una importante collezione canonica delle origini: “Gli 85 Canoni degli Apostoli”, in G. PASSARELLI (ed.), Miscellanea C. Capizzi edita in Studi sull’Oriente Cristiano 6 (2002), 151-175. 28 In merito si veda P. RODOPOULOS, Sacred Canons and Law, in «Kanon» 10 (1991), 9-15. Inoltre cft. B. BIONDI, Il diritto romano cristiano, vol. I, Milano 1952, 115 ss. 29 È questo il concetto, già instaurato da Giustinaino, noto col termine greco di sumfwnßa; per un excursus storico in merito ved. C. G. PITSAKIS, La “JJJJJJJJJJ” principe fondamental des rapports entre l’Eglise et l’État. (Idéologie et pratique byzantine et transformations contemporaines), in «Kanon» 10 (1991), 17-35.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
17
stupore che sia l’imperatore a detenere, di fatto, le sorti della Chiesa; del resto lo stesso Codex, ma anche tutta la legislazione imperiale d’Oriente seguente, contiene numerosi riferimenti inerenti alla disciplina ecclesiastica
30.
Tale stato di cose fu definito, quasi etichettato dagli occidentali, col termine di “cesaropapismo”; con questo lemma si è voluto indicare il concetto che la Chiesa era asservita al potere imperiale, il quale esercitava una forma di vera e propria autocrazia. Oggi il termine “cesaropapismo” è stato, dalla storiografia, alquanto ridimensionato. Infatti per gli uomini ed i fedeli di quel tempo, il fatto che l’imperatore si considerasse “supervisore” dell’ordinamento ecclesiastico non era affatto occasione di stupore, anzi si sarebbero stupiti del contrario. Nella concezione imperiale-cristiana prima, e bizantina poi, si considerava l’imperatore come colui il quale ha ricevuto l’impero da Dio, essendo questo frutto della provvidenza divina, dunque egli doveva rendere conto di ciò solo ed esclusivamente a Dio; pertanto tra le sue prerogative vi era necessariamente anche la cura verso la Chiesa, affinché le sue regole (i canoni) fossero rispettati ed affinché la vera fede venisse protetta dalle eventuali devianze (le eresie). Quindi, il termine “cesaropapismo”, sempre utilizzato per descrivere il carattere delle relazioni fra Chiesa ed Impero va usato con molta circospezione e comunque, a nostro avviso, sempre tra virgolette
31.
Col passare del tempo, particolare ruolo ebbero i concili ecumenici (tutti svoltisi in Oriente), i cui canoni divennero patrimonio giuridico-canonico in tutta la Chiesa indivisa del primo millennio
32. Tra questi,
particolarmente significativo fu il Concilio di Calcedonia (451) nel quale possiamo già individuare una prima concreta differenziazione tra Chiesa Occidentale e quella Orientale. Infatti il can. 28 di Calcedonia, concedeva il primato d’onore (taV presbei=a th=ò timh=ò) a Costantinopoli dopo Roma, essendo questa la “Nuova Roma” e la sede dell’Impero Romano
30 È sufficiente ricordare che il Corpus Iuris iniziava proprio con una serie di norme imperiali sul dogma trinitario e egli altri prinicpi della fede (I, 1, ss.). GIUSTINIANO, nella Novella 131 (a. 545) equiparò a leggi dello stato i canoni dei – primi quattro – concili ecumenici (ved. R. SCHOELL-G. KROLL, Corpus Iuris Civilis, III Novellae, Berolini 1928, 654-655). 31 In merito a tale tematica, ved. R. FARINA, Cesaropapismo, in Dizionario Patristico e d’Antichità Cristiane, I, 655-656 (con ivi ampia bibliografia). 32 Cfr. D. SALACHAS, Il Diritto Canonico delle Chiese Orientali nel Primo Millennio. Confronti con il diritto canonico attuale delle Chiese orientali cattoliche: CCEO, Roma-Bologna 1997.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
18
d’Oriente. La Chiesa Latina rifiutò il canone, probabilmente non comprendendolo a pieno, e così si iniziò quel distacco verso la Chiesa d’Oriente
33 che poi sfocerà nello scisma definitivo dell’XI secolo. Ciò è
importante perché già nel 451 in Occidente si assiste, in opposizione all’Oriente, ad una situazione politica completamente differente: qui la Chiesa è praticamente sola, in quanto l’Impero d’Occidente è ormai agonizzante e successivamente alla caduta di Roma (476) la Chiesa si troverà del tutto autonoma rispetto ai cd. regni romano-barbarici, i cui sovrani per poter avere un minimo di autorità dovranno ricorrere a Costantinopoli per farsi concedere il titolo di patricius Romanorum. In queste condizioni di lontananza da Costantinopoli, di mancata presenza in Occidente dell’Impero Romano d’Oriente (a parte poche regioni di Italia), la Chiesa inizia a ritagliarsi uno spazio proprio anche sul piano politico e col tempo diventa l’unica istituzione stabile; addirittura è la curia papale, modellata su quella romana, l’unica a possedere un archivio e capace di mandare missive a grande distanza. Inoltre, il patrimonio di San Pietro, già frutto degli ingenti lasciti elargiti in età basso imperiale, va sempre più aumentando e la donazione di Sutri da parte del longobardo Liuptrando, segna così per gli storici l’inizio del potere temporale della Chiesa. Col tempo il papato si trova a gestire una quantità immensa di latifondi e di territorio ed il patrimonio di S. Pietro diventa Regno Pontificio. In questa situazione la Chiesa Romana si ritaglia uno spazio diplomatico di primo livello, ma anche una autonomia territoriale che la porterà ad essere vero e proprio “Stato”, quello appunto pontificio. Infatti, la S. Sede diviene l’unica istituzione certa in un complesso mondo di invasioni barbariche e di regni romano-barbarici (a parte le zone dominate dall’Impero Romano d’Oriente); inoltre il papato diviene anche l’unico punto di riferimento per l’amministrazione delle città, ormai spopolate, in cui però continua a risiedere stabilmente il vescovo con il suo establishment. Pertanto nel IX sec. Carlo, re dei cattolici Franchi, conquistando ampi territori nell’Europa e contrastando i Longobardi (che erano di fede ariana, dunque eretici) “offre”, senza volerlo, la possibilità alla Chiesa Romana di “staccarsi” ulteriormente da Costantinopoli. Infatti, Carlo è incoronato dal Papa come Imperatore la notte di Natale dell’anno 800: nasce ufficialmente il Sacro Romano Impero (S.R.I.). Ora anche l’Occidente
33 Cfr. J. SPITERIS, La critica bizantina del Primato Romano nel secolo XII, «Orientalia Christiana Analecta» 208 (Roma 1979).
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
19
ha un impero pari a quello Romano d’Oriente, che oramai a partire da Eraclio, è del tutto grecizzante. Il S.R.I. è una creazione della Chiesa Romana e costituisce allo stesso tempo una eccezionale possibilità di autonomia per il papato, che ora ha il suo “braccio secolare” nell’imperatore. Le relazioni fra S.R.I. e Papato furono improntate all’armonia; i sovrani carolingi, prima di tutti Carlo, affiancano ai missi dominici imperiali i missi ecclesiastici, l’impero è organizzato e strutturato in base al sistema feudale (che era d’origine franca) e la Chiesa riceve aiuti e protezioni di ogni tipo per svolgere la sua missione. Dunque i rapporti di questo periodo sono estremamente positivi tra i due poteri; nonostante le pretese dell’imperatore carolingio di essere anche lui “garante” della Chiesa, in realtà egli è una “creazione” del Papato, infatti egli riceve la corona dal Papa, mentre il basileuvò è ancora incoronato secondo la tradizione imperiale romana. §3. Dalla lotta per le investiture alla formulazione della teoria teocratica
Con la disgregazione dell’Impero carolingio, e la renovatio imperii degli Ottoni di Sassonia, esplode la crisi tra S.R.I. e Chiesa; il problema è dato dalle investiture e questa fase è appunto contraddistinta dalla cd. “lotta per le investiture”. Il problema che si poneva era alquanto pratico, ma aveva anche forti implicazioni di natura dottrinale. Infatti, l’imperatore deteneva un potere fittizio sul territorio, essendo questo suddiviso in feudi che erano divenuti ereditari (col capitolare di Kiersky prima, e dopo con la Constitutio de Feudis di Corrado il Salico). Dunque gli Ottoni corsero ai ripari iniziando a nominare vescovi (che non potevano avere eredi legittimi) quali feudatari, così alla morte del vescovo il feudo ritornava alla corona che poteva allora tenerlo o ridarlo in concessione feudale. La Chiesa non si opponeva all’investitura laica, ossia al fatto che l’imperatore concedesse privilegi ai vescovi, bensì era contraria al fatto che i vescovi venissero nominati dal potere imperiale. Lo scontro, durissimo, terminò col Concordato di Worms (1122) in cui fu stabilito che il Papa solo poteva nominare e consacrare i vescovi, mentre l’imperatore rinunciava a tale prerogativa (eccetto che per la Germania, ove avrebbe potuto continuare ad avere ingerenza nella cosa). Pertanto durante i secoli X-XIII, i due poteri che un tempo da Papa GELASIO I (492-496) nella sua celebre epistola all’imperatore ANASTASIO I
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
20
(491-518)34 erano considerati divisi ed entrambi armonici, ora divengono
sempre più ostili e nonostante la risoluzione di Worms, che sancisce la fine della lotta per le investiture, da entrambe le parti – Chiesa ed Impero – ci si sforza di dare teorie che affermino la superiorità di uno dei due sull’altro. È questo il periodo, specie in Italia, che vide l’opporsi drammatico e cruento dei Guelfi (filo-papali) ed i Ghibellini (filo-imperiali). Nonostante gli sforzi di grandi imperatori come FEDERICO BARBAROSSA, l’Impero in realtà ha un potere nominale sull’Italia, che invece è sempre più egemone della diplomazia ecclesiastica. Il Papato favorisce i Normanni, creando così il Regno di Sicilia e strappando ai Bizantini le Puglie e la Calabria. La Santa Sede inizia a divenire sempre più arbitra non solo delle divisioni italiane ma anche della politica europea, ed il suo influsso sarà (Inghilterra a parte) fortissimo in tutta Europa fino all’età della Riforma. Dunque in questi secoli i rapporti fra Impero e Chiesa furono improntati alla reciproca tensione ed in alcuni casi all’astio vero e proprio. Sopra abbiamo accennato alle teorie, che poi portarono alle fazioni (Guelfi e Ghibellini) o che furono espressione ideologiche di esse. Le teorie in questione sono rispettivamente dette: (a) teoria curialista favorevole alla supremazia pontificia, (b) teoria imperiale, sostenitrice del “cesaropapismo”, cioè della preminenza dell’Impero sulla Chiesa; entrambe, sostenute da filosofi, intellettuali e giuristi, cercavano di evidenziare la superiorità di uno dei due poteri sull’altro. Chiaramente, entrambe le teorie, ebbero un loro proprio sviluppo né mancarono di differenti posizioni ed interpretazioni. Noi qui accenneremo alla dottrina canonistica del XII sec che sarà di appoggio al potere pontificio e che andrà a consolidare l’ideale teocratico, che toccherà il suo apogeo con INNOCENZO III (1198-1216) e con BONIFACIO VIII (1294-1303). §3.1. Cenni sulla dottrina canonistica sul potere pontificio
Sullo sfondo della complessa lotta per le investiture – che pur essendo formaliter risoluta, in realtà sottaceva due distinte ed opposte ideologie: quella papale e quella imperiale – si inseriscono le azioni dei Romani Pontefici per l’affermazione della teocrazia pontificia e del potere papale. La dottrina canonistica del XII sec. gode di una parte rilevantissima circa l’affermazione dell’idea della supremazia della S. Sede sul potere regale e su quello imperiale; infatti questa dottrina preparò il terreno a INNOCENZO III ed a BONIFACIO VIII. Procediamo dunque con ordine.
34 GELASIO, Epistula ad Imperatorem Anastasium, in Patrologia Latina [= PL], vol. LIX, 41-47.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
21
Già fin dai primordi abbiamo, di fatto, le premesse di ciò che sarebbe diventato nell’XII-XIII sec. l’ideale teocratico. L’epistola di Papa GELASIO (492-496) all’Imperatore ANASTASIO I (491-518) affermava la distinzione dei due poteri, quello pontificio come «auctoritas sacrata pontificum» e quello imperiale come «imperialis potestas»
35. A distanza di più di
cinquecento anni, GREGORIO VII (1073-1085) elaborò entrambi i concetti gelasiani nel suo «Dictatus Papae» del 1075, in cui getta i semi della teocrazia pontificia
36. Dalla concezione gregoriana, la canonistica del XII sec. e degli
inizi del XIII sec. inizia ad affermare la supremazia del Romano Pontefice sugli “Stati”, giustificando l’intervento pontificio nella sfera del princeps in ragione dell’auctoritas spiritualis. GRAZIANO (1140 ca.) pur manifestando un notevole ossequio alle direttive gregoriane, riconosce però il principio gelasiano della iurisdictio divisa ma dà per legittimo l’atto di deposizione dell’imperatore da parte del R. P., infatti ratione peccati è consentito al Papa interferire nel temporale deponendo il sovrano. I Decretisti, adoperandosi a commentare il Decretum Gratiani, nei sec. XII e XIII, si adoperano a rintracciare in esso un più acuto approfondimento della teoria circa la superiorità della Chiesa; tra costoro non mancano posizioni diverse e sfumature di pensiero, ma tra tutti spicca per importanza UGUCCIONE DA PISA (che fu maestro di INNOCENZO III). Per UGUCCIONE DA PISA l’imperatore riceve la conferma del suo potere grazie all’intervento papale, il Romano Pontefice può sempre giudicare l’imperatore se egli non si conformi ai precetti della Chiesa. Uguccione, pur rimanendo fedele all’autonomia gelasiana dei due poteri, afferma però la subiectio dell’imperatore al R. P. in spiritualibus ed aggiungendo, molto morbidamente, “et quoadmodo in temporalibus”. Egli riconosce che la potestà imperiale ha bisogno, per potersi esplicare validamente, dell’intervento dell’auctoritas pontificia che ad essa si sostituisce in caso di negligenza dell’imperatore. Questo rappresenta il germe più
35 PL, LIX, 41-47. 36 Il Dictatus Papae è composto da 27 brevi il cui contenuto è riassumibile nei seguenti punti: (i) la Chiesa è stata fondata da Dio solo, (ii) solo il Romano Pontefice [= R.P.] può ricevere l’appellativo di “universale”, (iii) solo il R.P. può deporre o assolvere i vescovi e solo egli può usare le insegne imperiali, inoltre il suo nome è unico nel mondo; (iv) egli può deporre gli imperatori, (v) il R.P. non può essere giudicato da nessuna persona, (vi) nessuno può condannare una decisione della Sede Apostolica, (vii) la Chiesa Romana è infallibile, (viii) il R.P. può sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà fatto ai principi regnanti o all’imperatore.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
22
visibile della teocrazia pontificia. Inoltre, UGUCCIONE mette in auge il titolo di Vicarius Christi. La dottrina di Uguccione sulla giurisidizione del Papa quale Vicarius Christi e sulla posizione reciproca dei due poteri esercita una influenze decisiva sul pensiero e sull’azione di INNOCENZO III (1198-1216). INNOCENZO III riesce, pur rimanendo fedele alla concezione dualistica gelasiana, a tramutarla in concezione unitaria. Secondo Innocenzo III il R. P. può trasferire l’imperium (transferre imperium) da una persona all’altra, qualora la “negligenza” (peccatum) dell’Imperatore provochi l’intervento della forza correttiva pontificia. Dunque l’auctoritas pontificia ha carattere sovra-nazionale e si manifesta in caso di intervento “in defectu iustitiae saecularis”. Ma ulteriore occasione di legittimo intervento nella vita degli “stati” è la salvaguardia della pace: il principe che abbia violato la pace incorre in grave peccato, perciò può essere costretto ad una penitenza e questo intervento pontificio è considerato di natura puramente spirituale. Infine, Innocenzo III sostiene che i vescovi debbono essere tutti fedeli al Romano Pontefice ed a lui solo. Le teorie dei Decretisi, specie UGUCCIONE, e poi di INNOCENZO III portano al pensiero teocratico, che viene ulteriormente espresso da BONIFACIO VIII (1294-1303), col quale si raggiunge probabilmente il culmine della potenza pontificia. Bonifacio VIII spinge all’eccesso ciò che i suoi predecessori avevano voluto ed annunciato. La summa del pensiero di Bonifacio VIII ci è data dalla bolla «Ausculta Filii» del 1301 a FILIPPO IL
BELLO, re di Francia37. Nella «Ausculta Filii», leggiamo: «Ascolta figlio mio
(...) Dio ha posto il Romano Pontefice al di sopra dei re e dei loro regni. Perciò tu non puoi dire, o re, di non avere nessuno sopra di te; anche tu sei soggetto al Papa. Chi ritiene il contrario o è un pazzo o è un infedele». Questo rappresenta certamente il culmine del potere papale, ma allo stesso tempo anche l’inizio di un lento declino. Infatti si deve sottolineare e ricordare che la società del ‘300 subisce profonde modifiche: si passa da un sistema feudale ad uno maggiormente organizzato quello nazionale. Essendo l’impero divenuto praticamente inefficace, iniziano a sorgere gli stati nazionali, cioè entità geografico-politiche ed etniche autonome rispetto all’impero. Quella coincidenza tra ecclesia e civitas caratteristica del primo medioevo, inizia ad avere le prime scosse e fratture. Quasi a riprova di ciò ed innovazioni risiede il fatto che la bolla di BONIFACIO VIII «Ausculta Filii»
37 Tale bolla fu inviata a FILIPPO IL BELLO poiché aveva nel 1285 tassato le Chiese del suo regno.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
23
non fu pubblicata in Francia, infatti Filippo ne impedì la pubblicazione della autentica, sostituendone un falso. Gli sforzi di BONIFACIO VIII, visibili chiaramente anche nella bolla «Unam Sanctam» sono poco efficaci nella realtà; nella «Unam Sanctam» del 1301, Bonifacio afferma che «la fede ci impone di credere e professare che esiste una sola chiesa, santa, cattolica ed apostolica (...). Infine dichiariamo, diciamo, definiamo e proclamiamo che per ogni creatura umana è necessità di salvezza sottostare al Romano Pontefice». Poco tempo dopo (il 7 settembre 1303) i Francesi assaltarono Anagni, residenza estiva di BONIFACIO VIII, ed ebbe luogo il celeberrimo “schiaffo d’Anangni”; il Papa scomunicò FILIPPO IL BELLO, ma un mese dopo morì. L’episodio di Anagni segna una cesura storica del papato; infatti di lì a breve tempo la Chiesa conobbe il periodo della cd. “cattività avignonese” e nessun Papa parlò mai più con i toni di Bonifacio e da allora cominciò il regresso del potere papale. Nuovi fermenti culturali stavano per percorrere l’Europa ed in concomitanza con Rinascimento una grave separazione si sarebbe consumata in seno alla Chiesa: la Riforma Luterana. §4. La Chiesa di fronte alla nascita degli stati nazionali: il “regalismo”
Nei secoli che vanno dal 1400 al 1600, assistiamo ad un radicale cambiamento dei rapporti fra “Stato” e Chiesa. Conclusasi l’età medievale, col suo sistema politico “monistico”, falliti i tentativi del “cesaropapismo” in Occiedente, caduto l’impero Romano d’Oriente (1453), avvenute le grandi scoperte geografiche (dal 1492 in poi), l’Europa conosce una nuova fase politica che generalmente prende il nome di “monarchie nazionali”, i cui prodromi sono da rintracciarsi nello sgretolamento del sistema feudale medioevale e nella debolezza della translatio imperii effettuata dai pontifici da Carlo Magno in poi. Lo sviluppo intenso dell’economia mercantile e la nascita delle banche e del diritto commerciale, favorisce il sorgere di dinastie che unificano mediante la corona intere regioni. In Italia si assiste ad una frammentazione del territorio in potentati, regni e zone di dominio che vedrà la propria unificazione (al pari della Germania) solo nel XIX sec. Il potere dei sovrani nazionali, specie quello francese, si rafforza sempre maggiormente e la Chiesa deve iniziare a “dialogare” con tali nuove “entità” politiche. Anche culturalmente si hanno sviluppi nuovi e profondi: l’Umanesimo prima ed il Rinascimento poi, con le loro teorie filosofico-giuridiche, e la riscoperta del diritto romano, contribuiscono ulteriormente ad indebolire la coincidenza della ecclesia con la civitas. La teoria medievale
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
24
della potestas directa in temporalibus viene a modificare in ciò che si definisce potestas indirecta in temporalibus valida ed attuata dalla Chiesa a tutt’oggi. *** Con l’età moderna (1492-1870) nascono nuove correnti di pensiero portano ad una ridefinizione della concezione dei rapporti fra Stato e Chiesa. Uno dei maggiori pensatori che si collocano alla fine del periodo medioevale, ma il cui pensiero è furiero dell’età moderna è MARSILIO DA PADOVA (ca. 1280-1343), che con la sua opera intitolata «Defensor Pacis» illustra le proprie teorie. Egli critica la struttura gerarchica della Chiesa dell’epoca, sostenendo che la gerarchia ecclesiastica è una istituzione umana e non già divina, dunque lo Stato ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione su di essa, dal momento che questa manca di tale potere. Inoltre, per MARSILIO, la Chiesa manca di una sovranità dunque si trova in rapporti di dipendenza nei confronti dello Stato. In sostanza MARSILIO è l’esempio, emblematico, della crisi del sistema teocratico ma anche di quello “cesaro-papista”; infatti l’impero assiste al proprio definitivo naufragio nel momento in cui sorgono, sempre più potenti e preponderanti, gli stati nazionali. Pertanto si assiste ad un mutamento delle concezioni curialista e regalista, che d’ora in poi iniziano a parlare rispettivamente di “potestas indirecta in temporalibus” (per la Chiesa) e di potere indiretto dello Stato nelle cose spirituali (da parte dello Stato). Vediamo brevemente queste due teorie. (a) La teoria della potestas indirecta in temporalibus. Già S. TOMMASO D’AQUINO (1221-1274) aveva nel suo pensiero distinto il diritto divino naturale da quello divino positivo. Sulla base delle dottrine tomistiche e della riflessione canonistica post-grazianea, BELLARMINO, SUAREZ ed i giurisiti teologi del XVI e XVII sec. giungono ad asserire che la Chiesa e lo Stato posseggono ciascuno nel proprio ordine autonomia ed autorità, anche se l’eccellenza maggiore dell’ordine spirituale e l’assoluta necessità che l’uomo raggiunga la sua salvezza eterna, anche sacrificando se è necessario il fine naturale, fanno si che l’autorità ecclesiastica possegga sulle questioni temporali un potere indiretto nella misura in cui tali questioni possono interessare il soprannaturale. La potestà pontificia è di per sé propriamente spirituale e concerne solo indirettamente la sfera temporale. Sorto il concetto di “Stato” in età moderna, e caduto il sistema monistico, la Chiesa attua una potestas indirecta in temporalibus, ossia ratione peccati rivolge la sua azione di direzione spirituale ai singoli, ai cives, in quanto l’autorità del princeps inizia ad essere da loro de facto delegata. Questa teoria, il cui sviluppo storico è impossibile qui sunteggiare, continuerà per tutto il XVII ed il
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
25
XVIII sec. per poi giungere fino ai giorni nostri. Infatti LEONE XIII (1878-1903) riprenderà le su citate posizioni nel suo magistero alimentando così in tutto l’orbe cattolico la teoria detta appunto della potestà direttiva. Il Concilio Vaticano II (1962-1965) sembra proseguire su tale scia, casomai cambiando piuttosto l’aspetto formale più che quello sostanziale della dottrina della potestà direttiva. Dai testi conciliari (Gaudium et Spes, Dignitate Humane, ecc.) emerge l’idea centrale che il potere della Chiesa sia soprattutto sulla coscienza dei fedeli, sulla necessità di indirizzarli e guidarli; dunque l’aspetto temporale entra nel potere del magistero ecclesiastico solo come fattore secondario o comunque di riflesso. Dunque la Chiesa non può, e non deve, rinunciare a quello che è il suo obiettivo primario: la salus animarum degli homines viatores in saeculo; ed è proprio il fatto che gli uomini vivano nel mondo, che dà adito all’ “intromissione” temporale, ma questa è e deve essere sempre finalizzata alla salus animarum. (b) Il Regalismo. Teoria opposta alla potestà direttiva della Chiesa è quella detta del regalismo, che nel corso della storia ha conosciuto numerosi aspetti nazionalistici. Il “Regalismo” sostiene nei rapporti fra Stato e Chiesa, la potestà indiretta dello Stato nella sfera religiosa. Nel passato, esempio di ciò ci è fornito dall’attività degli imperatori romani d’Oriente oppure le varie rivendicazioni imperiali in Occidente durante il periodo medievale. Con l’età moderna questa sorta di garantismo dello “Stato”, che ha dato luogo al cd. “monismo”, viene radicalmente cambiato da NICOLÒ MACHIAVELLI (1469-1527) e da JEAN BODIN (1530-1596). Entrambi i pensatori sono figli del loro tempo e testimoniano il mutato assetto dei rapporti fra “Stato”
38 e
Chiesa; entrambi smontano la visione unitaria cristiana ed assegnano al detentore dei poteri statali – il principe – ampia autonomia in campo religioso. Il diritto naturale si svincola dal diritto divino naturale e la concezione tomistica conosce il suo tramonto. L’affermazione degli stati nazionali non solo contribuisce al rafforzamento dei nazionalismi, ma anche allo sviluppo del concetto di Stato. Dunque il regalismo conobbe varie sfaccettature, a secondo dei paesi. Vediamole brevemente. (i) Gallicanesimo. Questo sistema si sviluppò in Francia, ove la corona aveva antichissimi privilegi e concessioni nella sfera ecclesiastica. Le prime
38 Si deve proprio al MACHIAVELLI (1469-1527) l’uso della parola “stato” – rifacendosi all’espressione classica status rei publicae - e l’introduzione della medesima nella scienza della politica; cfr. G. COSTAMAGNA, art. Stato, in Dizionario di Politica, Roma 1940, 382 (Enciclopedia Italiana Ed.).
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
26
affermazioni del gallicanesimo sono documentate nei concili di Parigi del 1398 e del 1406; nel 1682 il vescovo di Meaux, J. B. BOUSSET, redisse la Declaratio Cleri Gallicani in cui si affermava la superiorità del concilio sul Romano Pontefice ed allo stesso tempo rivendicava una maggiore libertà della Chiesa di Francia Il gallicanesimo tendeva a limitare la giurisdizione della S. Sede sulla Chiesa francese, in ragione degli antichi diritti acquisiti dalla corona e favoriva l’ingerenza del re nella sfera ecclesiastica; infatti le provvisioni della S. Sede non potevano considerarsi valide, nell’ambito dell’ordinamento del regno, senza il previo assenso regio. Una delle più vistose forme del sistema era la facoltà di poter ricorrere contro gli atti dell’autorità ecclesiastica, che violassero le norme statali, al Consiglio del Re. Il principio fondamentale del gallicanesimo era che il Papa non poteva intervenire in temporalibus nel Regno di Francia e che il suo potere era limitato, in Francia, dalle regole emanate dai concili accettati nel regno. L’influenza del g. fu grande in tutta Europa e la difesa delle libertà della chiesa gallicana servì non poco a rafforzare l’autorità reale in campo ecclesiastico, giungendo così a stabilire una sorta di potere indiretto dello Stato sulla Chiesa, limitando la giurisdizione della S. Sede. (ii) Febronianismo. In Germania il regalismo fu denominato “febronianismo” a causa dell’ispiratore di tale concezione, che fu NICOLA VON HONTHEM, vescovo suffraganeo di Treviri - sotto lo pseudonimo di GIUSTINO FEBRONIO – scrisse un trattato dal titolo «De Statu Ecclesiae» (1763). FEBRONIO, seguendo MARSILIO DA PADOVA e la scuola giusnaturalistica tedesca, ritorna alla tesi della Chiesa “democratica”, ispirata alla costituzione confederata dell’Impero, in cui i vescovi avevano il ruolo di principi indipendenti ed in cui il Papa era solo un primus inter pares. Per Febronio, il Papa è il tutore della Chiesa ma non ha alcuna potestà giurisidizionale; inoltre, pur non negando il primato, egli ritiene che esso debba interpretarsi in modo collegiale, cioè Cristo avrebbe dato il primato a tutti gli apostoli. Secondo FEBRONIO, il Papa è il centro di unità della Chiesa, è garante della legislazione ecclesiastica ed esercita i poteri, ma limitati, di giudice e di maestro della Chiesa; infatti secondo FEBRONIO questi sarebbero stati gli antichi e genuini diritti del primato che riflettevano l’antica costituzione della Chiesa, che poi col tempo, a partire dalle decretali pseudo-isidoriane (spurie, IX sec.), si sarebbero alterati. Col febronianismo emerge nuovamente il regalismo, cioè: l’episcopato nazionale, il concetto stesso di Chiesa nazionale. Questo tipo di rapporti fra Stato e Chiesa in Germania, ebbe fortuna in quanto seppe cogliere lo spirito del tempo, in cui i sovrani assolutistici avocavano a sé i diritti sulle chiese dei propri regni.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
27
Del resto nella concezione assolutistica, riassumibile con la celebre espressione l’etat c’est moi, non poteva non prevedere o considerare che l’organizzazione della Chiesa doveva conoscere una ingerenza regale. (iii) Giuseppinismo. La tipologia di regalismo che si instaurò in Austria fu detta “giuseppinismo” dal nome dell’imperatore GIUSEPPE II (1780-1790), figlio della grande imperatrice MARIA TERESA (1740-1780), a cui si deve già l’introduzione del febronianismo nell’impero asburgico. GIUSEPPE II introdusse la politica del controllo imperiale sulla religione, concretizzandosi negli “iura circa sacra”, per cui l’autorità civile rivendicava una notevole ingerenza nella sfera ecclesiastica. Si giunse così ad una attività giuridica dell’imperatore nell’ambito religioso. (iv) Il regalismo nei paesi mediterranei. L’Italia, la Spagna ed il Portogallo conobbero il regalismo, anche se con forme più attenuate. Negli stati italiani pre-unitari, il regalismo fu attuato nel Regno di Sardegna, mentre nel Granducato di Toscana fu introdotto il giuseppinismo dal granduca LEOPOLDO (1765-1790), tra i cui aspetti principali vi furono la soppressione delle esenzioni di imposta per il clero e la soppressione del privilegium fori (cioè l’immunità degli ecclesiastici); anche nel Regno delle due Sicilie, i Borboni attuarono un regalismo stabilendo una ingerenza regale nella sfera ecclesiastica. Il regalismo spagnolo e quello portoghese, conobbero la forma che si concretizzò nell’istituzione del padronado. Esso significava l’esercizio del potere regio con notevole imposizione tributaria gravante sugli enti ecclesiastici. Al contempo erano riconosciuti alla Chiesa ampi poteri, specie per la S. Inquisizione che era considerata un organo indiretto dello Stato. Anche in Spagna vigeva il regium exequatur, cioè la necessità che la corona possa decidere dei documenti emanati dalla S. Sede. Tuttavia il padronado fu assai meno rigido del regalismo gallicano o del febronianismo.
§4.1. Il liberalismo nei rapporti fra Stato e Chiesa
Con la progressiva affermazione degli stati nazionali ed il conseguente ampliamento dei poteri regali, si concretizza maggiormente ciò che fu definito l’ancien regime, che durò fino alla Rivoluzione Francese (1789). Nonostante la Chiesa non abbia più il potere dei tempi di Innocenzo III e Bonifacio VIII, essa mantiene tuttavia, anche col regalismo, una tacita alleanza col potere politico. Attuando una potestas indirecta in temporalibus più nominale che reale, nel concreto i regimi assolutistici precedenti alla
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
28
Rivoluzione Francese, conoscono una stretta alleanza tra “trono” ed “altare”, specie nei paesi cattolici. Senza dubbio la Riforma contribuì a dare un grave colpo al sistema, che però seppe reagire con il Concilio di Trento e fu capace di andare avanti. Ma, nel XVIII sec. un vasto movimento culturale e filosofico, l’Illuminismo, avrebbe ben presto gettato le basi dello Stato moderno, separando per sempre l’alleanza tra “trono” ed “altare”. Figlio diretto delle idee illuministiche e della Rivoluzione Francese, il Liberalismo rappresenta una vasta corrente filosofica e politica che ha caratterizzato l’epoca moderna fino alla Prima Guerra Mondiale (1914-1918). Nel campo religioso, il Liberalismo, sembra partire dalle idee della Riforma protestante: rifiuto di qualsiasi autorità visibile nella Chiesa, libero esame delle Sacre Scritture e negazione del magistero. In campo politico, esso si propose (al tempo dell’Illuminismo e della Rivoluzione Francese) come abbattitore dell’ancien regime e successivamente, dal XIX sec., in poi diviene fautore del concetto di democrazia moderna (“superando” così il pensiero greco-classico). (i) Ma un filo conduttore lega il liberalismo passato con quello moderno: l’agnosticismo dello Stato in materia religiosa. L’Occidente trovò nuove formule, ispiratesi al liberalismo, nel gestire i rapporti fra Stato e Chiesa: dalla confessionalità della Nazione o del Popolo, alla corporazione di diritto pubblico (sistema germanico) permettente l’esistenza di tutte le confessioni religiose riconoscendole come entità pubbliche da parte dell’ordinamento statale. Dunque dal liberalismo, originariamente agnostico, pertanto “disinteressato” al problema religioso ma in linea di principio tollerante (cfr. LOCKE), sorgono nuovi modelli dei rapporti fra Chiesa e Stato. (ii) Il giurisdizionalismo confessionale. È quello in cui, oltre alla preminenza del potere civile e statale sulle attività della Chiesa, lo Stato aderisce ad una determinata confessione religiosa e si impegna a proteggerla pur esercitando su di essa una sorveglianza. Nell’ambito del giurisdizionalismo confessionale si esercitano gli iura maiestatica circa sacra tra cui spesso ritroviamo lo ius advocaturae et protectionis e lo ius reformandi. (iii) Il giurisidizionalismo aconfessionale. È questo quel tipo di forma che considera lo Stato del tutto “disinteressato” o del tutto partecipe a qualsiasi forma di religione. Pertanto, abbiamo due sotto tipi di esso: una azione statale diretta a promuovere tutte le religioni oppure una azione statale mirata a frenare le attribuzioni riconosciute dallo Stato alle confessioni religiose. Nell’ambito del giurisdizionalismo aconfessionale, rintracciamo gli
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
29
istituti rientranti nel cd. ius cavendi et ius inspiciendi (dunque: lo ius nominadi, ius exclusivae, ius appellandi, e lo ius placiti regii o placet ed exequatur). (iv) Il separatismo. Questa teoria liberale, si fonda sul principio che lo Stato non avendo un proprio credo religioso non possa giudicare tra le confessioni quale sia quella vera. Dunque lo Stato deve limitarsi a prestare le condizioni generali per il libero esercizio dei vari culti ed il libero esercizio dei medesimi. In sostanza, si instaura un regime giuridico egualitario per tutti i cittadini, che vengono considerati quanto tali e non come appartenenti ad una data confessione religiosa. Questo sistema, che è attualmente il più seguito e quello che probabilmente risponde meglio alle esigenze dello Stato moderno, vede nello Stato una sorta di “casa comune” nella quale tutti i cittadini sono liberi di credere in ciò che vogliono. Tale regime fu adottato per primo nella Costituzione degli Stati Uniti d’America. Questo sistema riduce la Chiesa ad una associazione legalmente riconosciuta. (v) Il coordinazionismo. Esso trova nel concordato il suo strumento tecnico più frequente. Infatti Chiesa e Stato convengono, convergendo, ad un accordo reciproco (che può essere l’intesa, il concordato, il modus vivendi, ecc.)
39. Questo sistema è quello maggiormente gradito alla Chiesa, poiché lo
Stato riconosce che il suo obiettivo è quello di migliorare l’uomo e la società civile di cui è al servizio. Il coordinazionismo, è in fondo, un separazionismo in cui viga l’istituto concordatario
40.
§5. Gli Stati e le confessioni religiose: brevi cenni
Nei rapporti fra Stato e Chiesa, ma anche fra Stato e confessioni religiose, la legislazione statale può apparire orientata secondo diverse angolazioni e prospettive. Pertanto, possiamo avere varie casistiche: (a) una legislazione favorevole, nel caso in cui viga il sistema confessionale, (b) una legislazione avversativa, nel caso di un sistema “laico” ed anti-religioso (ad
39 Tale sistema è quello indicato dalla vigente Costituzione della Repubblica Italiana (cfr. artt. 7 e 8, 3° comma). 40 Cfr. P. A. D’AVACK, Concordato Ecclesiastico, in Eniclopedia del Diritto, vol. VIII, Milano 1961, 449 ss.: A. VITALE, Corso di Diritto Ecclesiastico, Milano 19926, 95 ss.; V. DEL GIUDICE, Manuale di Diritto Ecclesiastico, Napoli 1961, 110 ss.; P. CIPROTTI, Diritto Ecclesiastico, Padova 19642, 19 ss.; G. CATALANO, Problematica giuridica dei concordati, Milano 1963, 65 ss., ecc.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
30
es. un tempo nei paesi comunisti), (c) una legislazione basata sulla parità i trattamento per tutti i credi religiosi (p. es. gli U.S.A.). Tutto ciò – cioè la legislazione – riflette anche la natura dello stesso Stato, ossia se esso sia di tipo confessionale oppure laico (sistema separatistico) oppure ateo. Nell’ambito degli stati confessionali, cioè in cui una determinata religione sia riconosciuta per legge – costituzionale o non – quale confessione di Stato, abbiamo il cd. “sistema confessionale”. I sistemi confessionali, in accordo con CORRAL
41, sono di tre specie: (a) stati di
confessione islamica, (b) stati di confessione buddista, (c) stati di confessione cristiana; infine abbiamo stati laici, suddivisibili in (i) stati adottanti il regime di separazione, (ii) stati improntati all’ateismo. In aggiunta a ciò, ritengo che tale tematica sia stata molto ben centrata da PARLATO che, giustamente, afferma: «(…) per stato confessionale si deve intendere quello che, per il valore positivo riconosciuto ad una fede religiosa, impronta la propria normativa ai principî etico-religiosi di quella confessione; qualifico, al contrario, come stato laicista, quello che, considerando la religione come fattore negativo per il raggiungimento del suo fine, si farà portatore, nell’ordinamento, di una propria etica materialista o idealista, ma soprattutto antireligiosa o areligiosa; da ultimo configuro laico quello stato che, prescindendo da una valutazione positiva o negativa della religione, farà propri quei valori religiosi di cui i cittadini si fanno portatori, nella misura in cui saranno recepiti dalla comunità nazionale e dai suoi organi di governo»
42. In sintesi, dunque, possiamo suddividere la tematica
nei seguenti grandi “gruppi” come segue. (a) Negli Stati di confessione islamica. L’Islam è posto anche giuridicamente, mediante il diritto musulmano, quale regolatore ed ispiratore di tutti i rapporti giuridici; da ciò scaturisce il complesso meccanismo dello “statuto personale” che regola i non-musulmani, i cui diritti e doveri sono limitati dall’ambito di norme speciali rientranti o nello statuto personale o nel diritto emanato dal legislatore ad hoc (ved. cap. IV, §4).
41 C. CORRAL, Relazioni Chiesa-Stato: vigenti sistemi (Relationes inter Ecclesiam et Statum: systemata vigentia), in NDDC, 899-905. 42 V. PARLATO, Le Chiese d’Oriente tra Storia e Diritto – Saggi, Torino 2003, 149.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
31
L’Islam è religione ufficiale di Stato almeno nei seguenti paesi: Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Mauritania, Sudan, Arabia Saudita, Iran, Giordania, Malesia, Pakistan, Siria, Yemen. (b) Stati di confessionalità buddista. Questi stati riconoscono nelle loro costituzioni il buddismo come religione ufficiale di Stato: Birmania, Cambogia, Laos, Thailandia. Data la natura estremamente tollerante del buddismo, gli stati a confessionalità buddista hanno ben recepito il principio dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla leggi senza discriminazioni religiose e parimenti l’idea di libertà di pensiero e di culto. (c) Nell’ambito degli Stati confessionali cristiani, abbiamo diversi stati che proclamano la religione cristiana quale religione ufficiale di Stato; ma, abbiamo significative differenze tra confessionalità anglicana, cattolica, evangelico-luterana ed ortodossa. In Inghilterra, l’Anglicanesimo è religione ufficiale di Stato ed in base all’Act of Supremacy di Enrico VIII del 1534, è interdetto ai cattolici divenire re d’Inghilterra; tuttavia è concessa ai cattolici piena libertà a partire dal 1829 (tramite il Roman Catholic Act). In molti Stati la fede Cattolica è proclamata quale religione di Stato; ciò avviene in: Lichtenstein (art. 37), Monaco, Argentina (art. 2, 14, 76), Iralnda (art. 44)
43 Bolivia (art. 3), Colombia, Costa Rica (art. 75), Santo
Domingo (art. 6), Panama (art. 35), Haiti (de facto). Gli Stati che dichiarano la confessione evangelico-luterana come confessione di Stato sono: Danimarca (art. 4), Islanda (art. 62), Norvegia (art. 2, 16), Svezia (art. 87). È da notare che in questi stati la chiesa evangelica assurge a rango di vera e propria chiesa “nazionale”. L’unico Stato che ha dichiarato nella carta costituzionale la preminenza della fede greco-ortodossa è la Grecia, ai cui art. 13 e 16 si asserisce che «la religione predominante in Grecia è quella della Chiesa Ortodossa»; alle altre religioni si garantisce la libertà (art. 13, nn. 2 e 3) ma si proibisce il proselitismo (art. 13, 2)
44.
43 La Costituzione Iralndese assegnava una speciale posizione dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana; tuttavia il 5th Emendament della Costituzione Iralndese (8.VI.1972) ha abrogato la speciale posizione della Chiesa Cattolica. 44 La Costituzione greca stabilisce che la Chiesa Ortodossa è chiesa “ufficiale” di stato, costituendo parte rilevante, se non predominante, dell’identità nazionale, infatti la Costituzione Greca, ex art. 3.1, afferma che la religione dominante (ejpikratou=sa) in
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
32
(i) Moltissimi stati prediligono il sistema separatistico, cioè non riconoscono la preminenza di alcun credo religioso a scapito degli altri e dichiarano lo Stato come laico; in molti di tali paesi vige dunque l’istituto concordatario. Tali stati sono: Andorra, Belgio, Francia, Canada, Cile, Uruguay, Bhutan, Cina Nazionalista, Corea del Sud, India
45, Israele,
Giappone, Guinea, Tanganica e Zanzibar (= Tanzania), Italia, Germania, ecc. (ii) Gli Stati comunisti, fanno parte, ormai del passato anche se molto recente; in essi l’ateismo era la “confessione di Stato”. Oggi la Russia ha ampiamente riconosciuto la libertà di culto e la Chiesa Ortodossa Russa non manca in nessuna celebrazione ufficiale di Stato. Riguardo la Russia, è da sottolineare che la recentissima legge sulla religione, approvata il 19 settembre 1997, pur fondandosi su di una ampia tolleranza confessionale e sul rispetto dei credi religiosi, ha mutato completamente l’atteggiamento dello Stato in materia confessionale, asserendo che nessuna religione può essere definita di Stato e quindi obbligatoria, ma riconoscendo al contempo una posizione particolare nella storia della Russia alla Chiesa Ortodossa. Tuttavia, sia a causa della prassi burocratica russa che per altre ragioni causate dallo stesso testo legislativo – nel quale non desideriamo qui trattare – si evidenzia ancora una situazione giuridicamente confusa, ed anche in
Grecia è la l’ortodossia. Tale regime di cose è definito (dagli stessi Greci) JJJJJJJJJJ Tutto ciò, ovviamente crea dei problemi con le altre fedi cristiane, specie quella cattolica. In merito ved. Y. SPITERIS, La Chiesa Ortodossa Greca dall’Indipendenza ai nostri giorni, in a.c.d. L. VACCARO, Storia Religiosa della Grecia, Atti della XIX Settimana Europea, Gazzada, Villa Cagnola, 2-6 settembre 1997, Milano 2002, 379-408. Di contro vedasi: PITSAKIS, La “JJJJJJJJJJ” principe fondamental des rapports entre l’Eglise et l’État. (Idéologie et pratique byzantine et transformations contemporaines), in «Kanon» 10 (1991), 17-35 ed anche PROKOPIOS DI PHILIPPI, Das Verhältnis von Kirche und Staat in Griecheland, in «Kanon» 10, 1991, 53-60; A. N. MARIANOS, Les relations entre l’Eglise et l’Etat en Grece pendant le 12ème et le 20ème siécles, in «Kanon» 10, 61-76. Infine, segnaliamo gli ottimi studi di D. SALACHAS, La religione nella nuova Costituzione della Repubblica Greca, in Oriente Cristiano 15/2 (1975), 74-88; IDEM, La lettura e lo spirito dell’art. 3 della Nuova Costituzione (1975) della Grecia concernente i rapporti tra Chiesa e Stato, in Oriente Cristiano 16 (1976), 74-84; IDEM, La Nuova Carta Costituzionale della Chiesa Ortodossa di Grecia, in Oriente Cristiano 17/3 (1977), 11-32; V. PARLATO, Le Chiese d’Oriente tra Storia e Diritto – Saggi, Torino 2003, 139-147. 45 In merito fondamentale è G. NEDUNGATT, Christian Churches and the Secular State in India, in «Kanon» 10 (1991), 223-251.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
33
parte discriminatoria, che riesce a scontentare sia gli Ortodossi russi che i Cattolici
46.
Unici paesi in cui il comunismo è rimasto sono Cuba e la Repubblica Popolare Cinese (ed anche ancora Corea del Nord e Vietnam); ma anche in queste nazioni la situazione sta cambiando. Per quanto riguarda la Cina, la situazione è molto particolare. Infatti il Partito Comunista Cinese attua un rigido controllo sulla Chiesa Cattolica, considerando cattolici solo coloro che sono ritenuti tali dalla Associazione Patriottica. Dunque attualmente, e da diversi anni, coesistono nella Repubblica Popolare Cinese “due” Chiese Cattoliche: una “patriottica”, cioè di Stato, i cui vescovi sono graditi al partito comunista ed una “clandestina”, i cui vescovi sono consacrati da altri vescovi (sempre cattolici, in segreto). Ciò comporta un clima di vera e propria persecuzione da parte delle autorità comuniste cinesi verso i cattolici (in particolare, a quanto se ne sa, nell’Hebei, nello Zhejiang, nel Jangxi, nel Shaanxi e nel Guangdong). Recentemente è stato pubblicato dal governo un testo noto come «Libro Bianco sulla Libertà di religione in Cina» (da parte del Consiglio di Stato della Rep. Pop. Cinese 16 ottobre 1996) in cui si parla di 4 milioni di cattolici, mentre una statistica redatta nel ‘95 dall’Ufficio Statistico dello Stato cinese dava un numero di 12 milioni di cattolici! L’Agenzia Fides (della Propaganda Fide)
47 ha recentemente posto il luce tale aspetto sottolineando il clima
attuale in Cina (in cui i cattolici sarebbero circa 10 milioni, tra “patrioti” e clandestini). *** Ora possiamo cercare di dare una definizione, forse più precisa, di cosa sia il diritto ecclesiastico in base a tutto ciò che si è detto precedentemente ma anche in seguito ad uno sviluppo della dottrina relativa ad esso. Pertanto il diritto ecclesiastico è stato anche definito come «quel complesso di norme cui è commesso il compito di svolgere e specificare i principi costituzionali di garanzia dell’interesse religioso e della libertà
46 In merito a tale argomento ved.: J. G. PEREZ, La Legge Russa sulla Religione, in La Civiltà Cattolica, n° 3543, anno 149, 7 febbraio 1998, 293-299. G. CODEVILLA, Stato e Chiesa nella Federazione Russa. La nuova normativa nella Russia postcomunista, Bergamo 1988. 47 Ved. Agenzia Internazionale Fides, n° 3242, 24 ottobre 1997, n° 650-658.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
34
religiosa degli individui e della eguale libertà delle confessioni» (RUFFINI, CASUSCELLI). Quindi, come accennato nel precedente paragrafo, esiste un rapporto fra diritto ecclesiastico e diritto canonico. Infatti, secondo la dottrina canonistica il diritto ecclesiastico è quell’insieme di norme di natura concordataria che sono un aspetto del diritto pubblico, vengono definite dai canonisti come ius publicum externum. Allora la peculiarità del diritto ecclesiastico è data dal fatto che in esso confluiscano una quantità di norme di differente origine; infatti abbiamo: (a) norme provenienti dalla volontà statale, (b) norme emanate dallo Stato in virtù di atti bilaterali di accordo o di intesa (concordati, intese, accordi, ecc.), (c) norme che sono provenienti da un ordinamento diverso da quello dello Stato, cioè da altri ordinamenti, quale per es. quello canonico; queste norme regolano alcuni rapporti o alcuni istituti (p. es. il matrimonio) verso i quali lo Stato applica una certa “ingerenza”. È questo, ad es., il caso proprio del matrimonio cattolico, che è regolato dalle leggi canoniche, ma allo stesso tempo è regolato da quelle civilistiche statali, ecco allora che il Concordato “armonizzerà” le norme di entrambi gli ordinamenti, ma allo stesso tempo vi saranno una serie di ulteriori norme – di natura pattizio-concordataria – che avranno la caratteristica e la funzione di reciproco riconoscimento di una serie specifica di norme disciplinanti o regolanti quel dato istituto o quel dato rapporto (ad es. il fatto che il matrimonio religioso abbia effetti per l’ordinamento statale). Ma lo Stato può anche, in alcuni specifici casi, attuare una vera e propria ingerenza nell’ambito di determinate materie ed a certe specifiche condizioni. I giuristi ed i canonisti, in base a quanto sopra detto, si sono posti anche un problema di “logica giuridica”, ossia: le norme costituenti il diritto ecclesiastico, essendo questo inteso dallo Stato come un ramo del diritto pubblico, sono da considerarsi diverse dagli altri rami del diritto statale? Cioè: il diritto ecclesiastico è dotato di una autonomia scientifica? La risposta, in base alla dottrina prevalente, è in senso affermativo (BACCARI, D’AVACK, DEL GIUDICE, GISMONDI, PETRONCELLI, SPINELLI ecc.); ossia il diritto ecclesiastico gode di autonomia scientifica, in quanto in esso si sono sviluppate un insieme di norme che danno vita ad un compiuto sistema normativo che disciplina una particolare categoria di rapporti (quelli appunto fra Stato e confessioni religiose). Dunque il diritto ecclesiastico, per tutte queste motivazioni, fa parte del diritto pubblico statuale ed anzi esso costituisce un ramo intermedio tra
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
35
diritto costituzionale ed amministrativo; infatti esso ha per oggetto i diritti soggettivi pubblici di cui sono titolari persone (fisiche o giuridiche) che fanno parte – essendo cittadini – di uno Stato.
* * *
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
36
CAPITOLO TERZO
L’ISTITUTO CONCORDATARIO Sommario: §1. Verso una definizione dell’istituto concordatario §2. Natura giuridica ed effetti giuridici del concordato §3. Soggetti del Concordato §4. Oggetto del Concordato §5. Forma ed interpretazione del concordato §6. Cessazione del concordato e conseguenze giuridiche §7. Cenni sulla storia dell’istituto concordatario
§1. Verso una definizione dell’istituto concordatario
Finora abbiamo menzionato la parola “concordato”, pertanto ci sembra più che doveroso dedicare un apposito spazio a tale importante istituto, cercando di delinearne la storia, le origini nonché le caratteristiche. Dare una definizione di che cosa sia l’istituto concordatario è cosa abbastanza ardua; la difficoltà di ciò risiede nel fatto che gli studiosi hanno formulato diverse teorie sul concordato. Tuttavia, ai fini didattici non è cosa peregrina il cercare di darne una; riteniamo però che si possa dare una definizione di cosa sia il concordato solo considerando esso per l’età moderna (CATALANO). Dunque possiamo avere due definizioni: (a) una in senso lato, (b) una in senso stretto. (a) In senso lato, il C. indica un qualsiasi accordo diplomatico tra la S. Sede ed uno Stato concernente la disciplina di materie ecclesiastiche di interesse comune; (b) in senso stretto, il C., indica una convenzione mediante la quale viene regolata la condizione giuridica delle istituzioni ecclesiastiche in una data nazione, affinché si dia vita a quel sistema che si è soliti definire “concordatario”.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
37
Dunque, in generale, possiamo definire il C. come una convenzione stipulata tra la S. Sede ed uno dato Stato al fine di regolare materie, ovvero questioni religiose, di comune interesse. È da sottolineare che negli accordi tra la S. Sede e gli Stati oltre al vocabolo “concordato”, troviamo (per esprimere il C.) anche i termini: “convenzione”, “trattato”, “accordo”; nel latino curiale sono tutti detti solemnis conventio. Ma – oltre ai concordati – abbiamo anche protocolli, questi sono delle convenzioni di durata, in genere, limitata e di modesta importanza (comunque sempre inferiore rispetto al C.); questi ultimi sono definiti nel latino curiale modus vivendi. Infine, da non confondere con i concordati, sono le convenzioni che la S. Sede stipula in virtù della propria sovranità e come entità sovrana per un dato fine. La definizione di cui sopra, ance se accettabile, è in realtà approssimativa poiché le finalità dei concordati, la loro forma e le loro caratteristiche sono mutevoli nel corso del tempo ed egualmente eterogenei e diversi in base ai tempi ed alle circostanze che portano ad instaurare vari tipi di accordi tra lo Stato e la S. Sede. L’unico elemento comune a tutti i concordati è la reciproca volontà di divenire ad un accordo soddisfacente con il conseguente impegno a mantenere fede ai patti siglati. Moltissimi autori amano redigere una classificazione dei concordati. Infatti, scorrendo la dottrina, essa ci prospetta una ampia varietà di classificazioni; così i concordati sono raggruppabili in base al loro fine, in ragione dei soggetti, in base alla forma, in virtù del loro contenuto ed infine in merito alla loro durata. Inoltre una parte della dottrina ha provveduto a suddividere i concordati in due classi: conocordati-normativi e concordati-accordi, volendo con ciò suddividere qualitativamente le norme in esse presenti e creando una sorta di gerarchia d’importanza. In realtà tutte queste suddivisioni e classificazioni, benché meritorie, non portano ad alcun contributo sul piano pratico, e specie sulla divisione dei concordati in base alle norme, la recente dottrina ha posto in luce che questa può generare anche equivoci sul piano teorico (CATALANO). §2. Natura giuridica ed effetti giuridici del concordato
Circa la natura giuridica del C. ed i relativi effetti di esso molteplici sono state – e lo sono fino ad oggi – le teorie che si contrappongono in seno ai giuristi (tanto i canonisti quanto i pubblicisti). In realtà dall’età medievale fino ai giorni nostri i giureconsulti di entrambe le parti (Chiesa e
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
38
Stato) hanno fornito di volta in volta ed a secondo dei tempi e delle circostanze proprie teorie, che spesso sono state opposte le une alle altre. Pertanto il problema della natura giuridica del C. rappresenta una vasta problematica giuridico-canonica (ma anche ovviamente civilista-pubblicista) che solo recentemente sembra essersi ridimensionata, in quanto ad un approccio generale e dogmatico si inizia ormai a preferirne uno più realistico e pragmatico. Dunque per cercare di capire e comprendere la problematica in questione, è indispensabile ripercorrere – anche se molto succintamente – le principali teorie che nel corso della storia dell’istituto concordatario si sono sviluppate.
(a) La teoria curialista o dell’indulto o theoria privilegiorum48. Questa teoria
considera i concordati come semplici privilegi, concessioni date dalla Chiesa al princeps o allo Stato; in virtù di ciò i concordati sono interpretabili solo secondo le istruzioni del Romano Pontefice e sono altresì da lui revocabili a suo piacere. Dunque si afferma la superiorità della Chiesa sul principe o sullo Stato. In ragione di tale superiorità, la Chiesa non può venire a patti dal momento che il patto presuppone l’uguaglianza dei contraenti. Pertanto la theoria privilegiorum – detta anche “dei privilegi” – muove i suoi passi dalla immutabilità della suprema auctoritas del Romano Pontefice, dovuta alla sua intrinseca costituzione, che è data dallo ius divinum (Mt 22, 21). Da questa inalienabilità ed immutabilità del potere pontificale nasce spontanea la impossibilità di poter commutare i beni spirituali con vantaggi temporali e materiali. Dunque il C. è un privilegio che la Chiesa concede allo Stato o al principe. Tuttavia questa superiorità non sminuisce il ruolo dello Stato e la sua importanza, il suo potere sovrano ed il suo diritto-dovere di governare secondo giustizia e per il bene comune
49.
(b) La teoria regalista o legale detta anche Legaltheorie50. La Legaltheorie è
esattamente opposta alla teoria privilegiorum, essa si è sviluppata in particolare modo negli ambienti giuridici protestanti. Questa teoria si basa sul concetto
48 I maggiori esponenti di questa teoria, sono stati, anche se con delle significative varianti e con tendenze anche concilianti: TARQUINI, SATOLLI, RADINI-TEDESCHI. LIBERATORE, BALDI, WERNZ, CAPPELLO, BIERBAUM, REGATILLO, D’AVACK. 49 Così in M. FALCO, Corso di Diritto Ecclesiastico, vol. II, Padova 1938, 21. 50 Anche per questa teoria numerosi sono stati gli studiosi ed i sostenitori, che spesso si sono differenziati fra loro per singole interpretazioni; tra tutti ricordiamo: SARWEY, HINSCHIUS, THUDICHUM, STUTZ.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
39
dell’egemonia dello Stato, in virtù del quale la Chiesa non può sovrapporsi ad esso, ma neppure può dirsi eguale poiché derivano dallo Stato – che è potestà sovrana – ogni diritto. Dunque questa teoria non ammette che i concordati abbiano natura giuridica pattizia, dal momento che lo Stato non può patteggiare con chi gli è sottoposto senza altrimenti dover abdicare alla propria sovranità. Pertanto il C. è una concessione dello Stato e perciò da esso revocabile a suo piacere in qualsiasi istante. In particolare, questa teoria, è stata sviluppata dai liberali che considerano il C. come una serie di obblighi morali e la Chiesa come una associazione di fatto e non di diritto. Dunque i conocordati non producono obbligazioni in quanto la Chiesa e la S. Sede hanno diritti limitatamente in quanto lo Stato glieli conferisca. Infatti secondo costoro lo Stato ha il diritto-dovere di regolare le espressioni di culto e dirigerle al bene comune.
(c) La teoria contrattuale51. Questa teoria prescinde dal problema della
preminenza della Chiesa sullo Stato e viceversa, piuttosto considera la natura effettiva dei concordati. Ossia, essa analizza il rapporto che viene a crearsi allorquando si ponga in essere un concordato. Da tutto ciò si elabora il pensiero che il C. abbia l’indole giuridica di un contratto, che come tale dovrà essere pienamente rispettato da ambo i contraenti signatari. I concordati sono dunque patti che instaurano obbligazioni ex iustitia tra la Chiesa e lo Stato. A conforto della teoria contrattuale, si hanno anche numerosi documenti pontifici; per es. nel C. con la Francia del 1516 (tra Leone X e Francesco I)
52, in quello con la Spagna del 1753 (stipulato da Benedetto XV
e Ferdinando VI)53, ma anche un passo dell’enciclica «Nobilissima Gallorum
51 I principali esponenti della teoria contrattuale sono: FRIEDBERG, CUALTIER, PHILLIPS, ORLANDO, RUFFINI, CALISSE, CAVAGNIS, FINK, OTTAVIANI, PALMIERI, VAN HOVE, WAGNON, ANZILLOTTI, JEMOLO, LE FUR. Anche per questa teoria non sono mancate posizioni con sfumature diverse: chi considera il C. come contratti sui generis, chi invece come patti intersovrani, chi come trattati quasi-internazionali, chi infine come trattati internazionali veri e propri. 52 «(...) veri contractus et obligationis inter Nos et Sedem Apostolicam predictam, ex una, et prefatum Regem et regnum suum ex altera partibus, legitimae initi vim et robur obtinere, (...) necnon irritum et inane quicquid secus super his, vel eorum aliquo a quoquam, quavis auctoritate, etiam per nos et successores Nostros prefatos, scienter vel ignoranter, contigerit attemptari, decernimus» (MERCATI, op. cit., 246). 53 «La santità Sua in fede di Sommo Pontefice, e Sua Maestà in parola di re cattolico promettono mutuamente per se medesimi ed in nome dei loro successori la fermezza inalterabile e perpetua sussistenza di tutti e ciascheduno degli articoli precedenti, volendo e
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
40
gens» (8 febbraio 1884)54 di Leone XIII e la celebre enciclica «Vehementer nos»
di Pio X (11 febbraio 1906)55 concernente la rottura del C. napoleonico.
Questa teoria è dunque attualmente la più diffusa e quella che sembra essere maggiormente accettata. A riprova della natura contrattuale ed internazionale dei concordati risiede anche il fatto che la S. Sede riceva presso di sé legati ed ambasciatori dei vari stati e che a sua volta invii nunzi nelle nazioni
56. Infine, si deve sottolineare che la S. Sede da molto tempo
vede di buon occhio l’istituto concordatario, essendo questo un momento di dialogo e di accordo tra la chiesa e lo Stato, mirante a realizzare una “concordia” che possa essere la più stabile e la più duratura possibile.
§3. Soggetti del Concordato
I soggetti del C. sono (come appare facilmente intuibile): la S. Sede – soggetto di diritto internazionale – e lo Stato, persona giuridica sovrana e soggetto di diritto internazionale. La S. Sede sottoscrive il C. per mezzo dello stesso Romano Pontefice, o tramite suo legato ad hoc; mentre da parte dello Stato è contraente lo Stato stesso come persona giuridica e sovrana mediante i suoi rappresentanti legittimi. Dunque non è il capo del governo o dello Stato a stipulare il C. anche se è egli che lo firma; inoltre negli stati costituzionali, inoltre, è prevista la necessaria approvazione del C. in parlamento.
dichiarando che né la S. Sede, né i re cattolici abbiano rispettivamente da pretendere più di quello che viene compreso nei predetti capitoli, e che si abbia a tenere per irrito e di nessun valore ed effetto quanto si facesse in qualsivoglia tempo contro tutti, o alcuno degli stessi articoli» (MERCATI, op. cit., 436). 54 «Cum igitur pactis conventis inter sacram civilemque potestatem, publice aliquid constitutum est, tunc profecto quod iustitiae interest, interest item reipublicae, concordiam manere intergram» (Acta Leonis XIII, IV, Roma 1885, 16). 55 In questo si affermava che il C. obbliga la S. Sede e lo Stato alla stregua dei trattati internazionali, ved. ASS 39 (1906) 3 ss. 56 L’articolo 12 del Congresso di Vienna (9 giugno 1815) riservava alla Sede Apostolica il privilegio che ai Nunzi Apostolici spettasse il decanato diplomatico. Questa nobile tradizione diplomatica oggi va diminuendo di importanza, tuttavia essa è significativa del ruolo di primario livello che la diplomazia apostolica ha svolto e continua a svolgere nel mondo a tutt’oggi. In merito vedasi V. BUONOMO, Considerazioni sul rapporto tra Santa Sede-Comunità Internazionale alla luce del diritto e della prassi internazionale, in Ius Ecclesiae 8 (1996), 3-33.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
41
Al riguardo è da sottolineare che nei preamboli si fa sempre riferimento alla S. Sede e non già alla Chiesa Universale o a quella Nazionale. Tale concetto già fu espresso da PIO XI in una sua missiva inviata al Card. GASPARRI in data 30 maggio 1929, in occasione dei Patti Lateranensi: «(...) nel concordato sono in presenza, certissimamente due sovranità pienamente tali, cioè pienamente perfette, ciascuna nel suo ordine, ordine necessariamente determinato dal rispettivo fine, dove appena d’uopo soggiungere che la oggettiva dignità dei fini, determina non meno oggettivamente e necessariamente l’assoluta superiorità della Chiesa. Che la S. Sede è organo supremo della Chiesa Cattolica universale e quindi legittima rappresentante della organizzazione della Chiesa in Italia, non si può dire se non come direbbesi che il capo è l’organo supremo del corpo umano, e che il potere centrale del e sovrano di un paese è il rappresentante legittimo di ciascuna provincia del paese stesso. È sempre il sommo pontefice che interviene e che tratta nella pienezza della sovranità della Chiesa cattolica che egli, esattamente parlando, non rappresenta ma impersona ed esercita per diretto mandato divino»
57.
§4. Oggetti del Concordato
Molteplici sono gli oggetti, e dunque i fini, del C. tali che è praticamente impossibile elencarli tutti. Inoltre essi variano da C. a C. e sono il riflesso, ovviamente, della situazione diplomatico-politica di quel determinato territorio in quelle circostanze. Tuttavia è possibile delineare alcune aree generali che, sicuramente, costituiscono ciò che si definisce l’oggetto del C. Primo fra tutti, abbiamo il libero esercizio del potere spirituale della Chiesa, con annessa la sua potestà legislativa, giudiziaria, amministrativa. Da ciò scaturiscono tutto un insieme di ulteriori oggetti, quali: il libero e pubblico esercizio del culto cattolico, la libera comunicazione tra S. Sede ed espiscopato locale, ma anche col clero (religiosi inclusi) e con i fedeli laici. Inoltre da questo primario libero esercizio del potere spirituale, a cui è associato intimamente il libero e pubblico esercizio del culto, ne deriva l’oggetto che gli ecclesiastici negli atti del loro officio godano di protezione da parte dello Stato.
57 AAS 21 (1929) 300.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
42
Un secondo oggetto del C. è rappresentato dalla problematica inerente le forze armate ed il servizio di leva obbligatorio (qualora esista). La Chiesa richiede, tramite il C., l’esenzione della leva militare da parte degli ecclesiastici tutti, ma in caso di guerra mette a disposizione una parte del clero per l’assistenza spirituale delle truppe. In tempo di pace, la Chiesa provvede all’erezione o al mantenimento dell’Ordinariato militare, ossia di un vescovo castrense alle cui dipendenze vi sono sacerdoti che hanno come ufficio ecclesiastico quello di essere cappellani militari. In genere il vescovo castrense deve avere il gradimento del governo ed ha un grado pari a quello di generale, mentre i cappellani militari sono inquadrati nelle forze armate come ufficiali. Altro oggetto del C. è dato dal riconoscimento da parte di questo dei giorni festivi (p. es. la Domenica), egualmente la Chiesa si impegna a rispettare le festività nazionali e a pregare per il capo dello Stato o per la nazione in speciali circostanze ed occasioni. Ulteriore, ed importante, oggetto del C. è dato dal fatto che le circoscrizioni ecclesiastiche e le diocesi siano ordinate sul territorio nazionale affinché nessuna di queste venga ad essere alle dipendenze di superiori ecclesiastici di un altro Stato. In sostanza il vecchio principio, già caro alla Chiesa antica, secondo cui le provincie ecclesiastiche si ordino secondo quelle civili, resta sempre valido. Inoltre, sempre per amore del rispetto verso l’unità territoriale dello Stato e della nazione, i parroci ed i vescovi sono, generalmente, scelti tra coloro che godano della nazionalità di quello Stato, (ciò, oggi, non sempre è possibile, dati i flussi migratori connessi con la globalizzazione). Egualmente la Chiesa non ammette interferenze nella scelta dei vescovi, dei parroci e dei superiori degli Ordini, delle Congregazioni e dei monasteri. Tuttavia, accordi speciali possono essere stilati nell’ambito della scelta dei vescovi, anche se la cosa è alquanto rara; poiché da sempre la S. Sede desidera autonomia nella nomina dell’episcopato, anche se speciali condizioni possono poi permettere una certa ingerenza dello Stato. Un ulteriore punto generale che è sempre oggetto del C. è quello inerente al riconoscimento delle chiese pubbliche e degli enti ecclesiastici come persone morali. Da ciò scaturisce anche la richiesta, da parte della S. Sede, di un trattamento fiscale agevolato; pertanto le proprietà loro annesse godono di diritti e le attività finanziare di sostentamento e di distribuzione del denaro vanno soggette ad un regime tributario agevolato, spesso sotto la
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
43
forma di beneficenza. Sempre in ambito tributario, godono di privilegi o di esenzioni (a secondo dei paesi) i lasciti alla Chiesa o alla S. Sede. Altro punto di grande interesse ed importanza è il riconoscimento ai fini civili del matrimonio religioso. La S. Sede richiede che il matrimonio celebrato davanti ai ministri cattolici e secondo le norme dell’ordinamento canonico abbia pieno valore per lo Stato civile di quel paese. Se questo punto è accettato dal C. ne scaturisce anche la necessità (e quindi la richiesta) che le sentenze passate in giudicato dei tribunali ecclesiastici o della Rota Romana in materia di annullamento matrimoniale possano – previa delibazione del tribunale civile d’appello – avere effetti anche nel diritto civile. Infine, altro oggetto del C. ci è dato dall’area inerente all’insegnamento e l’educazione. Generalmente la S. Sede insiste affinché l’insegnamento della religione cattolica sia presente presso le scuole statali o che comunque possa essere liberamente esercitato in quelle private. Sempre nell’ambito dell’educazione, viene richiesta la totale autonomia per la formazione del clero; dunque seminari ed atenei universitari sono riconosciuti dallo Stato come centri di studio e di cultura. Tuttavia, i titoli rilasciati dalle università ecclesiastiche non sempre sono riconosciuti automaticamente dallo Stato, spesso vengono – previa ricognizione dei medesimi da parte dell’interessato al ministero competente per l’educazione – considerati “equipollenti”
58. In genere, nei paesi in cui esista il servizio
militare obbligatorio, gli alunni dei seminari e degli atenei ecclesiastici, anche se non ancora ordinati, possono avere il rinvio del servizio militare (se poi saranno ordinati, otterranno il congedo illimitato). Da ultimo, in ogni C. vi è una sezione dedicata alla regolamentazione delle possibili difficoltà interpretative o su eventuali dubbi inerenti l’accordo ed il modo di risolverli. §5. Forma ed interpretazione del Concordato
(a) La Forma. Si hanno tre momenti nella instaurazione del concordato: la negoziazione, la firma e la ratifica. Usualmente nei tempi odierni, per il C. si procede come in qualsiasi trattativa diplomatica ufficiale. I plenipotenziari della S. Sede e dello Stato preparano i protocolli
58 In merito ved. B. ESPOSITO, Il riconoscimento civile dei titoli accademici in Italia: studio per la realizzazione del pieno pluralismo, Roma 1996.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
44
concordatari, in duplice copia, quindi questi vengono sottoposti alla ratifica da parte del Romano Pontefice e delle rispettive competenti autorità dello Stato. Una vota ratificato e firmato, il C. viene pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis e nelle raccolte ufficiali delle leggi dello Stato (ad es. in Italia, nella Gazzetta Ufficiale). A loro volta gli stati che hanno una democrazia parlamentare, approvano il C., ratificandolo tramite una legge parlamentare. Ovviamente, la mancata autorizzazione alla ratifica, rende inoperante l’accordo. Circa la forma esteriore, cioè l’aspetto formale esterno, del C., essa ha conosciuto varie tipologie: quella di duplice legge promulgata in un unico testo, ossia due documenti separati (uno della S. Sede ed uno dello Stato)
59,
quella rappresentata dalla bolla pontificia, con la quale il Romano Pontefice concedeva privilegi e prerogative allo Stato che erano stati precedentemente pattuiti, ed infine i patti internazionali bilaterali (questa è la formula più moderna e quella che si è definitivamente imposta attualmente). (b) L’interpretazione. Il C., al pari di qualsiasi altro trattato o norma giuridica, deve essere interpretato. L’interpretazione può essere dottrinale oppure autentica (o pubblica). L’interpretazione autentica è unilaterale quando viene data dalle autorità competenti in modo separato. Entrambe queste interpretazioni, pur essendo perfettamente valide, tuttavia non vincolano la controparte; ossia se ad es. la S. Sede dà una interpretazione autentica di una norma concordataria, questa vincolerà i soggetti dell’ordinamento canonico ma non lo Stato e viceversa. Dunque, in caso di particolari questioni interpretative, si può attuare una interpretazione bilaterale, ossia ambo le parti contraenti il C. divengono ad una interpretazione comune di quel dato problema interpretativo. L’interpretazione autentica bilaterale ha ovviamente carattere definitivo e perfettamente risolutorio della questione. Tale interpretazione conosce diverse forme, quali ad es. il protocollo addizionale, le dichiarazioni congiunte, lo scambio di note, ecc. L’interpretazione dottrinale è quella che usualmente viene data dagli studiosi ed in genere mira a scoprire quale sia stata la reale volontà dei contraenti. Quindi per sua natura, l’interpretazione dottrinale, non è
59 Così ad esempio il celeberrimo Concordato di Worms (1122) constava di due documenti separati: il «Praeceptum Imperatoris» di ENRICO V (rinunciante alla nomina dei vescovi) ed il «Privilegium Pontificis» di CALLISTO II (concedente all’imperatore alcune prerogative nella provvisione degli episcopati nel territorio Imperiale).
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
45
vincolante, tuttavia il contributo degli studiosi molto giova al diritto ed all’istituto concordatario. §6. Cessazione del concordato e conseguenze giuridiche
Sia la S. Sede che lo Stato, allorquando stipulino un C. intendono, generalmente, regolare i loro rapporti in forma stabile e quanto più possibile definitiva, secondo la vecchia regula iuris: pacta sunt servanda. In particolare la S. Sede ha, praticamente da sempre, sostenuto la necessità affinché le parti del C. assumano l’obbligazione ad osservare gli articoli sottoscritti
60.
Tuttavia anche i concordati possono cessare al pari di qualsiasi patto bilaterale. Essenzialmente, le cause di cessazione del C. sono le seguenti: (a) per mutuo consenso dei contraenti, (b) per l’applicazione della clausola «rebus sic stantibus», (c) per cessazione della personalità giuridica, (d) per violazione unilaterale. (a) Cessazione del C. per mutuo consenso. Il C. sorge dal mutuo e reciproco consenso di entrambe le parti, pertanto è giuridicamente logico e corretto che se nasca un reciproco e bilaterale consenso atto a sciogliere il C., questo sarà sciolto
61. Alcuni concordati includono esplicitamente
clausole estinsorie o risolutorie62 oppure contengono esplicitamente norme
circa il lasso temporale in cui il C. avrà valore. (b) La clausola ‘rebus sic stantibus’. Il C. può anche cessare per l’applicazione della clausola rebus sic stantibus. Ciò significa che il C. è nella realtà “condizionato” da un determinato Stato di cose che ha portato alla creazione ed alla stipulazione del medesimo. Dunque se in quel dato paese, in cui viga il C., avviene un radicale e profondo cambiamento della situazione che portò al C. oppure se, sempre a seguito di notevoli mutazioni
60 Ad es. PIO IX, così scriveva: «Laica potestas auctoritatem habet rescindendi, declarandi et faciendi irritas solemnes conventiones (vulgo concordata), super usu iurium ad ecclesiasticam immunitatem pertinentium, cum Sede Apostolica initas sine huius consensu, immo et ae reclamante» (ASS 3, 1867, 167). 61 In termini giuridici ciò veniene denominata usualmente come “denuncia” del C. 62 Ad es.: il C. con la Romania (del 1927) stabiliva ex art. 23: «Le due parti contraenti si riservano di denunciare il presente concordato con sei mesi di preavviso»; il C. con la Colombia (del 1928) ex art. 16, conteneva la clausola temporale: «Questa convenzione sarà in vigore per 25 anni, trascorsi i quali le alte parti contraenti potranno prorogarla per il tempo necessario o sostituirla con un’altra nuova».
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
46
sociali o politiche, gli stessi articoli del C. risultino esser divenuti obsoleti oppure pregiudizievoli per le parti, allora in virtù della clausola rebus sic stantibus esso può cessare di essere attivo e perciò decadere. Dunque tale clausola costituisce un po’ una sorta di “valvola di sicurezza” per il trattato stesso e rappresenta la possibilità di mitigare la regola pacta sunt servanda. (c) L’estinzione del C. in seguito alla cessazione della personalità giuridica. Il C. può estinguersi anche per cessazione della personalità giuridica. Infatti esso è stipulato fra due istituzioni: la S. Sede e lo Stato. Per quanto riguarda la S. Sede l’estinzione della sua persona è da ritenere impossibile per ovvie ragioni; infatti per essa non è concepibile un mutamento sostanziale che riguardi l’identità o l’intima struttura della Chiesa. Invece, per quanto concerne lo Stato possiamo individuare tre ipotesi fondamentali di “mutazione” sensibile: (i) cambiamento di governo, (ii) modifiche della concezione dello Stato in seguito a cambiamenti della carta costituzionale oppure per mutamenti del regime politico, (iii) vera e propria radicale cambiamento dello Stato che provoca una trasformazione della stessa identità dello Stato o della sua sovranità. Dunque analizziamo brevemente i singoli punti. (i) Nel caso di cambiamento di governo, la dottrina e la prassi sono unanimemente concordi nel confermare che i concordati mantengono il loro vigore. Ciò è ben comprensibile se si rammenta che il C. è un accordo mirante a dare stabilità nelle relazioni fra Stato e Chiesa: dunque un cambiamento di governo, cioè un cambiamento politico, non può e non deve influenzare un accordo che è Stato stipulato fra due sovranità per il bene della comunità nazionale. (ii) Egualmente il cambiamento costituzionale o quello della forma di governo dello Stato non lede la bontà del C. Così ad esempio se in una nazione si passa da una forma di governo monarchica ad una repubblicana in seguito ad elezioni, il C. manterrà intatto il suo valore; infatti i trattati internazionali non perdono il proprio valore qualunque siano i cambiamenti che sopraggiungano nell’organizzazione interna dei popoli. (iii) Solo se le trasformazioni ed i cambiamenti sono così profondi e tali da mutare l’identità dello Stato, la sua sovranità, allora il C. potrà cessare di esistere. Ossia allorquando uno Stato, per varie cause, praticamente – ma anche giuridicamente – perde la sua personalità giuridica in modo chiaro ed inequivocabile, allora anche il C. cesserà di esistere. Ciò è ben comprensibile
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
47
in quanto mutata profondamente una delle parti contraenti fino all’estinzione, il C. – al pari di qualsiasi altro trattato – perde della sua efficacia. È questo, ad esempio, il caso dei concordati stipulati a suo tempo con la Lettonia (1922) e la Lituania (1927); ambo le nazioni baltiche furono annesse dall’U.R.S.S. In questo caso esse cessarono di esistere come entità sovrane, addirittura il loro territorio nazionale fu alterato profondamente, in quanto iniziò a far parte ddell’U.R.S.S. Altro esempio eclatante ci è dato C. con l’Impero Asburgico (del 1855); crollato in seguito alla Prima Guerra Mondiale (1914-1918), esso cessò di esistere come impero, i suoi confini furono ridisegnati e perse completamente la propria identità di Stato, dunque il C. cessò di esistere
63.
(d) La violazione unilaterale del C. Essendo il C. un patto bilaterale, esso non può estinguersi o cessare per volontà unilaterale di una delle due parti. Questa è una esigenza giuridica frutto della logica contrattuale (pacta sunt servanda) a cui non ci si può sottrarre. Tale principio è inoltre unanimemente accettato dal diritto internazionale nonché dalla stessa S. Sede che lo ha ribadito in numerose occasioni. Dunque nel caso di violazione unilaterale del C., la parte lesa ha il diritto di esigerne la piena osservanza e quindi può procedere alla denuncia del medesimo in virtù della antica regula iuris: «Frustra sibi fidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a se
praestitam servare recusat»64. Quindi la denunzia unilaterale è illecita, ma anche
nulla de iure in ragione del principio: «contra obligationem faciendo, nemo se
obligationi eximit»65. Pertanto la denunzia unilaterale può essere legittima solo
quando si abbia l’applicazione della clausola ‘rebus sic stantibus’ (ved supra); tuttavia è questo un caso grave in cui si verifichi la violazione o la mancata osservanza di alcuni articoli del C. da parte di uno dei due contraenti. Del resto la violazione conclamata di una delle due parti può offrire motivo giustificato perché l’altra parte denunzi il C. In vero, la prassi e la dottrina dimostrano una certa riluttanza affinché il C. venga posto in discussione e quindi denunciato. Infatti prima di giungere alla denuncia del C., la parte che si considera offesa presenta le opportune dimostranze, tramite la sua diplomazia, per ottenere la congrua riparazione o per dare vita a negoziati atti a risolvere la questione che è 63 In merito vedasi l’esplicita allocuzione concistoriale di BENEDETTO XV del 2 novembre 1921 in AAS, 13 (1921), 521-522. 64 Regula Iuris n° 75 in VI. 65 GROZIO, De iure belli et pacis, cap. 20, 38.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
48
venuta a crearsi. Solo allorquando tutti questi espedienti dovessero fallire, allora in virtù del principio «frangenti fidem, fides iam non est servanda», che porta alla denuncia del C. viene ad attuarsi, dal momento che si è manifestata la noluntas della parte che ha provocato la “crisi concordataria”. Importanti conseguenze giuridiche sorgono della cessazione del C. Cessato un C. le parti contraenti restano sostanzialmente libere di regolare – conformemente ai propri ordinamento giuridici – le materie che furono oggetto dell’accordo e che ricadono sotto le rispettive conseguenze. Tuttavia si presenta il problema se la norma concordataria possa sopravvivere all’accordo che la fece nascere, ossia se la norma concordataria – cessato il C. – viva nei rispettivi ordinamenti delle parti contraenti fino al momento in cui le parti non divenghino ad un nuovo accordo. La dottrina canonistica, in merito a tale questione, è incline a risolverla in base alla natura delle norme concordatarie; infatti distinguendo tra clausole contrattuali e clausole normative si può giungere ad una risposta sensata. Di fatti le prime non danno più obbligazioni, dal momento che è cessato il C., mentre per seconde la dottrina ritiene che possano continuare a sussistere. Secondo tale concetto, le clausole normative non cesserebbero automaticamente in quanto possono continuare ad esistere come norme di diritto interno «vuoi per la Chiesa, come se fossero norme di diritto canonico, vuoi per lo stato, come se fossero civili»
66. Ovviamente tutto ciò
dipenderà dalla relativa competenza e sfera d’azione che lo Stato o la Chiesa hanno su di esse; dunque potranno manternersi (anche se non saranno più propriamente dette norme concordatarie) oppure potranno essere eliminate. §7. Cenni sulla storia dell’istituto concordatario
Se finora si è descritto l’istituto concordatario nella sua sostanza, a completamento dell’argomentazione non possiamo non delineare, anche se succintamente, la storia e l’evoluzione che l’istituto concordatario ha avuto in quasi mille anni di storia. Nel periodo tardo-imperiale (dalla pace costantiniana del 313) e poi proseguendo nel medio-evo fino all’età carolingia tutta, il C. fu del tutto sconosciuto. Infatti, l’imperatore, ora cristiano, si considerava tutore dell’ordine ecclesiastico ed egualmente l’imperatore del S. R. I. si riteneva il garanate dei diritti della Chiesa. Successivamente, dopo lo sfacelo della 66 C. CORRAL, Concordato (Concordatum, conventio cum nationibus), in NDDC, 247.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
49
dinastia carolingia, assurta al potere la dinastia degli Ottoni di Sassonia (XI sec.) iniziarono i contrasti tra Impero e Chiesa in materia delle investiture episcopali. Il primo concordato che la storia ci abbia consegnato come tale fu dunque quello di Worms (detto anche pacta Callistina o Privilegium Calixtinum) stipulato il 23 settembre del 1122 da papa CALLISTO II e dall’imperatore ENRICO V di Franconia; esso fu confermato dal Concilio Lateranese I del 1123. Il Concordato di Worms è di nevralgica importanza nella storia del C. ma anche per le relazioni fra Impero e Chiesa, infatti esso pose fine alla tremenda lotta per le investiture iniziata con GREGORIO VII (1073-1085) ed ENRICO IV di Franconia (1056-1106, imp. 1091) e continuata dai loro rispettivi successori. Nonostante la nevralgica centralità del C. di Worms, siamo a conoscenza anche di significativi accordi intercorsi tra la Chiesa ed il potere politico in età precedente al 1122. Infatti, abbiamo il C. di Sutri del 1111 tra PASQUALE II (1099-1118) ed Enrico V che fu di preludio a quello di Worms ed una bolla di natura concordataria emanata (nel 1098) da URBANO II (1088-1099) in favore di RUGGIERO I Conte di Sicilia che diede vita alla monarchia normamma, ed infine il C. detto di Londra (promulgato nel 1107) stabilente la rinunzia reale alle investiture ecclesiastiche in cambio del giuramento di fedeltà da parte degli investiti. Successivamente a Worms, l’attività di stipulazione dei concordati proseguì specie nel periodo tardo medievale in cui andavano affermandosi le monarchie nazionali. Così abbiamo i seguenti concordati ed accordi: tra ALESSANDRO III (1159-1181) e FEDERICO I BARBAROSSA (1152-1190, imp. 1155) nel 1176-‘77, tra INNOCENZO III (1198-1216) e FEDERICO II di Svevia (1197-1250, imp. 1220) nel 1212-‘13, le promesse di GIOVANNI SENZA TERRA del 1212, la convenzione per l’investitura del Regno delle Due Sicilie (1265), quello tra i vescovi portoghesi e re DIONIGI (nel 1288) poi approvato da NICOLÒ IV (1288-1292), la convenzione per l’investitura del Regno di Sardegna (1297). Dopo il XIII secolo, particolarmente significativi sono i concordati stipulati da MARTINO V (1417-1431) nel 1418 per riaffermare l’autorità della Sede Apostolica in seguito al Grande Scisma di Occidente. Successivamente ulteriori capitula concordata, cioè concordati veri e propri, furono stipulati con la Germania, la Francia, la Spagna, l’Italia e l’Inghilterra. EUGENIO IV (1431-1447), al fine di sanare le controversie sorte dallo Scisma di Basilea, nel 1447 emanò una serie di concessioni di privilegi in quattro documenti noti col nome di C. di Francoforte. Nel 1448, NICOLÒ V (1447-1455) e
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
50
FEDERICO III (V) d’Asburgo (1439-1444) firmarono il C. di Vienna; in questo C. furono riconosciute le provvisioni degli uffici ecclesiastici e la libertà di elezione vescovile e la conferma da parte della S. Sede Nel XVI sec. è celebre il C. stipulato nel 1516 fra LEONE X (1513-1521) e FRANCESCO I al fine di abolire la prammatica sanzione di Bourges (del 1438). Nel XVII sec. si ebbero soltanto due concordati: quello tra PAOLO V (1605-1621) e FILIPPO III di Spagna (1598-1621), e quello tra URBANO VIII (1623-1644), BENEDETTO XIII (Pietro de Luna) con FERDINANDO II imperatore d’Austria (1619-1637). Nel XVIII sec., invece, troviamo numerosi concordati stipulati con le monarchie assolute; tra questi dobbiamo ricordarne i seguenti: il C. del 1741 tra BENEDETTO XIV (1740-1758) e CARLO VI re delle Due Sicilie; il C. del 1750 con CARLO EMANUELE III di Savoia; ed infine quello del 1784 tra PIO VI (1775-1799) e l’imperatore d’Austria GIUSEPPE II d’Asburgo-Lorena (1780-1790). Nel XIX sec., dopo la burrascosa parentesi della Rivoluzione Francese (1789) con tutte le sue conseguenze, Napoleone Bonaparte al potere stipulò nel 1801 il cd. C. napoleonico (rimasto in vigore fino al 1905). In generale il XIX sec. fu assai ricco di concordati. Eccone i principali: nel 1817 quello tra PIO VII (1800-1823) e MASSIMILIANO GIUSEPPE re di Baviera, nel 1818 vi fu il C. con FERDINANDO I (1799, re 1806-1825) re delle Due Sicilie. Particolarmente intensa fu l’attività diplomatica di Pio IX (1846-1878) che durante il suo lungo pontificato concluse vari concordati, tra i quali ricordiamo i seguenti: con l’Impero Russo (nel 1847), con il Granducato di Toscana (nel 1851), con il Regno di Spagna (1851), con l’Impero Asburgico (1855), con le Repubbliche di Costa Rica e Guatemala (nel 1852), con la Repubblica di Haiti (nel 1860), con quella dell’Honduras e del Nicaragua (nel 1861), infine con la repubbliche del Venezuela, dell’Ecuador e di S. Salvador (1862). L’attività di PIO IX fu proseguita dai suoi successori; infatti LEONE XIII (1878-1903) stipulò concordati con il Portogallo (1886), con l’Austria per la Bosnia Erzegovina (nel 1881), con la Svizzera per il Canton Ticino e Basilea (nel 1884), con il Regno del Montenegro (nel 1886), con la Colombia (1887), infine divenne ad un accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna per l’isola di Malta (nel 1890). PIO X (1903-1914) stipulò solo un C. con la Serbia (nel 1914) e poche altre convenzioni su questioni particolari.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
51
Con la Prima Guerra Mondiale (1914-1918), l’Europa conobbe devastazioni e tormenti che ebbero come conseguenza la caduta degli “imperi centrali” (Austria, Germania e Russia) ridefinendo così sensibilmente l’assetto geografico-politico europeo. Ma oltre a questo dato, la “caduta delle aquile” portò anche un grave colpo all’ideale monarchico, da sempre caro all’Europa. Inoltre il comunismo aveva fatto breccia, installandosi al potere in Russia. Dunque, molti Stati subirono profonde modifiche addirittura con la conseguente perdita della propria identità e sovranità. La S. Sede – grazie a BENEDETTO XV (1914-1922) – sempre sensibile alla realtà odierna, si dichiarò pronta e propensa a prendere atto di tali mutamenti, incoraggiando la diplomazia mondiale affinché si ponesse all’interesse degli stati la ridefinizione degli accordi concordatari
67. L’appello
papale non cadde nel vuoto: moltissimi stati inviarono i propri ambasciatori presso la S. Sede (molti di questi si erano precedentemente allontanati dalla S. Sede) ed allo stesso tempo ne furono accreditati di nuovi. Pertanto, si ebbe una intensa attività diplomatica finalizzata a redigere nuovi concordati, tenendo presente delle mutate condizioni che si erano instaurate all’indomani della guerra. Ecco, in estrema sintesi, una breve rassegna di essi. Il primo fu quello stipulato con la Lettonia (30 maggio 1922, rat. il 30 novembre), a questo seguì quello con la Baviera (29 marzo 1929). La Polonia, risorta dopo la Guerra, concluse un C. con la S. Sede il 29 marzo 1925, ulteriori accordi furono posti in essere con la Francia (18 gennaio 1925 ed il 4 dicembre 1926), un C. fu stipulato con il Regno di Romania (10 maggio 1927 e nel 1932 si divenne ad un accordo interpretativo sull’art. 9 dello stesso). Con la Cecoslovacchia fu stabilito un modus vivendi (17 dicembre 1927), mentre col Portogallo si raggiunsero due accordi (15 aprile 1928 e 11 aprile 1929). Di fondamentale importanza per la S. Sede e per l’Italia, ma anche per tutto il mondo diplomatico, fu il C. siglato l’11 febbraio 1929 appunto tra S. Sede e Regno di Italia. Infatti questo C. denominato “Patti Lateranensi”, pose fine al lungo dissidio tra la Sede Apostolica ed il Regno d’Italia, risolvendo così definitivamente l’annosa “Questione Romana”; tra le conseguenze immediate dei Patti Lateranensi vi fu la nascita dello Stato della Città del Vaticano (SCV) [ved. cap. 3°, §3]. Successivamente si ebbe il C. con la Prussia (nel 1929), poi con il Baden (1932), e poi con l’Austria 5 giugno 1933) ed infine il 20 luglio 1933 fu siglato il C. con la Germania (allo scopo di completare i concordati conclusi
67 Vedasi l’allocuzione concistoriale di BENEDETTO XV del 21 novembre 1921.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
52
con gli stati germanici ed al fine di assicurare una comune linea di rapporti fra Stato e Chiesa). Infine, nel 1940 viene stipulato un C. col Portogallo e nel 1941 la S. Sede divenne ad un accordo con la Spagna di Franco. Ma una nuova terribile guerra era ormai scoppiata: la II Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale (1939-1945) segna un ulteriore tragico evento del nostro secolo; gli orrori perpetretati, i genocidi di massa, la quantità enorme di civili coinvolti per la prima volta in una guerra, la nascita della potenza distruttiva nucleare, hanno segnato profondamente tutte le nazioni coinvolte. Dunque alcuni concordati ratificati precedentemente alla II Guerra Mondiale subiscono un duro colpo a causa della guerra che produce un riassetto dell’Europa e del mondo intero; tri C. dei i paesi europei travolti o coinvolti dalla II Guerra Mondiale restranno però in vigore i Patti Lateranensi e il C. con il Reich. Questa “continuità” dei due concordati ora citati non è casuale; infatti la Costituzione della Repubblica Italiana (emanata nel 1948) confermò i Patti Lateranesi e la Bundesrepublik tedesca sostenne la tesi che in realtà essa si trovava in condizioni di continuità rispetto allo smembrato Reich tale da assumere la rappresentanza germanica. La S. Sede accettò tale stato di cose, dunque i rispettivi concordati sopravvissero. Pertanto nella fase post-bellica, l’attività concordataria fu proseguita da PIO XII e dai suoi successori fino a GIOVANNI PAOLO II (1978), f..r.
68 Cerchiamo dunque di riassumerne
brevemente i momenti di maggior rilievo. Sotto il pontificato di PIO XII, nel 1953 fu ratificato il C. del ‘40 con la Spagna e nel 1954 fu stipulato il C. con San Domingo; inoltre si provvide a ripristinare – con degli aggiornamenti – il C. austriaco del 1933, che era stato stravolto dall’Anschluss hitleriano. A cavallo tra gli tra gli anni 1957-1968 entrarono in regime di concordato anche i cinque Länder della Germania. Sotto il pontificato di PAOLO VI nel 1964 fu stipulato il C. con il Venezuela e nel 1966 quello con l’Argentina. Inoltre, sempre in questo periodo, fu stipulata una convenzione sui generis con la Tunisia (unica convenzione tra S. Sede ed uno stato islamico); ma sotto il PAOLO VI si ebbero anche convenzioni con la Jugoslavia e l’Ungheria (all’epoca paesi marxisti). Anche dopo il Concilio Vaticano II (1962-1965) e fino al 1981 sono continuate le intense attività concordatarie da parte della S. Sede e degli stati interessati a ciò; ben 32 accordi sono stati 68 In generale sull’intensa attività di GIOVANNI PAOLO II ved. R. ASTORRI, Gli accordi durante il pontificato di Giovanni Paolo II. Verso un nuovo modello?, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 1 (1999), 23-30. G. BARBERINI, I concordati di Giovanni Paolo II nell’Europa Centrale, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 1 (1999), 49-72.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
53
stilati e ratificati con altrettanti paesi69. Di questo periodo dobbiamo
menzionare il C. con la Colombia del 1975 (sostituente quello del 1887) e la sottoscrizione di accordi di revisione del C. con il Portogallo (tra il 1975 ed il 1976). Sotto l’attuale pontificato di GIOVANNI PAOLO II, l’attività concordataria è proseguita brillantemente; infatti: nel 1979 (3 gennaio) vengono firmati quattro accordi con Spagna, viene stipulato il C. con il Perù (19 luglio 1980), viene autorizzato un accordo complementare al C. austriaco (24 luglio 1982); infine, viene portato a compimento il processo di revisione dei Patti Lateranesi stipulando l’Accordo delle modificazioni del Concordato Lateranense con l’Italia (18 febbraio 1984). Ma particolarmente intensa anche l’attività concordataria rivolta verso gli Stati dell’Est Europa: dall’Albania (concordato stipulato nel 2002) alla Slovacchia (accodro stipulato nel 2000)
70.
* * *
69 Dunque cade palesemente l’opinione sostenuta da alcuni che il Concilio Vaticano II abbia nei suoi testi criticato il principio dell’istituto concordatario. CATALANO ha osservato che tra il 1965 ed il 1981 sono state stipulate una quantità doppia di accordi rispetto alle convenzioni sottoscritte durante il lungo pontificato di Pio XII (ved. G. CATALANO, Concordato Ecclesiastico, in Enciclopedia Giuridica, VII, Roma 1988). 70 Cfr. ŠMID M – VASIL’ C., International Agreements between the Holy See and States: an occasion to study mutual relations of two legal systems, in International Bilateral Legal Relations between the Holy See and States: Experiences and Perspectives, Atti del Convegno Internazionale di Studi patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Slovacca – Pontificio Istituto Orientale – Ambasciata della Repubblica Slovocca presso la S. Sede, Roma, Pontificio Istituto Orientale 12-13 dicembre 2001, Città del Vaticano 2003, 327-359.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
54
CAPITOLO QUARTO
ALCUNE TEMATICHE Sommario: §1. L’istituto concordatario oggi: breve panoramica sui concordati §2. Cenni sul diritto ecclesiastico italiano e sua importanza §3. Lo Stato della Città del Vaticano §4 La problematica del diritto ecclesiastico esterno nei paesi islamici § 5. Cenni dei rapporti fra stato e diritto nei paesi musulmani §6. Alcune note in merito al modus vivendi stipulato fra la S. Sede e la Tunisia e lo scambio di note con il Marocco §7. La Santa Sede e il riconoscimento dello Stato di Israele: breve nota §8. La Santa Sede e l’O.L.P.: breve note sull’Accordo del 2000 §9. I Patriarchi delle Chiese cattoliche oirientali e le convenzioni con le autorità civili: breve nota
§1. L’istituto concordatario oggi
Dopo la Prima Guerra Mondiale si è avuto un periodo denominabile quale “nuova era dei concordati”; in effetti la S. Sede ha sempre visto di buon occhio il C. come strumento idoneo ed atto a regolare i rapporti fra Stato e Chiesa. Tuttavia, tale istituto è stato oggetto anche di pesanti contestazioni che sussistono fino a tutt’oggi. Alcuni studiosi criticano l’istituto concordatario, giudicandolo come uno strumento obsoleto che riflette tempi trascorsi; ossia si muove la critica basata sul principio che nella società moderna non ha più senso e ragione parlare di concordati. Secondo alcuni, oggi sarebbe privo di senso un C. con uno Stato moderno. Nell’ambito di tali concezioni, si possono grossomodo distinguere tre teorie. (a) Il C. è un qualcosa di contrario alla natura della Chiesa, (b) i concordati si basano su presupposti sociologici, politici ed ecclesiologici che oggi non esistono più e che anzi conducono ad una visione anti-evangelica, (c) i concordati sono atti superflui in quanto gli obbiettivi che essi si prefiggono sono raggiungibili per mezzo di altri strumenti. Possiamo
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
55
asserire che tutte e tre queste concezioni, non solo non rispondono all’insegnamento della Chiesa ma anche alla genuina prassi che esiste in essa e finiscono col contraddire la realtà storica. Infatti osserviamo, obiettando, quanto segue. Tutte e tre le suddette teorie, infatti, risultano errate poiché non tengono presente il fatto che la Chiesa è allo stesso tempo Corpo Mistico di Cristo, dunque realtà spirituale visibile, ma anche società umana dotata di un sistema normativo perfettamente autonomo (l’ordinamento canonico). Pertanto, la Chiesa per il compimento della propria missione nel mondo, in mezzo agli uomini, può e deve utilizzare – oltre che i mezzi spirituali – anche quelli umani, dunque inclusi quelli che sono offerti dal diritto. Allora perché la Chiesa non potrebbe servirsi dell’accordo giuridico, del patto, del C., per poter anche tramite questo realizzare il suo compito? In fondo, il C. non è uno strumento del potere, ma anzi un momento di dialogo fruttuoso tra due ordinamenti, che altrimenti potrebbero, accavallandosi, cadere in conflitto con il conseguente disorientamento dei cittadini (dello stato) che però sono i fedeli (della Chiesa). Circa invece la seconda teoria, si deve tenere conto che il C. non presuppone, oggi, una “ideologia” comune, né una passiva accettazione da parte di uno dei due contraenti dei principi propugnati dall’altro. Tanto per fare un esempio concreto: nei concordati lo stato non è tenuto a riconoscere che la Chiesa sia d’origine divina o il suo carattere sovrannaturale, così come la Chiesa non ha alcun obbligo di condividere l’ideologia o la forma dello stato o il suo regime politico. A riprova di ciò risiede il fatto, inoppugnabile, che la S. Sede in tempi moderni ha stipulato concordati non solo con stati cristiani o cattolici, ma anche con stati la cui ideologia era stata ampiamente condannata dalla Chiesa; un esempio chiarissimo ci è dato dal C. con la Germania nazista di HITLER (C. del 20 luglio 1933). Dunque la confessionalità dello stato non è il requisito di base o la condizione minima richiesta affinché si possa siglare un C.; l’unica cosa che veramente conta è la reciproca volontà di accordarsi per creare delle norme comuni ed armoniche tra Stato e Chiesa. Infine, circa l’ultima teoria, vi è da obbiettare che in realtà nel mondo contemporaneo non vi sono altri strumenti giuridici per poter realizzare un accordo compiuto ed efficace tra la Chiesa e lo Stato. Ed egualmente, a rigor di logica, è fuor di luogo ritenere che il C. sia lo strumento che metta a disposizione della Chiesa privilegi materiali o temporali o addirittura che esso sia uno strumento al servizio di alcuni interessi politici (basti pensare al recente Protocollo tra la S. Sede e la Repubblica Italiana del 15 novembre 1984). La Chiesa, da parte sua, considera - come si è già più volte detto -
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
56
positivamente l’istituto concordatario, perché innanzitutto permette l’esercizio della libertà religiosa e poi poiché si diviene ad una regolamentazione giuridica comune di materie di comune interesse per lo stato e per la Chiesa. Dunque il problema riteniamo che esista non tanto nell’istituto concordatario in sé, che presenta solo aspetti positivi, quanto piuttosto nel contenuto e nell’uso dello stesso. *** Moltissime sono le nazioni nelle quali vige l’istituto concordatario; dunque mi sembra opportuno e doveroso lo stilare, anche se molto succintamente, un breve resoconto inerente a questo complesso panorama.
– Elenco sommario dei concordati e degli accordi con gli stati 71 –
71 L’elenco, opportunatamente aggiornato, è stato tratto in gran parte da C. CORRAL, Concordati vigenti, concordata vigentia, in NDDC, 229-230, 232-233, 234, 235, 236.
Stati occidentali ed europei: ITALIA 1. Concordato tra la Santa
Sede e l'Italia, dell'11-II-1929.
2. Convenzione finanziaria dell'11-II-1929.
3. Accordi con l'Italia sul trattato e il C.: dal 1931 al 1964 se ne contano 18 (dei quali 8 riguardano il C.; 10 il -trattato; e 6 sono accordi, 2 convenzioni, 8 note diplomatiche e 1 documento addizionale).
4. «Accordo di revisione del concordato lateranense» con «Protocollo addizionale», del 18-II-1984 (n.d.r. detto Accordo di Villa Madama).
5. Protocollo di approvazione delle norme sulla regolamentazione della materia di cui si tratta nell'art. 7, n. 6, dell'«Accordo di revisione del concordato lateranense», con annesso scambio di note diplomatiche del 15-XI-1984.
6. Convenzione tra S. Sede e Italia in materia di previdenza sociale. 16-VI-2000 (rat. 15-X-2003).
7. Accordo con l’Italia per conto della Comunità Europea sulla convenzione monetaria
circa l’Euro, 29-XII-2000, rat. 1-V-2001.
REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA REICH: 1. Concordato del 20-VII-
1933; protocollo finale del 20-VII-1933.
2. Annesso segreto al concordato del Reich del 20-VII-1933.
3. Scambio di note sull’interpetazione dell’art. 26 del C. del Reich del 16/17-VII-1956.
4. Statuti dell’assistenza religiosa alle forze armate della RFT del 31-VII-1965.
5. Nota verbale della Nunziatura Apostolica in Germania del 22-II-1966, sulla interpretazione dell’art.15, cap. 2, par. I del C. del Reich.
BADEN WÜRTTEMBERG 1. C. del 12-X-1932; prot.
finale del 12-X-1932. 2. Protocollo addizionale del
7/10-XI-1932. BASSA SASSONIA 1. C. del 26-II-1965.
Annesso al C. del 26-II-1965. Protocollo intorno alla negoziazione del C. del 26-II-1965. Protocollo della stessa sessione di conclusione del 26-II-1965.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
58
2. Convenzione per la modifica del C. del 21-V-1973
BAVIERA 1. C. del 29-III-1924.
Accordi addizionali al C. del 1927/28 e 16-VII-1931. Accordo amministrativo del 29/30-VIII-1958.
2. Convenzione intorno alla facoltà di teologia cattolica dell’università di Regensburg, del 2-IX-1966.
3. Convenzione intorno alla soppressione della scuola superiore di filosofia e teologia di Freising e alla formazione scientifica degli studenti di teologia cattolica nell’università di Monaco del 2-IX-1966.
4. Convenzione intorno alla facoltà di teologia dell’università di Augsburg del 17-IX-1970. Protocollo finale del 27-IX-1970.
5. Convenzione per la modifica e l’integrazione del C. bavarese del 4-IX-1974. Protocollo finale del 4-IX-1974. Scambio di note fra il nunzio apostolico in Germania e il ministro presidente della Baviera del 4-IX-1974.
6. Convenzione per la modifica del C. del 7-VII-1978. Protocollo finale del 7-VII-1978.
7. Convenzione per introdurre alcune modifiche al C. del 29-III-1924 (Università Cattolica di Eichstätt).
PRUSSIA 1. C. del 14-VI-1929.
Protocollo finale. 2. Scambio di note tra il
nunzio apostolico a Berlino e il ministro presidente di Prussia del 5/6-VIII-1929.
3. Scambio di note tra il nunzio apostolico a Berlino e il ministro prussiano per l’educazione del 4-VIII-1933.
4. Scambi di note tra il ministro presidente della Prussia e il card. Segretario di Stato del 17-VII/3-VIII-1933.
RENANIANA-PALATINATO 1. Convenzione per
completare e modificare le disposizioni del C. nella Renania-Palatinato del 29-IV-1969. Protocollo finale del 29-IV-1969.
2. Convenzione intorno a questioni concernenti la scuola e il perfezionamento e la continua formazione degli
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
59
insegnanti del 15-V-1973. Protocollo finale del 15-V-1973.
3. Convenzione del 26-III-1984.
RENANIA DEL NORD-WESTFALIA 1. Convenzione del 19-XII-
1956. 2. Scambio di note sulla
sezione di teologia cattolica dell’università della Ruhr a Bochum del 20/29-XII-1967.
SAARLAND 1. Convenzione intorno
all’erezione di una cattedra di teologia cattolica del Saarland del 9-IV-1968. Protocollo addizionale del 9-IV-1968.
2. Convenzione intorno alla formazione degli insegnanti del 12-XI-1969.
3. Convenzione intorno alle scuole private dirette dalla Chiesa cattolica del 21-II-1975. Protocollo addizionale del 21-II-1975.
4. Convenzione sulla formazione del professorato nella materia speciale della religione cattolica e intorno all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole del Saarland del 12-II-1985.
5. Convenzione del 19-IX-2001.
SASSONIA-ANHALT: 1. accordo del 15.I.1998. MECLEMBURGO-POMERIANA ANTERIORE: 1. accordo del 15.XI.1997. TURINGIA: 1. Accordo del 19-XI-2002. BREMA: 1. accordo del 21-XI-2003. AUSTRIA 1. C. del 5-VI-1933.
Protocollo addizionale del 5-VI-1933.
2. Convenzione per regolare le relazioni patrimoniali del 23-VI-1960.
3. Convenzione relativa all’erezione a diocesi dell’amministrazione apostolica di Burgenland del 23-VI-1960.
4. Convenzione per regolare le questioni intorno all’organizzazione scolastica del 9-VII-1962.
5. Convenzione relativa all’erezione a diocesi dall’amministrazione apostolica di Innsbruck-Feldkirch del 7-VII-1964.
6. Convenzione relativa all’erezione a diocesi di Feldkirch del 7-X-1968.
7. Convenzione addizionale per regolare i rapporti patrimoniali del 29-IX-1969.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
60
8. Convenzione addizionale per regolare le questioni intorno all’organizzazione scolastica dell’8-III-1971.
9. Protocollo alla convenzione addizionale per regolare le questioni intorno all’organizzazione scolastica del 25-IV-1972.
10. Seconda Convenzione per regolare le relazioni patrimoniali del 9-I-1976.
11. Terza Convenzione addizionale per regolare le relazioni patrimoniali del 24-VII-1981.
SVIZZERA 1. Convenzione intorno
all’annessione di due parrocchie di Posciavo e Brusio alla diocesi di Coira del 23-X-1889.
2. Convenzione intorno all’amministrazione regolare della diocesi di Basilea del 1-IX-1884.
3. Convenzione sulla seprazione dell’amminsitrazione apostolica del Canton Ticino dalla diocesi di Basilea e sull’erezione della stessa in diocesi del 24-VII-1968.
4. Convenzione addizionale intorno alla diocesi di Basilea del 2-V-1978.
ARGOVIA E TRUGOVIA
1. Convenzione intorno all’incorporazione dei cantoni dell’Argovia e Turgovia nella diocesi di Basilea del 2-XII-1828.
BERNA 1. Convenzione intorno alla
riorganizzazione e nuova circoscrizione della diocesi di Basilea del 26-III-1828.
2. Convenzione relativa all’incorporazione dell’antica parte del cantone di Berna nella diocesi di Basilea dell’11-VII-1864.
FRIBURGO 1. Interscambio di note
diplomatiche del 26/VI-25/VII-1864.
SAN GALLO 1. Convenzione intorno alla
riorganizzazione della diocesi di San Gallo del 7-XI-1845.
LUCERNA 1. Accordo sui privilegi nella
provvisione di uffici e benefici ecclesiastici dell’11-VI-1926.
TICINO 1. Convenzione
sull’amministrazione apostolica del Canton Ticino del 23-IX-1884.
SPAGNA 1. Convenzione intorno al
riconoscimento agli effetti civili degli studi di materie
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
61
non ecclesiastiche eseguiti in Spagna nelle Università della Chiesa, del 5 IV 1962.
2. Accordo tra la Santa Sede e il governo spagnolo, del 28 VII 1976.
Accordi tra lo Stato e la Santa Sede, del 3-I-1979. Nota Verbale del 21 V 1979.
3. Accordo tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede su problemi giuridici, del 3-I- 1979. Protocollo finale del 3-I-1979.
4. Accordo tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede sull'assistenza religiosa alle forze armate e il servizio militare dei chierici e religiosi, del 3-I-1979. Protocollo finale del 3-I-1979. Annesso I. Annesso II.
5. Accordo tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede sull'insegnamento e problemi culturali, del 3-I-1979. Disposizioni transitorie. Protocollo finale del 3-1-1979.
6. Accordo tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede su problemi economici del 3-I-1979. Protocollo addizionale del 3-I-1979.
7. Accordo intorno all'applicazione dell'imposta alle società ed
entità ecclesiastiche, del 10-X-1980.
FRANCIA E ALSAZIA-LORENA 1. Convenzione tra Pio VII e
il governo francese, del 15-VII-1801.
2. Accordo sull'erezione di una facoltà di teologia cattolica nell'università «Kaiser Wilhelm» di Strasburgo, del 5-XII-1902.
3. Accordo sulla nomina dei vescovi in Francia, del maggio 1921.
4. Scambio di note sulla validità del progetto di statuti di Associazioni diocesane, del 7/13-V-1923.
4.1. Nota di mons. Cerretti, nunzio apostolico, a M. Poincaré, presidente del consiglio dei ministri, del 7-V-1923.
4.2. Progetto di statuti di «Associazioni diocesane».
4.3. Nota di M. Poincaré, presidente del consiglio dei ministri, in risposta alla nota del nunzio apostolico, del 13-V-1923.
4.4. Estratto dal registro delle deliberazioni del Consiglio di Stato, del 13-XII-1923.
5. Scambio di note tra il nunzio apostolico in Francia e il presidente del consiglio del ministri,
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
62
ministro degli affari esteri, che conferma la convenzione del 5-XII-1902, del 16/17-Xl-1923.
5.1. Nota della nunziatura apostolica di Francia al presidente del consiglio, ministro degli affari esteri, del 16-XI-1923.
5.2. Nota del ministro degli affari esteri a mons. Cerretti, nunzio apostolico, del 17-XI-1923.
6. Accordo tra la Santa Sede e la Francia sugli onori liturgici nei Paesi in cui si esercita il protettorato religioso francese, del 4-XII-1926.
7. Accordo sugli onori liturgici nei Paesi in cui le capitolazioni sono abrogate o non si applicano, del 4-XII-1926.
8. Convenzione tra la Santa Sede e la Repubblica francese relativa al Centro autonomo di insegnamento di pedagogia religiosa nell'università di Metz, del 25-V-1974.
MONACO 1. Lettera Apostolica di
Leone XIII Quemadmodum del 15-III-1887, che crea la diocesi di Monaco, del 17-III-1886/15-III-1887.
2. Convenzione del 25 VII 1981.
PORTOGALLO 1. C. tra la Santa Sede e la
Repubblica del Portogallo, del 7-V-1940.
2. Accordo missionario tra la Santa Sede e la Repubblica del Portogallo, del 7-V-1940.
3. Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica del Portogallo, del 18-VII-1950.
4. Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica del Portogallo per cambiare l'art. 24 del C. del 7-V-1940, del 15-II-1975.
MALTA Accordo provvisorio del 31 VII 1986. Stati dell’Europa Orientale: ALBANIA 1. Accordo del 23-III-2002, rat.
21-IX-2002. CROAZIA 1. Tre accordi del
19.XII.1997. 2. Quarto accordo del
9.X.1998, rat. 14-XII-1998.
ESTONIA 1. Note verbali sullo stato
giuridico della Chiesa del 23-XII-1988 e del 15-II-1999.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
63
LITUANIA 1. Tre Accordi, sulla
cultura, sulle relazioni giuridiche e sull’assistenza religiosa alle forze armate, tutti siglati il 5-V-2000 e tutti ratificati il 26-IX-2000.
LETTONIA 1. Accordo generale dell’8-
XI-2000, rat. 25-X-2002. UNGHERIA 1. Tre convenzioni: 1° sui
rapporti diplomatici (9-II-1990); 2° sull’assistenza alle forze armate (10-I-1994); 3° sui finanziamenti (20-VI-1997).
POLONIA 1. Concordato 28-VII-1993. REPUBBLICA LATVIA 1. Accordo dell’8-XI-2000. REPUBBLICA KAZAHSTAN 1. Accordo di mutue
relazioni; 24-IX-1998, rat. 24-VI-1999.
REPUBBLICA SLOVACCA 1. Accordo base tra S.Sede
e Rep. Slovacca del 24-XI-2000; rat. 15-XII-2000.
2. Accordo sull’assistenza alle forze armate, 21-VIII-2002; rat. 28-X-2002.
3. Concordato tra S.Sede e Rep. Slovacca 21-VIII-2002, rat. 28-X-2002.
REPUBBLICA SLOVENA 1. Accordo di base del 4-
XII-2001. JUGOSLAVIA 1. Protocollo relativo ai colloqui
tra i rappresentanti della Santa Sede e i rappresentanti del governo della repubblica socialista federale di Iugoslavia. del 25-VI- 1966. Protocollo del 25-VI-1966. Scambio di note del 25-VI-1966.
Stati Islamici: REGNO DEL MAROCCO 1. Scambio di note diplomatiche
tra Hassan II e Giovanni Paolo II intorno allo statuto della Chiesa cattolica in Marocco, del 30-XII-1983/5-II-1984.
REPUBBLICA DI TUNISIA 1 Modus vivendi tra la S. Sede e la
repubblica di Tunisia del 27-VI-1964. Protocollo addizionale del 27-VI-1964. Scambio di note del 27-VI-1964.
Vicino Oriente ISRAELE 1. Dichiarazioni di
riconoscimento reciproco e rapporti ufficiali del 30.XII.1993.
2. Ulteriore accordo sulla personalità giuridica del 10.XI.1997.
3. Concordato tra S.Sede e Israele del 10-XI-1997.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
64
O.L.P. 1. Accordo di base tra
Organizzazione per la Liberazione della Palestina e S. Sede; 15.II.2000.
Stati sud americani e caraibici: HAITI 1. tra Pio IX e la repubblica
di Haiti, del 28-III-1860. 2. Convenzione con la Santa
Sede, del 12-III-1861. 3. Convenzione con la Santa
Sede, del 17-VI-1862. 4. Convenzione tra la Santa
Sede e la repubblica di Haiti sui beni della Chiesa cattolica e sull'organizzazione e l'amministrazione delle entrate parrocchiali per il culto, del 25-I-1940.
5. Protocollo tra i plenipotenziari di Paolo VI e i plenipotenziari di François Duvalier, presidente a vita della repubblica di Haiti, del 15-VIII-1966.
6. Convenzione dell'8-VIII-1984.
PARAGUAY Convenzione tra la Santa Sede e
la repubblica del Paraguay sull'erezione del vicariato castrense, del 26-XI-1960. Protocollo addizionale del 26-XI-1960
PERÙ
Accordo tra la Santa Sede e la repubblica del Peru, del 19-VII-1980.
REPUBBLICA DOMINICANA 1. Concordato tra la Santa
Sede e la Repubblica Dominicana, del 16-VI-1954. Protocollo finale del 16-VI-1954.
2. Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Dominicana, del 21-I- 1958. Annesso: Regolamento.
VENEZUELA Convenzione tra la Santa Sede e
la repubblica del Venezuela, del 6-III-1964.
ARGENTINA 1. Accordo tra la Repubblica
Argentina e la Santa Sede sulla giurisdizione castrense e l'assistenza religiosa alle forze armate, del 28-VI-1957.
2. Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Argentina, del 10-X-1966.
BOLIVIA 1. Convenzione tra la Santa
Sede e la repubblica di Bolivia sulle missioni, del 4-XII-1957. Appendice alla convenzione sulle missioni (Art. I, n. 3).
2. Accordo tra la Santa Sede e la repubblica di Bolivia sulla giurisdizione ecclesiastica castrense e
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
65
l'assistenza religiosa delle forze armate, del 29-Xl-1958.
COLOMBIA 1. C. tra la repubblica di
Colombia e la Santa Sede, del 12-VII-1973. Protocollo finale del 12 VII 1973.
2. Dichiarazione al momento dello Scambio degli strumenti di ratifica del concordato, del 2-VII-1975.
ECUADOR 1. Modus vivendi e
convenzione addizionale tra la Santa Sede e la repubblica dell'Ecuador, del 24-VII-1937.
2. Convenzione addizionale del 24-VII-1937.
3. Convenzione sull'assistenza religiosa alle forze armate e alla polizia nazionale del 3-VIII-1978.
EL SALVADOR 1. Convenzione tra la S.
Sede e la repubblica di El Salvador sulla giurisdizione ecclesiastica castrense e l’assistenza religiosa alle forze armate e ai corpi di sicurezza dell’11-III-1968.
Stati africani:
REPUBBLICA DEL GABON 1. Convenzione
sull’insegnamento cattolico, 26-VII-2001.
O.U.A. 1. Accordo di cooperazione in
materie di comune interesse tra S. Sede e l’Organizzazione dell’Unità Africana; 19.X.2002.
Stati Asiatici: FILIPPINE 1. Interscambio di note tra le
Filippine e la S. Sede, relativo all’erezione del vicariato castrense nelle forze armate, del 20-IX-1951/28-III-1952.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
67
§2. Cenni sul diritto ecclesiastico italiano e sua importanza
Non si poteva tralasciare di delineare, anche se assai succintamente, il diritto ecclesiastico italiano; la sua importanza è estremamente significativa, sia per ragioni storiche che per motivazioni dottrinali. Infatti l’11 febbraio 1929 con la stipulazione dei Patti Lateranensi viene definitivamente risolta l’annosa “Questione Romana”, che si era aperta il 20 settembre 1870, allorquando Roma fu presa dalle truppe sabaude e si costituì definitivamente il regno unitario d’Italia sotto i Savoia. Senza addentrarci in particolari, bisogna sottolineare la grande importanza storica dei Patti Lateranensi, nei quali la S. Sede riconobbe ufficialmente la dinastia Sabauda quale sovrana d’Italia e dunque il Regno d’Italia; allo stesso tempo fu riconosciuta alla S. Sede il rango di stato come Stato della Città del Vaticano, conferendole o riconoscendole la personalità internazionale (7 giugno 1929, data dello scambio degli strumenti di ratifica dei Patti Lateranensi)
72. Questa
soluzione fu soddisfacente per tutti sia in Italia che all’estero. Il secondo punto di interesse è dato dal fatto che gli ecclesiasticisti italiani, insieme ai canonisti, hanno dato un contributo fondamentale al diritto ecclesiastico, inteso come disciplina scientifica del diritto; nomi come RUFFINI, JEMOLO, CAPPELLO, CIPROTTI, FEDELE, D’AVACK, PETRONCELLI, SPINELLI e tanti altri che fino ai giorni nostri si dimostrano degli eredi e allievi dei loro predecessori, hanno fornito un contributo di primo livello alla scienza ecclesiasticistica. Ciò non ci deve stupire poiché l’Italia fu sede, senza dubbio, del più importante concordato del XX sec., appunto i Patti Lateranensi; inoltre in Roma è geograficamente incorporato lo Stato della Città del Vaticano. Conclusasi la II Guerra Mondiale, l’Italia, al pari di altre nazioni conobbe un periodo di estrema difficoltà e di grandi mutamenti: la monarchia fu sconfitta con le elezioni, lo stato divenne una repubblicano e parlamentare. Si decise di scrivere la carta costituzionale e l’assemblea costituente preposta ad
72 Ad essi seguirono la legge del 24/06/1929, n° 1159 (Norme sull’esercizio dei culti ammessi), Regio Decreto del 28/2/1939, n° 289 (Norme sull’attuazione della legge 4/06/1929, n° 1159). In merito alla personalità giuridica della S. Sede e sul suo ruolo nel panorama internazionale, ved. V. BUONOMO, Considerazioni sul rapporto Santa Sede – Comunità internazionale alla luce del diritto e della prassi internazionale, in Ius Ecclesiae 8 (1996) 3-33; V. BUONOMO, La riforma della Curia Romana: sue incidenze nella azione diplomatica della Santa Sede nel processo di unità europea con particolare riferimento alla C.S.C.E., in Annali dell'Istituto di Studi Europei A. De Gasperi 9 (1987), 273-327; V. BUONOMO, La Segreteria di Stato. Competenze nella "funzione" diplomatica, in A. BONNET - C. GULLO, La Curia Romana nella Costituzione Apostolica “Pastor Bonus”, Città del Vaticano 1990, 77-188. Circa la S. Sede e l’Europa, ved.: V. BUONOMO, Il "processo C.S.C.E." da Helsinki 1 a Helsinki 2: l'apporto della Santa Sede, in Nuova Umanità 85 (1993), 109-120.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
68
hoc ritenne opportuno non intaccare i Patti Lateranensi, anzi furono inseriti nella Costituzione repubblicana, due articoli di fondamentale importanza circa i rapporti fra Stato e Chiesa; questi sono gli artt. 7 ed 8 della carta costituzionale italiana; eccone i testi: art. 7: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale»; art. 8: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».
Gli articoli ora citati sono estremamente importanti73, per una serie di
ragioni che cercheremo di esporre brevemente. L’art. 7 riconosce la piena sovranità della Chiesa e del suo ordinamento giuridico, dunque vi si ribadisce la piena parità delle due istituzioni. L’art. fa espressa menzione dei Patti Lateranesi, riconoscendone così la validità e l’efficacia, nonostante vi sia stato un cambiamento profondo della forma di governo in Italia (dalla monarchia alla repubblica). Inoltre, l’art. 7, statuisce che una eventuale revisione dei Patti Lateranensi non è oggetto di modifica costituzionale, dunque il Concordato “vive” quasi autonomamente; ciò ha permesso in modo agevole la revisione degli accordi lateranensi in tempi recenti; infatti nel 1984, sotto il governo di B. CRAXI, si è divenuti ad una revisione del trattato lateranense, sostituendolo con un nuovo concordato detto «Accordo di Villa Madama». Infine, è interessante sottolineare che la Costituzione italiana, praticamente riconosce l’istituto concordatario come mezzo dei rapporti fra Stato e Chiesa; infatti per le altre confessioni religiose si parla, ex art. 8, di Intese. Ma, estremamente interessante, è anche l’art. 8 della Costituzione italiana; esso è ispirato ai grandi principi di libertà religiosa e concede la libertà di culto a qualsiasi confessione, purché essa non contrasti l’ordinamento
73 Oltre ai su citati articoli, dobbiamo ricordare che di estrema importanza sono anche i segg. artt. della Costituzione Italiana: 2, 3, 21 (sulla libertà religiosa in generale); 19, 20 sulla libertà di professione e di proselitismo; 17, 18 (sulla libertà di riunione e di associazione), 33 (sulla libertà di insegnamento).
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
69
italiano, asserendo che i rapporti tra le varie confessioni sono regolati con intese stipulate con l’Italia
74.
A questo punto occorre soffermarci, anche se brevemente, sul significato e l’importanza degli accordi di Villa Madama (del 18 febbraio 1984)
75. L’art. 1 degli Accordi del 1984, statuisce che: «La Repubblica Italiana e
la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica, sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo ed il bene del paese». Gli accordi di revisione dei Patti Lateranensi hanno ulteriormente riconosciuto alla Chiesa alcune sue prerogative e funzioni, molte sono state le materie trattate (ci cui è impossibile qui sunteggiare). Tra queste segnaliamo: la libertà organizzativa della Chiesa (artt. 2-6), il matrimonio (art. 8), la scuola (artt. 9-10), l’assistenza spirituale (art. 11), i beni culturali di interesse religioso (art. 12). Tutto ciò costituisce l’attuale diritto ecclesiastico italiano, sul quale non mancano studi di ottimo livello ed interpretazioni dottrinali. Tuttavia, volutamente, non entriamo nella trattazione dei singoli articoli degli accordi di Villa Madama, per i quali si rinvia al proprio personale studio, essendo queste pagine delle institutiones academicae di carattere generale sul diritto ecclesiastico pubblico-concordatario. Dunque per i singoli aspetti si rinvia alle specifiche materie, mentre circa gli accordi di Villa Madama del 1984 vedasi Appendice.
§3. Lo Stato della Città del Vaticano
Chiesa, S. Sede, Stato della Città del Vaticano o sic et simpliciter Vaticano, sono nell’uso corrente della lingua usati quasi come sinonimi interscambiabili, in realtà non è così, infatti tutte e tre queste parole racchiudono concetti e significati molto ben precisi. La Chiesa è, secondo i canonisti, a parte le varie definizioni dottrinali, la società “giuridcamente perfetta”, ossia giuridicamente autosufficiente che
74 In virtù di tale principio l’Italia ha stipulato le segg. intese tramite le seguenti leggi: legge del 11/8/1984. n° 449 – Norme per la regolazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa Valdese; legge del 22/11/1988, n° 516-517 – Norme per la regolazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa Avventista Pentecostale; legge del 8/3/1898, n° 101 – Norme per la regolazione dei rapporti fra lo Stato e le Comunità Ebraiche. 75 Per una trattazione dell’argomentazione ved. nota bibliografia alla fine del testo relativa ai manuali di diritto ecclesiastico italiano, nei quali si trova anche ulteriore specifica bibliografia su singoli aspetti del diritto ecclesiastico italiano.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
70
assume la figura di corporazione istituzionale, non territoriale, provvista di sovranità originaria, di capacità subiettiva pubblica e privata (SPINELLI). Per Santa Sede o Sede Apostolica si intende il Romano Pontefice unitamente alla Curia Papale (cfr. CIC, can. 360). La Curia è definibile come quel complesso di dicasteri per mezzo dei quali il Romano Pontefice esercita il suo alto ufficio di governo della Chiesa Universale. Lo Stato della Città del Vaticano è quel territorio sul quale, in base ai Trattati Lateranensi, è riconosicuta alla S. Sede vera e propria sovranità, indiscutibile sul piano internazionale e assolutamente indipendente sul piano politico
76.
Lo Stato della Città del Vaticano è dunque sorto in virtù dell’art. 3 dei Trattati Lateranensi (11 febbraio 1929) ed ha iniziato ad esistere il 7 giugno del 1929 allorché avvenne lo scambio delle ratifiche del C. con le quali si diede efficacia giuridica agli articoli concordatari. Il 7 giugno del 1929, PIO XI emanò sei leggi organiche che costituirono la base dell’ordinamento giuridico dello SCV
77.
Dunque lo SCV possiede personalità giuridica internazionale autonoma, essendo la stessa Chiesa una societas iuridica perfecta al pari di tutti gli altri stati, inoltre lo stesso SCV ha un corpus legislativo completo; pertanto le teorie
76 Al riguardo è stato molto opportunamente osservato che lo Stato della Città del Vaticano «è diventato “piena proprietà” della S. Sede, ente sovrano su quel territorio. Il fatto che il territorio del piccolo stato sia di “proprietà” dell’ente sovrano, ha fatto sì che in pieno secolo XX fosse creato un Patrimonailstaat, ossia uno stato patrimonio del sovrano, non come astratta concezione della sovranità sul territorio, ma come effettiva appartenenza a titolo di proprietà di tutto il territorio dello Stato al sovrano» (F. FINOCCHIARO, Manuale di Diritto Ecclesiastico, Bologna 19976, 232). 77 Le sei leggi organiche erano le segg.: 1a (o Legge fondamentale) sugli organi costituzionali dello Stato, loro composizione ed attributi, le garanzie giuridiche, la bandiera, lo stemma ed il sigillo di stato; 2a Legge sulle fonti di diritto; 3a legge sulla cittadinanza ed il soggiorno; 4a Legge sull’ordinamento amministrativo; 5a Legge sull’ordinamento economico, commerciale e professionale; 6a Legge sulla pubblica sicurezza. Ovviamente, col passare degli anni a queste disposizioni di leggi se ne sono aggiunte altre fino alla recente Legge Fondamentale del luglio 2000; per uno studio dettagliato sull’ordinamento giuridico dello SCV, ved.: F. CAMMEO, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, Firenze 1932; W. SCHULZ, Lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede, «Apollinaris» 51 (1978), 661-674; W. SCHULZ, Leggi e disposizioni usuali dello Stato della Città del Vativcano, 2 voll., Roma 1981-1982; W. SCHULZ, Der Vatikanstaat, in HdbKatKR (1983), 301 ss. Inoltre ottima è la voce di C. CORRAL, Vaticano, Stato della Città del, in NDDC, 1094-1103.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
71
contrarie sono da rigettare per il canonista78. Ad ulteriore debellamento di tali
teorie (ved. nota supra), risiedono una mole elementi che ragionevolmente le sconfessano tutte. In primis, allorquando lo Stato Pontificio fu debellato con la presa di Roma (20 settembre 1870), la S. Sede ha continuato ad esercitare i diritti caratteristici di un soggetto internazionale (diritto di legazione attiva e passiva, diritto di stipulare convenzioni internazionali); inoltre la S. Sede esercita i propri diritti, al pari di qualsiasi altra persona internazionale, nell’ambito della propria natura. Infatti anche se il suo fine è non è quello comune a tutti gli altri Stati (ossia provvedere al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini). Ma anche si deve ricordare che la stessa finalizzazione tipica dello SCV, cioè assicurare la libertà, l’indiependenza della S. Sede per il proprio governo pastorale (art. 26 dei Trattati Lateranensi), non è di per sé elemento valido per non poter dichiarare che si tratti di uno stato o di una persona internazionale giuridicamente valida. Inoltre lo SCV è uno stato a tutti gli effetti poiché il suo riconoscimento è stato sia esplicito e diretto (art. 3 e 6 del Trattato Lateranense), che indiretto poiché gli stati che avevano allora rapporti diplomatici con la S. Sede furono tempestivamente informati ufficialmente dell’intenzione della S. Sede di sottoscrivere un trattato col Regno d’Italia che avrebbe dato vita ad un nuovo Stato (per l’appunto lo SCV); inoltre lo SCV è uno Stato neutralizzato, al pari della Confederazione Elvetica o della Repubblica di San Marino, pertanto ciò pone lo SCV nella posizione di non poter essere attaccato o offeso da operazioni belliche di altri Stati ed egualmente di non porne in essere
79.
Lo SCV, possiede – al pari di qualsiasi altro Stato – i tre elementi caratteristici affinché una entità possa definirsi “stato”, cioè: (a) il territorio, (b) il popolo, (c) la sovranità.
78 Infatti alcune teorie affermano che la Chiesa non può essere soggetto di diritto internazionale poichè la struttura cattolica è inconciliabile con la qualità di membro della comunità internazionale, essnedo la Chiesa una potenza sovranazionale (CHAUMONT), oppure che non si può parlare di soggetto di diritto internazionale poichè non vi è sovranità territoriale (DONATI), e che la S. Sede non è soggetto di diritto internazionale poiché non ha rapporti diplomatici con tutti gli stati (QUADRI). 79 Art. 24 del Trattato Lateranense: «La Santa Sede, in relazione alla sovranità che Le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli Stati ed ai Congressi Internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale. In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile».
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
72
(a) Il territorio. Lo SCV possiede un territorio proprio, sottratto allo Stato italiano e soggetto alla S. Sede ed alla sua propria potestà
80. La superficie
territoriale è di 0,49 Km2, e la sovranità territoriale si estende al sottosuolo e alla colonna d’aria sovrastante. A tale territorio, si debbono però aggiungere anche quegli edifici che godono di extraterritorialità al di fuori del perimetro vaticano (ex art. 13-16 del Trattato Lateranense, abbiamo: le basiliche patriarcali di S. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore e S. Paolo, il Palazzo Pontificio e la Villa di Castel Gandolfo, il palazzo della Dataria, quello della Cancelleria, il Vicariato, quello del S. Uffizio, quello di Propaganda Fide, ecc.). (b) Il popolo. La popolazione dello SCV è costituita dai cittadini del medesimo
81. Sono dunque cittadini dello SCV: coloro che hanno in esso
residenza stabile, coloro che sono autorizzati dal Romano Pontefice a risiedervi, il coniuge, i figli, gli ascendenti e discendenti di cittadini vaticani, conviventi ed autorizzati a risiedere nel territorio vaticano, inoltre tutti i Cardinali residenti a Roma (anche fuori del territorio dello SCV). Tuttavia è da sottolineare che la cittadinanza vaticana non si acquisisce per mezzo dello ius soli o dello ius sanguinis o dello ius coniugii, ma di norma viene data per rapporti di lavoro o per concessione del Romano Pontefice. Tuttavia la cittadinanza vaticana è comulabile con quella di altri stati ed è fondata sulla volontarietà, cioè occorre la volontà del soggetto ma anche quella dello Stato. (c) La sovranità. La sovranità è costituita dal potere d’imperio, o di comando o di governo; tale potere appartiene al Romano Pontefice il quale ha in sé la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario (art. 1 della Legge Fondamentale dello SCV). Il Romano Pontefice è dunque un sovrano assoluto. Dette queste poche parole sullo SCV, resta da delineare, seppur brevemente i caratteri dell’ordinamento interno dello Stato della Città del Vaticano ed i rapporti, speciali, che esso ha con lo Stato italiano. *** Dunque le caratteristiche dello SCV sono riassumibili come segue: (i) è una monarchia elettiva, infatti il Romano Pontefice, che è il capo del governo, è eletto dai cardinali; (ii) è uno stato assoluto (tutti i poteri sono accentrati nel Pontefice); (iii) è uno “stato patrimoniale”, poiché il potere sovrano del capo dello stato è inerente alla sua persona fisica e si attua anche come domino
80 Cfr. artt. 3, 4, 7-2° comma del Trattato Lateranense. 81 Cfr. artt. 9, 21-1° comme del Trattato Lateranense e della Legge speciale sulla cittadinanza vaticana
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
73
territoriale (che è oggetto del suo potere personale), (iv) è uno stato, ovviamente, confessionale. L’ordinamento interno dello SCV è costituito dalle Sei Leggi Fondamentali emanate da PIO XI (7 giugno 1929) ed il Romano Pontefice esercita la potestà legislativa o direttamente o con delega al Governatore dello Stato oppure anche mediante la Pontificia Commissione per lo SCV. Dobbiamo altresì ricordare che oltre alle 6 leggi organiche, PIO XI emanò con motu proprio anche l’Ordinamento Giudiziario ed il Codice di Procedura Civile (1 maggio 1946, ambo entrati in vigore il 10 dicembre 1946)
82.
Le leggi vaticane, firmate dal Romano Pontefice e sigillate col sigillo di stato, vengono depositate nell’Archivio delle Leggi dello Stato e pubblicate nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis; esse entrano in vigore nel 7° giorno della loro pubblicazione (a meno che non sia stato disposto diversamente). Sono, invece, fonti del diritto dello SCV: il CIC, il CCEO, le Costituzioni Apostoliche, le leggi emanate dal Sommo Pontefice e dagli organi delegati, i regolamenti emessi dalle autorità competenti. Gli organi consultivi, anche questi di nomina pontificia, sono: il Consigliere Generale dello Stato, la Consulta per lo SCV, mentre il potere giudiziario viene esercitato in nome del Sommo Pontefice dagli organi previsti dall’ordinamento giudiziario di cui sopra (ved. nota). L’ SCV è per sua natura territoriale un enclave, cioè è circondato per ogni parte dal territorio della Repubblica Italiana; ciò ha fatto sì che si inserissero nel C. del 1929 disposizioni particolari atte a salvaguardare entrambi gli stati (SCV e Italia). Dunque abbiamo una serie di obblighi dello Stato Italiano verso lo SCV ed una serie di obblighi dello SCV verso lo Stato Italiano. Riassumiamoli brevemente.
82 Gli organi del potere giudiziario sono: (i) il giudice unico, che ha competenza in materia civile e penale; (ii) il tribunale di prima istanza, che è un organo collagiale trattante le cause civili e penali non deferite al giudice unico nonchè tratta delle impugnazioni contro le decisioni del giudice unico, inoltre ha competenza specifica in materia tributaria e di stato civile; (iii) la corte d’appello, composta dal Decano della Rota Romana e da due Uditori rotali; questa corte decide sulle impugnazioni contro il tribunale di prima istanza ed è competente per i giudizi di delibazione delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari stranieri; (v) la Corte di Cassazione, composta dal Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e da altri due cardinali; questa corte è competente per tutti i ricorsi, per motivi di diritto, contro tutti i provvedimenti degli organi giudiziari precedenti. Si deve altresì sottolineare che il Romano Pontefice può avocare a sè qualsiasi causa, civile o penale, in qualsiasi grado del giudizio.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
74
(a) Obblighi dello Stato Italiano verso lo SCV. Oltre ai provvedimenti per la sistemazione dei confini (artt. 5 e 7-1° comma del Tratt. Lat.) gli accordi prevedono quanto segue:
– adeguata dotazione di acque in proprietà; collegamento ferroviario del Vaticano alle ferrovie italiane; collegamento con la rete italiana, e direttamente anche con gli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali della Città del Vaticano; coordinamento degli altri pubblici servizi (art 6 Tratt. Lat.);
– consultazione preventiva con lo SCV per eventuali trasformazioni urbanistiche nelle zone adiacenti alla Città del Vaticano (art. 7 Tratt. Lat.);
– libertà di corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, allo SCV e viceversa; libertà di accesso dei vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica (art. 12 Tratt. Lat.);
– immunità diplomatiche e libertà di passaggio in territorio italiano di rappresentanti diplomatici sia della Santa Sede che di Stati esteri presso quest'ultima (art. 19 Tratt. Lat.);
– esenzione dai diritti doganali e daziari delle merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano o ad altri istituti della Santa Sede, situati fuori della Città stessa (art. 20 Tratt. Lat.);
– libertà di transito, in Italia, per Cardinali e vescovi, senza limitazione della libertà personale, anche nel caso di conclave o di concili (art. 21 Tratt. Lat.).
(b) Obblighi dello SCV verso lo Stato Italiano.
– Piazza S. Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano dovrà rimanere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane, fino ai piedi della scalinata della basilica, nella quale le stesse autorità potranno accedere solo se richieste dalle competenti autorità vaticane (art. 3, 20° e 30° comma Tratt.Lat.);
– i tesori d'arte e di scienza, esistenti nella Città del Vaticano e nel palazzo Lateranense, rimarranno visibili agli studiosi e ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico (art. 18 Tratt.Lat.)
(c) In materia di diritto penale i rapporti fra SCV e Stato Italiano sono regolati dall'art. 22 Tratt. Lat., di cui riportiamo il testo integrale: «A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l’Italia provvederà nel suo territorio alla Punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
75
quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual case si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane
83. La Santa Sede
consegnerà allo Stato italiano le persone che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati. Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestare». Va precisato che, tutte le volte in cui per un delitto commesso nello SCV, la Santa Sede richieda allo Stato italiano di procedere, i nostri giudici applicheranno il diritto penale italiano, poiché la funzione punitiva attiene l'esercizio di una prerogativa sovrana alla quale lo Stato non può rinunciare applicando le leggi d’altro paese
84.
(i) Esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai Tribunali dello SCV. Si applicano, al riguardo, le relative norme del diritto internazionale (art. 23, 1° comma Tratt. Lat.) nonché le norme comuni interne italiane: per la materia civile: gli artt. 796 segg. cod. proc. civ.; per la materia penale: art. 12 cod. pen.; artt. 730-740 cod. proc. pen. Per il secondo comma dello stesso art. 23, «avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati dalle autorità ecclesiastiche od ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali e disciplinari»; tuttavia ciò avverrà, però, in base alla interpretazione accettata da Santa Sede e Stato italiano nel Punto 20 del Protocollo addizionale al nuovo Concordato. (ii) Notificazione degli atti in materia civile e commerciale. I rapporti relativi tra lo SCV e lo stato Italiano sono regolati dalla Convenzione del 6 settembre 1932, resa esecutiva in Italia con L.1 3-4-1933, n. 379. I punti principali dell'accordo sono i segg.:
– se la notificazione deve eseguirsi all'interno dello Stato della Città del Vaticano, su istanza di persone, enti o autorità che si trovino in Italia, l'istante dovrà rivolgersi al Procuratore della Repubblica perché questi inoltri domanda di notificazione al Promotore di giustizia presso il Tribunale di prima istanza dalla Città del Vaticano;
– se invece la notificazione deve eseguirsi in Italia ad istanza di persone, enti o autorità che si trovino nella Città del Vaticano, l'istante dovrà rivolgersi al
83 L’applicazione più nota è quella della condanna all’ergastolo dell’attentatore Alì Acgià da parte della Corte d’Assise di Roma (1981). 84 Ved. Cass. pen. 1 maggio 1955.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
76
Promotore di giustizia (v. sopra) perché inoltri la domanda al competente Procuratore della Repubblica in Italia; qualora si verifichino difficoltà in occasione della domanda di notificazione esse dovranno essere risolte per via diplomatica.
Concludiamo dunque qui questa sezione per passare alla descrizione dei rapporti fra Chiesa e paesi islamici. §4. Cenni sulla problematica dei rapporti fra Chiesa e Stato
nei paesi islamici
In tutti gli Stati in cui viga l’istituto concordatario, il diritto ecclesiastico si presenta con tratti del tutto simili da Stato a Stato. Occorre però individuare un altro tipo di problema: esiste un diritto ecclesiastico nei paesi islamici? La domanda che ci siamo posti all’inizio di questo paragrafo non è peregrina, ma ci consente di delineare una “casistica” nei rapporti fra stato e Chiesa nel mondo orientale (ed in particolare nei paesi di confessione musulmana). Possiamo tentare di rispondere a questa tematica come segue: nei paesi in cui viga il sistema concordatario, come abbiamo detto, non vi sono grossi problemi. Sono queste le nazioni in cui esiste una costituzione ed in cui in generale lo stato, pur essendo laico, o pur non avendo nella sua carta costituzionale un esplicito riferimento alla cd. “religione di stato”, crea tuttavia intese o accordi con le confessioni religiose oppure mira ad instaurare concordati con la Chiesa Cattolica. Il problema si fa molto più complesso allorquando siamo in presenza di stati islamici. Qui l’istituto concordatario non sussiste, in quanto le comunità cristiane sono soggette all’istituto dello statuto personale; unica “eccezione” ci è data dal modus vivendi stipulato fra la S. Sede e la Repubblica Tunisina (ved. infra §4.2). Ma, per cercare di rispondere alla domanda di cui sopra, e per cercare di spiegare la questione, occorre delineare – anche se brevissimamente – la problematica “stato e diritto” nei paesi musulmani. Oggi esistono Stati nazionali (sia sorti da ex domini ottomani sia da ex domini coloniali europei che si sono resi autonomi ed indipendenti), dunque non esiste più nell’Islam un’autorità politica “centrale”. Attualmente i fedeli musulmani vivono all’interno di stati, i quali a loro volta, a secondo dei casi, sono strutturati in diverse forme di governo: dalla repubblica (ijumhuriyya) all’emirato, alla monarchia, al sultanato ed un tempo anche il bey. In realtà nonostante le differenze politiche e delle forme di governo esistenti tra gli stati musulmani, l’Islam si sente nel suo complesso ancora unitario; infatti l’insieme
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
77
di fedeli costituisce la comunità islamica (umma), la quale conosce solo una tipologia di confine: i musulmani, i credenti fedeli, e i non musulmani cioè gli infedeli. La comunità islamica, benché non più unita sotto il califfo, costituisce comunque ciò che gli musulmani definiscono Dâr al-Islâm, cioè la “casa dell’Islam”, mentre il resto del mondo è il Dâr al-Harb, la “casa della guerra”. Da ciò si può comprendere lo spirito bellicoso che ha animato l’Islam verso l’occidente e le sue mire espansionistiche; tutto ciò ovviamente ha le proprie radici nell’Arabia pre-islamica, ma poi si é ben radicato nell’Islam, facendone una religione eminentemente “politica”. La necessità di estendere i confini del Dâr al-Islâm e sconfiggere gli infedeli é motivata anche da intenti teologici: fuori dell’Islam non vi è salvezza e coloro i quali non sono musulmani sono comunque “infedeli”, anche se al contempo l’Islam possiede uno spirito particolarmente tollerante verso i seguaci delle altre due religioni monoteiste (cristianesimo e giudaismo). L’Islam ha con questa concezione, in molti casi, giustificato la guerra ed ha creato il modello di ijad (“guerra santa”). In realtà molti fraintendimenti stanno alla base del ijad, pertanto ritengo utile dare qui una breve spiegazione di cosa ciò sia veramente per i musulmani. In arabo la parola “guerra” é harb, mentre per “guerra santa” ijad; tale distinguo lessicale racchiude in sé parte della problematica, cioè il ijad é un “particolare” tipo di guerra. Il ijad é innanzitutto lo sforzo personale di ogni musulmano affinché il Corano, dunque la Fede e la Verità, siano portati ovunque nel mondo; solo in casi rarissimi ed eccezionali tale sforzo si traduce in lotta militare, cioè in guerra che allora diviene ad essere “santa”. Il caso in cui sia necessario attuare ed applicare il jiâd é allorquando, ad es., un paese islamico sia oggetto di dominazione non islamica oppure una terra islamica sia sottratta al dâr al-Islâm (ad es. Saladino proclamò il jiâd nel 1187, riconquistando Gerusalemme ai crociati). In realtà il jiâd, nato sulle basi coraniche
85 quale lotta contro gli
aggressori e gli apostati, é stato spesso strumentalizzato politicamente per attribuire veste sacrale a mire espansionistiche che con la religione poco avevano a che vedere
86.
85 Innumerevoli i riferimenti coranici alla “guerra santa”, intesa come sforzo bellico, ved. Corano: II, 190-195, 216-218, 224-246; III, 167-174; IV, 71-77 e 84 e 94-95 e 102-103; V, 35; VIII, 38-40 e 57-66; IX, 29, 38-42, 73, 111 e 123; XXII, 78; XLVIII, 16-22; LXI, 3-11; LXVI, 9; intesa come sforzo non bellico Ved. C: XXV, 5; XLIX, 5. 86 In merito alla tematica trattata fondamentale è C. TROLL, La “Missione” secondo la concezione musulmana, in La Civiltà Cattolica del 3 gennaio 1988, anno 149, n° 3541, 40-54.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
78
Tuttavia nonostante la concezione delle “due case”, e quindi in teoria il perenne conflitto fra i due mondi (quello islamico e quello non-islamico), l’Islam – sia per motivi religiosi che politici – ha conosciuto ed applicato nella sua storia il concetto o la virtù della tolleranza, inoltre non potendo continuamente combattere sviluppò una sua diplomazia e regolari ambasciatori europei sono sempre stati inviati in paesi islamici. L’Islam ha conosciuto varie forme di governo e varie “titolature” ad esse connesse. Il primo periodo islamico, quello immediatamente susseguente alla morte del Profeta, conobbe il califfato (dall’arabo khalîfa); è questo il periodo considerato dai musulmani quale “epoca aurea”, ed al quale essi guardano con nostalgia auspicando che possa un giorno ritornare. Ma, oltre ai califfi, l’Islam ha conosciuto i: sultani, gli emiri, i re, ed i bey. Ognuna di queste cariche, cui é connessa una forma di governo, ha una propria storia ed un proprio significato (comunque l’Islam ha conosciuto una grande varietà di tipologie statali)
87.
Interessante é la teoria del potere nell’Islam; la quale é: «(...) intesa come patto tra il sovrano e i sudditi nell’interesse della comunità, concezione dell’assoluta trascendenza divina, positività della natura umana e necessità di esplicarla sulla terra»
88. Dunque anche la tirannide é tollerabile, purché il tiranno sia ligio alla
legge sharaitica; se infatti il governante si discosta troppo da questa, allora potrà essere accusato addirittura di apostasia e dunque sarebbe legittima la sua morte
89.
I paesi islamici hanno conosciuto il fenomeno della cd. “modernizzazione” del diritto; ossia alcuni stati hanno iniziato a distaccarsi, anche se solo in parte, dalla legge sharaitica
90 costituendo per singole branche
giuridiche dei veri e propri codici o statuti oppure (caso più frequente) hanno codificato alcune parti della legge sharaitica, introducendo elementi di modernizzazione. Il processo di codificazione e di modernizzazione ha,
87 Per un esatto e dettagliato quadro storico-politico dell’Islam, ved.: B. LEWIS, Il linguaggio politico dell’Islam, Roma-Bari 1991. 88 B. SCARCIA AMORETTI, Tolleranza e Guerra Santa nell’Islam, Firenze 1974, 17. 89 E’ questa una delle accuse più frequentemente mosse da parte degli oltranzisti islamici verso i governanti che abbiano intrapreso una via troppo occidentale o che abbiano manifestato il desiderio di non applicare più la legge coranica; ad esempio, con simili rivendicazioni fu giustificato da parte degli integralisti, l’assassinio di SADAT (presidente dell’Egitto dal 1970 al 1981). 90 Ricordo che la legge religiosa islamica non é stata mai codificata nella sua totalità; solo alcune parti sono state fatte oggetto, ma solo recentemente dal secolo scorso in poi, di tentativi di codificazione.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
79
ovviamente, conosciuto varie tappe e si presenta assai diversificato a seconda dei paesi nei quali tale tendenza abbia fatto breccia; pertanto i diritti dei paesi musulmani pur presentando caratteri comuni hanno al contempo anche cospicue differenze. L’influsso occidentale e di “modernizzazione” ha in certi paesi ridotto di molto il valore della legge sharaitica, mentre in altri solo singole discipline sono state riformate; tutto ciò costituisce il diritto dei paesi musulmani, che é in sostanza una miscela variabile di legge sharaitica e codificazione moderna. Il processo di modernizzazione del diritto vide il suo inizio nel secolo scorso e continua fino ad oggi, anche se attualmente la tendenza “integralista”
91 é così forte da contrastare il processo stesso mettendolo a dura
prova. Tale processo, che si articola sia in un’opera di codificazione che in una applicazione di norme più moderne, ha interessato varie discipline, ma quella che ha conosciuto maggiormente tale processo é senza dubbio il diritto di famiglia (matrimonio, eredità, filiazione, ecc.)
92. I metodi di riforma usati, in
accordo con ALUFFI BECK-PECCOZ93, sono essenzialmente due. Il primo
sistema é l’espediente procedurale-processuale, il quale é estremamente duttile ad usarsi; infatti «Senza interferire con la validità teorica delle norme tradizionali, essi [i.e. interventi riformatori procedurali] si limitano a impedirne l’applicazione, con l’ordinare ai giudici di prescindere in presenza di determinate circostanze»
94. Il secondo sistema, detto “eclettico”, si attua
qualora il legislatore nel codificare la sharî’a «(...) giudichi che la regola da applicare in base ai criteri di individuazione posti dal fiqh non risponda all’interesse generale. Ordina quindi ai giudici di sostituirla con un’altra, corrispondente a un’opinione giuridica diversa»
95. In entrambi i casi dunque si
assiste ad un parziale ampliamento dei poteri del legislatore o del sovrano il quale, pur adempiendo alla legge sharaitica, può limitare il potere del giudice 91 In realtà il termine “integralista/integralismo” non significa nulla, esso sta a indicare quella tendenza religiosa che vuole una osservanza completa della legge sharaitica, l’applicazione in toto della legge penale islamica e la totale coincidenza tra Stato e religione; in sostanza gli “integralisti” sono quei gruppi che si potrebbero definire: conservatori, ortodossi, le cui rivendicazioni attuali sfociano spesso in atti di fanatismo estremo. Dunque più che di integralisti, sarebbe opportuno parlare di “fondamentalisti islamici” o “ultra-ortodossi”. 92 Cfr. R. ALUFFI BECK-PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Milano 1990, passim. 93 Ibid., 49-55. 94 Ibid., 49. 95 Ibid., 51.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
80
nella sua competenza oppure rimuovere l’obbligo del giudice ad attenersi alle regole della scuola giuridica d’appartenenza. In realtà anche prima del processo di modernizzazione la legge sharaitica non era mai stata applicata nella sua totalità; di fatti nelle pratica forense ed in quella giurisdizionale si sono sempre messe in atto delle differenziazioni. Ciò é accaduto non a caso, infatti da una parte era necessario radunare la materia stessa, data la sua complessità anche in ambito sharaitico, e dall’altra poiché in molti paesi vige il sistema dello statuto personale. Lo statuto personale (ar.: ahwâl šahsiyyah) é quel sistema di norme regolanti il diritto delle persone, della famiglia e della successione ereditaria. È da rammentare che l’attuale tendenza è stata quella di procedere ad una codificazione dello statuto personale. Questo sistema è applicato un po’ in tutti i paesi musulmani e soltanto la Turchia fa eccezione; infatti a partire da Kemal Atatürk la Turchia abolì la legge sharaitica e promulgò, tra il 1926-‘27, un codice civile (modellato a quello elvetico) comune a tutti i cittadini, e pertanto in Turchia vige uno ius loci, un diritto comune di Stato
96. Anche in materia di
statuto personale si é avuto un processo di codificazione; il primo Stato a codificare in materia fu la Persia che promulgò un suo codice civile tra gli anni 1927-1935. In nota, ecco alcune tappe salienti del processo di “modernizzazione” – che formalmente inizia nel 1875 – che è ancora in pieno svolgimento
97.
96 Addirittura, in Turchia, é vietata la poligamia (ammessa invece dalla legge coranica). 97 1875 codificazione della legge hanafita del diritto di famiglia e dell’eredità in Egitto ad opera di Qadrî Pasha. 1916 Primo progetto di codice per lo statuto personale islamico in Algeria (“Codice Morand”). 1917 Legge Ottomana dei diritti di famiglia. 1920 Legge egiziana sul nafaqa (= mantenimento della moglie). 1926-1927 Abolizione della legge islamica in Turchia ed adozione del codice civile svizzero e del codice penale italiano. 1926-1927 Legislazione modernista iraniana. 1929 Legge egiziana sul divorzio. 1931 Regolamento egiziano per i tribunali, circa l’età minima matrimoniale. 1937 “Shariat Act” nell’India Britannica. 1939 “Dissolution of Muslim Marriages Act” nell’India Britannica. 1943 Legge egiziana sull’eredità. 1946 Legge egiziana sul Waqf (= pie fondazioni) e sui lasciti. 1951 Legge giordana dei diritti di famiglia. 1953 Legge siriana sullo statuto personale. 1956 Codice tunisino dello statuto personale e dell’eredità (1959): Majalla. 1957 Legge franco-algerina sulla tutela e sul divorzio. 1957-’58 Codice marocchino di statuto personale ed eredità. 1959 Legge irachena sullo statuto personale. 1959 Decreto franco-algerino sul matrimonio e sul divorzio. 1961 Decreto pakistano sul diritto di famiglia. 1962 Legge sulla famiglia e sulla tutela in Mali. 1962 Entrata in vigore, completa, della precedente legge algerina. 1963 Legge dell’età minima matrimoniale in Algeria. 1964 Legge di famiglia nella Costa d’Avorio. 1971 Legge sul matrimonio in Tanzania. 1972 Codice di famiglia in Senegal. 1973 Abrogazione della legge algerina del 1962. 1974 Legge indonesiana sul matrimonio. 1975 Diritto di famiglia somalo. 1975 Modifiche alla legge siriana
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
81
Si è prima accennato ai non musulmani, viventi in paesi islamici; in merito bisogna ricordare quanto segue. Verso gli idolatri, gli atei, i materialisti e gli apostati, l’Islam riconosce un solo stato di cose: la guerra; dunque queste categorie sono automaticamente escluse da qualsiasi forma di dialogo o di contatto (almeno nei paesi in cui viga la sharî’a). Particolare tolleranza e benevolenza l’Islam riserva invece alla cd. “Gente del Libro” (ahal al-Kitab), cioé: Cristiani, Ebrei e Mazdeisti. Infatti: «I seguaci di questi tre culti, che si sottopongono al dominio musulmano ed accettano di pagare il tributo, godono della protezione o sicurtà (“dimmah”) pubblica, e si dicono perciò “dhimmi” “protetti”»
98. Dunque la dimmah é un
vero e proprio contratto bilaterale, una sorta di concordato sui generis, tra Stato islamico e minoranza confessionale monoteista (ahal al-Kitab). In virtù di tale istituto: Cristiani (tutti), Ebrei e Mazdeisti risultano categorie giuridiche “protette”. Il dhimmi da parte sua promette di osservare e rispettare l’autorità islamica e lo Stato ed inoltre si impegna a pagare all’erario musulmano 2 tasse ben precise: (a) la tassa fondiaria per la propria terra (detta harag);
(b) la tassa annua personale o capitazione, detta gizyah99.
La condizione giuridica del dimmi é dunque particolarmente interessante, poiché impone al medesimo alcune restrizioni ed obblighi.
Infatti, secondo la dottrina sharaitica, il dhimmi non potrà100
: esercitare alcuna autorità sui musulmani, né essere esattore tributario, né ricoprire incarichi pubblici
101, né tutore o curatore di un musulmano, né giudice (potrà
tuttavia essere chiamato a svolgere l’officio di perito se non vi siano islamici in quella materia), né potrà essere testimone qualificato in un processo in cui sia
del ‘531976. Nuovo codice dello statuto personale in Giordania. 1979 Decreto egiziano su alcune disposizioni dello Statuto personale, abrogate poi nel 1985 ma reintegrate nello stesso anno. 1984 Codice algerino del diritto di famiglia. 1984 Codice kuwaitiano dello statuto personale. 1992 Legge sullo statuto personale della Repubblica dello Yemen. 98 D. SANTILLANA, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema sciafiita, I, Roma 1926, 99. 99 La giyzah è data annualmente dal dhimmi maschio, adulto, libero, sano di mente e capace economicamente di assolvere tale obbligo. 100 Per tale parte fondamentale resta D. SANTILLANA, op. cit., 100 ss. 101 Tale norma nel corso della storia ha avuto delle “palesi violazioni”, in Egitto p. es. molti visir erano copti (e quindi cristiani); inoltre i dimmi possono ricoprire l’incarico di aiutanti (segretari o cancellieri) nei tribunali.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
82
accusato un musulmano, ecc. Tuttavia, nonostante le suddette restrizioni, al dhimmi viene garantita una libertà personale ampia, la sua persona ed i suoi beni sono intangibili; egli potrà esercitare qualsiasi tipo di negozio giuridico con i musulmani, purché ciò non leda la legge religiosa islamica (p. es. un ebreo, cittadino saudita, non potrà commerciare bevande alcooliche in quel paese). Tra le imposizioni che creano, almeno da parte cattolica, maggior disagio vi é quella concernente i luoghi di culto; infatti nei paesi ove viga la sharî’a, viene dato (con difficoltà) solo il permesso per il restauro delle chiese e praticamente mai quello per edificarne nuove (allorquando ciò sia dato, accanto alla chiesa verrà edificata una moschea!). Un tempo vi erano anche imposizioni sull’abbigliamento del dhimmi, ma oggi sono di fatto desuete, resta invece una notevole ostilità in materia di proselitismo; p. es. in Arabia é vietato introdurre Vangeli. Particolarmente interessante é il profilo giudiziale circa il dhimmi; egli potrà essere giudicato dal tribunale islamico, ma il giudice ha l’obbligo di trattarlo come un musulmano, inoltre al dhimmi é data la facoltà di appellarsi sia al tribunale religioso islamico che a quello afferente alla propria fede religiosa
102. Il matrimonio del dhimmi sarà valido se osservate le norme della
propria legge religiosa, così: il matrimonio di un cattolico orientale dovrà ottemperare ai canoni del CCEO e l’invalidità o nullità dello stesso sarà giudicata dal tribunale cattolico (e quindi riconosciuta dallo Stato islamico). Solo circa le leggi della sicurezza dello Stato e dell’ordine pubblico, il dhimmi sarà oggetto diretto del tribunale islamico. La dhimmah, come ogni contratto, può venire ad essere risoluta; ciò accade nel momento in cui il dhimmi venga meno ad i suoi impegni
103. Secondo
la scola malikita e quella sciafiita, la dhimmah viene a decadere nei seguenti casi: • il dhimmi imbraccia le armi contro i musulmani; • mancato pagamento, per rifiuto, della giyzah; • rifiuto di obbedienza all’autorità nell’esercizio delle proprie funzioni; • rapimento di donna libera e musulmana, quindi seduzione della medesima ad opera del dhimmi, il quale le tace la sua condizione; • attività spionistica o tradimento nei confronti dello Stato islamico; • qualora il dhimmi oltraggi Allah o il Corano o Muhammad (o qualsiasi altro Profeta riconosciuto dall’Islam);
102 Se però vi é una causa tra dimmi di fede diversa (p.e. tra un ebreo ed un cristiano), allora ipso iure sarà competente il tribunale islamico al fine di dirimere la questione. 103 D. SANTILLANA, op. cit., 107.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
83
• allorquando il dhimmi converta alla propria fede un musulmano, distogliendolo così dall’Islam. In tal caso il dhimmi decade dalla condizione di protetto e diviene ipso iure un nemico della comunità islamica. Lo status del dhimmi varia ad ogni modo da Stato a Stato, a seconda che in esso sia applicata o no la sharî’a, per es. in Turchia il concetto di dhimmi, essendo stata abrogata la legge religiosa, non sussite! Dunque, per rispondere alla domanda che siamo posti all’inizio di questo quarto paragrafo, nel caso dei paesi musulmani il termine “diritto ecclesiastico” non è appropriato; infatti qui non esiste l’istituto concordatario, ma è presente lo statuto personale. Tuttavia, il sistema dello statuto personale, essendo una sorta di accordo bilaterale, presenta alcune analogie con il concordato. In tale sistema la sfera dell’influenza dello Stato è assai più marcata rispetto a quella dei paesi (non musulmani) in cui viga l’istituto concordatario. In sostanza, nei paesi musulmani lo Stato accorda alcuni diritti alla comunità confessionale non musulmana, riconoscendola, ed imponendole anche delle restrizioni (p. es. nell’attività di proselitismo). Allora, pur non esistendo un diritto ecclesiastico, così come è inteso dalla pubblicistica occidentale, non di meno esiste per la Chiesa Cattolica (ma anche per le altre Chiese Cristiane) un diritto ecclesiastico esterno il quale rientra nello statuto personale. In sostanza, nei paesi islamici, non sembra esistere la nozione di un “diritto ecclesiastico” facente parte del diritto pubblico dello Stato, bensì esiste sic et simpliciter il “diritto della comunità” cristiana (sia essa cattolica o acattolica) che è espresso, o racchiuso, o stigmatizzato all’interno dello statuto personale. Tutto ciò è ben comprensibile se si tiene conto che nei paesi musulmani, ma in generale in tutto l’Oriente, è uno ius personae che esiste al posto dell’occidentale ius loci (BUCCI). Da quanto detto, scaturisce un importante conseguenza: la Chiesa Cattolica, ove viga lo statuto personale o dove l’ordinamento del paese islamico sia fortemente improntato ai dettami shariatici, anziché regolare i rapporti fra fedeli cristiani e Stato islamico con un concordato, agisce in virtù dello statuto personale e dello ius personae cercando di far valere direttamente i codici di diritto canonico, anziché ricorrere alle norme di natura pattizio-concordataria. La Chiesa cattolica, però ha la possibilità di accordarsi tramite convenzioni, che possono essere stipulate dai patriarchi. Unico caso di concordato, o meglio di modus vivendi è quello con la Tunisia (ma ciò è dato dal fatto che la Repubblica Tunisina ha nella sua costituzione, de facto, lascito spazio ad una intesa maggiore verso i non-musulmani)
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
84
§5. Alcune note in merito al modus vivendi stipulato fra la S. Sede
e la Tunisia e lo scambio di note con il Marocco
L’accordo stipulato con la Repubblica Tunisina nel 1964 è un caso veramente unico nel panorama delle relazioni fra S. Sede e stati islamici. Infatti esso è Modus Vivendi, dunque un concordato in piena regola (anche se, coma abbiamo visto il modus vivendi è un tipo di accordo “inferiore” rispetto al concordato vero e proprio)
104. Il motivo giuridico per il quale fu possibile
istituire tale modus vivendi è da rintracciare nella stessa costituzione tunisina (che fu promulgata da Burghiba nel 1959, dopo soli due anni dalla indipendenza). Infatti nonostante la Repubblica Tunisina abbia dichiarato all’art. 11 la propria confessionalità islamica, riconobbe con un apposito articolo, il num. 5, la libertà religiosa. Dunque proprio in virtù dell’art. 5 della costituzione tunisina, si potette procedere ad instaurare un modus vivendi tra S. Sede e Stato tunisino. Le caratteristiche di questo modus vivendi (per il testo completo ved. Appendice) sono – in accordo con il PETSCHEN
105 – quattro: (a) riconoscimento
della personalità giuridica alla Chiesa Cattolica in Tunisia, (b) limitazioni alla attività della Chiesa Cattolica, (c) concessioni della Chiesa Cattolica allo Stato tunisino, (d) protezione della Chiesa Cattolica da parte dello Stato tunisino nella società. (a) La Chiesa Cattolica è riconosciuta come persona giuridica in Tunisia, il cui rappresentante legale è il Prelato nullius di Tunisi (art. 2); questo riconoscimento ha come effetti la libertà di comunicazione tra clero e fedeli e tra S. Sede e clero presente in Tunisia (art. 5). Inoltre viene riconosciuto alla Chiesa la libertà di praticare il culto. Infine vengono riconosciuti i beni appartenenti alla Chiesa (art- 6).
104 Una sorta di commento di questo Modus Vivendi ci è data dalla Lettre Pastorale de S. Exc. Mgr. Maurice Perrin in La Documentation Catholique n° 1430, 16 Aout 1964, 1005-1007. Mgr. Perrin fu arcivescovo di Cartagine prima dell’istituzione della Prelatura di Tunisi; egli parla giustamente di “climat nouveau” instaurato dall’accordo. In merito ved.; V. BUONOMO, Sullo scambio di Lettere tra Giovanni Paolo II e Hassan II circa la condizione giuridica della Chiesa Cattolica in Marocco: Adnotationis ad Acta Apostolicae Sedis 77 (1985), 712-715, in Apollinaris LIX (1986), 5-14. 105 S. PETSCHEN, Tunez, in C. CORRAL SALVADOR-J. GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Concordatos vigentes - Textos originales, traducciones e introducciones, II, Madrid 1981, 621-623. In merito si vedano anche: S. SANZ VILLALBA, El “Modus Vivendi” entre la Santa Sede y la Republica de Tunez, in Revista Epañola de Derecho Canonico 20 (1965), 49-53 [testo], 54-56 [commento]; F. ROMITA, Conventio (“Modus Vivendi”) inter Apostolicam Sedem et Tunentana Rempublicam - Adnotationes, in Monitor Ecclesiasticus 89/1 (1965), 15-32.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
85
(b) Le limitazioni imposte alla Chiesa sono diverse. La prima e più vistosa consiste nel divieto di compiere attività politica in Tuninsia da parte della Chiesa Cattolica. L’espressione usata dal modus vivendi indicante il divieto di «activité de nature politique» è in realtà alaquanto vaga. Infatti la Chiesa non fa politica e non è una istituzione politica, ma religiosa. Dunque quanto statuito dall’accordo potrebbe, unilateralmente, essere interpretabile anche come una limitazione del magistero ecclesiastico. La Chiesa Cattolica, nella figura del Prelato nullius, pur essendo libera di stampare e pubblicare le proprie ordinanze, lettere pastorali ecc., oltre a dover essere in regola con le leggi sulla stampa e l’editoria, dovrà darne copia al governo tunisino (art. 5). Inoltre si esige l’autorizzazione del governo per la compravendita di beni (art. 7). La scelta del Prelato nullius viene ufficialmente data dal modus vivendi alla S. Sede, tuttavia «afin de favoriser l’haromnie entre l’Eglise Catholique et l’Etat Tunisien» si richiede che la S. Sede invii al governo tunisino in modo segreto e tramite le vie diplomatiche il nome del prescelto (art. 10). In questo caso l’“ingerenza” sembra proprio evidente da parte dello Stato, infatti la frase usata dall’accordo implicitamente esprime la volontà di avere come prelato nullius un “persona gradita” alle autorità tunisine e tale volontà è maggiormente e chiaramente espressa nelle righe successive dell’art. 10. Il Prelato nullius dovrà presentare al governo tunisino la lista degli ecclesiastici residenti nella nazione (art. 11). (c) Il governo tunisino pur avendo riconosciuto alla Chiesa Cattolica il diritto di possesso sui luoghi di culto (art. 6a) richiede che parte di essi siano ceduti a titolo gratuito allo Stato (art. 6b; per l’elenco si rinvia agli annessi IV e V del protocollo di intesa). Tuttavia, questi beni immobili, pur divenendo proprietà dello Stato non saranno utilizzati per fini diversi da quelli del culto. (d) Lo Stato tunisino autorizza l’istituzione – establishment – delle scuole, degli ospedali e delle associazioni assicurandone la dovuta protezione (art. 9). Inoltre, data l’ostilità di alcuni musulmani verso i cattolici in Tunisia (che sono l’1% della popolazione, tutti non-tunisini) il governo richiede di essere preventivamente informato per gli atti di culto pubblico al fine di proteggere la minoranza cattolica (art. 6e). Infine il governo tunisino, in ottemperanza alle leggi di polizia sugli stranieri, faciliterà l’ingresso ed il soggiorno di clero destinato alla Chiesa in Tunisia (art. 8). In realtà, a conclusione di questo breve excursus sul modus vivendi instaurato tra la Tunisia e la S. Sede, possiamo osservare che esso pur essendo un accordo bilaterale internazionale, sorto grazie alla costituzione tunisina, nell’aspetto sostanziale esso si presenta molto come un qualcosa di simile allo statuto personale. Infatti il modus vivendi, ad una lettura attenta, risulta più come
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
86
un insieme di norme pattizie in cui lo Stato islamico primeggia ora dando alla Chiesa privilegi o protezioni, ora imponendole delle limitazioni e dei divieti. Ad ogni modo, meglio un modus vivendi un po’ sfavorevole alla Chiesa che il nulla oppure uno statuto personale (spesso assai penalizzante); infatti la Tunisia resta a tutt’oggi l’unico Stato musulmano ad avere un modus vivendi con la S. Sede. *** Altro caso interessante, nell’ambito dei rapporti fra Stato e Chiesa nei paesi islamici, ci proviene dallo scambio di note diplomatiche tra Giovanni Paolo II f. r. e Hassan II, re del Marocco, avvenute tra il 1983 ed il 1984 (ved. Appendice). L’avvenuto scambio di note è assai significativo; infatti il re del Marocco sembra mostrarsi estremamente disponibile verso il Romano Pontefice e la Chiesa Cattolica. Non dobbiamo dimenticare il ruolo e l’importanza attuale della casa reale marocchina nell’ambito dell’Islam (il re del Marocco discende direttamente da Maometto). Re Hassan II non esita ad affermare che «(...) l’Eglise catholique continuera, au Royaume du Maroc, d’exercer publiquement et librement ses activités propres, en particulier celles relatives au culte, au magistère, à la juridiction interne, à la bienfaisance de ses fideles et à l’enseignement religieux». Dunque più che uno scambio di note diplomatiche, specie la lettera del re marocchino, indica una reale volontà di accordo bilaterale. Certamente tutto ciò non rappresenta un concordato o un modus vivendi, ma egualmente dimostra che il Marocco ha la volontà di non ostacolare la Chiesa Cattolica, anzi il re riconosce espressamente il valore giuridico della gerarchia cattolica nel suo regno e asserisce che la sua lettera ha valore di “disposizione legislativa”; dunque egli ha manifestato un impegno preciso nei confronti dei Cattolici nel suo paese. Nella lettera pontificia di risposta (ved. Appendice) appare chiara e giustificata la soddisfazione per il tono ed i contenuti della lettera inviata dal re del Marocco. Dunque questo scambio di note appare estremamente importante; infatti la lettera del re del Marocco non è una semplice dichiarazione di intenti, ma racchiude in sé un vero e proprio statuto della Chiesa Cattolica in Marocco. Pertanto tutto ciò costituisce senza dubbio un grande passo in avanti nelle relazioni tra cristiani e musulmani in Marocco ed allo stesso tempo fornisce, come si ha modo di leggere nel testo, una vera e propria serie di garanzie giuridiche verso la Chiesa Cattolica. Come si potrà ben comprendere, nei paesi musulmani diverse sono le strade da proseguire al fine di rendere armoniosi i rapporti fra stato e Chiesa:
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
87
possiamo avere degli accordi di natura concordataria, come la Tunisia, oppure uno scambio di note dettagliate che abbia vigore di legge (caso del Marocco), oppure ancora una rivisitazione dello statuto personale (rendendolo per quanto possibile favorevole ed applicabile alla parte cattolica), infine – come vedremo nel prossimo paragrafo – anche lo stipulare delle convenzioni con l’autorità civile da parte dei patriarchi orientali (magari una vera e propria serie di convenzioni che tocchino diversi punti giuridici e sociali). Questa ultima via (cioè quella delle convenzioni stipulati dai patriarchi), potrebbe essere la più semplice ed anche, forse, la più politicamente diretta al fine di raggiungere una relazione armonica tra stato musulmano e Chiesa Cattolica. Ad ogni modo, i casi della Tunisia e del Marocco sono significativi perché sono i “primi”, speriamo che ad essi se ne possano presto aggiungere degli altri nel comune interesse di tutti. Inoltre poiché vi sono dei precedenti – per l’appunto quello tunisino e marocchino – auguriamo che tale strada possa essere percorsa dalle diplomazie interessate, al fine di avere una sempre maggior concordia tra confessioni religiose. §6. La S. Sede ed il riconoscimento dello Stato di Israele: breve nota
Il Concilio Vaticano II (1962-1965) ha, anche nel campo dei rapporti e delle considerazioni riguardo gli ebrei, segnato il mutare di atteggiamenti della Chiesa instaurando una svolta decisiva. Nel decreto «Nostra Aetate» così si esprime il Concilio: «Essendo perciò tanto grande il patrimonio comune ai cristiani e agli ebrei, questo sacro concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto dagli studi biblici e teologici e da un fraterno dialogo»
106.
La riflessione post-conciliare ha portato, poi, ad un prosieguo circa i rapporti con gli ebrei, alcune delle cui tappe possono essere rintracciate nei seguenti brani. «Praticamente è dunque necessario, in particolare, che i cristiani cerchino di capire meglio le componenti fondamentali della tradizione religiosa ebraica e apprendano le caratteristiche essenziali con le quali gli ebrei stessi si definiscono alla luce della loro attuale realtà religiosa. […] Il dialogo presuppone il desiderio di conoscersi, e di sviluppare e approfondire tale
106 Nostra Aetate 4; in EV I, 865.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
88
conoscenza. […] Condizione del dialogo è il rispetto dell’altro, così come esso è, e soprattutto rispetto della sua fede e delle sue convinzioni religiose»
107.
«Per gli ebrei [Gerusalemme] è oggetto di vivo amore e di perenne richiamo, ricca di numerose impronte e memorie, fin dal tempo di David che la scelse come capitale e di Salomone che vi edificò il tempio. Da allora essi guardano si può dire ogni giorno a essa e la indicano come simbolo della loro nazione. […] Per il popolo ebraico che vive nello Stato di Israele e che in quella terra conserva così preziose testimonianze della sua storia e della sua fede, dobbiamo invocare la desiderata sicurezza e la giusta tranquillità che è prerogativa di ogni nazione e condizione di vita e di progresso per ogni società»
108.
«Si può dire che, crimine senza precedenti, quello di sterminare una nazione intera, fece inorridire l’Europa cristiana e la mobilitò a riparare i torti recati attraverso i secoli agli ebrei e a volte incisi nelle strutture del pensiero e del costume. Dopo un intervallo di duemila anni gli ebrei hanno finalmente il loro proprio stato. E le nazioni della civiltà cristiana hanno intrapreso il penoso lavoro di sradicare dalla propria mentalità ogni ingiusto pregiudizio nei riguardi degli ebrei…»
109.
Tali riflessioni, essenzialmente ispirate dal Concilio Vaticano II, hanno avuto tra i positivi risultati, quello che ha portato all’accordo fra S. Sede e Stato di Israele, sigillato da una cerimonia svoltasi il 30 dicembre 1993 presso il ministero degli esteri israeliano a Gerusalemme. Tale accordo di cui si riporta il testo tradotto in italiano (ved. Appendice) ha portato al riconoscimento reciproco tra la S. Sede e lo Stato di Israele. Come ogni accordo, esso è stato frutto di intense trattative che prolungatesi per un anno e mezzo circa, hanno portato a buon fine la cosa
110. Firmatari dello
107 S. Em.za Rev.ma Card. J. WILLEBRANDS, Presidente della Commissione per i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo, Orientamenti e suggerimenti per l’applicazione della dichiarazione Nostra Aetate (n. 4), 1 dicembre 1974. 108 Lettera apostolica «Redemptionis Anno», 20 aprile 1984. 109 GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla comunità ebraica, Varsavia 9 giugno 1991. 110 Il 29 luglio 1992, nel Palazzo Apostolico del Vaticano, era stata istituita una commissione bilaterale fra i rappresentati della S. Sede e quelli dello Stato di Israele. La Commissione si è riunita in seduta plenaria il 19 novembre 1992 a Gerusalemme e poi il 29 dicembre 1993 in Vaticano, allo scopo di approvare i testi che erano stati compilati e presentati ad opera degli esperti. Tali testi comprendono l’Accordo fondamentale firmato nella cerimonia del 30 dicembre 1993.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
89
storico accordo sono stati YOSSI BEILIN, Vice Ministro degli Esteri dello Stato di Israele e Mgr. Claudio M. CELLI, Sottosegretario per i rapporti con gli stati della S. Sede. L’importanza storica di tale accordo è stata sottolineata anche dagli stessi firmatari; il viceministro israeliano YOSSI BEILIN così si è espresso: «Da un punto di vista formale quello che abbiamo firmato oggi è un accordo fra un piccolo stato, Israele, e uno stato ancora più piccolo, la Città del Vaticano. Tuttavia l’impatto di questo accordo va ben oltre i suoi confini geografici e giunge a toccare i cuori di milioni di ebrei e di più di un miliardo di cristiani in tutto il mondo. [...] Nel preambolo dell’accordo si sottolinea come le parti, nel firmarlo, siano “consapevoli della natura unica del rapporto fra Chiesa cattolica e popolo ebraico e del processo storico di riconciliazione e della crescita di comprensione reciproca e di amicizia fra cattolici ed ebrei”. [...] La firma, oggi a Gerusalemme, dell’accordo con la Santa Sede costituisce un successo della saggezza, un successo per il popolo ebraico e per lo Stato di Israele»
111.
Ma, il fruttuoso dialogo, con il relativo clima di distensione, è proseguito anche dopo questo accordo fondamentale. Infatti dopo 4 anni di trattative diplomatiche si è giunti ad un nuovo accordo nel 1997, che si incentra principalmente sul problema del riconoscimento della personalità giuridica alle istituzioni ecclesiastiche [ved. Appendice]. All’art. 2 di questo secondo accordo, infatti, si stabilisce il principio che la S. Sede ha autorità “sovrana” sulla Chiesa Cattolica. Da ciò discende che lo stato di Israele accorda lo status di personalità giuridica alla Chiesa Cattolica in Israele e dunque godono di personalità giuridica (art. 3-5 dell’Accordo del 1997): i Patriarcati, l’Assemblea degli Ordinari della Terra Santa, la Custodia della Terra Santa, gli Istituti di vita consacrata, ecc. Particolarmente interessante – come rileva PALOMINO – è l’art. 9 sul diritto processuale; qui il principio civilistico iura novit curia viene a “saltare” poiché si sancisce che allorquando durante lo svolgimento di un processo si tocchi questioni inrenti al diritto canonico, il caso verrà trattato come un quaestio facti e non come una quaestio iuris; in sostanza il diritto canonico è equiparato – dallo Stato di Israele – ad un diritto straniero
112.
111 Dichiarazione di YOSSI BEILIN, Vice Ministro degli Esteri dello Stato d’Israele in occasione della firma dell’Accordo Fondamentale con la Santa Sede (Gerusalemme, 30 dicembre 1993); in NES 6 (1994). 112 Per tale accordo si rinvia alla Documentation Catholique, 14 gennaio 1998; R. PALOMINO ha curato una traduzione spagnola nel suo saggio: Avances en las relaciones jurídicas entre Israel y la Santa Sede. El “Acuerdo sobre Personalidad Jurídica” de 1997, in Annuario de Derecho Ecclesiástico del Estado 14 (1998), 737-754.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
90
Sicuramente tali accordi segnano una completa revisione del processo di dialogo non solo tra S. Sede e Israele, ma tra le due grandi religioni monoteiste, quasi sembrano essere l’espressione, o la continuazione, giuridica di quella “purificazione della memoria”, tanto cara a GIOVANNI PAOLO II.
§7. La Santa Sede e l’O.L.P.: breve nota sull’Accordo del 2000
Non si poteva non toccare, dopo Isreale, l’Accordo di base tra la S. Sede e l’O.L.P. (Organizzazione per la Liberazione della Palestina), siglato in Vaticano il 15 febbraio dell’anno 2000
113. L’Accordo, composto da un preambolo
e 12 articoli, rappresenta un momento di enorme risonanza politica ma – come osserva PALOMINO
114 – anche giuridica della praxis concordataria. Questo
accordo pone un particolare significato sul problema della libertà religiosa in generale ed anche sulla questione dello status che dovrebbe avere la città di Gerusalemme, rappresentando così un apporto specifico nella prassi concordataria, consolidando così quella cooperazione tra Chiesa e quei paesi o “entità” che sono “alieni” – per usare la terminologia di PALOMINO – alla tradizione cristiana. Questo accordo, segna sicuramente anche un altro importante punto da rilevare: il concordato o l’accordo è utilizzato come strumento verso la tutela dei diritti umani, è in sostanza il momento “pratico-giuridico” di quanto stabilito dal Concilio Vaticano II; il concordato assume a mezzo per poter realizzare e ribadire quei diritti – propriamente detti “umani” – che oggi la civiltà giuridica moderna, in specie quella europea, si sforza di attuare. Dunque anche sul piano giuridico, la portata di tale accordo è più che significativa, per non dire oltremodo rilevante. §8. I Patriarchi delle Chiese cattoliche orientali e le convenzioni
con l’autorità civili: breve nota
Ritengo che non si possa tralasciare il ruolo dei Patriarchi delle Chiese Orientali cattoliche riguardo alle relazioni tra “Stato” e Chiesa, espresse tramite una normativa specifica dettata oggi dal Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium.
La normativa generale che informa sulle “convenzioni” stipulate assicura ex can. 4 CCEO la natura stabile degli accordi pattuiti; in sostanza il Codice dei
113 Il testo di tale Accordo è reperibile nel quotiadiano vaticano L’Osservatore Romano, 16 febbraio 2000; testo francese in Documentation Catholique, n. 2221, 210-211. 114 R. PALOMINO, El Acuerdo Básico entre la Santa Sede y la OLP en el contexto de la práctica concordataria reciente, in Revista Española de Derecho Canónico 58 (2001), 275-289.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
91
Canoni per le Chiese Orientali, – come pure il CIC (il cui can. analogo a quello del CCEO è il can. 3)
115 – statuisce la bontà degli accordi già esistenti dichiarando
che il Codice non li inficia: Can. 4: «Canones Codicis initas aut approbatas a Sancta Sede conventiones cum nationibus aliisve societatibus politicis non abrogant neque eis derogant; eaedem idcirco perinde ac in peaesens vigere pergent contrariis Codicis praescriptis minime obstantibus».
Il CCEO ci fornisce alcuni interessanti canoni aventi per oggetto le prerogative patriarcali in merito alle “conventiones”
116.
I canoni del CCEO di nostro interesse sono i seguenti: 98, 99, 100117
. Principiamo col can. 98 CCEO, che statuisce:
Can. 98 «Patriarcha de consensu Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis et praevio assensu Romani Pontificis conventiones iuri a Sede Apostolica statuto non contrarias cum auctoritate civili inire potest; easdem eutem conventiones Patriarcha ad effectum ducere non potest nisi obtenta Romani Pontificis approbatione».
In base al can. 98 è data facoltà al Patriarca di poter stipulare convenzioni con l’autorità civile o statale; tuttavia egli dovrà ottemperare le seguenti condizioni: (a), si necessita del consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, (b) dovrà ottenere il previo assenso del Romano Pontefice, (c) la convenzione con le autorità civili non dovrà essere contraria al diritto stabilito dalla Sede Apostolica, (d) la convenzione sarà esecutiva solo dopo aver ottenuto l’approvazione del Papa. La cura che pone il Codice è più che giustificata dal momento che le convenzioni con lo stato sono materia importante nei rapporti fra stato e Chiesa. Dunque è comprensibile che l’instaurazione delle medesime avvenga nell’interesse di tutta la Chiesa
115 CIC, can. 3: «Codicis canones initas a Apostolica Sede cum nationibus aliisve societatibus politicis conventiones non abrogant neque iis derogant; eaedem idcirco perinde ac in peaesens vigere pergent, contrariis huius Codicis praescriptis minime obstantibus» 116 In merito ai Patriarchi e le convenzioni vedasi: W. SCHULZ, Die Katholischen orientalischen Patriarchen und ihre Rechtsstellung gegenüber den zivilen Autoritäten in ihern Patriarchatsgebiezen, in V. K. LÜDICHE - H. MUSSINGHOFF - H. SCHWENDENWIEN, Kanonistiche Überlegungen zu einer vergessenen Norm des katholishen Ostkirchenterchts, in Iustus Iudex. Festgabe für P. Wesemann, Essen 1990, 675-692. 117 Per un commento ai cann. 99-100 del CCEO, ved.: J. FARIS, Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance. According to the Code of Canons of the Eastern Churches, New York 1992, 271-274.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
92
patriarcale ed in armonia con i dettami della Sede Apostolica. Queste “convenzioni” sono in realtà vere e proprie forme di intese. Infatti nonostante la S. Sede, nella persona del Romano Pontefice, debba fornire l’assenso prima ed l’approvazione poi, queste convenzioni sono piuttosto degli accordi bilaterali, che tuttavia non hanno natura internazionale poiché i firmatari sono il Patriarca e i rappresentati del governo o delle autorità civili. Pur essendo importanti, esse non hanno i requisiti dei concordati, poiché sono accordi non già tra la S. Sede e lo Stato, bensì tra una Chiesa e lo stato. Tuttavia non per questo, tali accordi, sono di poca importanza; infatti essi possono andare a modificare, anche profondamente, una certa situazione o delimitare la reciproca sfera di influenza della Chiesa e dello stato su determinate materie. Specie nei paesi islamici (ove viga il sistema dello statuto personale) questi tipi di accordi si possono ben offrire quali mezzi per la revisione degli statuti personali o per l’applicazione di alcune clausole o disposizioni. Il fatto che si conceda al Patriarca un tale diritto, rientra perfettamente e nella tradizione orientale, in base alla quale i patriarchi sono da sempre considerati anche come “etnarchi” (capi di una etnia) oltre che capi religiosi. Il CCEO, prosegue sul tema con un canone, che rinvia direttamente alla problematica degli statuti personali:
Can. 99 «§1. Patriarcha curet, ut Statuta personalia in regionibus, in quibus vigent, ab omnibus serventur. §2. Si plures Patriarchae eodem in loco potestate in Statutis personalibus agnita vel concessa utuntur, expedit, ut in negotiis maioris momenti collatis consiliis agant»
Il canone è estremamente significativo, poiché prende in considerazione anche il fatto che più patriarchi possano essere soggetti al medesimo regime civile. In tal caso è necessario che i patriarchi agiscano di comune interesse, cioè che attuino una sinergica cooperazione. Ma al patriarca spetta anche il compito di “vigilare” sugli statuti personali affinché siano rispettati da tutti, ossia che essi siano adempiti sia dall’autorità civile che da quella religiosa. Ancora una volta si avverte nel canone il concetto di “etnarca”; il Patriarca è un pastore di anime e di popolo, ed il suo popolo (nei paesi islamici) costituisce una etnia a se stante (si pensi ai Copti d’Egitto o ai Caldei dell’Iraq, ecc.): Infine abbiamo il can 100, che rappresenta un po’ una sorta di corollario dei due precedenti; esso infatti statuisce:
Can. 100 «Negotia, quae plures eparchias respiciunt et auctoritatem civilem tangunt, Patriarcha ad se advocare potest; statuere autem de eisdem non potest nisi consultis Episcopis eparchialibus, quorum interest, et de consensu Synodi
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
93
permanentis; si vero res urget nec suppetit tempus ad coadunandos Episcopos Synodi permamentis membra, horum vices in casu gerunt Episcopi curiae patriarchalis, si habentur, secus vero duo Episcopi eparchiales ordinatione episcopali seniores».
Questo canone conferisce ulteriori prerogative al patriarca, anche se con delle limitazioni, in materia di problematiche inerenti i rapporti fra la sua Chiesa e le autorità civili. Infatti si possono avverare dei casi in cui il patriarca potrà risolvere egli stesso la questione, con la sua capacità e con la sua influenza. Tuttavia, prima di decidere, il patriarca dovrà ottenere il consenso del sinodo permanente e dovrà consultare i vescovi eparchiali interessati alla cosa; ma se la cosa è urgente è prevista anche una procedura d’urgenza.
* * *
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
94
BREVE NOTA BIBLIOGRAFICA
Sui rapporti fra Stato e Chiesa
CARON P. G., Corso di Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa, 2 voll., Milano 1981-
1985. CORRAL C., Relazioni Chiesa-Stato: vigenti sistemi (Relationes inter Ecclesiam et Statum:
systemata vigentia), in NDDC, 899-905. CORRAL C., Relazioni Chiesa-Stato: teoria (Relationes inter Ecclesiam et Statum:
Theoria), NDDC, 905-912. DELLA TORRE G., La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle
relazioni fra Chiesa e Comunità politica, Roma 1996. FARINA R., Cesaropapismo, in Dizionario Patristico e d’Antichità Cristiane, I, 655-656. FREND W.H.C., Church and State: perspective and problems in the Patristic Era, in Studia Patristica 17 (1982), 38-54. GAUDEMET J., L’Église dans l’Empire Romain (IVe-Ve siècles), «Historire du Droit
et des Institutions de l’Église en Occident», III, Paris 1958. GHERRO S., (a.c.d.), Studi sui rapporti tra Chiesa e gli Stati, Padova 1989. GHERRO S., Stato e Chiesa Ordinamento, Torino 1994. LEZIROLI G., Relazioni fra Chiesa Cattolica e potere politico. La religione come limiti al
potere (Cenni storici), Torino 1994. LEZIROLI G., Stato e Chiesa. Per una storia del dualismo giurisdizionalista cristiano,
Torino 1991. JEMOLO C.A., Chiesa e Stato, in Dizionario di Politica, (Istituto dell’Enciclopedia
Italiana), Roma 1940, I, 462-469. JOANNOU P.P., La législation impériale et la christianisation de l’Empire Romain (311-
476), «Orientalia Christiana Analecta» 192, Roma 1972. PERI V., La pentarchia: istituzione ecclesiale (IV-VII sec.) e teoria canonico-teologica, in
“Bisanzio, Roma e l’Italia nell’Alto Medioevo”, (XXXIV Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 3-9 aprile 1986), Spoleto 1988, 209-311.
SINISCALCO P., Chiesa e Impero, in Dizionario Patristico e d’Antichità Cristiane, I, 657-661.
SPINELLI L., Lo Stato e la Chiesa. Venti secoli di relazioni, Torino 1988. SPINELLI L., Studi sui rapporti tra la Chiesa e gli Stati, Padova 1989.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
95
Sui rapporti fra Chiesa e Stato nei paesi musulmani
BASILE B., Statut Personnel et compétence judiciaire des communautes confessionnelles au
Liban (étude juridique comparée), «Bibliothèque de l’Université Saint-Esprit de Kaslik» 30, Kaslik 1993.
BERGER S. M., The Legal System of Family Law in Syria, in Bulletin d’Études Orientales 49 (1997), 115-127.
BUONOMO V., Sullo scambio di Lettere tra Giovanni Paolo II e Hassan II circa la condizione giuridica della Chiesa Cattolica in Marocco: Adnotationis ad Acta Apostolicae Sedis 77 (1985), 712-715; in Apollinaris LIX (1986), 5-14.
HABBI J., Minorites chrétiennes dans les pays arabes musulmans, in Kanon 9 (1991) 187-189.
PRADER J., Das Personalstatusrecht der Christlischen Religionsgemeinschaften in den Ländern des Vorderen Orients, in Kanon 9 (1991) 195-222.
FATTAL A., La situation légal des Non-Musulmans en Pays d’Islam, Beirut 1958. SYRIANI G., L’exécution des jugements émis par les tribunaux confessionnels des
communautés catholiques orientales au Liban; in R. COPPOLA (a.c.d.), Atti del Congresso Internazionale “Incontro fra canoni d’Oriente e d’Occidente”, 2 vol., Bari 1994, 663-666.
Sui rapporti fra Santa Sede ed Israele
AA. VV., Symposium: The Fundamental Agreement between the Holy See and the State of
Israel: A third Anniversary Perspective, in Catholic University Law Review 47 (1998), 369-533.
FERRARI S., Vaticano e Israele, dal conflitto mondiale alla Guerra del Golfo, Firenze 1991.
KALIL E. ELLIS (ed.), The Vatican, Islam and the Middle East, Syracuse University Press 1987.
KREUTZ A., Vatican Policy on the Palestinian Israeli Conflict. The struggle for Holy Land, New York 1990.
KREUTZ A., The Vatican and the Palestinians: a historical overview, in Islamochristiana (1992), 109-125.
JAEGER D.A.M., The Fundamental Agreement between the Holy See and the State of Israel: A New Legal Regime of Church-State Relations, in Catholic University Law Review 47 (1998), 427-440.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
96
PALOMINO R., L’accordo sulla personalità giuridica tra Israele e S. Sede, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 2 (1998), 419-428.
PALOMINO R., Avances en las relaciones jurídicas entre Israel y la Santa Sede. El “Acuerdo sobre Personalidad Jurídica” de 1997, in Annuario de Derecho Ecclesiástico del Estado 14 (1998), 737-754.
PALOMINO R., El acuerdo básico entre la Santa Sede y la OLP en el contexto de la prática concordataria reciente, in Revista Española de Derecho Canónico 58 (2001), 275-289.
Alcuni strumenti di studio sul diritto ecclesiastico
(in particolare quello italiano)
AA. VV., Nuovi accordi fra Stato e confessioni religiose. Studi e testi, Milano 1985. AA. VV., Delibazioni delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali e ordine pubblico, Padova
1989. AA. VV., Scritti di diritto ecclesiastico e canonico, vol. 1, Diritto della Chiesa e diritto dello
Stato, Padova 1991. BERLINGÒ S. - CASUSCELLI G., Codice del diritto Ecclesiastico, Milano 1993. BONNET P. A., Diritto Concordatario Italiano (Ius concordatarium Italiae), in NDCC,
358-374. BERTONE T., Il rapporto giuridico tra Chiesa e Comunità Politica; in AA. VV., Il diritto
nel Mistero della Chiesa III, «Quaderni di Apollinaris» 10, Roma 19922, 607-681.
BUCCI A., Diritto della Chiesa e diritto dello Stato nel divenire dell’atto processuale. Un approccio storico giuridico alle attuali prospettive, «Studia et Documenta – Academia Historico-Iuridico-Theologica Petrus Tocânel», Bucarest 2003, 1-260.
BUCCI A., Gestione dei Beni Ecclesiastici ed enti No Profit, in Apollinaris, LXX 1/2 (1997), 271-278.
BUCCI A., Problemi aperti nella gestione e amministrazione dei beni ecclesiastici, in Apollinaris, LXXI 3/4 (1998), 545-576.
CARDIA C., Diritto Ecclesiastico, Bologna 1997. CARDIA C., Stato e confessioni religiose. Il regime pattizio, Bologna 1990. CECCARELLI MOROLLI D., Brevi Riflessioni sul significato del Concordato in Italia», in
International Bilateral Legal Relations between the Holy See and States: Experiences and Perspectives, Atti del Convegno Internazionale di Studi patrocinato dal
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
97
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Slovacca – Pontificio Istituto Orientale – Ambasciata della Repubblica Slovacca presso la S. Sede, Roma, Pontificio Istituto Orientale 12-13 dicembre 2001, Città del Vaticano 2003, 189-193.
COPPOLA R. (a cura di), Il matrimonio nel Diritto Canonico e nella legislazione concordataria in Italia, Bari 2003.
COPPOLA R. (a.c.d.), Il nuovo accordo tra l’Italia e Santa Sede, Milano 1987. COPPOLA R., Le Concordat Italien comme modèle de concordats modernes, in Kanon 9
(1991), 89-104. DALLA TORRE G., Il fattore religioso nella Costituzione, Torino 1988. DALLA TORRE G. (a.c.d.), La revisione del Concordato, «Qaderni de
“L’Osservatore Romano» 1, Città del Vaticano 1985. DALLA TORRE G., Lezioni di Diritto Ecclesiastico, Torino 2000. DAMMACCO G., Diritto Ecclesiastico e professione forense, Bari 2003. FINOCCHIARO F., Diritto Ecclesiastico, Bologna 1988. LACROCE L., La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e l’efficacia
delle sentenze dei tribunali ecclesiastici, in Ius Ecclesiae 8/2 (1996) 677-688. LILLO P., Concordato, Accordi e Intese tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, Mialno 1990. LILLO P., L’adattamento dell’ordinamento interno al diritto pattizio, Milano 1992. MORGANTE M., Il Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana¸ Cinisello
Balsamo (Ed. Paoline) 1988. PEZZANA A., Le Chiese Palatine e l’ultimo concordato, in Rivista di Studi Politici II/3
(1990), 33-45. PARLATO V., Le Chiese d’Oriente tra Storia e Diritto - Saggi, Torino 2003. TEDESCHI M., Contributo alla determinazione della scienza del diritto ecclesiastico,
Milano 1983.
Alcuni studi sull’istituto concordatario e
sul ruolo della S. Sede nel diritto internazionale
BUONOMO V., Considerazioni sul rapporto Santa Sede – Comunità internazionale alla
luce del diritto e della prassi internazionale, in Ius Ecclesiae 8 (1996), 3-33. BUONOMO V., La riforma della Curia Romana: sue incidenze nella azione diplomatica della
Santa Sede nel processo di unità europea con particolare riferimento alla C.S.C.E., in Annali dell'istituto di Studi Europei “A. De Gasperi” 9 (1987), 273-327.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
98
BUONOMO V., La Segreteria di Stato. Competenze nella "funzione" diplomatica, in A. BONNET - C. GULLO, La Curia Romana nella Costituzione Apostolica “Pastor Bonus”, Città del Vaticano 1990, 77-188.
BUONOMO V., Il "processo C.S.C.E." da Helsinki 1 a Helsinki 2: l'apporto della Santa Sede, in Nuova Umanità 85 (1993), 109-120.
CARDIA C., La soggettività internazionale della S. Sede e i processi di integrazione europea, in Ius Ecclesiae 11 (1999), 345-364.
CARDIA C., Concordati e diritto comune, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 1 (1999) 147-152.
CORRAL C., De univerali vigentia concordatorum in XXXI Statibus cuiuslibet systematis, in Periodica de Re Morali et Canonica 75 (1986), 467-510.
CORRAL C., The Concordat and the Conventions between the Roman Catholic Church and various states “in vigore” at the present, in Kanon 9 (1991), 77-88.
IBÁN I.C., I concordati nell’Europa Orientale, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 1 (1999), 23-30.
GAUDEMET J., Laicità e concordato, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 1 (1999), 127-146.
MARTÍN DE AGAR J. T., Studio comparativo dei concordati fra S. Sede e gli Stati dell’Europa Centrale e Orientale, in International Bilateral Legal Relations between the Holy See and States: Experiences and Perspectives, Atti del Convegno Internazionale di Studi patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Slovacca – Pontificio Istituto Orientale – Ambasciata della Repubblica Slovacca presso la S. Sede, Roma, Pontificio Istituto Orientale 12-13 dicembre 2001, Città del Vaticano 2003, 61-89.
MIGLIORE C., Relazioni tra Santa Sede e gli stati europei, in Ius Ecclesiae 11 (1999), 365-408.
NEDUNGATT G., Christian Church and the secular state in India, in Kanon 9 (1991) 223-251.
NEUWIRTH A., Il cittadino e gli accordi concordatari, in International Bilateral Legal Relations between the Holy See and States: Experiences and Perspectives, Atti del Convegno Internazionale di Studi patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Slovacca – Pontificio Istituto Orientale – Ambasciata della Repubblica Slovacca presso la S. Sede, Roma, Pontificio Istituto Orientale 12-13 dicembre 2001, Città del Vaticano 2003, 279-284.
PARLATO V., Intéréts religieux et loi civile dans l’Orient Chrétien, in Kanon 9 (1991), 67-76.
VITALE A., Corso di Diritto Ecclesiastico, Milano 1996.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
99
ŠMID M – VASIL’ C., International Agreements between the Holy See and States: an occasion to study mutual relations of two legal systems, in International Bilateral Legal Relations between the Holy See and States: Experiences and Perspectives, Atti del Convegno Internazionale di Studi patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Slovacca – Pontificio Istituto Orientale – Ambasciata della Repubblica Slvocca presso la S. Sede, Roma, Pontificio Istituto Orientale 12-13 dicembre 2001, Città del Vaticano 2003, 327-359.
WAGNON H., L’institution concordataire, in AA. VV., La institución concordatarie en la ectualidad, (Trabajos de la III semana de derecho canónico), Salamanca 1971.
Alcune voci tratte da enciclopedie e dizionari
JEMOLO C.A., Concordato, in Dizionario di Politica, (Istituto dell’Enciclopedia
Italiana), Roma 1940, I, 563-564. JEMOLO C.A. - GISMONDI P., Ecclesiastico, Diritto, in Dizionario di Politica,
(Istituto dell’Enciclopedia Italiana), Roma 1940, II, 7-13. BERLINGÒ S., Ordinamento giuridico - Oridinamento giuridico canonico, in Enciclopedia
Giuridica, vol. XXII, Roma 1990. BERTOLA, Concordato, in Enciclopedia Italiana, XI, 79-81. LO GRASSO G., Concordati, in Enciclopedia Cattolica, IV, 186-194. CATALANO G., Concordato Ecclesiastico, in Enciclopedia Giuridica, VII, Roma 1988. CATALANO G., Concordato Ecclesiastico, in Novissimo Digesto Italiano, Appendice, II,
Torino 1982. CORRAL C., Concordati vigenti (concordata vigentia), in NDDC, 225-238. CORRAL C., Concordato (Concordatum, conventio cum nationibus), in NDDC, 238-247. CORRAL C., Diritto Concordatario (Ius Concordatarium)¸ in NDCC, 357-358. CORRAL C., Diritto Ecclesiastico dello Stato (Statale), Ius ecclesiasticum Status, in
NDCC, 374-382. PALAZZINI I., Pacta Concordataria, in Dictionarium Morale et Canonicum, vol. III,
556-560 (Romæ 1966).
Principali Raccolte di Concordati
MERCATI A., Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le autorità
civili, Roma 1919.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
100
PERUGINI A., Concordata vigentia notis historicis et iuridicis declarata, Roma 1950 (rist.).
SCHÖPPE L., Konkordate seit 1800. Originaltext und deutsche Übersetzung der geltenden Konkordate, Frankfurt 1964.
SCHÖPPE L., Neue Konkordate und Konkordatäre Vereinbarungen. Abschlüsse in den Jahern 1964 bis 1969, Hamburg 1970.
CIPROTTI P. - TALAMANCA A., I Concordati di Pio XII (1938-1958), Milano 1976. CIPROTTI P. - ZAMPETTI E., I Concordati di Giovanni XXIII e dei primi anni di Paolo
VI (1958-1974), Milano 1976. OCHOA X., Leges Ecclesiae, praesertim: vol. 5 - Leges anni 1973-1978 (Roma
1987), vol. 6 - Leges anni 1979-1985 (Roma 1987). CORRAL C. - GIMÉNEX Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL J., Concordatos vigentes. Textos
originales, traducciones e introducciones, 2 voll., Madrid 1981. WLODARCZYK T., Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym uwzglednieniem XX
wieku, 2 voll., Warzawa 1986. MARTÍN DE AGAR J. T., Raccolta di Concordati 1950-1999, Città del Vaticano
2000. MARTÍN DE AGAR J. T., I Concordati del 2000, Città del Vaticano 2001.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
101
A P P E N D I C I
ACCORDI DEL 18 FEBBRAIO 1984
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA S. SEDE
(MODIFICHE AL CONCORDATO LATERANENSE)ℵ
La Santa Sede e la Repubblica Italiana tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II avendo presenti, da parte della Repubblica Italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà di religiosa ed i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico; considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell’art. 7 della Costituzione della Repubblica Italiana, i rapporti tra, lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali peraltro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale; hanno riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:
Art. 1 La Repubblica Italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto ditale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese.
Art. 2 1. La Repubblica Italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà, di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione, di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica. 2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la
ℵ
AAS 77 (1985), 521-546; OCHOA, III, 5040, coll. 8770-8779.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
102
libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa. 3. È garantita al cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 4. La Repubblica Italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.
Art 3 1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall’autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro stato. 2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Quest’ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori e degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello Stato. 3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cattolici italiani.
Art. 4 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo. 2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d’anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso tra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari. 3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dei servizio militare accordati agli studenti delle università italiane. 4. Gli ecclesiastici non sono tenuti e dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
Art. 5 1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
103
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica. 3. L’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
Art. 6 La Repubblica Italiana riconosce come giorni festivi tutte le Domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa tra le parti.
Art. 7 1. La Repubblica Italiana, richiamandosi al principio enunciato dall’art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. 2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che sono’ attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale de enti medesimi. 3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. 4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all’interno o all’ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente. 5. L’amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche. 6. All’atto della firma del presente Accordo, le Parti istituisco no una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
104
approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato Italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via transitoria e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.
Art. 8 1. Sono riconosciuti agli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme de diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile. La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo: a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione; b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta. La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi. 2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse,
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
105
dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo: b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano; c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La corte d’appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia. 3. Nell’accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.
Art. 9 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e Istituti di educazione. A tali scuole che ottengono la parità é assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato. 2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore delta cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storica del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non università di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto (su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad una forma di discriminazione.
Art. 10 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
106
ecclesiastiche, istruiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall’autorità ecclesiastica. 2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia. 3. Le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.
Art. 11 1. La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici. 2. L’assistenza spirituale ai medesimi ~ assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità.
Art. 12 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti. 2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l’onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe. Con l’osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.
Art. 13
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
107
1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall’art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate. 2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 14 Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.
Roma, 18 febbraio 1984.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
108
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL’ACCORDO DEL 18 FEBBRAIO 1984 TRA LO STATO ITALIANO E LA SANTA SEDE
Al momento della firma dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:
1. In relazione all’Art. 1 Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai ‘atti lateranensi, dei la religione cattolica come sola religione nello Stato italiano.
2. In relazione all’Art. 4 a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d’anime gli Ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti al servizi di assistenza spirituale di cui all’art. 11. b) La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici. c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d’accordo, senza pregiudizio dell’ordinamento canonico, con interpretazione che lo Stato italiano dà del l’art. 23, secondo comma del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.
3. In relazione all’Art. 7 a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni. b) La Commissione paritetica di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.
4. In relazione all’Art. 8 a) Ai fini dell’applicazione del n. 1, lett. b) si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile: 1) l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente; 2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili; 3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
109
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell’applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare: 1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge dei luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico; 2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico; 3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito. c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell’art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847 peri quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.
5. In relazione all’art. 9 a) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo. b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati: 1) i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche; 2) le modalità di organizzazione ditale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni; 3) i criteri per la scelta dei libri di testo; 4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.
6. In relazione all’art. 10. La Repubblica italiana, nell’interpretazione del n. 3 – che non innova l’art. 38 del Concordato dell’11 febbraio 1929 – si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte Costituzionale relativa al medesimo articolo.
7. In relazione all’Art. 13 n. 1 Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l’attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
110
Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell’ Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 1994
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
111
CONVENTIO (MODUS VIVENDI)
INTER APOSTOLICAM SEDEM ET TUNETANAM REMPUBLICAMℵℵℵℵ
ARTICLE 1. – Le Gouvernement de la République Tunisienne protège le libre exercice du Culte Catholique en Tunisie, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Constitution de la Republ1que Tunisienne du 1er Juin 1959 et dans les conditions prévues au present Modus Vivendi. ARTICLE 2. – L’Eglise Catliolique en Tunisie groupe les personnes de confession catholique résidant en Tunisie: elle possède la personnalité civile; son siège est établi a Tunis. Elle est légalement représentée par le Prélat nullius de Tunis. A ce titre, ce dernier a le pouvoir d’accomiplir, directement ou par mandataire, tout acte de gestion ou de disposition concernant les biens meubles et immeubles dépendant de la Prélature, sous réserve de se conformer aux lois et règlement en la matière. ARTICLE 3. – L’Eglise Catholique s’interdit toute activité de nature politique en Tunisie. ARTICLE 4. – Le Gouvernement de la République Tunisienne accepte que l’Eglise Catholique en Tunisie: 1) pourvoie, dans le respect des lois générales du pays, à son organisation
intérieure; 2) dispense, dans les lieux visés aux paragraplies a, c, d et de l’article 6 ci-après,
l’enseignement de la doctrine chrétienne; 3) dispense, dans les établissements scolaires prévus à l’article 9 du présent
accord, l’enseignement de la doctrine chrétienne aux élèves exclusivement de confession catholique et sous riserve de l’autorisation des parents.
Le Gouvernement de la République Tunisienne ne fera pas obstacle a l’exercice de l’autorité spirituelle du Prélat de Tunis sur les fldèles catholiques en Tunisie. ARTICLE 5. – Dans le cadre de ses activités spirituelles, le Saint-Siège pourra communiquer avec le Clergé et les fidèles catholiques en Tunisie; ceux-ci le pourront avec le Saint-Siège. Dans le même cadre, les membres du Clergé en Tunisie pourront communiquer entra eux ainsi qu’avec leurs fidèles. L’Eglise Catholique en Tunisie pourra publier, à l’interieur des lieux affectés au culte, ses instructions, ordonnances et lettres pastorales destinées aux fldèles. Le Prélat communiquera, pour information, au gouvernorat dont
ℵ
AAS 56 (1964) 917-924; OCHOA, III, n° 3197, coll. 4499-4502.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
112
dépend le lieu, le jour même de la publication, une copie de ces instructions, ordonnances et lettres pastorales. Toute autre publication faite par l’Eglise Catholique en Tunisie, quels qu’en soient la forme ou l’objet, sera régie par les lois tunisienne en matière de presse, imprimerie et libraire. ARTICLE 6. a) – Le Gouvernement dela République Tunisienne reconnaît a l’Eglise Catholique en Tunisie la propriété des lieux affectés au culte et des immeubles figurant aux annexes I et II du présent Modus Vivendi. Toute modification de ces annexes ne pourra intervenir que d’un commun accord entre les deux Parties. Celles-ci se reuniront, trois mois ava’it l’échéance préuvue dans chaque cas, pour examiner la situation des Iieux affectés au indiqués dans l’annexe III. b) L’Eglise Catholique en Tunisie consent à céder définitivement et à titre gratuit a l’Etat Tunisien les lieux de culte et autres biens imeubles figurant aux annexes IV et V a la date indiquée pour chacun d’eux. Le Gouvernement de la République Tunisienne donne l’assurance que les lieux de culte ainsi cédés ne seront utilisés qu’à des fins d’intérêt public compatibles avec leur ancienne destination. c) Dans les localités où il n’y a pas de lieu affecté au culte catholique, et lorsque les deux Parties auront convenu d’un commun accord que l’assistance religieuse aux fidèles catholiques justifie la présence d’un lieu de culte approprié, le Gouvernement de la République Tunisienne autorisera la célébration habituelle du culte dans des locaux n’offrant pas les aspects extérieurs des lieux de culte. d) Le culte catholique pourra continuer à être célébré, sans autorisation civile, dans les chapelles ou autres lieux destinés à cette fin, à 1’intérieur des établissements prévus à l’article 9 du présent accord. e) Le culte catholique pourra être célébré occasionnellement, sans autorisation, dans des locaux privés; dans ce cas, le propriétaire du lieu avisera au préalable les autorités locales, lorsque la cérémonie doit réunir des personnes ne residant pas dans ce lieu, afin que l’autorité publique assure la protection nécessaire du local. ARITICLE 7. – Les acquisitions d’immeubles à titre onéreux et les dispositions a titre gratuit en faveur de l’Eglise Catholique en Tunisie ne pourront avoir effet qu’après autorisation du Gouvernement de la République Tunisienne. Tout appel à la générosité publique, sous quelque forme que ce soit, effectué en dehors des eglises, reste soumis a la réglementation générale. ARTICLE 8. – Le Gouvernement de la République Tunisienne accordera toutes facilités pour l’entrée et le séjour en territoire tunisien aux prêtres
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
113
destinés à l’Eglise, et ce sous réserve de l’observation par ces derniers des règlements de police en vigueur. ARTICLE 9. – Le Gouvernement de la Republique Tunisienne autorise les établissements scolaires (écoles, colleges, jardins d’enfants, pouponnières) ou hospitaliers (clinique et dispensaires) appartenant à des associations, des sociétis civiles ou anonymes à participation religieuse et dont la liste figure a l’annexe VI, à continuer à exercer leur activité et leur accordera le bénéfice de sa bienveillance tant qu’ils se conformeront aux lois, règlements et programmes en vigueur en Tunisie. ARTICLE 10. – Le choix du Prélat nullius de Tunis appartient au Saint-Siège. Afin de favoriser l’harmonie entre l’Eglise Catholique et l’Etat Tunisien, le Saint-Siège fera connaître dans le secret le plus absolu au Gouvernement de la République Tunisienne, par voie diplomatique, le nom de l’ecclésiastique choisi. Au cas où le Gouvernement de la République Tunisienne aurait quelque objection de caractère politique général au sujet de la personne envisagée, il pourra la manifester au Saint-Siége, par voie diplomatique, dans le délai d’un mois à partir du jour de la communication. ARTICLE 11. – Le Prélat de Tunis présentera au Gouvernement de la République Tunisienne, dans le mois qui suivra l’entrée en vigneur du présent accord, la liste des membres du Clergé exerçant en Tunisie. Il informera le Gouvernement de la République Tunisienne de la nomination de tout nouveau curé, afin que celui-ci soit introduit auprès des autorités locales. ARTICLE 12. – Le présent Modus Vivendi entrera eri vigueur dès l’échange des intruments de ratification. Du Vatican, le 27 juin 1964. – A. I Card. CICOGNANI.
PROTOCOLLE ADDITIONNEL A l’Article 5, alinéa 3: Il est entendu que cette liberté de publication est reconnue â l’Eglise Catholique sous reserve qu’il ne sont pas porté atteinte à l’ordre public. A l’Article 6, paragraphe b: A la date de la cession, la Prélature remettra au Gouvernement soit la copie bleue des titres fonciers correspondant aux biens immatrilculés cédés, soit les actes de propriété des biens cédés non encore immatriculés. A l’Article 6, paragraph c: Au cas où l’autorité ecclésiastique juge que l’assistance religieuse aux fidèles catholiques justifie la présence d’un lieu de culte approprié, elle en fera la demande motivée au Gouvernement: celui-ci, fidèle à sa volonté, exprimée à plusieurs reprises, de faciliter aux Catholiques
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
114
résidant en Tunisie l’exercice de leur culte, sur tout le territoire du pays, examinera avec bienveillance la demande en tenant compte tant de l’importance numerique des fldèles que de l’éloignement des autres lieux de culte ainsi que, le cas échéant, des exigences de l’ordre public ou de la défense nationale. A l’Article 6, paragraphe e: Le propriétaire avisera les autorités locales au moins vingt-quatre heures à l’avance, autant que possible. A l’Article 7: Dans le cadre de la réglementation en vigueur le Gouvernement Tunisien facilitera l’entrée en Tunisie d’offrandes envoyées par le Saint-Siège a la Prélature.
Du Vatican, le 27 juin 1964. – A. I. Card. CICOGNANI.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
115
*** Conventione inter Apostolican Sedem cum Reipublicam Tunetanam rata habita, die IX
mensis Iulii anno MDCCCCLXIV Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die IX mensis Iulii anno MDCCCCLXIV, huiusmodi Conventio inter Apostolicam Sedem et Reipublicam Tunetanam icta rigere coepit ad normam articuli
XII eiusdem Pactionis.
DOCUMENTA quibus Pactionis exemplaria, rite subscripta, accepta et reddita mutua fuerunt, hic transcribuntur:
Du Vatican, le 27 juin 1964. N.3731/64 Excellence, J’ai l’honneur de remettre ci-joint à Votre Excellence l’exemplaire signé par moi-même, au nom du Saint-Siège, du Modus Vivendi et du Protocole Additionnel, ainsi que les listes y annexées, dont le texte a été établi au cours des négociations qui se sont déroulées entre les représentants du Saint-Siège et ceux du Gouvernement de la Réublique Tunisienne. Comme il a été convenu, l’échange des instruments de ratification de cet accord aura lieu au plus tard deux semaines à partir de la date de ce jour. En souhaitant que cet accord inaugure une nouvelle ère de coopération entre le Saint-Siège et l’Etat Tunisien, je vous prie de croire, Excellence, aux assurances de ma tres haute considération. – A. I. Card. CICOGNANI. Son Excellence Mr MONGI SLIM, Secretaire d’Etat aux Affaires Etrangères. – Tunis.
Tunis, le 27 juin 1964 Eminence, J’ai l’honneur de remettre ci-joint à Votre Eminence l’exemplaire signé por moi-même, au nom du Gouvernement de la République Tunisienne, du Modus Vivendi et du Protocole Additionnel, ainsi qua les listes y annexées, dont le texte a été établi au cours des négociations qui se sont déroulées entra les représentants du Gouvernement de la République Tunisienne et ceux du Saint-Siège. Comme il a été convenu, l’échange des instruments de ratification de cet accord aura lieu au plus tard deux semaines à partir de la date del ce jour. En souhaitant que cet accord inaugure una nouvalle ère de coopération entre l’Etat Tunisien et le Saint-Siège, je vous prie de croire, Eminence, aux
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
116
assurances de ma très haute considération. – MONGI SLJM, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères. Son Eminence Le Cardinal AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, Secretaire d’Etat de sa Sainteté le Pape.
Tunis, le 27 juin 1964. Eminence, Au cours des négociations ayant abouti à l’accord de ce jour, vous avez souligné le voeu du Saint-Siège de mettre à la disposition des fldèles cathollques résident à Carthage, après la cession à l’Etet Tunisien de la Cathédrale, un moyen de pratiquer leur religion dans la dite localité. J’ai l’honneur de signeler à Votre Eminence que l’article 6, dans son paragraphe d), répond dès à présent à ce voeu; en tout cas, le paregraphe c), du même article permet toujours d’envisager, d’un commun accord, une solution appropriée. – MONGI SLIM, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères. Son Eminence Le Cardinal AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, Secretaire d’Etat de sa Sainteté le Pape.
Du Vatican, 27 Juin 1964 N. 3769/64 Excellence, Vous avez bien voulu m’adresser le lettre dont la teneur suit: «Au cours des négociations ayant abouti à l’accord de ce jour, vous avez souligné le voeu du Saint-Siège de mettre à la disposition des fidèles catholiques residant e Carthage, après la cession à l’Etat Tunisien de le Cathedrale, un moyen de pretiquer leur religion dans la dite localité. J’ai l’honneur de signeler à Votre Eminence que l’article 6, dans son paragraphe d), répond dès à présent à ce voeu; en tout cas, le paregraphe c), du même article permet toujours d’envisager, d’un commun accord, une solution appropriée». En vous remerciant de cette courtoise communication, j’ai l’honneur, en réponse, de porter à votre connaissance que, per dérogetion au paragrephe d) de l’article 6 du Modus Vivendi, l’Eglise Catholique, tenant compte de la situation particulière de Carthege, utilisera, aux fins de la célébration publique du culte dans cette localité, exclusivement la chapelle sise au Pensionnat des Soeurs Blanches. Tout cela, naturellement, sans préjudice de la possibilité offerte par le paragraphe c) du même article, mentionnée dana la lettre de Votre Excellence. Je profite de cette occasion pour vous confirmer que l’Egilse Catholique n’ignore pas qu’elle exerce son activité dans un pays où l’Islam est la religion de l’Etat et de la majorité des habitants. De ce point de vue, l’Etat Tunisien sait qu’il peut attendre d’Elle un respect et une discrétion qui sont
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
117
d’ailleurs conformes à la doctrine et à l’esprit catholiques. Il plaît au Saint-Siège de rappeler qu’il entre dans le attributions normales du Prélat de Tunis de prévenir ou de réprimer les imprudences éventuelles dommageables aux bonnes relations réciproques. Je vous prie, Excellence, de croire aux assurances de ma très haute considération. – A. I. Card. CICOGNANI. Son Excellence Mr MONGI SLIM, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
118
DE STATUTO ECCLESIÆ CATHOLICÆ IN MAROCHOℵℵℵℵ
I - Litterae a Summo Pontifice Regi Marochii die 5 febr. 1984 datae
A SA MAJSTÉ HASSAN II, ROI DU MAROC:
C’est avec une profonde satisfaction que j’ai pris connaissance du Message du 30 décembre dernier, par lequel Votre Majesté, au terme d’entretiens entre nos Représentants, a bien voulu fixer par écrit un ensemble de despositions législatives, adaptées aux exigences de notre temps, en vue de mieux définir et situer la présence de l’Eglise catholique au Maroc. J’ai examiné avec une attention toute particulière le statut ainsi octrayé a l’Eglise et je ne puis qu’exprimer à Votre Majesté ma plus vive gratitude pour ce geste significatif continuant et confirmant la tradition d’accueil et de compréhension qui, depuis des siècles, caractérise les relations du Royaume du Maroc avec l’Eglise catholique. Ainsi assurée de pouvoir exercer publiquement et librement sa mission spirituelle, l’Eglise catliolique sera mieux à même d’assurer ses activitès propres – telles que le culte, le magistère, la juridiction interne, la bienfaisance, l’enseignement religieux et l’assistance aux prisonniers –, en faveur de ses fidèles. En outre, la possibilité qu’auront les supérieures des circonscriptions ecclésiastiques de donner naissance aux association à but confessionel, éducatif charitable, de gérer le patrimonie, de recevoir les aides nécessaires au fonctionnement des institutions et de béneéficier de certaines exemptions, permettra à l’Eglise qui est au Maroc de vivre toujours plus harmonieusement sa foi et de témoigner de son esprit de service. Je donne donc mon accord pour que l’Eglise et les catholiques du royaume chérifien se conforment en tout aux normes convenues, lesquelles seront dûment communiquées aux chefs spirituels concernés. Appréciant à sa juste valeur la marque de bienveillance ainsi manifestée, tous auront à cœur, j’en suis sûr, d’observer ces sages dispositions assurant à chacun la liberté de croire et de vivre sa foi dans une société soucieuse de coexistence et de collaboration. Il m’est agréable de redire à Votre Majesté mes sentiments de très baute estime et l’assurance de mes ardentes prières, alors que j’invoque sur
ℵ
AAS 77 (1985) 712-715; OCHOA, VI, n° 5037, coll. 8766-8768.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
119
Sa Personne et sur le Peuple marocain tout entier les abondantes bénédictions Dieu Tout-Puissant.
Du Vatican, le 5 fevrier 1984. – IOANNES PAULUS PP. II II. Litterae a Rege Marochii die 30 decembris 1983 Summo Pontifici
Ioanni Paulo II datae sequentis erant tenoris iuxta versionem officialem quae edita est in commentario, cui titulus «Bulletin Officiel - Royaume
du Maroc», N. 3764, 25 rebia I, 1405 (19 décembre 1984) Au Nom de Dieu, le Clément Miséricordieux. Il n’y a de force de puissance que par Dieu, le Trés-Haut et Très-Grand. Le serviteur de Dieu, qui compte sur l’assistance de Dieu, le Commandeur des Croyants, fils du Commandeur des Croyants. (Grand Sceau de Sa Majesié Hassan II).
A SA SANTITÉ JEAN-PAUL II TRÉS SAINT-PÈRE ET ILLUSTRE AMI, Nous adressons à Votre Sainteté Nos meilleures salutations et l’expression de Notre sincère amitié et de Nos sentiments de consideration et d’estime. Nos représentants diplomatiques respectifs se sont recemment entretenus de ce que devra être au Royaume du Maroc le statut de l’Eglise catholique. Depuis des temps immémoriaux, un esprit d’entente fraternelle a toujours marqué, dans Notre pays, les rapports entre chrétiens et musulmans. Nos Ancêtres en ont fait une règle de conduite qui ne fut à aucun moment transgressée, quelles que fussent les vicissitudes du temps passé. Nous-Même, depuis que Dieu Nous a confié les rênes du pouvoir, avons tenu à ce que cette règie fut scrupuleusement observée. Nous comprenons cependant le légitime souci de Votre Sainteté de voir cette coutume ancestrale traduite dans les réalités contemporaines dans les formes qui répondent le mieux aux exigences de notre époque. Et pour ce qui est precisement de la forme, Nos qualités respectives – Votre Sainteté en tant que Chef de l’Eglise catholique, Nous-Même en tant que Commandeur des Croyants – confèrent à la teneur de la presente lettre valeur de dispositions législatives. Quand au fond, l’Eglise catholique continuera, au Royaume du Maroc, d’exercer publiquement et librement ses activités propres, en particulier celles relatives au culte, au magistère, à la juridiction interne, à la bienfaisance de ses fideles et à l’enseignement religieux.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
120
L’Eglise catholique est représentée par les supérieurs de circonscriptions ecclésiastiques qui peuvent exercer, soit directement, soit par mandataires, tous actes concernant la gestion de ses biens. Les prêtres, religieux, religieuses et assimilés qui exercent leurs activités dans les oeuvres de l’Eglise – y compris dans les établissements d’assistance et d’éducation – ne seront soumis à aucun impôt du fait qu’ils ne perçoivent pas de salaire. De meme, bénéficieront de l’exonération fiscale les édifices du culte et les bâtiments religieux. Afin de subvenir à sa subsistance, l’Eglise est habilitée à recevoir l’aide necessaire. Le statut ainsi octroyé à l’Eglise catholique comprend en outre le droit de créer des associations à but confessionnel, éducatif et charitable, ainsi que le droit de visite aux prisonniers de confession catholique. Nous sommes ainsi certain qu’en créant chez Nous les conditions d’une coexistence paisible entre musulmans et catholiques, Nous ne faisons que projeter dans la réalité marocaine l’esprit d’extrême tolérance que caractérise l’islam et qui a toujours présidé à Nos rapports. Veuillez agréer, Votre Sainteté, l’assurance de Notre profonde amitié et l’expression de Notre très haute considération. Fait au Palais Royal de Rabat, le vendredi 21 rebia I 1404 correspondant au 30 décembre 1983.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
121
ACCORDO FONDAMENTALE TRA LA SANTA SEDE E LO STATO DI ISRAELE
DEL 30 DICEMBRE 1993118
Preambolo
La Santa Sede e lo Stato di Israele, memori del carattere particolare e del significato universale della terra Santa; consapevoli della natura unica del rapporto fra Chiesa cattolica e popolo ebraico e del processo storico di riconciliazione e della crescita di comprensione reciproca e di amicizia fra cattolici ed ebrei; avendo deciso in data 29 luglio 1992 di istituire una “Commissione bilaterale di lavoro permanente” allo scopo di individuare e approfondire insieme questioni di comune interesse e al fine di normalizzare i propri rapporti; prendendo atto che il lavoro della sopra menzionata Commissione ha prodotto materiale sufficiente per un primo e fondamentale Accordo; ritenendo che tale accordo fornirà una base solida e duratura per lo sviluppo continuativo delle loro presenti e future relazioni e per il progredimento del compito della Commissione; concordano sui seguenti articoli.
Articolo 1 § 1. Lo Stato di Israele, richiamandosi alla propria Dichiarazione di
indipendenza, afferma il proprio continuo impegno a sostenere e osservare il diritto umano di libertà di religione e di coscienza, come evidenziati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e in altri strumenti internazionali cui ha aderito. § 2. La Santa Sede, richiamandosi alla Dichiarazione sulla libertà di religione del Concilio Ecumenico Vaticano secondo, Dignitatis humanae, afferma l’impegno della Chiesa cattolica a sostenere il diritto umano di libertà di religione e di coscienza, come evidenziato nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e in altri strumenti internazionali cui ha aderito. La Santa Sede desidera affermare altresì il rispetto della Chiesa cattolica per le altre religioni e i loro seguaci così come solennemente enunciato dal Concilio Ecumenico Vaticano secondo nella sua Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non-cristiane, “Nostra Aetate”.
Articolo 2 § 1. La Santa Sede e lo Stato di Israele si impegnano in una appropriata
cooperazione nel combattere tutte le forme di antisemitismo e tutti i tipi di razzismo e di intolleranza religiosa e nel promuovere la reciproca
118 Testo integrale; traduzione non ufficiale dall’originale in inglese.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
122
comprensione fra le nazioni, la tolleranza tra comunità e il rispetto per la vita e la dignità dell’uomo.
§ 2. La Santa Sede coglie l’occasione per riaffermare la propria condanna dell’odio, della persecuzione e di ogni altra manifestazione di antisemitismo diretta contro il popolo ebraico o singoli ebrei in ogni luogo, in ogni tempo e ad opera di chicchessia. In particolare, la Santa Sede deplora gli attacchi contro ebrei e la profanazione di sinagoghe e cimiteri ebraici, atti che offendono la memoria delle vittime dell’Olocausto, specialmente quando accadono negli stessi luoghi che ne furono testimoni.
Articolo 3 § 1. La Santa Sede e lo Stato di Israele riconoscono di essere entrambi
liberi nell’esercizio dei loro rispettivi diritti e poteri e si impegnano a rispettare questo principio nei loro reciproci rapporti e nella loro cooperazione per il bene della popolazione.
§ 2. Lo Stato di Israele riconosce il diritto della Chiesa cattolica di adempiere le sue funzioni religiose, morali, educative e caritatevoli e di avere le proprie istituzioni, di formare, nominare e collocare il proprio personale nelle suddette istituzioni o per le suddette funzioni per questi fini. La Chiesa riconosce il diritto dello Stato di adempiere le sue funzioni, come promuovere e proteggere il benessere e la sicurezza della popolazione. Sia lo Stato che la Chiesa riconoscono la necessità di un dialogo e di una cooperazione nella materie che per propria natura li richiedano.
§ 3. Per quanto concerne la personalità giuridica cattolica secondo il diritto canonico la Santa Sede e lo Stato di Israele negozieranno in modo da conferirgli piena efficacia nel diritto israeliano, facendo seguito a una relazione da parte di una sottocommissione congiunta di esperti.
Articolo 4 § 1. Lo Stato di Israele afferma il proprio continuo impegno a
mantenere e rispettare lo “Status quo” nei Luoghi santi cristiani ai quali esso si applica e i relativi diritti delle comunità cristiane interessate. La Santa Sede afferma il continuo impegno della Chiesa cattolica a rispettare il sopra menzionato “Status quo” e i suddetti diritti.
§ 2. Quanto sopra si applicherà indipendentemente da una interpretazione in senso contrario di qualunque articolo di questo Accordo fondamentale.
§ 3. Lo Stato di Israele concorda con la Santa Sede sull’obbligo di un continuo rispetto e protezione del carattere proprio dei posti sacri cattolici, come chiese, monasteri, conventi, cimiteri e simili.
§ 4. Lo Stato di Israele concorda con la Santa Sede sul permanere della garanzia della libertà del culto cattolico.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
123
Articolo 5 § 1. La Santa Sede e lo Stato di Israele riconoscono di essere entrambi
interessati a favorire i pellegrinaggi cristiani ai Luoghi santi. Ogniqualvolta sorga l’esigenza di un coordinamento, le appropriate agenzie della Chiesa e dello Stato si consulteranno e coopereranno come richiesto.
§ 2. Lo Stato di Israele e la Santa Sede esprimono la speranza che tali pellegrinaggi siano occasione per una migliore comprensione tra i pellegrini e la popolazione e le religioni in Israele.
Articolo 6 La Santa Sede e lo Stato di Israele congiuntamente riaffermano il diritto
della Chiesa cattolica di fondare, mantenere e dirigere scuole e istituzioni di studi a ogni livello, venendo questo diritto esercitato in armonia con i diritti dello Stato nel campo dell’educazione.
Articolo 7 La Santa Sede e lo Stato di Israele riconoscono un comune interesse nel
promuovere e incoraggiare scambi culturali tra istituzioni cattoliche in tutto il mondo e istituzioni educative, culturali e di ricerca in Israele e nel facilitare l’accesso a manoscritti, documenti storici e simili fonti, in conformità con le leggi e i regolamenti relativi.
Articolo 8 Lo Stato di Israele riconosce che il diritto della Chiesa cattolica alla
libertà di espressione nell’adempiere le proprie funzioni si esercita anche attraverso i mezzi di comunicazione della Chiesa stessa, venendo questo diritto esercitato in armonia con i diritti dello Stato nel campo dei mezzi di comunicazione.
Articolo 9 La Santa Sede e lo Stato di Israele congiuntamente riaffermano il diritto
della Chiesa cattolica di adempiere le sue funzioni caritatevoli attraverso le sue istituzioni sanitarie e di assistenza sociale, venendo questo diritto esercitato in armonia con i diritti dello Stato in questo campo.
Articolo 10
§ 1. La Santa Sede e lo Stato di Israele congiuntamente riaffermano il diritto della Chiesa cattolica alla proprietà.
§ 2. Senza pregiudizio per diritti su cui le parti fanno assegnamento: (a) la Santa Sede e lo Stato di Israele negozieranno in buona fede un
accordo globale, contenente soluzioni accettabili per entrambe le Parti su questioni non chiare, non risolte o in discussione riguardanti materie proprietarie, economiche o fiscali concernenti la Chiesa cattolica in generale o specifiche comunità o istituzioni cattoliche.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
124
(b) Per lo scopo dei suddetti negoziati, la Commissione bilaterale permanente di lavoro nominerà una o più sottocommissioni bilaterali di esperti per studiare le questioni e formulare proposte.
(c) Le Parti intendono iniziare i sopra menzionati negoziati entro tre mesi dall’entrata in vigore di questo Accordo e puntano a raggiungere un accordo entro due anni dall’inizio dei negoziati.
(d) Durante il periodo di questi negoziati, saranno evitate azioni incompatibili con questi impegni.
Articolo 11 § 1. La Santa Sede e lo Stato di Israele dichiarano il loro rispettivo
impegno nella promozione della pacifica risoluzione dei conflitti fra Stati e nazioni, eliminando violenza e terrorismo dalla vita internazionale.
§ 2. La Santa Sede, pur mantenendo in ogni caso il diritto di esercitare il proprio ufficio di insegnamento morale e spirituale, ritiene opportuno ricordare che, per via del suo proprio carattere, è solennemente impegnata a rimanere estranea a ogni conflitto di carattere puramente temporale; principio che è valido in modo specifico per le dispute territoriali e le controversie di confine.
Articolo 12 La Santa Sede e lo Stato di Israele continueranno a negoziare in buona
fede in adempimento dell’Agenda concordata a Gerusalemme il 15 luglio 1992 e confermata in Vaticano il 29 luglio 1992, sia su questioni sollevate da articoli di questo Accordo, sia su altre questioni bilaterali concordemente stabilite oggetto di negoziato.
Articolo 13 § 1. In questo Accordo le Parti usano questi termini nel significato che
segue: (a) La Chiesa cattolica e la Chiesa - che comprende, inter alia, le sue
Comunità e istituzioni; (b) Comunità della Chiesa cattolica - per indicare le entità religiose
cattoliche considerate dalla Santa Sede come Chiese sui iuris e dallo Stato di Israele come Comunità religiose riconosciute;
(c) Lo Stato di Israele e lo Stato - che comprende, inter alia, le sue autorità stabilite dalla legge.
§ 2. Indipendentemente dalla validità di questo Accordo tra le Parti e senza detrimento della generalità di ogni applicabile norma di legge con riferimento a trattati, le Parti concordano che questo Accordo non pregiudica diritti e obblighi risultanti da trattati esistenti tra una delle Parti e uno Stato o Stati, che siano noti ed effettivamente disponibili a entrambe le Parti al momento della firma di questo Accordo.
Articolo 14
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
125
§ 1. All’atto della firma di questo Accordo fondamentale e in preparazione dell’allacciamento di piene relazioni diplomatiche, la Santa Sede e lo Stato di Israele si scambiano Rappresentanti speciali, con il rango e le prerogative specificati nel Protocollo aggiuntivo.
§ 2. In seguito all’entrata in vigore e immediatamente al momento dell’avvio dell’attuazione del presente Accordo fondamentale, la Santa Sede e lo Stato di Israele stabiliranno piene relazioni diplomatiche a livello di Nunziatura Apostolica, da parte della Santa Sede, e di Ambasciata, da parte dello Stato di Israele.
Articolo 15 Questo Accordo entrerà in vigore alla data dell’ultima notifica di ratifica
da parte di una delle Parti.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 1. In riferimento all’Articolo 14§1 dell’Accordo fondamentale firmato
tra la Santa Sede e lo Stato di Israele, i “Rappresentanti speciali” avranno, rispettivamente, il rango personale di Nunzio Apostolico e di Ambasciatore.
2. Questi Rappresentanti speciali godranno di tutti i diritti, privilegi e immunità garantiti ai Capi di missione diplomatica secondo la legge internazionale e l’uso comune, su una base di reciprocità.
3. Il Rappresentante speciale dello Stato di Israele presso la Santa Sede, residente in Italia, godrà di tutti i diritti, privilegi e immunità definiti dall’Articolo 12 del Trattato del 1929 tra la Santa Sede e l’Italia, riguardante gli Inviati di Governi stranieri presso la Santa Sede residenti in Italia. I diritti, privilegi e immunità estesi al personale di una Missione diplomatica saranno allo stesso modo garantiti al personale della Missione del Rappresentante speciale israeliano. In conformità a un uso consolidato, né il Rappresentante speciale né i membri ufficiali della sua Missione possono essere contemporaneamente membri della Missione diplomatica israeliana presso l’Italia.
4. Il Rappresentante speciale della Santa Sede presso lo Stato di Israele può contemporaneamente esercitare altre funzioni di rappresentanza della Santa Sede ed essere accreditato presso altri Stati. Egli e il personale della sua Missione godranno di tutti i diritti, privilegi e immunità garantiti da Israele alle Missioni e agli Agenti diplomatici.
5. Nomi, rango e funzioni dei Rappresentanti speciali compariranno, in modo appropriato, nelle liste ufficiali delle Missioni estere accreditate presso ciascuna delle due Parti.
Nota concordata. Interpretazione concordata dell’Articolo 14
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
126
Con riferimento all’Articolo 14 dell’Accordo fondamentale firmato tra la Santa Sede e lo Stato di Israele, si concorda che “l’avvio dell’attuazione del presente Accordo fondamentale” significa l’istituzione di due delle Sottocommissioni bilaterali di esperti, purché non più tardi di quattro mesi dopo l’entrata in vigore di questo Accordo.
Fatto in due copie originali nelle lingue inglese ed ebraica, essendo entrambi i testi egualmente autentici. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.
Firmato a Gerusalemme, il trentesimo giorno del mese di dicembre dell’anno 1993, che corrisponde al sedicesimo giorno del mese di Tevet dell’anno 5754.
Per il Governo dello Stato di Israele Dottor Yossi Beilin Viceministro degli Esteri. Per la Santa Sede Monsignor Claudio Maria Celli Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati.
AGREEMENT BETWEEN THE STATE OF ISRAEL AND THE HOLY SEE
PURSUANT TO ARTICLE 3 (3) OF THE FUNDAMENTAL AGREEMENT BETWEEN
THE STATE OF ISRAEL AND THE HOLY SEE (ALSO REFERRED TO AS THE «LEGAL PERSONALITY AGREEMENT»)
Article 1
This Agreement is made on the basis of the provisions of the «Fundamental Agreement between the State of Israel and the Holy See», which was signed on 30 December 1993, and then entered into force on 10 March 1994 (hereinafter: the “Fundamental Agreement”).
Article 2 Recalling that the Holy See is the Sovereign Authority of the Catholic Church, the State of Israel agrees to assure full effect in Israeli law to the legal personality of the Catholic Church itself.
Article 3 1. The State of Israel agrees to assure full effect in Israeli law, in accordance with the provisions of this Agreement, to the legal personality of the following: a. these Eastern Catholic Patriarchates: the Greek Melkite Catholic, the Syrian
Catholic, the Maronite, the Chaldean, the Armenian Catholic (hereinafter: the “Eastern Catholic Patriarchates”);
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
127
b. the Latin Patriarchate of Jerusalem, id est the Latin Patriarchal Diocese of Jerusalem;
c. the present Dioceses of the Eastern Catholic Patriarchates; d. new Dioceses, wholly in Israel, Eastern Catholic or Latin, as may exist
from time to time; e. the “Assembly of the Catholic Ordinaries of the Holy Land”. f. The Holy See states, for the avoidance of doubt, that the listing in par. 1
does not prejudice in any way the established order of precedence of the Heads of the various entities, according to their personal rank and as it is fixed by traditional usage and accepted by them.
g. For the avoidance of doubt, it is stated that the question of assuring full effect in Israeli law to the legal personality of any new cross-border Diocese is left open.
h. For the purposes of this Agreement, a Parish is in integral part of the respective Diocese, and, without affecting its status under the canon law, will not acquire a separate legal personality under Israeli law. A Diocese may, subject to the canon law, authorise its Parishes to act on its behalf, in such matters and under such terms, as it may determine.
i. In this Agreement, “Diocese” includes its synonyms or equivalents. Article 4
The State of Israel agrees to assure full effect in Israeli law, in accordance with the provisions of this Agreement, to the legal personality of the Custody of the Holy Land.
Article 5 The State of Israel agrees to assure full effect in Israeli law, in accordance with the provisions of this Agreement, to the legal personality of the following, as they exist from time to time in Israel: the Pontifical Institutes of Consecrated Life of the kinds that exist in the Catholic Church, and such of their Provinces or Houses as the Institute concerned may cause to be certified; other official entities of the Catholic Church.
Article 6 1. For the purposes of this Agreement the legal persons referred to in Articles
3-5 (hereinafter, in this Article: “legal person”), being established under the canon law, are deemed to have been created according to the legislation of the Holy See, being Sovereign in international law.
2.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
128
a. the law which governs any legal transaction or other legal acts in Israel between any legal person and any party shall be the law of the State of Israel, subject to the provisions of sub-paragraph (b). b. Any matter concerning the identity of the head, of the presiding officer or of any other official or functionary of a legal person, or their authority or their powers to act on behalf of the legal person, is governed by the canon law. c. Without derogation from the generality of sub-paragraph (b), certain kinds of transactions by a legal person concerning immovable property or certain other kinds of property, depend on a prior written permission of the Holy See in accordance with Its written Decisions as issued from time to time. Public access to the aforesaid Decisions will be in accordance with the Implementation Provisions. 3. a. Any dispute concerning an internal ecclesiastical matter between a member, official or functionary of a legal person and any legal person, whether the member, official or functionary belongs to it or not, or between legal persons, shall be determined in accordance with the canon law, in a judicial or administrative ecclesiastical forum. b. For the avoidance of doubt it is stated that the provisions of 2(a) shall not apply to disputes referred to in the above sub-paragraph (a). 4. For the avoidance of doubt, it is stated: a. a legal person, whose legal personality is given full effect in Israel, is deemed to have consented to sue and be sued before a judicial or administrative forum in Israel, if that is the proper forum under Israeli law. b. Sub-paragraph (a) does not derogate from any provision in Articles 6-9. Article 7 The application of this Agreement to any legal person is without prejudice to any of its rights or obligations previously created.
Article 8 1. For the avoidance of doubt, nothing in this Agreement shall be construed as supporting an argument that any of the legal persons to which this Agreement applies had not been a legal person prior to this Agreement. 2. If a party makes a claim that such a legal person had not been a legal person in Israeli law prior to this Agreement, that party shall bear the burden of proof.
Article 9
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
129
Should a question with regard to the canon law arise in any matter before a Court or forum other than in a forum of the Catholic Church, it shall be regarded as a question of fact.
Article 10 The terms “ecclesiastical” and “canon law” refer to the Catholic Church and Its law.
Article 11
1. Without derogating from any provision, declaration or statement in the Fundamental Agreement, the ecclesiastical legal persons in existence at the time of the entry of this Agreement into force are deemed as being legal persons in accordance with the provisions of this Agreement, if listed in the ANNEXES to this Agreement, which are specified in par. 4. 2. The ANNEXES form, for all intents and purposes, an integral part of this Agreement. 3. The ANNEXES will include the official name, respective date or year of establishment in the Catholic Church, a local address and, if the head office is abroad, also its address. 4. ANNEX I list.
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
130
BASIC AGREEMENT BETWEEN THE HOLY SEE
AND THE PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION Preamble
The Holy See, the Sovereign Authority of the Catholic Church, and the Palestine Liberation Organization (hereinafter: PLO), the Representative of the Palestinian People working for the benefit and on behalf of the Palestinian Authority: Deeply aware of the special significance of the Holy Land, which is inter alia a privileged space for inter-religious dialogue between the followers of the three monotheistic religions; Having reviewed the history and development of the relations between the Holy See and the Palestinian People, including the working contacts and the subsequent establishment — on October 26, 1994 — of official relations between the Holy See and the PLO; Recalling and confirming the establishment of the Bilateral Permanent Working Commission to identify, study and address issues of common interest between the two Parties; Reaffirming the need to achieve a just and comprehensive peace in the Middle East, so that all its nations live as good neighbours and work together to achieve development and prosperity for the entire region and all its inhabitants; Calling for a peaceful solution of the Palestinian-Israeli conflict, which would realize the inalienable national legitimate rights and aspirations of the Palestinian People, to be reached through negotiation and agreement, in order to ensure peace and security for all peoples of the region on the basis of international law, relevant United Nations and its Security Council resolutions, justice and equity; Declaring that an equitable solution for the issue of Jerusalem, based on international resolutions, is fundamental for a just and lasting peace in the Middle East, and that unilateral decisions and actions altering the specific character and status of Jerusalem are morally and legally unacceptable; Calling, therefore, for a special statute for Jerusalem, internationally guaranteed, which should safeguard the following: a. Freedom of religion and conscience for all. b. The equality before the law of the three monotheistic religions and their institutions and followers in the City. c. The proper identity and sacred character of the City and its universally significant, religious and cultural heritage. d. The Holy Places, the freedom of access to them and of worship in them. e. The Regime of "Status Quo" in those Holy Places where it applies;
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
131
Recognizing that Palestinians, irrespective of their religious affiliation, are equal members of Palestinian society; Concluding that the achievements of the aforementioned Bilateral Permanent Working Commission now amount to appropriate matter for a first and Basic-Agreement, which should provide a solid and lasting foundation for the continued development of their present and future relations, and for the furtherance of the Commission' s on-going task, Agree on the following Articles:
Article 1 Paragraph 1: The PLO affirms its permanent commitment to uphold and observe the human right to freedom of religion and conscience, as stated in the Universal Declaration of Human Rights and in other international instruments relative to its application. Paragraph 2: The Holy See affirms the commitment of the Catholic Church to support this right and states once more the respect that the Catholic Church has for the followers of other religions.
Article 2 Paragraph 1: The Parties are committed to appropriate cooperation in promoting respect for human rights, individual and collective, in combating all forms of discrimination and threats to human life and dignity, as well as to the promotion of understanding and harmony between nations and communities. Paragraph 2: The Parties will continue to encourage inter-religious dialogue for the promotion of better understanding between people of different religions.
Article 3 The PLO will ensure and protect in Palestinian Law the equality of human and civil rights of all citizens, including specifically, inter alia, their freedom from discrimination, individually or collectively, on the ground of religious affiliation, belief or practice.
Article 4 The regime of the "Status Quo" will be maintained and observed in those Christian Holy Places where it applies.
Article 5 The PLO recognizes the freedom of the Catholic Church to exercise her rights to carry out, through the necessary means, her functions and traditions, such as those that are spiritual, religious, moral, charitable, educational and cultural.
Article 6
D. Ceccarelli Morolli – Breve Introduzione al Diritto Ecclesiastico
132
The PLO recognizes the rights of the Catholic Church in economic, legal and fiscal matters: these rights being exercised in harmony with the rights of the Palestinian authorities in these fields.
Article 7 Full effect will be given in Palestinian Law to the legal personality of the Catholic Church and of the canonical legal persons.
Article 8 The provisions of this Agreement are without prejudice to any agreement hitherto in force between either Party and any other party.
Article 9 The Bilateral Permanent Working Commission, in accordance with such instructions as may be given by the respective Authorities of the two Parties, may propose further ways to address items of this Agreement.
Article 10 Should any controversy arise regarding the interpretation or the application of provisions of the present Agreement, the Parties will resolve it by way of mutual consultation.
Article 11 Done in two original copies in the English and Arabic languages, both texts being equally authentic. In case of divergency, the English text shall prevail.
Article 12 This Agreement shall enter into force from the moment of its signature by the two Parties. Signed in the Vatican, 15 February, 2000.