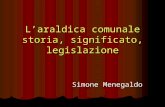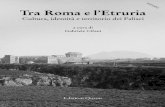PICCINNI, Come introduzione. Gli anni delle svolte
Transcript of PICCINNI, Come introduzione. Gli anni delle svolte
FEDELTÀ GHIBELLINA AFFARI GUELFIa cura di GABRIELLA PICCINNI
FEDE
LTÀ
GH
IBEL
LINA
AFF
ARI
GUE
LFI
3
Dentro il MedioevoCOLLANA DIRETTA DA GIOVANNI CHERUBINI, FRANCO FRANCESCHI E GABRIELLA PICCINNI
Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento
II
22,00
ISBN: 978-88-7781-913-0
9 788877 819130
Gli autori sono consapevoli di aver dato a questo libro un titolo un po’ a effetto – perché né la fedeltà di Siena fu sempre e integralmente ghibellina né gli affari solo guelfi – ma non per questo inopportuno. Esso è adatto a connotare non solo la svolta che si determinò, mentre in Italia divampava il conflitto tra guelfi e ghibellini, a seguito dal cambiamento di fronte politico di Siena (verso lo schiera-mento guelfo), ma anche i suoi passaggi tortuosi, le sue premesse, le importanti trasformazioni che l’accompagnarono. Quelle che con i loro saggi cercano di far parlare sono le contraddizioni che si annidarono nel rapporto tra finanza e potere politico, tra potere politico e mercato, tra potere politico e scalate sociali, tra affari ed etica che quelle quattro parole evocano e riassumono.
Questo volume è composto da saggi. Gli autori – Giovanni Cherubini, Duccio Balestracci, Franco Franceschi, Andrea Giorgi, Renato Lugarini, Roberta Muc-ciarelli, Michele Pellegrini, Gabriella Piccinni, Sergio Roveggi – sono studiosi di storia medievale italiana, in particolare dell’età comunale, Petra Pertici si occupa di storia del Rinascimento, Alessia Zombardo è paleografa.
DENTRO IL MEDIOEVO.TEMI E RICERCHE DI STORIA ECONOMICA E SOCIALE
Collana del Dipartimento di Storia dell’Università di Siena
diretta da Giovanni Cherubini, Franco Franceschi e Gabriella Piccinni
3
La grafica del logo è di Augusto Mazzini, libera rielaborazione dell’immagine del mese di otto-bre, di anonimo, in Salterio, The Hague, conservato nella Biblio-teca Reale del Belgio.
I
Dentro il medioevo. Temi e ricerche di storia economica e socialeDentro il Medioevo. Temi e ricerche di storia economica e sociale, è una collana del Dipartimento di Storia dell’Università di Siena, diretta da Giovanni Cheru-bini, Franco Franceschi e Gabriella Piccinni, nella quale vengono pubblicati tanto i risultati di ricerche originali quanto rivisitazioni tematiche relative alla società medievale, alle sue articolazioni e ai conflitti interni, alle sue idealità e aspirazioni, alla fisionomia economica delle città e delle campagne.
Volumi pubblicati1. DUCCIO BALESTRACCI, Cilastro che sapeva leggere. Alfabetizzazione e istruzione nelle campagne toscane alla fine del Medioevo (XIV-XVI secolo)2. ROBERTA MUCCIARELLI, Piccolomini a Siena (XII-XIV secolo)
FEDELTÀ GHIBELLINA AFFARI GUELFIa cura di GABRIELLA PICCINNI Dentro il Medioevo
Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento
I
L’immagine di copertina è tratta da Niccolò di Giovanni di Francesco Ventura, La scon-fitta di Montaperto, (Biblioteca Comunale di Siena, ms. A IV 5), quella in quarta di copertina è un particolare di Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Cattivo Governo, Palazzo pubblico di Siena.
© Copyright 2008 by Pacini Editore SpA
ISBN 88-7781-913-0
Realizzazione editoriale
Via A. Gherardesca56121 Ospedaletto (Pisa)
Rapporti con l’UniversitàLisa Lorusso
Responsabile editorialeElena Tangheroni Amatori
ImpaginazioneValentina Schiavone
Fotolito e StampaIndustrie Grafiche Pacini
Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Storia dell’Università di Siena (Piano di Ateneo per la Ricerca 2003)
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le ripro-duzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail <mailto:[email protected]>[email protected] e sito web <http://www.aidro.org>www.aidro.org.
INDICE
G. PICCINNI, Come introduzione: gli anni delle svolte . . . . pag. 9
I. QUADRI GENERALI
1. S. RAVEGGI, Siena nell’Italia dei guelfi e dei ghibellini . . » 292. R. MUCCIARELLI, Il traghettamento dei mercatores: dal fronte imperiale alla pars ecclesiae . . . . . . . . . . . . » 633. M. PELLEGRINI, La Chiesa di Siena nella transizione dal ghibellinismo al guelfismo: tra appartenenza cittadina, centralizzazione romana e nuovi equilibri . . . . . . . . . . . » 1054. A. GIORGI, Quando honore et cingulo militie se hornavit. Riflessioni sull’acquisizione della dignità cavalleresca a Siena nel Duecento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1335. G. PICCINNI, Il sistema senese del credito nella fase di smobilitazione dei suoi banchi internazionali . . . . » 209
II. SGUARDI INCROCIATI
1. F. FRANCESCHI, Siena comunale nella Storia di Firenze di Robert Davidsohn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2932. S. RAVEGGI, Mondolfo e Il Populus di Siena . . . . . . . . . . » 3293. G. CHERUBINI, Ernesto Sestan e il suo Siena avanti Montaperti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3454. D. BALESTRACCI, Quando Siena diventò guelfa. Il cambiamento di regime e l’affermazione dell’oligarchia novesca nella lettura di Giuseppe Martini . . . . . . . . . . » 363
9
COME INTRODUZIONE: GLI ANNI DELLE SVOLTE di Gabriella Piccinni
Come si vede dall’indice, questo è un libro composto da saggi 1. Ciò significa che, per sua natura, non si ripromette di esaurire una tematica né di affrontarne tutti gli aspetti. Presen-ta, questo sì, alcuni contributi utili alla conoscenza di una fase importante della storia senese che pur vantando una biblio-grafia prestigiosa 2 appare tuttavia meritevole di una riconsi-derazione: sui due fronti della ricostruzione dei “fatti” e del riesame delle “opinioni”.
In Italia l’arco cronologico per il quale si parla in senso più stretto di guelfi e ghibellini va dagli anni Cinquanta del XIII secolo fino al terzo decennio del XIV, quando sulla penisola per qualche anno si riaccese la prospettiva di una restaurazione imperiale. Di poco più ampio è quello interessato dai saggi rac-colti in questa sede, dedicandosi alcuni autori a rintracciare nel primo Duecento premesse e radici dei fenomeni studiati, spin-gendosi altri un po’ più avanti, ad individuare alcuni esiti della svolta filo-guelfa. Cento anni, o poco più o poco meno, conten-gono, comunque, il cuore cronologico e il nocciolo problemati-co delle ricerche e delle riletture che vengono qui proposte.
1 Si tratta di studi originali, con le sole eccezioni dei saggi di M. PELLEGRINI, Attorno all’‘economia della salvezza’. Note su usura, pratica pastorale ed esercizio della carità in una vicenda senese del primo Duecento (già edito “Cristianesimo nella storia”, 25 (2004), pp. 55-98), di S. RAVEGGI, La vittoria di Montaperti, in Storia di Siena, a cura di R. Barzanti, G. Catoni, M. De Gregorio, Siena, Banca di credito cooperativo di Monteriggioni-Alsaba, 1995, pp. 79-94) e di G. PICCINNI, Un intellettuale ghibellino nel-l’Italia del Duecento: Ruggieri Apugliese, dottore e giullare in Siena (già edito “BISIME”, 105 (2003), pp. 53-85, con lievi modifiche). Si ringrazia-no vivamente le riviste e gli editori per aver permesso la riedizione.
2 In questa introduzione i riferimenti bibliografici sono limitati all’essen-ziale e a quanto non è direttamente reperibile nei singoli saggi.
10
FEDELTÀ GHIBELLINA, AFFARI GUELFI
Concorre ad identificare un ciclo con una coerenza in-terna il fatto che in quegli anni si collochi il culmine della crescita senese ma anche il punto di una svolta, o meglio i punti di varie svolte, non tutte necessariamente coincidenti. Cambiarono il fronte politico, la struttura portante dei governi e la loro base sociale (con l’esclusione da tutte le cariche pub-bliche delle famiglie dei casati magnatizi, fossero essi guelfi o ghibellini, di giudici, notai e medici dalla signoria e, general-mente, di tutti ghibellini, e con la progressiva concentrazione del potere nelle mani di un ceto di mercanti), mutarono certi punti di forza dell’economia (con le crisi bancarie, l’abban-dono degli affari in molte piazze internazionali), decollò una possente architettura civile, determinando un mutamento del volto della città che Ernesto Sestan definì quasi paradossale proprio perché avvenuto “nella fase dell’arresto, del ristagno, anche dell’incipiente declino politico ed economico” 3.
Non c’è bisogno di spendere molte parole per ricorda-re che quello del quale si tratta fu un ciclo particolarmente fertile della storia d’Italia, quando la popolazione toccava il punto più alto dell’intero arco plurisecolare del Medioevo e, per quello che qui ci riguarda, la civiltà comunale raggiungeva il suo massimo sviluppo istituzionale, politico, sociale, econo-mico e culturale. Anche la popolazione urbana della Toscana raggiunse l’apice tra l’ultimo quarto del Duecento e l’inizio del Trecento, quando il rapporto numerico tra quella delle città e quella delle campagne in qualche caso poté rasentare il pareggio 4. Anche Siena passava dai circa 15.000 abitanti della
3 È quasi un paradosso che questo volto incantevole della città, che desta stupita ammirazione universale, sia, sostanzialmente, il volto che la città assunse non nel periodo dell’ascesa […] ma nella fase dell’arresto, del ristagno, anche dell’incipiente declino politico ed economico”: E. SESTAN, Siena avanti Montaperti, “BSSP”, LXVIII (III Serie, vol. XX) (1961), pp. 3-49, riedito in ID., Italia medievale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italia-ne, 1966 (in realtà 1967), pp. 151-192, dal quale cito la p. 192.
4 Circa 300.000 abitanti, su un totale di 1.300.000 della regione, sareb-bero vissuti in quattro grandi città e nei nove centri urbani medi e minori: G. PINTO, La Toscana nel tardo Medioevo, Ambiente, economia rurale, società, Firenze, Sansoni, 1982, pp. 62, 78 e G. CHERUBINI, Città comunali di Toscana, Bologna, Clueb, 2003, p. 191.
11
COME INTRODUZIONE: GLI ANNI DELLE SVOLTE
prima metà del XII secolo, e che erano forse raddoppiati alla metà del Duecento, ai 47-50.000 raggiunti intorno agli anni Venti-Trenta dal Trecento 5.
Il disegno del circuito urbano visualizza bene questo an-damento. Negli anni Venti del XIII secolo i senesi avevano terminato lo sforzo di costruzione di una nuova cerchia delle mura, intorno alla metà del secolo mettono mano al suo am-pliamento, seguito da un ultimo, progettato nel 1323-26, che aveva portato la circonferenza della città a 6666 metri (a circa 165 ettari la superficie compresa al suo interno) 6, includendo borghi nati a ventaglio verso sud e una superficie semivuota, valorizzando proprietà che entravano nel mercato immobilia-re dei suoli edificabili, trasformando lo spazio urbano in una figura, una sorta di stella con tre punte arrotondate o una ypsilon rovesciata. Una documentazione molto particolare dà la rara opportunità di collocare il culmine della curva demo-grafica nel settennio 1324-1331, quando troviamo registrate nella Tavola delle possessioni, la grande rilevazione dei beni immobili della città e del contado, le case di un nuovo quar-tiere che, per qualche anno, accolse i flussi degli inurbati nelle balze retrostanti il palazzo pubblico 7.
A differenza di quella della popolazione (che continuò ad aumentare fino agli anni Trenta, ma forse anche fino alla metà, del Trecento), la curva in salita disegnata dallo sviluppo econo-mico senese aveva raggiunto il culmine già sul finire del XIII secolo, quando Siena raccoglieva i frutti della stagione in cui era divenuta un centro importante nel campo della finanza e del commercio internazionale: ma quando ci è anche ben chia-
5 Dati riassunti in G. PICCINNI, Siena nell’età di Duccio, in Duccio. Alle origini della pittura senese, a cura di A. Bagnoli, R. Bartalini, L. Bellosi, M. Laclotte, Milano, Silvana Editoriale, 2003, pp. 27-35.
6 L. BORTOLOTTI, Siena, Bari, Laterza, 1983, p. 30, che riporta i dati, com-menta che “la sproporzione tra perimetro e superficie denuncia di per sé l’irregolarità della forma urbana, e la frequenza di rientranze nella cerchia”. Confronta l’estensione senese con quella delle altre città to-scane CHERUBINI, Città comunali, cit., p. 140: Firenze 144 ettari, Pisa 185, Lucca 140, Arezzo 107.
7 Sull’espansione trecentesca di Siena D. BALESTRACCI, G. PICCINNI, Siena nel Trecento. Assetto urbano e strutture edilizie, Firenze, Clusf, 1977, pp. 30-37.
12
FEDELTÀ GHIBELLINA, AFFARI GUELFI
ro – guardando con il privilegio della distanza – il segnale della sua particolare svolta, il profilarsi di una serie di cambiamenti che sarebbero stati più visibili dalla metà del XIV secolo.
A Siena nessun fiume ha offerto le sue acque per creare quelle condizioni minime per lo sviluppo della manifattura che fece grande Firenze, vivificata dal commercio, nel quale i suoi operatori furono maestri, e dalla sua popolazione parti-colarmente consistente. Nemmeno il mare le è vicino, anche se nel 1303 il Comune cercò una soluzione acquistando il porto di Telamone 8. La città ha avuto, questo sì, una strada importante che le ha reso prossimi Roma e i mercati nel cuore d’Europa, e miniere di argento. Su denaro e collegamenti ha dunque fatto forza, costruendo su di essi, finché è stato possi-bile, la sua clamorosa fortuna, ma continuando a mancare di una struttura produttiva in grado di reggere il confronto con l’agguerrita concorrenza fiorentina sul piano manifatturiero e, soprattutto, di fornirle una spina dorsale continuativa alla quale agganciare l’economia finanziaria, che avrebbe potuto permettere, se non di superarne, almeno di ammortizzarne le inevitabili fasi di debolezza o di crisi.
È certo che gli uomini di affari senesi – che si erano dedi-cati a varie forme di prestito in giro per l’Europa – si ritirarono dagli affari di vasto raggio nel volgere di qualche decennio, per una serie di circostanze generali che non ripeto in questa introduzione. Clamorosa fu la crisi della compagnia dei Bonsi-gnori – aperta nel 1298, cui seguirono il suo fallimento e l’av-vio della liquidazione tra 1307 e 1309 – che segnò il passaggio tra i due secoli, anch’esso evento noto ma non pienamente valutato nelle sue motivazioni specifiche, ricadute locali e in-terazioni con il sistema del credito a livello regionale. Quello che seguì fu un momento di trasformazione sostanziale nel-l’assetto economico senese, segnato dall’alternarsi di tentativi di ripresa e nuovi fallimenti, fino al 1338, quando certi suoi banchi affrontarono una nuova importante crisi in coinciden-za con l’avvio della guerra dei Cent’anni. Sul significato di
8 B. SORDINI, Il porto della ‘gente vana’. Lo scalo di Talamone tra il secolo XIII e il secolo XV, Siena, Protagon Editori Toscani, 2001.
13
COME INTRODUZIONE: GLI ANNI DELLE SVOLTE
questi eventi e sugli esiti nel breve e nel lungo periodo, la ri-cerca storica non ha trovato ancora tutte le sue risposte e su di essi si tenta, in questa sede, di aggiungere qualche elemento di conoscenza, riflessione, datazione.
Quando le compagnie di mercatura e banca incontrarono difficoltà nel mercato internazione ed emersero chiari i limiti della debolezza produttiva della città, gli uomini d’affari senesi cominciarono, in varie forme e se così si può dire, ad investire nel ‘pubblico’, e tra i contributi di novità di questo volume c’è anche questa consapevolezza storiografica. Una parte della ricchezza che si andava liberando fu impegnata nel prestito al Comune di Siena e ai Comuni del suo territorio, che si dilatò fino a comprendere un terzo della attuale regione 9.
Per la parte restante, tutt’altro che insignificante, i capitali privati ritirati prima dal settore del credito internazionale e più tardi anche dalle imprese minerarie, vennero orientati verso la rendita fondiaria. I senesi più ricchi compravano terra, che era abbondante, e questo avrebbe fatto loro accentuare la tenden-za a vivere di rendita con l’avanzare del Trecento 10 quando
9 O. REDON, Lo spazio di una città. Siena e la Toscana meridionale (se-coli XIII-XIV), trad.it., Roma, Viella, 1999, nel quale è da segnalare l’utilissima cartografia.
10 Alla metà del XIII secolo la mezzadria poderale era presente in 16 dei comuni che costituiscono oggi la Provincia di Siena, e più salda-mente in quelli di Siena, Asciano, Sovicille, Monteroni e Rapolano. Intensamente mezzadrili le Crete (Asciano, Monteroni, Buonconvento e S. Giovanni d’Asso); un secolo dopo era già diffusissima anche nei territori compresi nei comuni attuali di Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Montalcino, Pienza, Trequanda, Torrita e Sinalunga. Per la diffusione della mezzadria in Toscana G. CHERUBINI, La mezzadria toscana delle origini, in Contadini e proprietari nella Toscana moder-na. Atti del Convegno di Studi in onore di Giorgio Giorgetti, vol. I, Dal Medioevo all’età moderna, Firenze, 1979, pp. 131-152, ora in ID., Scritti toscani. L’urbanesimo medievale e la mezzadria, Firenze, Salimbeni, 1991, pp. 189-207; G. PINTO, L’agricoltura delle aree mezzadrili, in Le Italie del tardo Medioevo, a cura di S. Gensini, Pisa, Pacini, 1990, pp. 433-448; M. GINATEMPO, La mezzadria delle origini. L’Italia centro-set-tentrionale nei secoli XIII-XV, “Rivista di storia dell’agricoltura”, XLII (2002), pp. 49-110, cui si aggiungano Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale I, Contado di Siena, sec. XIII-1348, a cura di G. Pin-to - P. Pirillo, Firenze, Olschki, 1987, II; Contado di Firenze, sec. XIII, a
14
FEDELTÀ GHIBELLINA, AFFARI GUELFI
alla minore dinamicità e voglia di rischiare che contraddistinse i suoi operatori, fece da spalla l’interesse, questo invece cre-sciuto, per un’agricoltura anch’essa molto ben protetta e soste-nuta dal ‘pubblico’, oltre che per investimenti redditizi nell’al-levamento del bestiame. Ben più tiepidi furono gli interventi politici nei confronti del mondo artigiano, limitato del resto, come vedremo, anche nella sua rappresentanza politica 11. Tut-to questo ha fatto parlare – dopotutto opportunamente, fatto salvo il problema non secondario della misura e quello dei tempi, sui quali occorrerà ragionare ancora – di un processo di ‘ruralizzazione’ dell’economia senese alla fine del Medioevo.
E dunque, mentre in Italia divampava il conflitto tra guelfi e ghibellini, importanti trasformazioni accompagnavano i pas-saggi tortuosi del cambiamento di fronte politico. Torniamo, perciò, alla politica, dalla quale siamo partiti, e ai nuovi nessi che è possibile ricostruire tra assetti di potere, assunzione di decisioni, istituzioni, strutture sociali, sistema economico.
Proprio poco dopo la metà del Duecento Siena visse la brevissima illusione di un’egemonia sulla Toscana, quando l’intrepido Provenzano di Ildibrandino Salvani, chiamato da Dante il “sire quando fu distrutta la rabbia fiorentina” del cui nome “Toscana sonò tutta”, rappresentò il punto di riferimen-to dei ghibellini toscani in appoggio a re Manfredi contro i guelfi e Firenze, cercando nella radicalizzazione della grande divisione tra una parte pontificia e una imperiale l’occasione per affiancare un forte ruolo politico nello scacchiere nazio-nale a quella posizione di primo piano che i suoi banchieri detenevano nel quadro della finanza internazionale. Miraggio inebriante e breve, cresciuto anche intorno ad uno scontro – la battaglia di Montaperti del 4 settembre 1260 – che per qualche anno sembrò poter essere quello decisivo.
cura di O. Muzzi - M.D. Nenci, Firenze, Olschki, 1988; III, Contado di Siena, 1349-1518. Appendice: la normativa, 1256-1510, a cura di G. Piccinni, Firenze, Olschki, 1992, dal quale traggo i dati.
11 G. CHERUBINI, I mercanti e il potere, in Banchieri e mercanti di Siena, prefaz. di C.M. Cipolla, Roma, De Luca, 1987, pp. 163-222 (riedito, con aggiornamenti e con il titolo I mercanti e il potere a Siena in ID., Città comunali, cit., pp. 297-348) alle pp. 187-188.
15
COME INTRODUZIONE: GLI ANNI DELLE SVOLTE
Un epos straordinario ha circondato la battaglia vittoriosa per Siena, specchio di un momento particolarmente intenso per la maturazione dell’autocoscienza cittadina. I senesi ne conservano memoria, tutt’oggi, nel mito di una loro identità ghibellina. Sintetizza Sergio Raveggi: “Se per l’Italia dei guelfi e dei ghibellini intendiamo quella proverbiale delle contrap-posizioni di campanile, un’Italia di lunghissimo periodo dove si coltivano miti e sentimenti di identità, un’Italia che ha radici secolari e fronde che talvolta arrivano fino ai giorni nostri, Siena è ghibellina. Se per l’Italia dei guelfi e dei ghibellini intendiamo l’epoca in cui questi nomi di fazione ebbero un significato preciso nella vita conflittuale dei comuni medievali italiani, epoca che ha ben marcati (e non tanto estesi) confini cronologici, Siena è prima ghibellina e poi, ancora più a lun-go, guelfa.” A questa frase non c’è molto da aggiungere.
Fu proprio il radicalismo rappresentato da Provenzano, il desiderio di dare a se stesso e alla città un ruolo politico di ri-lievo, la stessa vittoria ottenuta a Montaperti, a marcare l’avvio di una lacerazione del tessuto sociale e del gruppo dirigente di proporzioni che la città non aveva mai conosciuto, dal mo-mento che fino ad allora era riuscita, bene o male, ad essere filo-imperiale, ma non per questo automaticamente e intera-mente antipapale, tanto che il Comune si era trovato a com-battere a fianco degli Svevi – valendosi di un finanziamento dei Salimbeni, stando al cronista, di 118.000 fiorini – mentre altri dei cittadini più importanti offrivano crediti al papa per le guerre contro di essi. Cartina di tornasole di questa clamorosa lacerazione era stata la contromossa con la quale il pontefi-ce aveva fatto esplodere le contraddizioni che, all’indomani della sconfitta guelfa a Montaperti, opposero all’orientamento ghibellino del governo il tornaconto particolare dei più ricchi banchieri che trattavano affari con Roma. A questo punto, alla scomunica lanciata alla città e alla conseguente e drammatica cancellazione dei crediti delle compagnie senesi in tutto il mondo, seguì la stesura della lista di famiglie a lui fedeli che il papa esentò dalle conseguenze economiche di quelle sanzioni spirituali. Gli uomini d’affari, divisi nella politica, si scoprirono quasi tutti guelfi nella borsa. “Gli anni 1262-1263 – scrive Ro-berta Mucciarelli nel suo saggio in questo volume – sono per
16
FEDELTÀ GHIBELLINA, AFFARI GUELFI
Siena uno snodo fondamentale: la scomunica di Urbano crea le premesse per la formazione di una identità guelfa che qui, snaturando l’equazione altrove valida fra tradizione popolana e guelfismo, è comunanza di una élite di mercatores nella tu-tela dei propri interessi”.
Con la morte di Provenzano e l’avvio della sua damnatio memoriae, la città affrontò una fase convulsa: furono gli anni della sconfitta militare, del rientro di fuorusciti guelfi, dei ten-tativi di mediazione, del giuramento di fedeltà agli angioini e alla Chiesa, del controesodo dei ghibellini, della resa dei conti, delle rappresaglie e delle distruzioni di palazzi e torri che, come ferite vive, resero la sopraffazione di una fazione sull’al-tra fisicamente percepibile nel tessuto urbano, dell’abbandono della ‘parola’ come strumento importante di lotta politica 12. Proprio dagli anni del ghibellinismo vincente derivarono per Siena regimi di governo guelfo: prima, nel 1271, quello detto dei Trentasei e poi quello detto dei Nove, dal 1287 fino al 1355, scaturito da una crisi profonda degli equilibri politici cittadini, quando si dovettero affrontare prima il conflitto e poi la riconciliazione tra guelfi e ghibellini e, insieme, contenere il potere degli esponenti dei casati. Questa signoria di straordi-naria longevità 13, di orientamento guelfo e fisionomia popo-lare, fu dominata da ceto medio-alto di impronta mercantile
12 Si veda la biografia di Ruggieri Apugliese in questo stesso libro.13 Colse subito la singolarità della lunga durata dei governi noveschi BAR-
TOLO DA SASSOFERRATO, Tractatus de regimine civitatis, in D. QUAGLIONI, Politica e diritto nel Trecento italiano, Il “De tiranno” di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), con l’edizione critica dei trattati “De Guel-phis et Gebellinis”, “De regimine civitatis” e “De tiranno”, Firenze, Ol-schki, 1983, p. 163: “Fuit enim annis fere LXXX. quidam ordo divitum hominum regentium civitatem bene et prudenter”. Commentò il passo in questione G. SALVEMINI, La teoria di Bartolo da Sassoferrato sulle co-stituzioni politiche, ora in La dignità cavalleresca nel Comune di Fi-renze e altri scritti, a cura di E. Sestan, Milano, Feltrinelli, 1972, p. 336. Lo ha di nuovo segnalato M. ASCHERI, Siena sotto i “Nove” in un libro di W.M. Bowsky, “Nuovi studi cateriniani”, 3 (1988), p. 132 e ID., La Siena del “Buon governo” (1287-1355), in Politica e cultura nelle repubbliche italiane dal Medioevo all’età moderna. Firenze, Genova, Lucca Siena, Venezia, a cura di S. Adorni Braccasi - M. Ascheri, Roma, Istituto storico italiano per l’Età moderna e contemporanea 2001, p. 106.
17
COME INTRODUZIONE: GLI ANNI DELLE SVOLTE
composto, a termini di statuto, da mercanti “de la mezza gen-te” 14, con l’esclusione dal collegio di governo (anche se non da altre importanti magistrature) di gran parte delle famiglie di grandi affaristi appartenenti al ceto magnatizio che pure erano state, in buona misura, protagoniste del passaggio dal ghibel-linismo al guelfismo e, certo, interessate alle sue implicazioni economiche. Anche il mondo artigiano – se si esclude qualche produttore di tessuti 15 – restò fuori dal governo.
In questa parabola, gli anni del governo guelfo dei Nove sono stati considerati, per tradizione storiografica e in parti-colare a partire dagli studi di William Bowsky 16, l’età d’oro senese. Per buona parte di quei sessantotto anni la città fu amministrata in modo stabile. “La città – enfatizza il cronista – stava in grande pace e tranquillità, e ognuno attendeva ai suoi guadagni e così il contado, e tutti s’amavano come fratel-li” 17. È certo che si trattò di una periodo di rinnovati sogni di grandezza, anche se diversi da quelli attuati nella precedente, che paiono “di volta in volta realizzarsi nell’ardita architettura della torre del Mangia, nella conchiglia mattonata del campus fori, nella fortunata sequenza di sottomissioni dei castelli del contado” 18. Alcune imponenti opere pubbliche – rimaste quasi l’unico modo per rispondere alla grandezza fiorentina – furono, infatti, concepite con fierezza nel giro di pochi anni, proprio tra la fine del Duecento e il primo quarto circa del Trecento, anche se alcune di esse sarebbero state in seguito modificate in fase di realizzazione o addirittura abbandonate, come sarebbe acca-duto ai lavori di ampliamento della cattedrale. È senza dubbio
14 Il governo dei Nove si autodefiniva “de’ mercanti della città di Siena o vero de la meza gente” o della “gente media” (CG 91, cc. 139v-140, dicembre 1318 e Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, ediz. critica a cura di M. Salem El Sheikh, Siena, Fon-dazione Monte dei Paschi, 2002, d. VI, r. 5, vol. II, p. 535).
15 W.M. BOWSKY, Un Comune italiano nel medioevo, Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1986, p. 306.
16 Basti citare qui per tutti W.M. BOWSKY, Le finanze del Comune di Siena. 1287-1355, trad. it., Firenze, La Nuova Italia, 1976 e ID., Un comune, cit.
17 AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, Cronaca senese, cit.18 F. CARDINI, L’argento e i sogni: cultura, immaginario, orizzonti mentali,
in Banchieri e mercanti, cit., pp. 291-375.
18
FEDELTÀ GHIBELLINA, AFFARI GUELFI
indicativo che proprio nei loro primi anni di attività i Nove intraprendessero i lavori per la costruzione del nuovo grande palazzo civico affacciato sulla conca del Campo con il quale definitivamente vollero emancipare il Comune dall’ospitalità nei palazzi magnatizi. Il lavoro venne portato avanti dal 1298 a ritmi serrati e nel 1310 il governo si installò nel nuovo edificio, nel quale furono codificati tutti gli stilemi dell’architettura me-dievale senese 19. Nel 1325, in occasione di una nuova fase di lavori, venne posta la pietra angolare della torre del Mangia.
Il denaro, che si rese improvvisamente disponibile per finanziare grandi opere pubbliche, supportava il desiderio, e forse anche la necessità, di organizzare e poi mantenere il con-senso intorno alla nuova fase politica, producendo programmi grandiosi d’abbellimento del tessuto urbano come la sistema-zione del Campo o il nuovo acquedotto o il palazzo civico o la costruzione del battistero o gli ampliamenti del duomo, e le commesse pubbliche di autentici splendori artistici che ac-compagnavano complessi messaggi ideologici. Basta ricordare che fu il Comune a commissionare a Duccio per la cattedrale, nel 1287, la grande vetrata circolare per la parete terminale del coro, e nel 1308 la stupenda Maestà che nel 1311 venne collocata sull’altare maggiore. Basta ricordare, nell’ospedale cittadino, almeno le quattro storie della Vergine eseguite nel 1335 da Simone Martini e Pietro e Ambrogio Lorenzetti, anda-te perdute: un ciclo esemplare, lo ha definito Luciano Bellosi, riferendosi “alla immensa fortuna di cui questi affreschi godet-tero come esempi e modelli per i pittori successivi ogni volta che si trovarono a trattare soggetti come quelli raffigurati sulla facciata dello Spedale; così questa decorazione, più di ogni al-tra impresa artistica cittadina, diventò per molte generazioni il simbolo della grandezza solo imitabile e non più raggiungibi-le della pittura senese della prima metà del Trecento” 20. Basta
19 F. GABBRIELLI, Stilemi senesi e linguaggi architettonici nella Toscana del Due-Trecento, in L’architettura civile in Toscana. Il Medioevo, a cura di A. Restucci, Pisa, Amilcare Pizzi per Monte dei Paschi di Siena, 1995, p. 326.
20 L. BELLOSI, Il terzo polo artistico di Siena, in Spedale di Santa Maria del-la Scala, cit., pp. 35-36 ricorda come ancora nel 1451, quando commis-sionò a Sano di Pietro la tavola per la Cappella del Palazzo Pubblico,
19
COME INTRODUZIONE: GLI ANNI DELLE SVOLTE
ricordare, infine, nel palazzo civico, almeno la Maestà affre-scata da Simone Martini nella sala di riunione del Consiglio generale (1315); e quando Ambrogio Lorenzetti, nel 1338-39, ricevette la commessa per dipingere, nella sala attigua dove si riuniva il governo, i tre famosi affreschi sui quali sono corsi fiumi d’inchiostro, fissando i principi sui quali si doveva ba-sare l’azione di governo, i Nove avrebbero avuto, ancora e di nuovo, bisogno di proporsi come i paladini del benessere, della sicurezza e soprattutto della concordia civica.
Infatti le prime crepe del lungo regime politico novesco si videro già nei primi decenni del Trecento, quando il gover-no fu messo in pericolo più volte da congiure che avevano al centro la rivendicazione di un allargamento, verso il basso e verso l’alto, della sua base sociale. In quelle occasioni furono strette nuove alleanze tra nobili e popolani, come nel 1318 e nel 1328, quando si coagulò lo scontento di alcuni magnati, di gruppi di carnaioli (grossisti di bestiame colpiti della politica sui pesi, sui prezzi e sulla qualità) e di notai e giudici (forse per le parcelle tenute basse). Ci furono in quegli anni anche dure carestie, e basti ricordare, per tutte, quella che dette origine alla sommossa del 1329, quando “i Signori e i cittadini ebero gran paura che Siena non fusse messa a sacco dai povari” 21. Più o meno negli stessi anni il poeta Bindo Bonichi, che pure era stato più volte membro della signoria novesca 22, faceva sentire la sua voce critica contro le chiusure del governo e il troppo amore per i soldi del ceto medio che lo esprimeva 23: Quando i mezzan diventano tiranni/ Preghi Iddio la cittade, che la guardi/ Dagli affamati e pessimi leopardi/ Ch’hanno assaggiato il Giglio e San Giovanni, (cioè il fiorino d’oro).
Ambrogio Lorenzetti, come membro del Consiglio gene-rale, otto anni dopo aver dipinto il Buongoverno sarebbe an-
il Comune prescrisse che le storie della Vergine della predella fossero “come sono quelle della faccia dello Spedale”.
21 BOWSKY, Un comune, cit., pp. 104-105, 191, 193, 196; AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, Cronaca senese, cit., p. 485.
22 BOWSKY, Le finanze, cit., p. 19723 Rime di Bindo Bonichi da Siena, a cura di L. Banchi, Bologna, Roma-
gnoli, 1867, sonetto XVI.
20
FEDELTÀ GHIBELLINA, AFFARI GUELFI
dato di nuovo a soccorso dei Nove, questa volta sostituendo al pennello le parole e il voto. L’11 novembre del 1347, in un momento di rinnovata difficoltà per il governo, il pittore avreb-be pronunciato infatti un discorso pieno di sapienza, del quale purtroppo ci resta labile anche se chiara traccia: “Il pittore do-vrebbe […] aver fatto una dichiarazione di principio sui due ar-gomenti all’ordine del giorno, il mantenimento dello stato paci-fico e libero e il rafforzamento del governo dei Nove. Ambrogio dunque parla dei contenuti ritratti nei suoi affreschi. Con ogni evidenza le sua parole non soltanto trovano ascolto, ma anzi colpiscono per il loro contenuto: ‘sua sapientia verba’” 24.
Nel 1355, dopo sessantotto anni e dopo che la pestilenza aveva aggiunto a queste difficoltà il suo carico di destabiliz-zazione, Siena cambiò sistema di governo e i Nove furono spazzati via da un movimento nato dalle arti e sostenuto da alcuni esponenti dei casati magnatizi.
Si tratta di eventi che sono conosciuti nella loro ossatura ma che da tempo non vengono riproposti in una prospettiva unitaria o ripensati alla luce delle nuove acquisizioni della sto-riografia sul piano generale e su quello locale 25 o scavando ancora nella ricca documentazione inedita dell’epoca, soprat-tutto quella di carattere pubblico per la quale gli archivi sene-si si segnalano nel panorama italiano 26, e che riceve, in questa
24 “Magister Ambrosius Laurentii alius ex consiliariis dicti Consilii sur-gens in dicto Consilio ad dicitorium circa dictas duas propositas dixit sua sapientia verba”, Archivio di Stato di Siena, Concistoro 2, cc. 8-9v, citato da M. SEIDEL, Arte italiana del Medioevo e del Rinascimento, vol. 1, Pittura, Venezia, Marsilio 2003, p. 335.
25 La bibliografia su Siena due e trecentesca è cresciuta molto negli ultimi decenni. Tra le monografie più recenti ricordo almeno M. PELLEGRINI, Chiesa e Città. Uomini, comunità e istituzioni nella società senese tra XII e XIII secolo, Roma, Herder Libreria Editrice, 2004 e ID., Lo statu-to dell’Ospedale di Santa Maria della Scala (Siena, 1305), edizione e saggio introduttivo di M. Pellegrini, Pisa, Pacini, 2005; R. MUCCIARELLI, Piccolomini a Siena. XIII-XIV secolo. Ritratti possibili, Pisa, Pacini edi-tore, 2005; S. MOSCADELLI - A. GIORGI, Costruire una cattedrale. L’Opera di Santa Maria di Siena tra XII e XIV secolo, München, Deutscher Kun-stverlag, 2005; Federico di Giunta notaio. Imbreviature (1268-1271), a cura di Laura Neri, Firenze, Sismel- edizioni del Galluzzo, 2006.
26 Un’illustrazione sistematica delle fonti senesi è in REDON, Lo spazio di
21
COME INTRODUZIONE: GLI ANNI DELLE SVOLTE
stessa sede, nuova attenzione (valga per tutti il contributo che valorizza le carte dell’archivio del Comune di Siena conserva-to presso i domenicani negli anni Ottanta del XIII secolo).
In questo complesso quadro emergono alcune caratteri-stiche della vicenda senese.
Osserviamo che una tradizione bancaria locale, pur dopo il ritiro dalle piazze internazionali, sopravvisse nel Trecento, attraverso il finanziamento del debito pubblico e anche attra-verso il ruolo ricoperto dal maggiore ospedale cittadino. Il passaggio da una attività finanziaria condotta sullo scacchiere internazionale ad una al servizio anche della ‘cosa pubblica’ mette in discussione l’idea di un crollo e di un abbandono repentino e totale di quelle attività creditizie documentando, al contrario, anche da questo fronte come la tradizione finan-ziaria degli operatori senesi non venisse mai del tutto meno nemmeno durante il Trecento. Sappiamo, infatti, che la nuova strategia delle società si orientò a soddisfare la domanda in-terna di credito al consumo e, soprattutto, quella proveniente dal disavanzo dei bilanci comunali 27, il cui crescente fabbiso-gno determinava una sicura domanda creditizia. Contempo-raneamente, come minimo dal 1326, le casse dell’ospedale di S. Maria della Scala costituirono un rifugio robusto e remune-rativo per la ricchezza prodotta nella fase precedente, scudo di molte importanti eredità, nell’attesa di tempi migliori in cui essa potesse essere impegnata di nuovo. Conosciamo poco, invece, di cosa successe dell’impegno di quegli operatori nel territorio toscano e in altre parti d’Italia.
La stesura della lista dei casati esclusi dal governo lascia intravedere, in nuce, il delinearsi del primo dei monti, come si chiameranno, ma solo nella seconda metà del Trecento, i
una città, cit., pp. 24-60. 27 R. MUCCIARELLI, Potere economico e potere politico a Siena tra XIII e XIV
secolo: percorsi di affermazione familiare, in Poteri economici e poteri politici. Secoli XIII-XVIII, a cura di S. Cavaciocchi, Atti della XXX setti-mana di Studi dell’Istituto Internazionale di Storia economica F. Datini (Prato 1998), Firenze, Le Monnier, 1999, pp. 569-590, con esempi di prestiti al comune di Massa Marittima da parte di esponenti di famiglie magnatizie senesi.
22
FEDELTÀ GHIBELLINA, AFFARI GUELFI
raggruppamenti che si costruirono in Siena a partire da suc-cessivi processi di “schedatura” dei gruppi di famiglie che si erano succedute al potere fra il 1284 e il 1368.
Si conferma anche il forte contributo dato dagli stessi ca-sati alla cosa pubblica (pur dopo la loro esclusione dai collegi di governo) soprattutto nelle magistrature finanziarie, nelle quali del resto fare a meno della garanzia rappresentata dai denari dei cittadini più ricchi sarebbe stato un problema per qualunque governo, pur convintamente popolare e pur con-sapevole di consegnare in questo modo in mano altrui uno strumento formidabile di pressione politica.
La politica di mediazione tra gli interessi confliggenti dei ceti sociali inseguita dai Nove – e che fece seguito, per qual-che decennio, agli anni più rabbiosi del conflitto interno – non pacificò la città, che continuò a fare i conti con le continue rot-ture della convivenza civile rappresentate dalle violenze dei casati e tra i casati, che arrivarono ad episodi di vera e propria guerriglia urbana 28, contro le quali poco ottenne il Comune con la politica delle ‘paci’ solennemente imposte alle famiglie rivali 29 e con l’elaborazione di forme originali di propaganda politica, pur espresse in stupendi affreschi attraverso i quali i messaggi ideologici venivano lanciati attraverso i secoli: fin dalla Maestà di Simone Martini del 1315 30 per arrivare al Buo-no e cattivo governo di Lorenzetti del 1338-39.
Infine, e soprattutto, va sottolineato il ruolo forte attribui-to alla dimensione del ‘pubblico’ sotto il governo mercantile dei Nove. Nel governo della cosa pubblica venne impegnata, come accadde a parte del denaro, anche l’esperienza di gestio-ne di tanti uomini di affari ed è lì che crebbero sperimentazio-ni nuove e talvolta ardite di amministrazione e di regolamen-tazione, come lo statuto di 260 rubriche della magistratura dei
28 Ripercorre le violenze BOWSKY, Un comune, cit., pp. 184 sgg., 199.29 A. CARNIANI, I Salimbeni. Quasi una signoria, Siena, Protagon, 1995,
pp. 96, 193 sgg.30 Da notare come nel 1314, durante una riunione del Consiglio generale
che varò una serie di provvisioni contro i potentes che offendevano i de-biles, si ascoltassero quasi le stesse parole che si leggono nella Maestà di Simone (CG 86, cc. 166v-169v, citato da BOWSKY, Un comune, cit., p. 76)
23
COME INTRODUZIONE: GLI ANNI DELLE SVOLTE
Viarii (1290) che ci consegna la chiave per comprendere il funzionamento di un importante settore amministrativo 31; o come lo statuto cittadino, volgarizzato in un bell’italiano nel 1309-10, e scritto in “lettera grossa”, perché potesse essere letto anche dalle “povare persone et altre persone che non sanno grammatica”; come la già ricordata Tavola delle posses-sioni del 1316-1320, precocissimo catasto nel quale vennero descritti i beni immobili esistenti in città e in 295 comuni del territorio, un’operazione gigantesca considerando l’epoca, pri-mo tentativo organico di un Comune italiano di valutare le proprietà utilizzando dei mensuratores professionisti anziché poggiando sulle auto-dichiarazioni dei proprietari 32; come, infine, la trasformazione dell’ospedale cittadino in una forte ‘impresa’ della pubblica carità. Le trasformazioni che la città affrontava, in sé e in rapporto alla Toscana, alla penisola, al continente, mentre allontanavano dallo scacchiere dell’econo-mia internazionale e avvicinano alla terra – di fatto ‘saltando’ ancora una volta ogni scelta davvero convinta di sviluppo del-le produzioni artigiane – portavano anche verso la finanza pubblica, verso l’assistenza pubblica, la committenza artistica pubblica, le opere pubbliche: al punto che anche “l’elegante, leggera e colorita ‘monumentalità’ gotica della città” appare riconducibile non ad una fase di predominio aristocratico, ma all’età, all’opera, agli orientamenti di un governo mercantile della classe media, “a ulteriore riprova dell’originalità di que-sta storia cittadina” 33. In tutti questi ‘luoghi’ non mancarono né i capitali per finanziare le grandi opere che, proprio in
31 Viabilità e legislazione di uno statuto cittadino del duecento. Lo statu-to dei Viari di Sienai a cura di D. Ciampoli - T. Szabò, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1992.
32 CHERUBINI, I mercanti e il potere, cit., p. 187. Il valore della fonte fu per la prima volta messo in luce da L. BANCHI, La lira, la tavola delle Possessioni e le preste della Repubblica di Siena, “ASI”, s. III, t. VII (1868), parte II, pp. 53-58. Il primo importante lavoro di elaborazione dei dati della Tavola è stato coordinato da Giovanni Cherubini; i risultati sono stati restituiti in G. CHERUBINI, Proprietari, contadini e campagne senesi all’inizio del Tre-cento, in ID., Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso medioevo, Firenze, La Nuova Italia, 1974, pp. 230-311.
33 CHERUBINI, Città comunali, cit., pp. 328-329.
24
FEDELTÀ GHIBELLINA, AFFARI GUELFI
quegli anni considerati di “incipiente declino”, cambiarono la fisionomia della città, né il coraggio di alcune ardite sperimen-tazioni. Tanto che, se è opportuno ridimensionare l’idea che una stagione di difficoltà economiche possa essere considera-ta tout court un’età d’oro, resta tuttavia in ogni caso arduo li-quidarla con una netta valutazione di decadenza: almeno fino alla metà del secolo XIV, quando i casati ottennero dal nuovo governo artigiano un “controllo pressoché esclusivo” dei posti di governo del contado 34 e, non a caso, si fecero più chiari i processi di valorizzazione della rendita fondiaria, di sostegno politico dei cittadini proprietari terrieri, tra i più ricchi dei quali, ancora una volta, si trovavano membri dei casati, seguiti da noveschi di origine sia nobile che popolare 35.
Fedeltà ghibellina affari guelfi. Gli autori sono consape-voli di aver dato a questo libro un titolo un po’ a effetto – per-ché né la fedeltà fu sempre e integralmente ghibellina né gli affari solo guelfi – ma non per questo inopportuno. Quelle che con i loro saggi più cercano di far parlare sono, infatti, le contraddizioni che si annidano nel rapporto tra finanza e po-tere politico, tra potere politico e mercato, tra potere politico e scalate sociali che quelle quattro parole evocano e riassumo-no e che si possono elencare in una serie di interrogativi: - come e perché in tempi di duro scontro tra papato e impero
i senesi così filo-imperiali furono in ottimi rapporti di affari con la curia pontificia; come vissero, i banchieri ghibellini, il dramma della scelta quando diventò chiaro che l’interes-se materiale per sopravvivere risiedeva nel guelfismo; come vissero, i banchieri, e come risolsero il conflitto tra borsa e coscienza, tra usura e religione; perché i rapporti di affari di alcune compagnie con la curia si andarono affievolendo proprio nei tempi del passaggio della città al fronte guel-fo; quanto pesarono le capacità strategiche dei banchieri, quanto la posizione di forza che derivava loro dai servizi
34 S. MOSCADELLI, Apparato burocratico e finanze nel Comune di Siena sotto i Dodici (1355-1368), “BSSP”, LXXXIX (1982), pp. 29-118, alle pp. 44-45, 53.
35 BOWSKY, Un comune, cit., p. 264
25
COME INTRODUZIONE: GLI ANNI DELLE SVOLTE
che svolgevano, quanto le loro debolezze improvvisamente manifestatesi con le crisi bancarie;
- se, ed eventualmente in quale misura e su quale fronte, le di-verse articolazioni della chiesa locale si inserirono nella lotta politica, che aveva sullo sfondo il diretto coinvolgimento, in quello scontro, del papato romano; e perché non si riscon-trarono vistose fratture né nelle relazioni fra comune e chiesa cittadina, né all’interno della stessa compagine ecclesiastica;
- come e perché, e in cambio di cosa, le grandi famiglie di casato finirono per partecipare e consentire – oppure per essere costrette a consentire – alla elaborazione di leggi che li escludevano dal governo comunale 36; attraverso quali momenti di negoziazione, dopo aver superato la la-cerazione tra guelfi e ghibellini degli anni del fuorusci-tismo, il nuovo governo riuscì a tessere la tela di una pa-cificazione sociale che avrebbe dovuto mantenere l’ordine pubblico e contenere il potere familiare anche dei grandi esponenti del guelfismo 37; attraverso quali momenti di conflitto irrisolto si approdò alla nuova rottura che, a metà Trecento, scaturì dal fallimento di quella politica di ricon-ciliazione pur tenacemente perseguita con gli strumenti della politica e quelli dell’economia e sostenuta con quelli della propaganda;
- perché il governo dei “mercanti della gente media” sostenne l’economia delle grandi famiglie colpite dalle crisi bancarie ma non protesse mai con altrettanta convinzione ed effi-cacia il comparto produttivo cittadino, il mondo artigiano dove, non a caso, covò lo scontento; perché furono pochi a scegliere di destinare nuovi capitali allo sviluppo della manifattura tessile, e Siena rimase irretita in una sorta di bi-
36 Per il contributo dato da alcuni membri dei casati (Piccolomini, Paglia-resi, Tolomei) alla fase di stabilizzazione politica e istituzionale connes-sa alla legislazione antimagnatizia e alla pacificazione con i ghibellini vedi il bel ritratto di Enea di Rinaldo Piccolomini in R. MUCCIARELLI, Piccolomini a Siena. Ritratti possibili, Pisa, Pacini, 2005, pp. 171-207.
37 Tradizione documentaria e storia cittadina, Introduzione P. CAMMARO-SANO, in Il Caleffo vecchio del Comune di Siena, a cura di G. Cecchini, Firenze, Olschki, 1988, vol. I, pp. 7-81, alla p. 73.
26
FEDELTÀ GHIBELLINA, AFFARI GUELFI
polarismo economico, che andava dalla finanza alla rendita, tenendola sempre abbastanza lontana dalla produzione;
- quali sono le ragioni che resero possibile la fioritura della città – ad esempio sul piano architettonico, urbanistico, giu-ridico, artistico – pur in anni di difficoltà?
Quel titolo, perciò, è sembrato adatto a connotare non solo la svolta determinata dal cambiamento di fronte politico e le sue premesse, ma anche le contraddizioni che la accom-pagnarono. Sotto l’ombrello di quel titolo e intorno ad alcuni dei nodi ora ricordati riflettono, in questa sede, Sergio Raveg-gi, Roberta Mucciarelli, Michele Pellegrini, Andrea Giorgi, io stessa, mostrando come, dopo tanto dibattere, ancora possa aver senso parlare di scontro tra magnati e popolani, di colla-borazioni trasversali, di negoziazioni politiche, di guelfi e di ghibellini, di trasformazioni di un’economia urbana. La serie di saggi – oltre che dall’apporto di Alessia Zombardo sul fron-te documentario e di Petra Pertici sugli anni in cui i nomi dei guelfi e dei ghibellini riaffiorarono in scenari del tutto mutati – è affiancata da riletture incrociate della bibliografia più an-tica alle quali si dedicano Giovanni Cherubini, Franco Fran-ceschi, Duccio Balestracci, ancora Sergio Raveggi. Nel quadro che ne scaturisce non mancano – come del resto non sono mai mancati nella storiografia sul comune italiano e su Siena – i chiaroscuri delle opinioni dei singoli autori, soprattutto quando essi appaiono più o meno inclini a dar valore agli ele-menti di continuità e mediazione politica di quegli anni, che certo ci furono, o ad accentuarne quelli di cesura e di scontro, che anch’essi ci furono e bene si manifestarono.
E se è consentito, mentre si chiude un lavoro, pensare anche a quale altro potrebbe seguirlo, può avvicinarsi ora an-che il momento di una rilettura dell’epopea dei mercanti e banchieri senesi e delle circostanze del loro declino, della tra-sformazione della loro attività e del raggio di azione, del loro ricomparire alla grande, nel Quattrocento, in circostanze mu-tate, per ripensare al senso complessivo della parabola di un sistema economico, della vicenda di un sistema politico, dello sviluppo di specificità sul piano culturale, artistico, architet-tonico, urbanistico. Se la “grande stagione” conserva intatto il suo fascino, la più “piccola” può riservare delle sorprese.