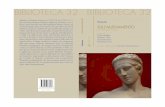Un’abduzione aberrante. Recensione e commento di Luigi Zoja, Paranoia, 2011
Epistola sul Messia: Introduzione, traduzione e commento.
Transcript of Epistola sul Messia: Introduzione, traduzione e commento.
Epistola sul Messia Introduzione, traduzione e commento*
Annunziata RUSSO
Introduzione
Testo ed autore
L’originale arabo che qui si presenta, con annessa traduzione italia-na e corredato da note esplicative e commento, porta il titolo di Epi-
stola sul Messia1 e si sviluppa in diciotto capitoli, in cui viene trattata
la figura del Messia in relazione a vari argomenti basilari della dottri-na cristiana rivisitati in una luce shi‘ita-‘alawita.
La traduzione e lo studio sono stati eseguiti sulla copia di un mano-scritto che è parte di una collezione privata, e che dal colophon risulta
appartenere ad ambienti ‘alawiti localizzabili sulla costa siriana tra ¦ar¥™s e la zona prospiciente il Mar Mediterraneo. Inoltre, il colophon
ci informa che la copia in questione è datata 28 mu|arram 1410, ovve-ro 30 agosto 1989, mentre l’incipit attribuisce l’opera a Mu|ammad b.
‘Al† al-ßill† (320-399/932-1009).2
* Questo studio è il frutto di diversi anni di lavoro volto alla comprensione
dell’Epistola, oltre che del pensiero ‘alawita in generale. Un ringraziamento va al Prof. Bartolomeo Pirone e al dott. Issam Shamma per i loro preziosissimi consigli di carattere filologico, senza i quali la completa resa in italiano della suddetta opera non sarebbe stata possibile. Ringrazio, inoltre, la Prof. Carmela Baffioni per aver rivisto le diverse fasi del lavoro e per i consigli di carattere metodologico che mi sono stati di fondamentale importanza. Gli eventuali errori in questo lavoro sono da ascrivere solo ed esclusivamente alla sottoscritta.
1 Si preferisce questa traduzione, in luogo di una eventuale resa con “Epistola Cristiana”, per gli argomenti trattati nell’opera, che vedono nella figura del Messia il fulcro intorno a cui ruota tutta la trattazione in essa contenuta.
2 L. Massignon, Esquisse d’une bibliographie nusayrie, in Mélanges syriens
offerts à monsieur René Dussaud: secrétaire perpétuel de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres, II, Geuthner, Paris 1939, p. 916, e ‘Al† Akbar þiy…’†, “Al-ma¡…dir al-‘amma al-‘alawiyya” [Le fonti generali ‘alawite], in Fihrist ma¡…dir
al-firaq al-isl…miyya [Elenco delle fonti dei gruppi religiosi islamici], D…r al-Rawÿa, Bayr™t 1992, p. 102, la ascrivono ad al-ßill† (320-399/932-1009). Dal canto suo,
Annunziata RUSSO 210
Il testo, di 30 pagine, fa parte di una raccolta di sette opere attribui-te allo stesso autore, e si presenta in buone condizioni. Scritto in arabo
nas²†, con una cornice per pagina che lo racchiude, segue una nume-razione successiva, pertanto presenta una paginazione che non tiene
conto del verso e del recto.3 La traduzione italiana che qui si presenta è fedele al manoscritto;
nelle note al testo arabo, invece, sono riportate alcune varianti al testo sulla base di un’altra redazione dattiloscritta dallo stesso titolo, ma
priva di qualsivoglia vocalizzazione, note a margine e colophon, e per-tanto, poco funzionale alla resa del significato originario del testo e
perciò poco utile alla contestualizzazione dello stesso.4
‘Al† ‘Abb…s ðarf™š, Al-maÐm™r™na al-qudam…’ f† Þib…l al-La÷qiyya [Gli ignoti antesignani dei monti di Laodicea], D…r al-Yan…b†‘, Dimašq 1996, p. 119, attribuisce uno scritto dal titolo al-Ris…la al-mas†|iyya ad al-³a¡†b† (260-346 o 358/874-957 o 968). Infine Y. Friedman, The Nu¡ayr† - ‘Alaw†s. An Introduction to the Religion,
History and Identity of the Leading Minority in Syria, Brill, Leiden - Boston 2010, pp. 148-149 la attribuisce al suo allievo al-¦abar…n† (358-427/969-1005), mentre a p. 36 e passim è attribuita ad al-ßill†. Per maggiori informazioni sulle opere attribuite ad al-ßill† e al suo maestro al-³a¡†b†, cfr. A. Russo, “Lista di manoscritti ‘alawiti”, in Un testo sapienziale ‘alawita. Kit…b al-Us™s. Introduzione, traduzione e note, a cura di A. Russo, tesi di dottorato in Studi sul Vicino Oriente e Maghreb, discussa il 1/4/2004 presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, alle pp. 22-38; Ead., “Manoscritti ‘alawiti: un aggiornamento”, in corso di stampa in Orientalia
Parthenopea. Per le date di nascita e di morte di al-ßill†, cfr. infra, nota 4. 3 Il manoscritto sembra sia un unicum nel suo genere e non mi risulta mai stato
studiato. Tuttavia, il titolo era già noto a Massignon che lo cita nel suo Esquisse, come pure è citato da þiy…’† e ðarf™š. Pertanto è da presumere l’esistenza di altri manoscritti dallo stesso titolo, di cui però non sono in grado di dare alcuna notizia. Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, cfr. A. Russo, “Manoscritti ‘alawiti: un aggiornamento”, cit.
4 al-Ris…la al-Mas†|iyya li’l-ßill† ap. Ras…’il al-|ikma al-‘alawiyya, ed. Ab™ M™sà - Šay² M™sà, Silsilat al-tur…Å al-‘alaw† II, D…r li-aÞl al-Ma‘rifa, Diy…r ‘Aql-Lubn…n 2006, pp. 287-302. Sembrerebbe che gli autori che si nascondono dietro gli pseudonimi dei due curatori non siano ‘alawiti, come il termine di “capo religioso” (šay²) lascerebbe intendere. Inoltre gli errori di interpretazione dei termini riportati nel manoscritto (per cui vd. infra) inducono a pensare che si tratterebbe di autori estranei a tale milieu, e forse più vicini all’ambiente druso di cui altre Ras…’il al-
|ikma fanno parte. Il nome immaginario di “dimore d’intelletto” (diy…r ‘aql ), inoltre, ci riporterebbe inequivocabilmente all’ambiente druso. Il dattiloscritto in questione è stato visionato, in modo sommario, da Y. Friedman, The Nu¡ayr† -
‘Alaw†s, cit. A p. 226 lo studioso propone di tradurre il titolo con “Epistola del Messia Gesù”, e riporta un segno della croce che non risulta figurare nel testo; a p. 256 indica lo scopo dell’opera nella spiegazione del significato di simboli, santi e giorni sacri cristiani, sottolineandone i riferimenti a Nestorio, e il fatto che, all’inizio dell’Epistola, venga chiesto all’autore di offrire la verità di Gesù nel mondo di luce e nell’esistenza materiale.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 211
Dall’esame del testo, risulta difficile collocare cronologicamente l’opera, perché mancano riferimenti che permettano una datazione
certa. Gli unici elementi sicuri sono l’attribuzione dell’opera ad un au-tore vissuto a cavallo tra i secoli X e XI d.C. e che, stando a quanto ri-
feriscono fonti ‘alawite inedite che forniscono i suoi dati anagrafici, è stato successore del suo maestro al-³a¡†b† (m. 346/957 o 358/968)5 e,
a sua volta, è stato maestro di al-¦abar…n†,6 e ha dimorato ad Aleppo.7
5 Nuovi ragguagli sulla vita di al-ßill† sono riferiti dall’anonimo autore del Kit…b
al-tilm†÷ [Il libro dell’allievo], p. 273, un testo moderno ‘alawita reso in forma di manoscritto, in cui sono riportati, sotto forma di dialogo con domande e risposte, diversi argomenti necessari alla formazione del neofita. Nel caso di Ab™’l-ðusayn Mu|ammad al-ßill†, viene riportato che nacque nel 320/932, e che era il decimo allievo di al-³a¡†b†. Fece diverse volte il pellegrinaggio a Mecca, ed ebbe circa cinquantacinque allievi, a Mecca, nello Š…’m e in ‘Ir…q (asma‘a bi-Makka wa’l-Š…’m
wa’l-‘Ir…q zuh…’a ²amsa wa-²ams†na tilm†÷ an). Fu scelto da al-³a¡†b† come suo successore per l’intensità della sua scienza (li-quwwatihi f† ‘ilmihi), per cui fu chiamato “lo šay² degno di fede” (al-šay² al-Åiqa). Morì nel 399/1009. La sua tomba si trova a Palmira. Questi nuovi ragguagli si vanno ad aggiungere a quanto riportato da Y. Friedman, The Nu¡ayr† - ‘Alaw†s, cit., pp. 35-39, per lo più sulla base di supposizioni dedotte da opere pubblicate nella Silsilat al-tur…Å al-‘alaw†. Per ulteriori informazioni su Ab™ ‘Abd All…h al-ðusayn b. ðamd…n al-³a¡†b†, si veda Y. Friedman, The Nu¡ayr† - ‘Alaw†s, cit., pp. 17-35.
6 L’autore del Kit…b al-tilm†÷, p. 273, ci informa, infatti, che Ab™ Sa‘†d Maym™n b. al-Q…sim al-¦abar…n† nacque a Tiberiade nel 358/969, e partì alla volta di Aleppo dove fu allievo di al-ßill†, come lo era stato anche Ab™’l-ðasan ‘Al† b. ‘‡sà al-ßisr†. Quanto alla possibilità di trovare fra gli allievi di al-ßill† discepoli che facevano parte del circolo dei Ban™ Šu‘ba al-ðarr…n†, come riportato da Friedman [The
Nu¡ayr† - ‘Alaw†s, cit., p. 28 e p. 38, nota 142], ciò non sembra trovare riscontro nel Kit…b al-tilm†÷, dove non viene citato nessun componente di tale circolo come allievo del Nostro. Sarebbero, pertanto, opportuni ulteriori studi su tale argomento. D’altronde, se la mia lettura non è errata, proporrei per Ras…’il al-|ikma al-
‘alawiyya, IV, p. 184, una tesi diversa rispetto a quanto sostenuto da Friedman, che vede in al-ðasan b. Šu‘ba al-ðarr…n† il destinatario di una tradizione tramandatagli da al-ßill† ad Aleppo nel 397/1006. Proporrei, cioè, quale destinatario di tale tradizione, al-¦abar…n† e non al-ðasan b. Šu‘ba al-ðarr…n†. Infatti:
ه وتؤكدي ما رواي الشيخ أبى سعيد ميمىن به القاسم الطبراوي قدس هللا روح قال: حدثىي الشيخ الثقة أبى الحسيمحمد به علي الجلي وضر أهلل وجه وذلك بحلب سىة سبع وتسعيه وثالثمائة قال: حدثىي شيخي ووالدي أبى
.)...( عبد هللا الحسيه به حمدان الخصيبي
“e conferma ciò lo šay² Ab™ Sa‘†d Maym™n b. al-Q…sim al-¦abar…n†, che Iddio santifichi il suo spirito, il quale disse: ‘Mi ha detto lo šay² degno di fede, Ab™’l-ðusayn Mu|ammad b. ‘Al† al-ßill†, che Iddio faccia risplendere il suo volto, e ciò [avvenne] ad Aleppo nell’anno 397: mi ha detto mio padre [spirituale] Ab™ ‘Abd All…h al-ðusayn b. ðamd…n al-³a¡†b† (...)’”.
Ciò non escluderebbe, comunque, del tutto un rapporto indiretto tra al-ðasan b. Šu‘ba al-ðarr…n† e al-ßill†, che sembrerebbe possibile da un passo di Ras…’il al-
|ikma al-‘alawiyya, IV, p. 183, in cui l’autore usa la formula naÿÿara All…h
Annunziata RUSSO 212
Egli sarebbe stato testimone della riconquista della Cilicia e di Antio-chia ad opera dell’imperatore bizantino Niceforo Foca (358/969), e
quindi della costa siriana per mano di Giovanni Zimisce (363/975). Sarebbe rimasto per un certo periodo di tempo prigioniero dei cristia-
ni,8 ed è morto certamente dopo il 397/1006, dal momento che in quell’anno lo incontriamo ad Aleppo mentre passa una tradizione al
suo discepolo al-¦abar…n†.9 Ad oggi, quindi, la biografia di al-ßill† si arricchisce di dati crono-
logici sicuri, e possiamo sostenere che la sua educazione sembra com-prendere una conoscenza teologica accanto ad un contesto culturale
mistico-shi‘ita ricevuto direttamente – come si evince dalle opere a lui attribuite – dal suo maestro al-³a¡†b†.
Come già detto, degli eventi del momento non abbiamo informa-zioni nell’Epistola qui tradotta, ma si può provare a ricollegarla ai fatti
storici dell’epoca tenendo conto di quanto accadeva allora ad Aleppo e nella Siria del Nord.
È questo il periodo in cui i Bizantini si lanciano in una spedizione contro la Siria del Nord, che era in mano ai ðamdanidi, conquistando
diverse città tra cui ßabla e Latakia, sulla costa siriana, mentre Antio-chia veniva consegnata loro dai cristiani della città – fatto, questo, che
portò i Fatimidi ad entrare in Siria nel 969.10 Ciò seguì ad un assetto politico che vedeva l’emiro Sayf al-Dawla11 più volte dimostrare un
atteggiamento favorevole nei confronti dei Fatimidi. Infatti, aveva ad esempio appoggiato i Carmati – all’epoca al servizio dei Fatimidi –
nei rifornimenti di ferro nel 353/964, utili a potenziare i loro arma-menti e quelli delle tribù berbere di Alessandria, cui ricorrevano i loro
waÞhahu, “Iddio faccia risplendere il suo volto” come riferita ad al- ßill†, e dice che sta pronunziando (o “è pronunziata”?: mancando la vocalizzazione, risulta impos-sibile comprendere appieno il senso) un testamento di colui a cui Dio fa risplendere il volto, senza peraltro dire a chi fosse destinato tale testamento. Infatti:
)...(. وقد وطقت وصيت أيضا بمثل ذلك قىل وضر هللا وجه
“ho anche proferito/è stato proferito il suo legato testamentario, analogamente a come lo ha detto colui a cui Iddio fa risplendere il volto”.
7 Cfr. supra, nota 6. 8 H. Halm, “Nu¡ayriyya”, in The Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., VIII, Brill,
Leiden 1995, pp. 145-148. 9 Cfr. supra, nota 6. 10 Th. Bianquis, Damas et la Syrie sous la nomination fatimide (359-468/969-
1076). Essai d’interpretation de chroniques arabes medievales, Institut français de Damas, Damas 1969, I, pp. 18-19.
11 Emiro |amdanide, ‘Al† b. Ab†’l-HayÞ…’ ‘Abd All…h b. ðamd…n regnò su Aleppo dal 336/947 al 356/967 col nome di Sayf al-Dawla.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 213
comuni signori.12 Inoltre, lo stesso Sayf al-Dawla avrebbe manifestato in varie occasioni simpatie marcate per il nu¡ayrismo/‘alawismo na-
scente, accogliendo alla sua corte al-³a¡†b†, il quale a sua volta gli avrebbe dedicato uno dei suoi scritti.13
Il successore, Sa‘d al-Dawla, dové destreggiarsi tra Bisanzio, i Buyidi e i Fatimidi, non rimanendo fedele ad alcuno. Relativamente ai
Fatimidi, sembra che abbia riconosciuto la sovranità del califfo al- ‘Az†z (365-86/975-96) nel 376/986, mentre fu costretto varie volte a
ricorrere all’aiuto dei Bizantini per riprendere il controllo di Aleppo, vista la situazione di declino in cui versavano i vicini Buyidi.14
Ciò detto, potremmo suppore che la Ris…la oggetto del nostro stu-dio costituisca un tentativo di rappacificare contro il nemico bizantino
le diverse anime, per lo più shi‘ite, esistenti ad Aleppo e fuori di essa15 all’epoca di al-ßill†: al-‘Az†z perseguiva incessantemente il controllo
sulla città, anche se, di fatto, egli riuscì a far arrivare la sua azione sol-tanto fino a Tripoli. La vera e propria conquista di Aleppo da parte dei
Fatimidi non si ebbe infatti che nel 406/1015, ed essi misero a capo della città un loro governatore nel 408/1017.16 Se si tiene conto del fat-
to che la zona siro-palestinese fu continuamente teatro di scontri e di rivolte durante il periodo in cui si presume sia vissuto al-ßill†, vale a
dire dall’epoca di al-Mu‘izz (341-65/953-75) sino al califfato di al-ð…kim (386-411/996-1021), potremmo ritenere che l’Epistola sia stata
composta effettivamente per un uditorio ‘alawita,17 presumibilmente
12 Per i riferimenti ad Alessandria e il trono d’Occidente (Kurs† al-MaÐrib), allora
sotto il controllo fatimide (969-1171), v. infra, Capitolo Primo. 13 M. Canard, Histoire de la dynastie des H’amdanides de Jazîra et de Syrie (Pu-
blications de la Faculté des lettres d’Alger), Presses Universitaires de France, Paris 1953, vol. IV, pp. 632-34. A proposito dello scritto dedicato a Sayf al-Dawla, si tratta dell’opera al-Hid…ya al-kubrà, contenente una serie di detti e di fatti attribuiti al Profeta Mu|ammad e ai dodici imam shi‘iti. Per ulteriori informazioni, cfr. Ab™ ‘Abd All…h al-ðusayn b. ðamd…n al-³a¡†b†, al-Hid…ya al-kubrà, s.l., 1986; per
un’edizione più recente: D…r li-aÞl al-Ma‘rifa, Diy…r ‘Aql 2007. 14 La politica coi Bizantini conobbe anche momenti di tensione, come avvenne
nel 375/985, quando lo stesso emiro inviò suoi uomini a massacrare un gran numero di monaci portandone altri in cattività ad Aleppo dal monastero di Dayr Sam‘an. Cfr. M. Canard, “ðamd…nids”, in The Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., III, Brill, Leiden 1986, pp. 126-131.
15 Cfr. il Capitolo Primo dell’Epistola. 16 M. Canard, “F…¥imids”, in The Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., II, Brill, Leiden
1983, pp. 850-862. 17 Diversamente da quanto ipotizzato da Friedman [The Nu¡ayr† - ‘Alaw†s, cit., p.
37], e in base a quanto risulta dalla traduzione del testo, l’Epistola non doveva avere come scopo un’opera di proselitismo fra i cristiani nestoriani, quanto piuttosto
Annunziata RUSSO 214
lo stesso cui faceva riferimento al-³a¡†b† e che, nel periodo in que-stione, era in stretto contatto sia con gli shi‘iti Buyidi che con gli
isma‘iliti Fatimidi e i Carmati. Infatti, dall’esame delle varie parti che compongono l’opera, si evince la volontà del redattore di riportare la
vittoria tra le fila alidi, rappresentate dai ðamdanidi al potere e dai Buyidi.18 Tenuto conto del fatto che fu proprio durante il secolo XI
che i seguaci di al-ð…kim,19 nella persona del fondatore della setta drusa ðamza b. ‘Al†, indirizzano un’epistola di condanna nei confronti
degli ‘alawiti, in cui costoro sono chiamati per la prima volta nu¡ayriti,20 è probabile che l’opera in questione avesse come fine ulti-
mo l’affermazione di un governo shi‘ita che raggruppasse le diverse anime presenti in Nordafrica e nella zona siro-palestinese, e compren-
desse un’alleanza con cristiani nestoriani di filiazione persiana21 da contrapporre alle continue minacce bizantine: ciò, totalmente in sinto-
nia con quanto si proponevano i Fatimidi.22 Tale supposizione sembra essere confortata dal contenuto dei capitoli in cui l’Epistola si suddi-
apparirebbe diretta a shi‘iti che erano, verosimilmente, alleati di cristiani nestoriani, a loro volta in aperto conflitto col nemico bizantino e con l’impero romano d’Occidente. Ciò è presumibile dalla menzione dei Siri come cristiani che non avevano compreso il vero messaggio del Messia e da altri elementi dell’Epistola, cfr. infra, p. 23.
18 L’atteggiamento favorevole dei nu¡ayriti nei confronti dei Hamdanidi e dei Buyidi, entrambi pro-shi‘iti, risulta confermato dalla produzione letteraria di al-³a¡†b†, autore di due opere ad essi dedicate, la al-Hid…ya al-kubrà, di cui si è detto, e l’Epistola di Rastb…š (al-Ris…la al-Rastb…šiyya), dedicata al buyide Ba²tiy…r. Cfr. A. Russo, “Lista di manoscritti ‘alawiti”, in Un testo sapienziale ‘alawita, cit., p. 31; Ead., “Manoscritti ‘alawiti”, in corso di stampa, cit.
19 Al-ð…kim entrò in occultamento nel gennaio del 1021. 20 ðamza b. ‘Al† al-H…d†, “Al-Ris…la al-d…miÐa f†’l-radd ‘alà’l-f…siq al-nu¡ayr†”
[L’epistola confutante in risposta all’empio nu¡ayrita], in Der Islam 25, 1938, pp. 269-281. Tale lettera sarebbe stata scritta in risposta ad un’opera nu¡ayr† dal titolo Kit…b al-|aq…’iq wa-kašf al-ma|Þ™b [Libro delle verità e svelamento del nascosto], in cui la setta drusa era messa in cattiva luce. Sull’origine dei termini nu¡ayr† e muwa||id™n, quest’ultimo condiviso sia dagli ‘alawiti che dai drusi, vd. A. Russo, Un testo sapienziale ‘alawita, cit., pp. 10-11.
21 È fondamentale ricordare che la Chiesa nestoriana era nota anche come Chiesa siriaca orientale, e si contrapponeva alla Chiesa bizantina e al Patriarcato siriaco occidentale di Antiochia. Suddivisa in sei province, localizzate nei territori dell’impero sasanide, da un Concilio tenutosi in Seleucia-Ctesifonte nel 410, queste raggiunsero il numero di otto. La dottrina nestoriana andò diffondendosi nei territori a est fino ad arrivare in Cina e in India. Cfr. B. Holmberg, “Nas¥™riyy™n”, The Ency-
clopaedia of Islam, 2nd ed., VII, Brill, Leiden 1993, pp. 1030-1033. 22 Per un approfondimento sui Fa¥imidi, vd. F. Daftary, Gli Ismailiti: storia di una
comunità musulmana, Marsilio, Venezia 2011.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 215
vide, ognuno dei quali reca un titolo che si riferisce a soggetti cristia-ni, trattati attraverso il ricorso a terminologia propria dell’ambiente
shi‘ita eterodosso. Dall’analisi dell’Epistola risulta comunque una serie di elementi che
non trovano una spiegazione esauriente. Abbiamo, infatti, un Nestorio riproposto sotto una luce completamente gnostica, e dottrine che sem-
brano avere paralleli in ambiente isma‘ilita, come il passo in cui i quat-tro estremi della croce sono identificabili con l’attestazione di fede (l…
il…ha ill… All…h), o la differenziazione tra i nome ‘‡sà e al-Mas†|.23
Sunto dell’Epistola sul Messia Introduzione
L’autore si rivolge al postulante anonimo, e gli ricorda quanto questi gli ha chie-sto a proposito della realtà del Messia in quanto natura luminosa, e delle Sue mani-festazioni alle creature nella natura umana. Seguono passi in cui tale affermazione viene sviluppata, specialmente il concetto del Messia che, in quanto eternità a parte
post, è principiata dalla luce dell’essenza del Suo Signore, l’eternità a parte ante. Per tale motivo non vi è stato alcun parto da Maria, ma il Messia sarebbe stato
solo la manifestazione, in una certa forma, dello Spirito di Santità. Il Messia avrebbe fatto tutto questo per farsi comprendere dalle creature. Esse, infatti, hanno visto il Messia grazie alla loro similitudine per specie (muš…kala), come chi, guardando nel-lo specchio, vede sé stesso.
Il Messia è sia esoterico che essoterico: si cela, e ciò perché si manifesta come Dio attraverso i suoi attributi, ma è essoterico attraverso i suoi profeti e messaggeri.
È chiamato Uno (w…|id ) in quanto è origine dei numeri, e il suo significato risale al Suo Signore. È, infine, colui a cui è stato affidato il regno.
Capitolo Primo
I vari capi provenienti dalla Siria e dall’Egitto hanno riportato episodi che vedo-no il Messia e i suoi discepoli coinvolti in quanto accaduto, e ricordati nelle festività cristiane.
L’autore prosegue negando nuovamente la nascita carnale del Messia, confor-memente a quanto Giovanni l’Evangelista avrebbe affermato a proposito della nasci-ta dell’Emanuele. Il Messia, pertanto, è l’Adamo perpetuo, e non il secondo Adamo come asseriscono gli essoterici; ma è l’essoterico rispetto al Padre da cui deriva, ed è il compimento della Parola che, scendendo, egli ha portato con Sé lungo tutto il tempo, fino alla sua fine. È il possessore del regno, ed è stato originato dalla luce dell’essenza del Padre.
Capitolo Secondo
L’autore sostiene che la croce è un segno, e ne fornisce diverse interpretazioni basate sul numero delle lettere e dei numeri, posti in riferimento a tale segno.
23 Cfr. infra, Capitolo Quarto.
Annunziata RUSSO 216
Capitolo Terzo
Viene esposta la motivazione per cui il Messia è stato chiamato così, attraverso diverse interpretazioni del nome, a partire dai diversi significati della radice *ms|.
Capitolo Quarto
Si evidenzia il rapporto tra la natura umana (al-n…s™t) e quella divina (al-l…h™t) del Messia.
Capitolo Quinto
Viene riportato quanto Nestorio avrebbe detto a proposito del “maestro della mi-sericordia” e del “saggio della comunità”, il quale avrebbe mandato i suoi discepoli nelle dodici regioni di cui Egli è il sovrano. L’unità fra costoro è dovuta al fatto che apparve loro lo Spirito di Santità derivante dall’essenza di Dio, vale a dire Salsal, che li rese veritieri.
Capitolo Sesto
L’autore riporta la tesi docetista dell’uccisione del Messia, che avrebbe avuto come protagonista Giuda Iscariota e non il Messia, e ciò a similitudine della luce del sole che si eclissa, ma rimane sempre nel mondo corporeo.
Capitolo Settimo
Vengono descritti gli Apostoli, assimilati ad un muro con diverse finestre attra-verso cui filtra la luce del sole.
Capitolo Ottavo
Nestorio disse, a proposito della manifestazione di Cristo nella Trinità, che si era manifestato in ‘‡sà, D…ny…l, Isaia e Geremia. Sostenne inoltre che, dopo aver abbat-tuto il secondo tempio, tornò a parlare nelle lingue di ogni popolo. Affermò, quindi, che il Messia si è manifestato nella Trinità, analogamente all’alif che è una quanto a ductus, ma trina nella pronunzia e nella grafia.
Capitolo Nono
Giovanni l’Evangelista, figlio di Zebedeo, riferisce come lo Spirito di Santità si era manifestato nella forma di Giovanni il Battista, indossando una pelliccia di pelli di pecora, cinto in vita con una cintura fatta di peli di cammello, e recando in mano il calice del “servo della Luce”. I seguaci del Messia hanno preso questo esempio e si sono annodati la cintura quattro volte. L’autore enumera i diversi significati esote-rici contenuti nell’annodarsi la cintura e nel farsi crescere i capelli da parte dei mo-naci, secondo quanto aveva mostrato lo stesso Gabriele al momento della sua mani-festazione sotto forma di un monaco.
Capitolo Decimo
L’autore enumera i vari sacrifici compiuti dai diversi profeti, e ne fornisce il si-gnificato esoterico.
Capitolo Undicesimo
L’autore fornisce il significato esoterico dell’ara, dell’altare e del tempio, da identificare con Salsal.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 217
Capitolo Dodicesimo
L’autore fornisce il senso esoterico delle lampade, che rappresentano la luce che si manifesta col Mahd†.
Capitolo Tredicesimo
L’autore fornisce il significato esoterico del battesimo, che è metafora di vita eterna.
Capitolo Quattordicesimo
L’autore fornisce il significato esoterico della forma, che ha luogo nella Chiesa attraverso il suo manifestarsi nelle diverse regioni.
Capitolo Quindicesimo
L’autore fornisce il significato esoterico ed essoterico del turibolo, che è metafo-ra di Maria.
Capitolo Sedicesimo
L’autore enumera le diverse festività cristiane, fornendone il senso esoterico no-bile, da ricondurre al significato di “ritorno” proprio del termine ‘†d.
Capitolo Diciassettesimo
L’autore fornisce il senso esoterico della domenica, che è metafora di Adamo e della perpetuità. Chi conosce il senso esoterico diventa santo come Adamo, Noè, Abramo, Mosè, il Messia e Mu|ammad, altrimenti rimane un essere umano.
Capitolo Diciottesimo
L’autore fornisce il significato esoterico del termine šuhad…’. I “testimoni” han-no visto il Messia nello spirito e Lo hanno riconosciuto.
Annunziata RUSSO 218
Traduzione e note
[148]24 Nel nome di Dio Clemente e Misericordioso
Epistola sul Messia
[149] Epistola sul Messia (al-Ris…la al-mas†|iyya)
Opera del dotto eccellente, del perfetto, dello šay² degno di fede (Åiqa)25 Ab™ ’l-ðusayn Mu|ammad b. ‘Al† al-ßill†,
che Iddio santifichi il suo spirito
Nel nome di Dio Clemente e Misericordioso
[Introduzione]
Lode a Dio, Signore dei mondi, non c’è potenza (quwwa) se non in Dio Altissimo e Sublime.26 Hai avanzato quesiti – che Dio abbia misericordia di te – sulla Realtà (|aq†qa) di nostro Signore il Messia (al-Mas†|) – dalla cui menzione scenda su di noi la pace – in quanto natura luminosa (n™r…niyya), sulle Sue manifestazioni (©uh™r…t) alle creature nella natura umana (bašariyya), sulle qualità (¡if…t) con cui si manifestò nella dimensione corpo-rea (Þusm…niyya) facendosi uomo (ta’n†s) per le Sue creature. Egli, in verità, non è un corpo ma è luce eterna (¡amad…n†), è il Padre Misericordioso, il precettore sapiente, la forma (¡™ra) da cui scaturiscono le sostanze (maw…dd) della sapienza. È l’origine di tutte [quelle] cose grazie alle quali [Egli] rese atto la potenza, è il principio di ogni moto, è il punto da cui ebbe origine
(naša’a) il numero come il punto del compasso (nuq¥at al-b†k…r), poiché l’eternità a parte post (al-abad) è principiata (mu²tara‘)27 dalla luce
24 Per facilitare l’approccio al testo, viene segnata la paginazione originale, e
sono indicati i termini arabi in tutti i casi in cui la traduzione/interpretazione risulta particolarmente complessa o problematica.
25 Si tratta di un appellativo con cui gli ‘alawiti designano l’autore dell’Epistola in oggetto.
26 Cor. I,3. 27 Secondo l’Epistola 42 degli I²w…n al-øaf…’, “Quanto all’instaurazione (ibd…‘)
e all’originazione (i²tir…‘), è il far esistere (al-†Þ…d) la cosa dal nulla (l… min šay’)”. Cfr. A. Straface, L’origine del mondo nel pensiero islamico dei secc. X-XI, Istituto Universitario Orientale, Napoli 1996, p. 72; I²w…n al-øaf…’, Ras…’il, III, al-D…r al-Isl…miyya, Bayr™t 1992, III, p. 473. Ciò indicherebbe che non c’è alcun atto creativo attuato attraverso la mediazione, essendo l’eternità a parte post contenuta, e quindi simultanea per natura, all’eternità a parte ante, come nel caso della metà, che è contenuta nel doppio, e del doppio che, come tale, implica l’esistenza della metà. Secondo le Ta‘r†f…t [Definizioni] di ‘Al† b. Mu|ammad al-ßurÞ…n† (m. 816/1413): “Presso i filosofi (|ukam…’) per i²tir…‘ si intende ‘il portar fuori la cosa dal niente attraverso una materia (m…dda)’ oltre al ‘produrre cose nuove senza una causa esterna’”. Cfr. Lexicon arabico-latinum praesertim ex Djeuharii Firuzabadiique et
aliorum arabum operibus adhibitis Golii quoque et aliorum libris confectum, accedit
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 219
dell’essenza dell’eternità a parte ante (al-azal) senza dar luogo a suddivisioni in parti (tab‘†ÿ),28 senza che vi sia nascita dalla signora delle donne dei mon-di (sayyidat nis…’ al-‘…lam†n),29 Maria, su di Lei la benedizione e il saluto di Dio. Ella altro non è che una cortina (sitr)30 sotto cui avviene la manifesta-zione (©uh™r) della forma corporea (al-¡™ra al-Þusmaniyya), e la forma [in quanto tale] non è universale (kulliyya). La forma31 infatti è [di per sé] limi-tata (ma|d™da), percepita coi sensi (ma|s™sa) e compresa (madr™ka), mentre lo Spirito di Santità [150] è illimitato, non percepito coi sensi e non compre-so. Si è manifestato sotto forma umana pur essendo luminoso e sostanziale (n™r…niyya Þawhariyya), facendosi uomo per le Sue creature, mosso da mise-ricordia e compassione per loro, giacché sapeva che quelle non avrebbero
avuto la capacità di confermarne l’esistenza se si fosse mostrato loro così com’è; se si fosse infatti manifestato nella pienezza della Sua natura lumino-sa (n™r…niyya), la Sua luce avrebbe oscurato le luci e gli sguardi per la pro-pria intensità (min ‘i©am n™rihi), e avrebbe bruciato tutto ciò che è sulla fac-cia della terra. E ciò non sarebbe stato compatibile con la sapienza, né sareb-be stato fondato sulla giustizia. Egli – esaltato sia – proviene dal Suo Signo-
re, eternità a parte ante, non congiunto (maw¡™l), non separato (maf¡™l), non distante da Lui (n…zi| ‘anhu), non identico a Lui (mulimm bihi), al contrario Egli [fa parte] di Lui nel senso della parte rispetto al tutto.32 Se qualcuno di-cesse: “Cosa significa ‘non congiunto’ e ‘non separato’?”, risponderemmo: “‘Non congiunto’ tanto da essere Lui,33 ‘non separato’ tanto da essere altro
index vocum latinarum locupletissimus, ed. G.W. Freytag, apud C.A. Schwetschke
et filium, Halis Saxonum 1830-35, vol. I, p. 477, s.v. 28 Quest’affermazione porta a supporre una ‘simultaneità di natura’, per cui la
realtà di ciascuna delle due eternità non è causa della realtà dell’altra, dato che esse sono in un rapporto di reciproca implicazione, come avviene nel caso della metà e del doppio; inoltre, si sottintende qui che i termini, disposti parallelamente gli uni agli altri, derivano dallo stesso genere. Cfr. Aristotele, Categorie, 13, 14b25-40.
29 L’espressione sayyidat al-nis…’ è applicata solo a F…¥ima, la figlia del profeta Mu|ammad. Cfr. al-‘All…ma al-MaÞlis†, Bi|…r al-Anw…r, Mu’assasat al-Waf…’, Bayr™t 1404/1984, XIII, p. 184; XVII, p. 242; XXII, p. 502; XXVIII, p. 307; XXIX, p. 246 e passim.
30 Da intendere nel senso di “copertura”. 31 “La forma è sempre una parte della quiddità (m…hiyya) nei composti
(murakkab…t ), e in ogni semplice la forma [corrisponde] alla sua essenza perché non vi è composizione, mentre riguardo ai composti la forma non è la loro essenza, né la loro quiddità è la loro essenza. Per quanto riguarda la forma, è evidente che essa è una loro parte, mentre riguardo alla quiddità è ciò per mezzo di cui [qualcosa] è ciò che è, ed è ciò che è soltanto per l’essere della forma nei confronti della materia” (Ibn S†n… [m. 1037], al-Šif…’. Al-Il…hiyy…t [La cura. Le cose divine], al-Hay’a al-‘ţmma li-Šu’™n al-Ma¥…bi‘ al-Am†riyya, al-Q…hira 1960, p. 245).
32 Similmente alla metà col doppio, e viceversa. 33 Scil., Dio.
Annunziata RUSSO 220
da Lui, né corrispondente (muq…bil) a Lui, né estraneo a Lui (n…’in ‘anhu), e né identico a Lui”.
E la risposta [è la seguente], e in Dio è il successo: I raggi che scaturisco-no dai dischi solare e lunare sono da intendersi come unione (itti¡…l) e sepa-razione (infi¡…l), ed [Egli] si è manifestato assumendo una forma unicamente per affermarne34 l’esistenza (wuÞ™d ), la visibilità e l’accertabilità, poiché tut-to ciò a cui non è attribuibile il nome di “manifestazione” (©uh™r) arriva qua-si a essere nulla; asseriamo, di conseguenza, che quella forma che Egli mani-festò alle creature e all’esistenza (wuÞ™d) [tutta] è un’affermazione della Sua esistenza. [Dio] ne ha dato un esempio là dove dice: “Come miraggio nel de-serto, [151] miraggio che l’assetato crede acqua ed ecco che, quando lo rag-
giunge, non vi trova nulla, ma trova, accanto, Dio, per saldargli il conto, ché Dio rapidissimo conta”.35 Lo Spirito di Santità quindi esiste (mawÞ™d) con il manifestarsi delle forme, non è circoscritto (ma|¡™ra), non percepito coi sen-si e non tangibile. Ma il mondo lo ha visto quanto alla sua36 similitudine per specie (muš…kala)37 come chi, [guardando] nello specchio, vede sé stesso.
Egli si è manifestato al mondo sotto una forma umana congenere
(mu’…nasa muÞ…nasa)38 nei nomi e negli attributi propri (¡if…t), celandosi nella madre e apparendo al mondo mentre mangiava e beveva39 per via della Sua natura umana (n…s™tiyya), per rendersi accessibile ai loro intelletti.40 Se si fosse mostrato al mondo quanto alla Sua natura divina (l…h™tiyya), il mon-do non Lo avrebbe frequentato41 e non avrebbe affermato di averLo visto; Egli [quindi] si è manifestato in siffatta maniera unicamente perché le crea-ture lo frequentassero, benché fosse al di sopra di tutto ciò. Questa manife-
34 Riferito a Dio. 35 Cor. XXIV,39. 36 Al plurale nel testo, evidentemente al-‘…lam (“il mondo”) è considerato come
un collettivo. 37 Secondo il Kit…b al-Ta‘r†f…t [Libro delle Definizioni] di al-ßurÞ…n†, D…r al-
Kutub al-‘Ilmiyya, Bayr™t 2003, p. 12, s.v. al-itti|…d: “L’unione (itti|…d) nel proprio
(²…¡¡a) è la muš…kala”, mentre per Ših…b al-D†n b. Ya|yà al-Suhraward† (m. 1191/1777), Kit…b al-Lama|…t [Libro dei balenii], D…r al-Nah…r li’l-Našr, Bayr™t, s.d., p. 126: “Si chiamerà muš…kala ciò che è secondo l’unione (itti|…d) della specie”.
38 Secondo al-ßurÞ…n†, Kit…b al-Ta‘r†f…t, cit., p. 12, e al-Suhraward†, Kit…b al-
Lama|…t, cit., p. 126: “La muÞ…nasa è secondo [l’unione] nel genere”. 39 In Cor. V,75 e 116-117 si dice che Gesù figlio di Maria e sua madre, che era
una santa, mangiavano cibo. Questo versetto, secondo Alessandro Bausani (Il Corano, introduzione, traduzione e commento, Rizzoli, Milano p. 538), si contrap-porrebbe a un possibile culto mariano attestato presso alcune sètte cristiane eretiche. Cfr. P. Jean Muhammad Abd al-Jalil, Probleme de mariologie en Islam, s.l., 1948, pp. 6ss.
40 Ritorna qui il concetto di Dio che voleva farSi conoscere. 41 Il verbo anisa significa in I forma “diventare familiare con qn.”, in III “condi-
videre” o “avere in comune” (s’intende qui, la natura umana).
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 221
stazione c’è stata unicamente per confermare la prova (|uÞÞa) e fare di Sé stesso per loro una via da percorrere (ta|Þ†Þ, ma|aÞÞa). Egli è esoterico (b…¥in) quando si manifesta, ed è essoterico (©…hir) quando si cela. Soltanto attraverso l’anima concreta (al-nafs al-|aq†qiyya) ha richiamato l’attenzione sull’anima divina (al-nafs al-l…h™tiyya), essenziale (al-÷…tiyya), eterna (al-sarmadiyya) e universale (al-kulliyya); come essoterico è profeta e messag-gero, come esoterico è Iddio, Signore dei mondi, vale a dire quegli attributi di Dio con i quali qualifica Sé stesso: Dio, colui che ascolta, che vede (ba¡†r), che sa, che è tollerante, clemente e misericordioso, poiché è eterno a parte ante (al-azal), sia Egli esaltato, [152] non è suscettibile di limiti e non rientra nelle modalità (kayfiyy…t), né è suscettibile di numerazione, e non Gli
si riconosce una fine, né si raddoppia in una [qualche Sua] parte. Dato che il Suo Creatore (B…ri’) Lo chiama Uno (w…|id) sì da essere l’origine (a¡la)42 dei numeri, non pensi che, qualora tu dicessi “mille”, sarebbe inevitabile ri-ferirsi all’Uno (w…|id), che è il primo dei numeri? Egli è un principio il cui significato risale al Suo Signore, ed è Colui al quale è stato affidato (mufawwaÿ) il regno. Crea, sostenta, “fa morire e fa vivere. Egli è di ogni
cosa capace”.43 Ha mostrato imperfezione così come ha mostrato portenti, e le creature ancora invischiate [nel mondo della materia] han considerato ciò come imperfezione alla luce della propria imperfezione, mentre gli uo-mini di purità (ahl al-¡af…’) e di discernimento (ahl al-ba¡…’ir) lo han considerato come sapienza e potenza in considerazione dei loro gradi e dei loro livelli, la pace di Dio sia su tutti loro.
Capitolo Primo
La sua manifestazione da Maria
Questo è quanto di cui mi hanno informato gli eccellenti capi (a¡|…b al-
s…da), coloro che furono messi alla prova [provenienti] dalla terra di Palesti-na, da Gerusalemme, da Tiberiade, dallo Š…’m,44 dal Kurs† al-MaÐrib, da Alessandria e da al-Q†s…n, ovvero quanto di cui parla Giovanni (Yu|ann…) a
proposito di ciò che la Vergine Maria mise alla luce (m†l…d) a Betlemme; di ciò che [la forma] operò nel Giordano con Giovanni il Battista (Yu|ann… al-Ma‘mad…n†) nel giorno del sacrificio (zaba²);45 di ciò che il Signore (sayyid) Simon Pietro (Šam‘™n) manifestò quando entrò in Gerusalemme e [lo] chia-mò [153] “i Rami di Palma” (al-ša‘…n†na); di ciò di cui parlò il giorno della Sua ascesa chiamandola “l’Ascensione” (al-Sull…q), vale a dire il giorno del-
42 Nel testo: a¡lu. 43 Cor. LVII,2. 44 Il Bil…d al-Š…’m corrisponde grosso modo al territorio occupato dagli attuali
Stati del Libano, Siria, Giordania e Palestina. 45 Traduco in questo modo il termine in questione, per la vicinanza di luogo di
articolazione tra la z…’ e la ÷…l, nonché tra la |…’ e la ²…’. Ritengo, comunque, che la resa zaba² al posto di ÷ab| sia dovuta ad una cattiva interpretazione da parte del copista.
Annunziata RUSSO 222
la Sua salita al cielo; di ciò che Egli patì46 prima della Sua resurrezione (qiy…m), nella quale realizzò la resurrezione (ba‘t) chiamandola “Pasqua” (al-Fa¡|); [su] come mise alla prova le creature nel giorno in cui discese lo Spirito di Santità sugli Apostoli attraverso ®ah†r…,47 che chiamò al-Qus¥an¥†n† − vale a dire il giorno della Pentecoste (al-‘An¡ara) −; di ciò che si manifestò
il giorno del ritrovamento della croce48 sulla quale si era mostrato appeso, chiamandolo “festa della croce” (‘†d al-¡al†b); e di ciò che Luca commentò a proposito di quando lo seguì il nostro Signore Geremia,49 e il suo monito a Paolo [il quale fu] messo alla prova, e la preghiera rivolta a Dio, Signore dei mondi: “È un uomo sul quale [Dio] scende (ya|ullu) senza inabitarvi (|ul™l), ma [in cui] si incarna (yataÞassad) senza che sia un corpo e senza [discende-
re] dalla [stirpe] eletta (mu²t…ra) di Ibr…h†m, l’eletto (al-Mu¡¥af…),50 e dalla stirpe del prescelto (muntaÞab) D…wud, e di chi lo ha concepito, [vale a dire] la Vergine Maria, per via di una discendenza di sangue [che] fu fatta oggetto di annunciazione (al-mufÿiyya)”.51 Il racconto della nascita dell’Eterno a
parte post (al-abad) è una situazione impossibile a descriversi e che gli ese-geti non riescono a commentare, giacché non c’è stata nascita, ma solo una manifestazione (©uh™r), e Maria è un velo posto sui cuori di coloro che ac-cettano di credere (al-‘…rif†na)52 e di coloro che rifiutano, perché del Messia il Signore – da Lui ci venga pace – non si può descrivere il principio né si può conoscere la fine; né Gli si addice alcun racconto riguardo al come e al quando per stabilirne un tempo, ma Yu|ann… b. Zayd al-InÞ†l†53 riferì secon-do quanto gli ispirò e gli rivelò lo Spirito di Santità, [154] descrivendo e di-cendo che “dalla Vergine Maria vi apparirà una luce da luce che sarà chia-mata Emanuele (‘Imm…n™’†l), il cui significato [è]: ‘il nostro Dio’, e il suo
46 Lett.: “sperimentò”. 47 Il nome ®ah†r/®ah†ra era lo stesso con cui il padre dell’im…m ‘Al† chiamava
suo figlio. A tal proposito, cfr. al-‘All…ma al-MaÞlis†, Bi|…r al-Anw…r, cit., XXXV,
pp. 45-48; CXIII, cap. 2, p. 275; ‘Al† b. ¦…wus al-ðill†, al-Ta|s†n [L’ornamento],
Mu’assasat D…r al-Kit…b, Qum 1413/1993, p. 610. In ambito ‘alawita, ®ah†ra
corrisponde ad uno dei nomi del Significato nelle lingue dei vari popoli, come riportato da Al-Ţal…t al-|alabiyya [La Preghiera aleppina], manoscritto inedito, p. 33, l. 13.
48 Si tratta del 16 o 17 settembre, e corrisponde all’esaltazione della croce che venne ripresa da Eraclio dalle mani dei Persiani di Chosroe II, nel 614.
49 Si è tradotto in questo modo sulla base di quanto riportato infra, in connessione con lo stesso nome.
50 Da notare che il titolo proprio di Mu|ammad è dato anche ad Abramo, in quanto Nome del Significato del suo tempo.
51 Una lettura alternativa potrebbe essere: “che fluì su di lei, essendo emanata”. In tal caso sarebbe da leggere mufayyaÿa invece di mufÿiyya.
52 Lett.: “che riconoscono”. 53 Il testo riporta erroneamente Zayd, che andrebbe emendato in Zabda, vale a
dire “Zebedeo”. Il “Giovanni” di cui si fa qui parola è Giovanni l’Evangelista, figlio di Zebedeo.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 223
nome sarà: ‘risplendé la meraviglia’,54 il Creatore (al-bad†‘)55 colui a cui mi-rare, la guida, il ben guidato, Padre dei mondi”. Il nostro Signore il Messia si è manifestato non per via di sperma (nu¥fa) o per copulazione;56 Egli è l’Adamo perpetuo (ţdam al-daw…m)57 <...>58 Gli essoterici (ahl al-©…hir) as-seriscono che Egli è il secondo Adamo (ţdam al-t…n† ),59 Colui di cui Matteo e Marco parlano nel [loro] Libro. Il Messia è la sostanza e l’accidente, la lin-gua che parla di Lui,60 [Egli] è la figura (šaba|)61 e l’ombra (al-²ay…l ), l’essoterico rispetto al Padre, l’esistente per coloro che Lo cercano, latore del messaggio dei mondi [destinato] agli uomini che Lo riconoscono, riferimen-to per chi si lascia guidare. Egli è il compimento della Parola che ha fatto di-scendere con Sé lungo tutto il tempo fino all’estrema fine.
Dio è la Parola, e la lingua che la proferisce è il Messia, è un unico (w…|id) che il Suo Signore l’Uno (al-a|ad)62 ha rivelato (abd…hu);63 sotto diversi nomi si è manifestato e ad essi è tornato: è il Signore delle creature, e con ciò nascondo quanto sto dicendo: [È] una concessione per la piena signi-ficazione (ma‘nawiyya) del senso (ma‘nà), Lodato sia Egli ed Esaltato.
Stando così le cose, Egli è il possessore del regno, le creature64 sono i
suoi servi e la Signora Maria è soltanto un velo su ciò steso. Se qualcuno do-vesse dire: “Ella Lo ha generato”, e Dio stesso dice: “[Sono venuto] sulla terra attraverso Colei che mi generò, ed [Egli] non mi rese né un prepotente, né un malfattore”,65 risponderemmo: “Nostro Signore [155] il Messia è eter-no (¡amad),66 non è nutrito, è una luce che non prende corpo; ha manifestato
54 Questo passo sembra essere la sintesi di Gv 1,9 e Mt 1,23. Cfr. Is 7,14; 8,8. 55 Per il significato della radice *bd‘, vd. Commento, p. 42. 56 Il testo dà muy…‘aÿa, che emendo in mub…ÿa‘at secondo quanto suggerito a
margine del manoscritto. 57 In questa espressione si intravede il concetto di successive manifestazioni di
Adamo-Cristo, vale a dire il Verus Propheta che Ippolito di Roma, Elenchos IX, 14,1, attribuisce ad Elchasai. A tal proposito, cfr. Commento, pp. 35-36.
58 I puntini sospensivi indicano una lacuna nel testo arabo. 59 Questa affermazione si rifà alla teologia paolina, per cui Cristo è “l’ultimo
Adamo”, colui “che è uno spirito che dona la vita”. Vd. 1Cor 15,45; Rm 5,12-21; 1Cor 15,21ss. e 15,45-49; Col 1,15.
60 Scil., di Dio. 61 In ambito ‘alawita, il termine šaba| significa “essenza di Dio”. Gli ašb…|
furono i primi ad essere creati, insieme alle ombre (a©illa) di luce divina e agli spiriti (arw…|). Cfr. al-Mufaÿÿal b. ‘Umar al-ßu‘f†, Al-Haft al-šar†f min faÿ…’il mawl…n…
ßa‘far al-Ţ…diq [Il nobile sette tra le virtù del nostro signore ßa‘far al-Ţ…diq], D…r al-Andalus, Bayr™t 1977, p. 21.
62 Cor. CXII,1. 63 Vd. p. 162 del testo arabo, dove è usato bad… per lo Spirito di Santità (bad…
min ÷…tihi, per cui cfr. Capitolo Quarto, p. 161). 64 Si è preferito tradurre “creature” invece di “mondo”, per la presenza del
termine che segue al plurale (‘ab†d). 65 Cor. XIX,32. 66 Cor. CXII,2.
Annunziata RUSSO 224
la nascita nel momento in cui ha manifestato la natura umana [n…s™tiyya] della Sua nascita, per mezzo di lui son cresciuti in discernimento coloro che sanno, mentre coloro che non sanno ne prendono maggiormente distanza e disconoscimento. Egli si rende manifesto (©…hir) e parla (n…¥iq) al momento stesso della nascita,67 mentre ciò non è fattibile in chi una donna ha conce-pito nelle proprie viscere; e sia benedetto Colui che Lo ha originato (i²tara‘ahu) dalla luce dalla Sua essenza, così come volle”.
Capitolo Secondo
Sulla conoscenza della causa che rende necessaria
la manifestazione della croce
Essa è un segno (iš…ra); tu sai bene che la croce in origine (a¡l) è [fatta] di due [pezzi] di legno; mettendoli l’uno sull'altro ne risultano quattro estre-mità. L’origine, infatti, di l… il…ha ill… All…h (“Non c’è dio al di fuori di Dio”) è [rappresentata da] quattro parole.
Da un altro aspetto, il nome ¡al†b è composto di quattro lettere; governa le nature (¥ab…’i‘) da cui si riproduce68 il mondo, quindi è l’origine della
creazione. Da un altro aspetto, la croce è paragonabile al macrocosmo (al-‘alam al-
kab†r). Il macrocosmo, infatti, è come la sfera comprensiva,69 [che racchiu-de] le altre sette sfere, poiché ne causa il movimento circolare. E come que-sto70 ha quattro parti, così la croce ha quattro termini.
[156] L’origine della croce è che essa è costituita da due termini [derivan-ti] da uno solo; tanto i due che l’uno sono come l’ordine e la volontà (al-amr wa al-maš†’a),71 mentre il terzo limite è una metafora (matal) per l’Eterno a
parte ante (al-azal) – Onnipotente è Egli. L’origine della croce è del pari co-stituita di due legni che hanno un polo (qu¥b) che li unisce. Prova di ciò è quanto dici: “Uno per uno è uguale a uno”, per cui questi sono tre termini uniti, non separati. Tuttavia tu constaterai che quando dici: “Uno per uno è uguale a uno”, [avviene] in virtù della molteplicità di un medesimo,72 e non
perché gli si aggiunga alcunché a mo’ di calcolo. Dunque sappi quanto ti ho già indicato.
Il microcosmo (al-‘alam al-¡aІr), invece, è quello di cui hai reso la croce sua proprietà. Poi [consiste nel fatto] che la croce ha otto melograni, due su ciascuna parte, per cui i melograni con i quattro limiti [equivalgono a] dodici limiti, conformemente al numero delle dodici tribù israelitiche (sib¥) di Mosè
67 Qui l’autore si riferisce a Cor. III,46; V,110; XIX,29. 68 Nel senso di “moltiplicarsi per generazione”. 69 Riferimento alla sfera più estrema del sistema tolemaico. 70 Scil., il mondo. 71 Il comando di cui parla l’autore è il Kun che origina il Messia dalla luce
dell’essenza dell’Eterno a parte ante. Cfr., a tal proposito, Cor. II,117; III,47, 59; VI,73; XVI,40; XIX,35; XXXVI,82; XL,68.
72 Scil., l’uno.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 225
e al numero degli Apostoli del Signore il Messia Gesù. La croce deve inelut-tabilmente avere un polo che la tenga ferma, per cui il polo costituisce il tre-dicesimo rispetto a quanto precedentemente detto a proposito degli otto me-lograni e dei quattro termini (arba‘at al-|ud™d)73 che li portano. Il tredice-simo polo è metafora del Signore il Messia, attraverso cui c’è la sussistenza
(qiw…m) di ogni cosa. Qualora volessi compitare [il termine] al-¡al†b, trove-rai che esso è [costituito] da quattro lettere che fanno riferimento a quattro, ovvero agli evangelisti (a¡|…b al-an…Þ†l ), già menzionati in precedenza, [157] che sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni.
Da un altro punto di vista, se sommi le lettere dei nomi “M™sà”, “‘‡sà” e “Mu|ammad”, constaterai che sono dodici come gli otto melograni (ka’l-
rumm…n†na)74 e i quattro termini su cui essi poggiano. È questa la definizione della Crocifissione (¡alb™t) quanto al suo senso esoterico, comprendilo. Fine del capitolo.
Capitolo Terzo
Sulla conoscenza del perché il Messia è stato chiamato il Messia
Quindi disse: “Con ciò ti ho designato perché da esso ti faccia guidare, e sappi che nei confronti di Dio non c’è segreto che non circoli per bocca delle Sue creature, né nei Suoi confronti v’è fortezza più inaccessibile di quanto non sia l’ignoranza che han di Lui. Quanto [verrà] riportato (|ad†Å) [provie-ne] dal santo Capo per via di chi conobbe il Signore il Messia. [Qualcuno] ha chiesto: ‘Perché il Messia è stato chiamato Messia?’ Ha risposto: ‘Perché Egli su ogni cosa ha un’impronta (mas|a) e in Lui non v’è impronta di nul-la’”.
Ha detto:75 “In ogni Profeta vi è un’impronta del Messia, mentre in Lui non v’è impronta di un altro. Egli è la Parola di Dio che è sempre stata per Lui e con Lui76 lungo tutta l’Eternità a parte post (al-abad), fino all’estremo limite del tempo. Dio, infatti, è la parola, e la lingua che [di Lui] parla è il Messia.
[158] È una natura divina (l…h™t) che ha innovato (a|daÅa) una natura umana (n…s™t) perfetta, poi ha cancellato (masa|a) sé stessa ed è diventata un tutt’uno con essa (ta’a||ada bihi).77
Egli era invisibile78 (mams™|) e senza avere nulla di quanto appartiene agli uomini. Stando così le cose, Egli è una natura divina che si è fatta uomo
73 Nel testo: al-arba‘at al-|ud™d. 74 Nel testo: ka’l-ramm…m†na. 75 Ha qui inizio una serie di opzioni, ciascuna introdotta dall’espressione: “da un
altro punto di vista” (wa-waÞh …²ar), che in traduzione è stata sempre omessa. 76 Scil., per il Messia e con il Messia. 77 Cfr. il ricorso allo stesso verbo a p. 160 [testo arabo] del Capitolo Quarto,
dov’è riportato: ta’a||ada al-‘illa bi’l-n…s™t. 78 Si propone qui una traduzione libera, sulla base del significato “cancellato”,
nel senso di “senza forma originaria, privo di forma umana”. Cfr. H. Wehr, A
Annunziata RUSSO 226
(ta’annasa) assumendo la natura umana (ilà n…s™t al-‘…lam†na) delle creature sotto un nome simile ai loro e una qualità come le loro, perché la forma (al-
¡™ra) fosse più accessibile ai loro intelletti di modo che fosse confermata ad essi la prova”.
Si racconta che quando il Signore, Mosè ‒ su di Lui la pace ‒ giunse a
Gerusalemme,79 vide un corno che stillava olio. Allora strofinò la mano su quel corno e l’olio si arrestò, quindi disse ai figli di Israele: “Verrà a voi, do-po di me, chi strofinerà la propria mano su di esso e l’olio scorrerà copioso”. Quando si manifestò il Signore, il Messia, e strofinò il corno con la mano, l’olio sgorgò copioso e [continuò a] scorrere.
Sfiorò (masa|a) il mondo spirituale (al-‘…lam al-r™|…n†) con il mondo
corporeo (al-‘…lam al-Þusm…n†), e in ognuno dei mondi si manifestò (©ahara) con la sua80 sembianza (hay’a), si trasfigurò (taÞallà) con la sua trasfigura-zione (taÞliya), e si manifestò (©ahara) uomo tra gli uomini nel corpo.
Era polito (mams™|) e non possedeva né membro virile né terga, al con-trario era fatto di luce (n™r…n† ), eterno (¡amad…n† ) e conoscitore delle cose di Dio (‘…lim rabb…n† ).
[159] Conduceva assiduamente vita ascetica (kaņr al-siy…|a),81 riposava poco, insegnava ai Suoi servi la scienza dell’essoterico, li incitava ad ap-prenderla e gliela rendeva nota. Egli è lo spirito supremo (‘ulw† ), lo spirito manifesto (Þal† ), visibile (©…hir) e puro (zak† ).
Misurò (masa|a) la terra e il cielo, rivelando in ciascun cielo la mansione
ad esso propria (amrah… ) e stabilendo per ogni terra il sostentamento e i
mezzi di sussistenza.
Sottrasse (k…na mas†|an) alle infermità la gente e la guarì dalle sofferen-
ze. Prova di ciò è quanto dice, sia Egli esaltato: “Guarirò colui che è cieco
dalla nascita e il lebbroso e resusciterò i morti, col permesso di Dio”.82
Un decimo aspetto: Quando Lo sfigurarono83 e Lo esposero al pubblico
ludibrio sul tronco (šawwah™hu),84 gli uccelli e le fiere iniziarono a strofinar-
si (tamassa|a) sul Suo legno, riportandone una benedizione. Era spiritua-
le (r™|…n† ) quanto a conoscenza (ma‘rifa), santo (quds) quanto a nome
(ism…n†), eterno a parte ante (azal† ) quanto alla forma. La Sua forma è come
Dictionary of modern written Arabic, Librairie du Liban, MacDonald & Evans Ltd, Beirut - London 1980, p. 908: mams™| min al-ma‘nà: “privo di significato”.
79 Siamo in presenza di una incongruenza, dal momento che Mosè non è mai sta-to a Gerusalemme.
80 Scil., qui e oltre, del Messia. 81 Si riferisce alla vita anacoretica. Si noti la forzatura operata, per motivi conte-
nutistici, a livello di radicali. L’autore, infatti, mostra di confondere la radice *sy| con *ms| al fine di apportare nuove definizioni relative all’etimo di “Mas†|”.
82 Cor. III,49-50. 83 Nel testo: šahhawuhu. 84 Cfr. Cor. XX,71, dove il Faraone minaccia di crocifiggere su tronchi di palma i
seguaci di Mosè.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 227
il sole, ognuno la vede come egli è, non muta quanto alla propria essenza
(kiy…n), è la potenza che indica il Potente. Fine del capitolo.
Capitolo Quarto
Sulla conoscenza del perché è stato chiamato
Messia in quanto nome della [sua] divinità (ism al-lāhūt),
mentre ‘Is… è il nome della [sua] umanità (ism al-nāsūt)85
[160] Ha detto: “Il Messia sfiorò (masa|a) la terra e ciò che vi è sopra, e
per questo è stato chiamato il Messia. L’empio che avrebbe voluto inganna-
re, uccidere e crocifiggere nostro Signore il Messia è Giuda Iscariota
(Yah™÷… al-Is²ary™¥†), che Dio lo maledica.86 La natura divina completa ha manifestato una natura umana completa in
quanto potenza (quwwa) che passa all’atto (fi‘l ).87 Poi la causa (al-‘illa) si unì (ta’a||ada) alla natura umana,88 quindi si avvicinò agli uomini (taqarra-ba ilà al-‘…lam)89 e, di conseguenza, quella forma attraverso cui si avvicinò (taqarraba) ad essi divenne come la natura umana (al-n…s™t), mentre l’atto
che viene loro è quello della natura divina (fi‘l al-l…h™t)”. Un santo ha detto: “La natura divina (al-l…h™t) completa ha preso come
Suo velo la natura umana (al-n…s™t) completa. E la Sua manifestazione nella natura umana è avvenuta non per via di mistione (mum…zaÞa), né di supera-mento (muÞ…waza), né attraverso la somiglianza (muš…kala),90 giacché se così fosse stato, si sarebbe vanificata con essa. Egli, invece, ha manifestato il Nome e l’Attributo (¡ifa) affinché, attraverso questi, si avvicinasse alle Sue
creature, e ciò per confermare la sua giustizia (‘adl ) nei loro confronti. Del pari il sigillo porta un’incisione sulla pietra e con essa si suggella ovunque lo si porti, facendo mutare (yuÐayyiru)91 e non mutando, e si manifesta nella forma (¡™ra), ma questa non si manifesta con esso. Da ciò deriva che il punto sono le lettere, che non sono divisibili in qualsiasi modo si possa immagina-
85 Per un riscontro sulle convergenze di questo tema in ambito ‘alawita e
ism…‘†lita, vd. Commento, pp. 33-34. 86 Si veda nota 75. 87 Per il passaggio dalla potenza all’atto, cfr. supra, Capitolo Primo. 88 Cfr. supra, Capitolo Terzo. 89 V. anche infra, p. 162 [testo arabo] del Capitolo Sesto: taqarraba ilà’l-‘…lam bi-
Ðayri’l-ab. Si traduce ‘…lam con “uomini”, perché seguito dai sintagmi ilayhim e ya’t†him che ne richiamano la significazione plurale.
90 Nel senso di “unione nel proprio”. Cfr. supra, Introduzione, p. 12, nota 37. Riguardo al significato di “proprio” (²…¡¡a) in quanto elemento fondamentale della muš…kala, vd. Ya‘q™b b. Is|…q al-Kind† (m. 866), Ras…’il falsafiyya, ed. ‘Abd al-H…d† Ab™ R†dah, D…r al-Fikr al-‘Arab†, Ma¥ba‘at al-I‘tim…d, Mi¡r 1950, p. 130: “Il proprio (²…¡¡a) si dice di un’unica specie e di ognuna delle sue persone”; p. 126: “Il genere, la persona e la differenza sono sostanziali; il proprio e l’accidente comune (al-‘arÿ al-‘…mm) sono accidentali”.
91 Nel testo: yuÐayyaru.
Annunziata RUSSO 228
re, [ed è] l’alif e i suoi accidenti (a‘r…ÿ ). Come il punto è un’alif mentre l’alif non [può] essere un punto, [161] così pure la natura divina si manifesta con quella umana, mentre la natura umana non può manifestarsi con quella divi-na. Fu chiesto a un teologo (mutakallim™na): “Come fu necessario che si manifestasse alle creature attraverso la natura umana?”, ed egli rispose: “Semmai fosse apparso (bad…) loro per via di altro, si sarebbe reso necessa-rio (al-w…Þib) quest’ultimo, e quindi sarebbe stato necessario per essi cono-scere l’altro. Egli, però, mandò loro lo Spirito di Santità (r™| al-quds) [deri-vante] dalla Sua essenza (÷…t) nell’atto di aver principio (|†na ’l-ibtid…’ ) da Esso,92 e quindi non una quiddità (m…hiyya)93 del Suo94 genere (Þins), giac-ché Colui che [era] congiunto (mutta¡il )95 con lo Spirito di Santità96 possiede
la natura divina nella [forma] più completa. E gli intelletti han dimostrato che il moto, per quanto leggero (la¥ufat) o pesante (‘a©umat) possa essere, appartiene al genere del moto, e lo stesso dicasi di una cosa derivante da un’altra (al-šay’ min al-šay’)”.
Capitolo Quinto
Sulla conoscenza delle regioni (aqālīm) e dei discepoli
Disse Nestorio97 (Nas¥™rus) a proposito del maestro della misericordia (mu‘allim al-ra|ma) e del saggio della comunità (|ak†m al-umma): “Egli è il
92 Scil., dallo Spirito di Santità. 93 “Gli antichi chiamavano ‘sostanza di quella cosa’ il predicato della cosa di cui
si comprendeva che cosa fosse e l’essenza di quella cosa, e chiamavano ‘quiddità (m…hiyya) di una cosa’ la sua sostanza (Þawhar ) e ‘parte della sua quiddità’ una parte della sua sostanza”: Ab™ Na¡r al-F…r…b† (m. 950), Kit…b al-|ur™f, D…r al-Mašriq, Bayr™t 1970, p. 176.
94 Scil., di Dio. 95 “La congiunzione è l’unione (itti|…d) degli estremi”: al-Kind†, Ras…’il
falsafiyya, cit., p. 176. 96 Cfr. supra, Capitolo Primo. 97 Vissuto nel IV secolo, Nestorio fu consacrato vescovo di Costantinopoli
nell’aprile del 428. La chiesa che da lui prende il nome, principalmente collocata in territori di origine persiana, propone due nature, due ipostasi e un prosopon di Cristo. Egli, infatti, parla di unione volontaria del Logos con l’uomo, affermando che vi è un solo prosopon, da intendere in latino come persona, in cui è presente il significato di “apparenza”, “aspetto esterno” in cui si uniscono le due nature. In questo senso andavano le sue affermazioni su Maria, che non si poteva definire “madre di Dio” (Theotokos), essendo invece preferibile il titolo più comprensivo di Christotokos, in quanto “madre di Gesù nella sua unione col Logos”. In questo senso, Nestorio rimaneva vicino alla cristologia antiochena, che considerava Maria madre soltanto dell’uomo Gesù. Riguardo a Cristo, Nestorio, di formazione antio-chena, tendeva a non intaccarne l’integrità della natura umana, intendendola come personalità completa e capace di libera iniziativa, in contrasto con gli alessandrini, che vedevano in essa un puro e semplice strumento passivo del Logos. Sempre collegandosi alla teologia antiochena, Nestorio parla di un uomo assunto dal Logos,
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 229
sovrano delle dodici regioni e ha fatto dei suoi discepoli dei reggitori (mu-dabbira), perché come tali fossero riconosciuti, intendo i dodici discepoli, mandandoli [ciascuno], nello stesso tempo, nelle dodici regioni, e manife-stando in dette regioni le sue dodici forme. Di ognuno di essi fece una deno-tazione (ma‘nà) e della denotazione di ciascuno di essi una forma. Quindi parlò alla gente di ogni regione nella loro lingua,98 e manifestò loro di volersi occultare (al-Ðayba)99 – eccelso Colui che non è nascosto – [162] e nel mani-festare il Suo occultamento100 rimandò ogni apostolo al luogo [affidatogli]. Così quando venne a mancare l’amore fra loro e furono discordi in quel che asserivano i quattro, ossia Giovanni, Matteo, Luca e Marco, autori dei Van-geli, tornarono a cercarLo, e allorquando furono giunti al luogo (mawÿi‘) in
cui era il Messia, apparve loro lo Spirito di Santità [derivante] dalla Sua101 essenza (÷…t), vale a dire Salsal.102 Quindi Salsal li nascose sotto le sue luci, per cui parlarono attraverso i quattro Vangeli, menzionando che il Signore il Messia li aveva resi veritieri (abarrahum) con lo Spirito di Santità”. I quattro Vangeli, perciò, parlano per bocca di essi, uniti (mutta¡il™na), come sono, con lo Spirito di Santità.
Capitolo Sesto
Sulla conoscenza dell’occultamento (ġayba)
di nostro Signore il Messia
Disse: “Un intimo chiese a proposito di nostro Signore il Messia, da Lui
la pace: ‘Come Gli accadde ciò?’ Rispose: ‘Egli si accostò al mondo senza
Padre e in questo modo si manifestò al mondo, facendo ricadere su di Sé ciò
a cui essi stessi erano stati assoggettati, mosso da pietà e compassione per
loro e da bontà nei loro confronti. Abbiamo visto il ferro arroventarsi nel
fuoco, essere battuto sulle incudini, e tuttavia non era il fuoco a patire, ma a
sottostare al dolore era soltanto colui che era nel fuoco. Così pure, [163]
quando103 nostro Signore il Messia fece sembrare che venisse ucciso, in veri-
tà [la cosa] era al contrario, giacché l’Altissimo è ben al di sopra di ciò. Il
cambiamento era solo agli occhi di chi guardava (al-n…©ir). Il sole si eclissa
(tankasifu) e tuttavia la sua luce [permane] nel mondo corporeo (al-‘…lam al-
Þusm…n† ), essendo essa una sostanza semplice (Þawhar bas†¥), che si propa-
ga. Vediamo l’uomo prefiggersi di colpire il sole con la spada, mentre non è
il sole che viene tagliato, ma soltanto ciò su cui il sole si trova. Lo stesso di-
di tempio in cui dimora il Logos: Dizionario patristico e di antichità cristiane, dir. A. di Berardino, Marietti, Genova 1994, II, pp. 2389-2394, s.v.
98 Probabile riferimento alla Pentecoste. 99 Termine di contesto shi‘ita, che indica l’occultamento dell’ultimo im…m. 100 Probabile riferimento all’Ascensione. 101 Scil., di Dio. 102 Vale a dire Salm…n al-F…ris†, che ricopre il ruolo di “Porta” nella triade
‘alawita Significato, Nome, Porta, su cui cfr. Commento, p. 39, nota 212. 103 Il termine manca nel testo.
Annunziata RUSSO 230
casi della croce. Infatti la crocifissione ha luogo nell’avversario104 poiché il
Nome, al-m†m† 105 − da Lui la pace −, quando manifestò il Suo occultamento
per il tramite della [Sua] uccisione, riverberò sul prediletto [wal† ] la sua so-
miglianza, e costui, a sua volta, riverbera la sua somiglianza sull’antagonista.
E semmai qualcuno si prefiggesse di percuotere il sole con la spada, il colpo
avrebbe effetti non sul sole ma sulla terra, su di essa avverrebbe e non sul
sole. Lo stesso dicasi di nostro Signore il Messia. Tutto ciò che Egli lasciò
che si abbattesse su di Sé come uccisione e crocifissione, fu un’illusione
(talb†s), mentre ciò che lasciò che si abbattesse sull’antagonista corrispose a
verità. Poiché abbiamo visto [che] il sole, [che] è nel quarto mondo superiore
(al-‘…lam al-‘ulw† al-r…bi‘), è più maestoso di quanto v’è sopra e sotto di es-
so, del pari è del nostro Signore il Messia nel mondo superiore, e della Sua
sapienza (|ikma) nel mondo inferiore (al-‘…lam al-sufl† ). Se alcuni cristiani
(na¡…r…)106 inesperti dovessero addurre come pretesto di aver visto con i
propri occhi nostro Signore il Messia, ucciso e crocifisso sul tronco [164] di
palma, risponderemmo: [Ciò sarebbe vero] a patto che colui che volgeva lo
sguardo su nostro Signore il Messia vedesse unicamente il Suo aspetto este-
riore (hay’a). L'incapacità (‘aÞz) di cui è vittima è [ascrivibile] a lui stesso,
giacché fu la sua incapacità a fargli immaginare ciò che aveva visto, e non è
imputabile a lui107 quanto non rispondente al vero per esprimere la qualità
(¡ifa) e la definizione di conoscenza. Spesse volte è indotto in errore, poiché
l’essere umano intravede da lontano il cammello e lo ritiene una pecora, ve-
de un albero e pensa che sia un uomo, si ferma sulla riva di un fiume e si ve-
de al rovescio (munakkas), e sono cose del genere ad ingannare lo sguardo.
La stessa cosa [avvenne] con chi guardava nostro Signore il Messia, avendo-
lo visto ucciso e crocifisso. L’imperfezione dall’Onnipotente [è] Potenza,
Egli, di fatto, assegnò (alq…) la forma (¡™ra) del Messia al prediletto (wal† ),
e assegnò la forma del prediletto e la somiglianza all’avversario Giuda Isca-
riota (Yah™÷… al-Is²ary™¥†)”.108
104 La traduzione del termine ÿidd con “antagonista, avversario” viene suggerita
dalla sua vicinanza col nome di Giuda Iscariota, su cui cfr. infra, p. 22. 105 Con al-m†m† è da intendere Mu|ammad, che occupa il ruolo di “Nome” nella
triade ‘alawita Significato, Nome, Porta; nella “cupola” (qubba) cristiana è occupato da Gesù. Per maggiori chiarimenti sulle cupole in ambito ‘alawita, cfr. A. Russo, “Insegnamenti ermetici e dottrine ‘alawite”, in P. Lucentini, I. Parri, V. Perrone Com-pagni eds., Hermetism from late antiquity to humanism. La tradizione ermetica dal
mondo tardo-antico all’Umanesimo. Atti del Convegno internazionale di studi, Napoli 20-24 novembre 2001, Brepols, Turnhout 2003, pp. 355-367, alle pp. 358-359.
106 Si noti che il termine generico usato nell’islam per indicare i cristiani è Mas†|iyy™na, mentre raramente si ricorre a Na¡…r…, che verosimilmente potrebbe indicare piuttosto una o più sette eretiche.
107 Scil., del Messia. 108 Come di consueto, è stata omessa in traduzione l’espressione: “da un altro
punta di vista”.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 231
E Ab™ Ya‘q™b109 narrò [a proposito di ciò] che disse: “Un certo giorno
Nestorio (Nas¥™rus) ebbe a dire: ‘Come pretendete che diciamo: Il Messia è
Iddio il supremo al di sopra del quale non v’è nulla, quando vediamo che,
quando ebbe luogo [la sua crocifissione], disse: ‘O mio Signore, o Altissimo
(‘Al†) dove sto andando?’, come a dire: ‘Dove vai, e mi abbandoni?110 [Ciò]
è da intendere [come riferito] al Suo Signore’. Disse: ‘Sorrisi e gli risposi:
[165] ‘Che intendi dire?’. Quindi disse: ‘[‘Al†] è uno dei nomi di All…h con
cui Lo si invoca’”.
Capitolo Settimo
Descrizione degli apostoli (ḥawāriyyūna) in relazione al Messia
Sappi che la descrizione dei discepoli e degli apostoli e l’immagine [a cui si rassomiglia] il Messia [è] come un muro su cui si trovano finestre grandi e piccole, e quando il sole lo inonda, ogni finestra ne riceve luce a seconda della propria capacità. Del pari ogni apostolo apprendeva dal Signore il Mes-sia a seconda della propria capacità, e fu proprio del Messia manifestarsi al posto loro (maq…m), mentre non si addiceva loro che si manifestassero al po-
sto Suo.
Capitolo Ottavo
Sulla conoscenza della manifestazione del Messia nella Trinità
A proposito della manifestazione del Signore il Messia nella Trinità, Ne-storio (Nas¥™rus) disse: “All’inizio, [vale a dire nella] Sua prima manifesta-zione, non fu ‘‡sà, né D…ny…l, né Isaia (Aš‘ayy…), né Geremia (Aramiyy…), e poi si manifestò il Messia?111 Chiamò tutte le tribù [dei figli di Israele] che attorno a Lui si radunarono dopo essere state separate. E provocò la distru-zione del secondo tempio dopo quella del primo, 112 abbatté i sacrifici (qar…b†n) dopo che si erano elevati, e rese nuovamente udibile113 il Verbum del principio (al-kalima al-™là) [166] con un travestimento (talb†s), ma il tra-
vestimento venne a cessare poiché era il giorno della rivelazione (kašf ). Li
109 In questo punto, l’autore dell’Epistola si riferisce a Giacomo Baradeo, vissuto
nel secolo VI. Morto nel 578, fu il fondatore della chiesa giacobita di Antiochia, che da lui prese il nome.
110 Vd. Mt 27,46; Mc 15,34. 111 Sarebbe da ipotizzare la presenza di due persone: una è Gesù e l’altra il
Messia, quest’ultimo il vero e unico, come spiegato nell’Introduzione all’Epistola, dove viene riportato che il Messia ha solo una realtà di luce.
112 Il primo tempio fu distrutto dai Babilonesi nel 587 a.C. Ricostruito nel 520 a.C., fu distrutto per la seconda volta nel 70 d.C.
113 Cfr. Al-MunÞid f†’l-luÐa wa’l-a‘l…m, D…r al-Mašriq, Bayr™t 1992, p. 308, s.v. Sim‘…n, in cui si rimanda a Šim™n, mentre è menzionato Sim‘…n b. Y™n… come corrispondente a Simon Pietro, e p. 335, s.v. Šim‘™n, dove questi corrisponde a un figlio di Giacobbe e capostipite di una delle dodici tribù di Israele. Non è, però, da escludere una possibile interpretazione del termine inteso come “udibile, udito”.
Annunziata RUSSO 232
chiamò ed essi risposero, parlò loro in tutte le lingue, e il parlare ad ogni po-polo nella sua lingua fu un atto di equanimità da parte Sua. E [così] confer-mò loro la prova attraverso loro [stessi], e invitava i Siri nella loro lingua, parlò loro ma non risposero e furono, di conseguenza, meritevoli di castigo <...>”. Poi Nestorio disse: “Chi ha riconosciuto il Signore il Messia in tutte e
dodici le regioni [del mondo] ha meritato, in forza di questo riconoscimento, di passare (nuqla)114 al mondo spirituale (al-‘…lam al-r™|…n† ) e di congiun-gersi con il mondo della luce (al-‘…lam al-n™r…n† )”. Nestorio disse pure: “Il Messia si è manifestato nella Trinità. Non negatelo, l’alif infatti è una a ve-dersi (muš…hada), ma quanto al numero, è formata di tre lettere, poiché l’alif
è autosussistente (q…’im bi ÷…tihi) quanto ad esser vista mentre, quanto a
computazione, è costituita di tre lettere che denotano le tre che sono una sola sostanza (Þawhar)”.
Fu chiesto ad un teologo (mutakallim™na) ragione della Trinità ed egli ri-spose: “L’alif è una quanto a ductus, ma è tre quanto a grafia (‘iy…n) e pro-nunzia (laf©). Parimenti, il luogo non può fare a meno di un qualcosa che vi sia stabilito dentro e sussista in sé, e i composti (ta’l†f ) e i corpi che sono tra
di essi115 [167] non agiscono di per sé. L’atto (‘amal ) [di fatto] riguarda esclusivamente le sostanze (Þaw…hir) che sono in essi, attraverso il loro mo-vimento”.116
Capitolo Nono
Sulla conoscenza dell’iniziazione con la cintura (zunnār)
e sul suo [significato] esoterico
Giovanni l’Evangelista, figlio di Zebedeo (Y™|ann… b. Zayd al-InÞ†l†) so-steneva che lo Spirito del Santo (r™| al-quds) si sarebbe manifestato, e indos-sava una pelliccia di pelli di pecora, cingeva la vita con un kašt†z117 fatto di peli di cammello e recava in mano il calice del servo della Luce (‘abd al-
n™r)118 che portava con sé. Gli chiesero del loro Padre e rispose: “Mio Padre e vostro Padre è nel cielo, e ha fatto di voi (Þa‘alakum) un’immagine della
Sua carne e del Suo sangue <...>”, [cosa di cui] i seguaci del Messia (mas†|iyy™na) fecero un modo per avvicinarsi a Lui.119
114 Nel testo: naqla. 115 Scil., tra l’alif e il luogo. 116 Con riferimento alla lettera alif, avremmo “la loro vocale”. In senso filosofico,
l’atto appartiene solo a qualcosa di spirituale. Gli I²w…n al-øaf…’, ad esempio, osservano ripetutamente che un atto è compiuto dall’anima, e non dal corpo. Cfr., ad es., Epistole 18 e 19 in Ras…’il, cit., pp. 66, 113 e 115.
117 Per il termine in questione, nella variante kast†Þ, cfr. quanto riportato da al-ßurÞ…n†, al-Ta‘r†f…t, cit., p. 183, dove, a proposito dello zunn…r, dice che è “una grossa cintura in seta larga quanto un dito”, diversa dal kast†Þ che, invece, ritiene essere “una grossa cintura di lana, spessa quanto un dito, portata in vita dal ÷imm†”.
118 Per gli ‘alawiti, l’espressione “servo della luce” si riferisce al vino. 119 Si tratta di un’evidente rielaborazione in chiave ‘alawita di Gv 1,19-51.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 233
Quanto alla cintura: Quando il patriarca Adamo cadde dal Paradiso [fi-nendo] sulla terra, fu a lungo triste, e grande divenne la sua afflizione, e si diede a ininterrotta adorazione ed esecuzione [della preghiera]. Quindi Ga-briele si presentò a lui sotto forma di un monaco che aveva addosso una tu-nica di peli e in vita un kašt†z di pelliccia; quando lo vide gli chiese: “Chi
sei? E che cos’è questa tristezza che traspare da te?”. Gabriele rispose: “La mia tristezza è dovuta a me e alla mia colpa, le mie vesti sono invece segno della mia umiliazione davanti al mio Signore. Quanto a ciò che porto in vita e con cui mi stringo, è la mia forza”.
Si racconta che Gabriele annodò la cintura quattro volte, gliene chiesero ragione [168] ed egli rispose “Per qualcosa che sarà e [per] un mistero [che] si manifesterà dalla madre della luce, la Grande Signora (al-sayyida al-
kubrà) <...>120”. Gabriele non aveva colpa alcuna, voleva soltanto rammen-tare ad Adamo la colpa [da lui commessa] affinché chiedesse ripetutamente perdono e crescesse così quanto alla facoltà di adorare. E quando il Signore il Messia si manifestò, disse agli Apostoli: “Dovete cingervi i fianchi con le cinture e radervi al centro del capo”. Ma con questo Egli intendeva dire:
“Badate a conoscere gli a’imma121 che [occupano] le tappe spirituali (maq…m…t) [intercorse] fra me e Mu|ammad”.122
Quanto al radersi la testa, ciò sta a significare: [Badate] a non manifestare alla gente l’[aspetto] esoterico delle vostre conoscenze. È stato [infatti] detto: “Nostro Signore il Messia si presentò un giorno agli Apostoli con una cintura ai fianchi quattro volte annodata, e quando Lo videro gli Apostoli chiesero: ‘Signore nostro, cosa significa ciò e [qual è] la sua spiegazione
esoterica (ta’w†l )’? Rispose quindi: ‘Il significato di ciò è che voi Lo cerchiate in quattro stadi (maq…m…t)’”.123
Un altro punto di vista: Disse loro: “Mi manifesterò (a©haru) dai monti Q…r…n,124 mi trasfigurerò (ataÞallà) a Gerusalemme, mi velerò (astatiru) nella
120 I puntini sospensivi indicano l’esistenza di una lacuna nel manoscritto (o di un
testo che l’amanuense non è riuscito a leggere o a capire). 121 Nella letteratura arabo cristiana, con questo termine sono indicati coloro che,
nei loro specifici paesi e per le loro cariche, godono di autorità di magistero grazie alla conoscenza che hanno di quanto pertiene alla loro confessione religiosa. Il termine ha quindi un senso più ampio di quanto im…m (pl. a’imma) non abbia nel contesto islamico.
122 Siamo in presenza di un evidente anacronismo. 123 Ritorna in questo contesto il numero quattro. Cfr. a tal proposito il Capitolo
Secondo in riferimento alla croce, e infra a proposito delle quattro cariche ricoperte nella gerarchia della chiesa.
124 Da leggere “Paran”, vale a dire la regione che corrisponde al Negev meridio-nale, tra Kades e l’Egitto. In questo passo è parafrasato Dt 33,2: “Il Signore è venuto dal Sinai, è spuntato per loro dal Seir; è apparso dal monte Paran (...)”. L’autore qui opera un evidente collegamento col passo in questione, per affermare la sua dottrina della manifestazione di Dio nel Messia.
Annunziata RUSSO 234
grande Costantinopoli (R™miya al-kubrà) e mi occulterò (aІbu) nel Giorda-no”.125
Il fatto di aver annodato la cintura quattro volte è una similitudine dei quattro che rappresentano il mondo della cristianità (‘…lam al-na¡r…niyya), ovverossia il patriarca, il metropolita, il vescovo e il sacerdote.126 Questo è quanto dice il Signore il Messia con le parole: “Chi mi appartiene, si lasci allungare [i capelli] e si cinga ai fianchi”. [169] I monaci si son così lasciati crescere i capelli e legate [ai fianchi] le loro cinture. Con ciò ritennero che [il Messia] avesse fatto intendere di lasciarsi crescere i capelli e legare le cintu-re ai loro fianchi. Tuttavia non compresero ciò che voleva [dire], e nemmeno a cosa Egli alludesse con ciò che aveva detto loro, in quanto intendeva con ciò [significare]: “Chi è da me nasconda la scienza (al-‘ilm) da chi non ne è degno, e tenga ben celato l’esoterico (b…¥in) a chi è assoggettato alla corpo-reità”.
Quanto alle Sue parole: “Chi è da me si cinga i fianchi”, alludeva con ciò che gli uni fossero inseparabili dagli altri perché non li trafiggesse (yan|allu) nessuno e perché non intervenisse alcuno dall’esterno, e di stare in guardia
nei confronti dell’avversario. Sai bene che la cintura è un cerchio (d…’ira) che girando si annoda127 in un punto preciso, di modo che quando il nodo si scioglie, si annulla [anche] il cerchio.128
[A proposito di] quanto il Signore il Messia ha detto: “Cingete i vostri fianchi con cinture”, [significa]: “vi rafforzerete e vi diverrà visibile la luce”.
Capitolo Decimo
Sulla conoscenza del senso esoterico del sacrificio (qurbān)
Il sacrificio costituisce una definizione di enorme [importanza] e una questione altamente significativa. Colui che per primo offrì un sacrificio fu Abele (H…b†l), poiché l’offerta, prima della manifestazione del Signore il Messia, consisteva in carne [di animali] sgozzati e lasciata sugli altari. Quin-di scendeva un fuoco che la rimuoveva [celandola] agli occhi degli astanti.129
[170] Si continuò così fino a quando si manifestò (©ahara) il Signore il Mes-sia, il Longanime (al-|al†m), il Sapiente (al-‘…lim) e il Misericorde (al-ra|†m). Quando Egli scelse di occultarsi (Ðayba)130 disse agli Apostoli: “Vi lascio in eredità (mu²allif ) un sacrificio che è la mia carne, e sarà per voi,
125 In questo passo è evidente la simbologia battesimale dei Giudeo-Cristiani. Si
fa notare che a tale frase ne segue un’altra in cui è stata omessa in traduzione l’espressione: “da un altro punta di vista”.
126 Si tratta di gradi della chiesa ortodossa orientale. 127 Ar.: ‘uqida, lett.: “unisce”. 128 A tale frase ne segue un’altra in cui è stata omessa, in traduzione, l’espressio-
ne: “da un altro punta di vista”. 129 Lett.: “dei mescolati (al-mamz™Þ†na)”. 130 Da notare l’uso del termine Ðayba in riferimento a un contesto cristiano. Vd.
anche supra, p. 21.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 235
per virtù del Padre Supremo (al-ab al-akbar), ciò che salda (la|ma) e ciò che unisce (wa¡la) <...>”. Poi in un altro passo (mawÿi‘) ha detto: “Sono la mia carne e il mio sangue, quindi osservate ciò fino a quando mi incontrerete” <...>, volendo dire: “Questo è il mio essoterico e il mio esoterico,131 dunque attenetevi a questo”. Quel che si dice del sacrificio è un ambito di enorme [importanza], e non c’è Profeta (nab† ) che non abbia avuto un sacrificio. Adamo prendeva dalle foglie del Paradiso, e non erano delle [semplici] fo-glie, ma costituivano la sua offerta (qurb…nahu).132 E con esse si muoveva alla luce (bi-n™r) dell’albero che Ibl†s aveva reso appetibile, tanto da deside-rarne i frutti (²ayrah…).
E il sacrificio di Noè era la sua arca, sulla quale egli portò di ogni cosa
una coppia. L’arca non era un legno, ma una persona ragguardevole. Alcuni sostengono: “L’arca era un legno”, e ne adducono come pretesto quanto dis-se il Nome:133 “‘Al† è l’arca di Noè,134 chi vi sale sopra si salva, chi resta in-dietro perisce”. Altri invece dissero: “L’arca è Salsal,135 e di ogni cosa portò una coppia: gli orfani (al-ayt…m), i sovrintendenti (nuqab…’), gli eminenti (nuÞab…’), i contraddistinti (mu²ta¡¡†na), i devoti (mu²li¡†na) e i saggiati
(mumta|an†na), vale a dire coloro che occupano dei Ranghi (a¡|…b al-
mar…tib)”. [171] Il sacrificio di Abramo fu l’ascia con cui mandò in frantumi gli idoli;136 non era ferro, ma [era] una persona ragguardevole, ed era Ismaele.
Il sacrificio di Mosè fu l’acqua di Madyan sopra la quale trovò una folla (umma) di gente,137 [secondo] quel che dice Dio Altissimo: “E quando scese alle fonti di Madyan vi trovò una folla di gente che colà abbeverava [le greggi], e trovò, oltre ad essa, due donne che invece ne tenevano lontane le
loro. Chiese: “Che vi accade?”. Risposero: “Non abbeveriamo [le nostre greggi] finché i pastori non avran portato via le loro, perché nostro padre è un vecchio carico d’anni!”. Allora [Mosè] abbeverò il loro [gregge], poi tor-nò all’ombra e così pregò: “O Signore, certo di qualsiasi bene tu voglia
131 Lett.: “è la mia parte essoterica ed esoterica”, nel senso di “ciò che appare
all’esterno” e di “ciò che è interno”. 132 Nel testo: qurb…nuhu. 133 Da intendere Mu|ammad, che occupa l’ipostasi del “Nome” nella triade
‘alawita. Cfr. supra, p. 21, nota 105, a proposito di quanto detto sul termine m†m† nel
Capitolo Sesto. 134 È un chiaro riferimento alle tradizioni attribuite al Profeta in ambito shi‘ita, in
cui Mu|ammad identifica la gente della sua casa con l’arca di Noè. A tal proposito si veda al-‘All…ma al-MaÞlis†, Bi|…r al-Anw…r, cit., XXIII, p. 123; XXIX, p. 341; XXX, p. 40; XXXI, p. 277.
135 Da intendere Salm…n al-F…ris†, che fu soprannominato dal Profeta Mu|ammad “acqua pura che elargisce sapienza” (salsal yamna|u al-|ikma). Cfr. al-‘All…ma al-MaÞlis†, Bi|…r al-Anw…r, cit., XXII, p. 348; al-Šay² al-Muf†d, al-I²ti¡…¡, Mu’tamar al-Šay² al-Muf†d, Qumm 1413/1993, p. 341.
136 Probabile riferimento a Cor. VI,74. 137 Da intendere i Madyaniti.
Annunziata RUSSO 236
mandarmi io ho bisogno grande”.138 E l’acqua è la scienza grazie alla quale i credenti vivono.
Il sacrificio di Gesù fu quello che abbiamo summenzionato, e quanto di esso abbiam detto [parlando] dei suoi [aspetti] esoterico ed essoterico.139
Il sacrificio del Signore Mu|ammad – da lui la pace – fu [il seguente]: Il
tutto, [vale a dire] il m†m [cosmico], fu il velamento dei suoi fantasmi (ašb…|):140 F…¥ir, al-ðasan, al-ðusayn e Mu|sin. Così la comunità di ogni singolo Profeta offriva (qarraba)141 a Dio – Potente ed Eccelso – un sacrifi-cio, [consistente] in ciò che ogni Profeta vi lasciava come suo successore. Quanto a quel che il Signore il Messia dice sul sacrificio: “Questa è la mia carne, mangiatela, e questo è il mio sangue, bevetelo”,142 vuol dire: “Questa
è la mia carne, cioè aderite alla mia natura umana (n…s™t) [172] [e] pascole-rete in libertà nel mio Regno (malak™t)”. Quanto alla sua affermazione: “Questo è il mio sangue, bevetelo”, vuol dire: “Perseverate nell’obbedire alla forma visibile (al-¡™ra al-mar’†yya) [e] vivrete la vita eterna (al-|ay…t al-abadiyya)”.
Capitolo Undicesimo
Sulla conoscenza dell’altare e dell’ara sacrificale
L’ara sacrificale (ma÷ba|) è immagine dell’altare su cui era stato [posto] il sacrificio di Abele. L’altare (haykal ) era Salsal;143 quindi ogni altare è Sal-sal, e il drappo (sitr) che copre l’altare è immagine dell’esoterico (b…¥in) che [per sua natura] non può essere propagato in pubblico, e rimane [perciò] ve-lato (mast™r). Il sacrificio che si trova sull’altare è la persona che [è rappre-
sentata da] ‘Al†, mentre la gente raccoglie l’offerta. Il drappo [allo stesso tempo] è immagine di colui che attua lo svelamento (¡…|ib al-kašf ), il quale raduna la gente con una sola parola, vale a dire la conoscenza (ma‘rifa) dell’Eterno a parte ante dopo che la gente è stata in discordia tra loro. Così il sapiente (|ak†m) è Dio l’Altissimo (‘al† ) e il Magnifico (‘a©†m).
Capitolo Dodicesimo
Sulla conoscenza del senso esoterico delle lucerne e delle lampade
Quanto alle lampade, esse [rappresentano] la luce (n™r) che si manifesta col Mahd†,144 [e detta luce] è la luce dell’Uno (a|ad†) – [173] esaltata sia la
138 Cor. XXVIII,23-24. 139 Cfr. supra, in questo stesso capitolo. 140 Per il significato in ambito ‘alawita, cfr. supra, p. 15, nota 61. 141 Nel testo: taqtaribu. 142 Queste parole sono una chiara rielaborazione di Mt 26,26-29; Mc 14,22-25;
Lc 22,19-20. 143 Per l’identificazione di Salsal, cfr. infra. 144 Col termine al-Mahd† (“il ben guidato”) si intende l’ultimo im…m della linea
di discendenza duodecimana che, uscito dallo stato di occultamento in cui è entrato nell’ 873, ritornerà alla fine dei tempi per riportare pace e giustizia nel mondo.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 237
Sua menzione. Il Signore il Messia ha detto: “Illuminate le dimore della vo-stra preghiera, [e] i vostri cuori vivranno a lungo”. I cristiani (na¡…r…) hanno acceso le lampade in casa senza conoscere il senso celato di quan-to il Signore il Messia aveva detto. Egli, infatti, [con quanto sopra,] intende-va [dire]: “Ubbidite a coloro che occupano gli stadi (maq…m…t) di luce che
sono dimore di preghiera, [e] con la loro sapienza i vostri cuori verranno il-luminati”.
Capitolo Tredicesimo
Sulla conoscenza del senso esoterico del battesimo (ma‘mūdiyya)
Il battesimo145 è immagine della vita eterna (al-|ay…t al-d…’ima); è la co-
noscenza (ma‘rifa) del credente e la sua ascesi (irtiq…’) fino alla purificazio-ne, poiché egli, una volta purificato, non muore mai. Quanto al battesimo, [esso] è [quindi] la conoscenza dell’esoterico, in virtù del quale ogni cosa vive. Il Signore il Messia, quando si manifestò nascendo e prese come velo (i|taÞaba) la madre della luce, fece sapere a Giovanni il Battista che c’è un esoterico per l’essoterico di chi conosce [quell’] essoterico, e che questo146 è
immagine della Sua scienza (‘ilm) che, quando è conosciuta da qualcuno, lo farà vivere di vita eterna (al-abadiyya). Egli ha fatto dell’olio un’immagine dello Spirito di Santità grazie al quale le luci han ricevuto lucore. Non sai forse che [quando] l’Altissimo dice: “Dio è la Luce dei cieli e della terra, e si rassomiglia la Sua Luce [174] a una Nicchia, in cui è una Lampada, e la Lampada è in un Cristallo, e il Cristallo è come una Stella lucente, e arde la
Lampada dell’olio di un albero benedetto, un Olivo né orientale né occiden-tale, il cui olio per poco non brilla anche se non lo tocchi fuoco. È Luce su Luce; e Iddio guida alla Sua Luce chi Egli vuole, e Dio narra parabole agli uomini, e Dio è su tutte le cose sapiente”,147 il Santo (qudus) è Mu|ammad, mentre è Salsal148 lo Spirito che è espressione del Santo?
Si racconta che quando si manifestò nascendo,149 si schiuse una porta nel cielo da cui scese una mano [che si protrasse] fin tanto che si avvicinò al Si-
gnore il Messia e fece apparire di Sé ciò che manifestò, dicendo agli Aposto-li: “Battezzate i vostri cuori, raggiungerete150 la vita eterna (al-|ay…t al-
abadiyya)”.
145 Y. Friedman, The Nu¡ayr† - ‘Alaw†s, cit., p. 227, afferma che il battesimo
simbolizza l’iniziazione in conoscenze esoteriche; secondo lui, la crocifissione aveva lo scopo di mettere alla prova i credenti, allo stesso modo dell’illusione del martirio di al-ðusayn. Tuttavia – se la mia lettura non è errata – questa notizia non sembra essere riportata nel testo. Cfr. Silsilat al-tur…Å, cit., II, pp. 288, 300
146 Scil., esoterico. 147 Cor. XXIV,35. 148 Per tale identificazione, cfr. supra, pp. 8, 21. 149 Scil., il Messia. 150 Manca la particella che introduce la proposizione finale.
Annunziata RUSSO 238
Capitolo Quattordicesimo
Sulla conoscenza della forma e della chiesa
La forma che ha luogo nella chiesa è immagine di ciò per cui si manifestò il Signore il Messia. Quanto all’immagine del supremo, [essa è rappresentata
dal] Suo manifestarsi nelle regioni.151 La chiesa [a sua volta] è immagine del-la Porta,152 che è la sostanza (m…dda) di ogni cosa, ed è [175] ciò che soccor-re i credenti con le scienze esoteriche provenienti dal nostro Signore il Mes-sia,153 da Lui pace e misericordia (ra|ma).
Capitolo Quindicesimo
Sulla conoscenza del turibolo e dell’incenso
Il turibolo ha un [significato] esoterico, notevole e degno di considera-zione, mentre il suo aspetto essoterico è apprezzabile, ciò per il fatto che quando il Signore il Messia si manifestò per il tramite della madre della luce, Gabriele se ne stava ogni sera ritto con in mano un incensiere fatto di perle bianche, con catenelle di rubino rosso, contenente un fuoco [alimentato] dal-la luce di Santità e incensi provenienti dal giardino del Paradiso (Þannat al-
firdaws). Con esso incensava la madre della luce, la Signora, la Santa; nell’atto di manifestarSi, il Signore il Messia disse agli Apostoli: “Fate esa-lare aromi nei templi dei sacrifici e accompagnate la luce con gli incensi”. [Quindi] il turibolo è immagine della Signora Maria, mentre la Porta154 che vi è contenuta è similitudine della luce che si manifestò per mezzo di Lei. L’incenso e il turibolo sono immagine della fragranza che il Signore il Mes-
sia rese manifesta [con] quanto rivelò [riguardo] alla conoscenza del Suo si-gnificato, esaltata sia la Sua menzione.
[176] Capitolo Sedicesimo
Sulla conoscenza del [significato] esoterico delle feste
Le feste hanno un senso esoterico nobile e una scienza sottile.155 Sono: l’Ascensione (sull…q), l’Epifania (Ði¥¥…s /Ði¥…s), al-Qal†la,156 le feste di Ga-
briele e di Michele, la festa della crocifissione (¡alab™t), desiderio (ma’rab)157 di Maria, la festa del giorno del riq…‘,158 la festa delle Palme
151 Il contesto si riferisce alla diffusione della Chiesa mediante gli apostoli nelle
varie parti del mondo. 152 Scil., Salsal o, in alternativa, l’arcangelo Gabriele o lo Spirito di Santità. 153 Per il ruolo di iniziatore alle scienze da parte di Salsal in quanto identificato
con lo Spirito di Santità, cfr. Commento, p. 40. 154 Si riferisce allo Spirito, Salsal. 155 Sulle feste cristiane, cfr. anche Y. Friedman, The Nu¡ayr† - ‘Alaw†s, cit., p.
162. 156 Scil., ‘Illiya: Eucarestia o ultima Cena. 157 Fino ad oggi, non mi è stato possibile trovare una traduzione adeguata del
termine in questione. 158 E.n.t., da leggere rif…’, cioè “mercoledì delle Ceneri”.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 239
(ša‘…n†n), la festa del m…r™m,159 il Fuoco Nuovo160 e la Pasqua (Fi¡|). Queste dodici grandi feste sono comprese tra le feste dei martiri; se ne fornisce noti-zia nel loro aspetto esoterico: “Sappi, Iddio abbia di te pietà, che il Signore il Messia ha avuto degli occultamenti (Ðayb…t)161 di luce rispetto all’essoterico delle sue apparizioni (ašb…|),162 mentre il Suo esoterico [lo ha mostrato] ele-vandosi al Regno dei Cieli (malak™t) e col Suo far ritorno alla luce della Di-vinità (l…h™t). In ogni manifestazione appariva dopo essere stato occultato sotto forma di uno degli apostoli; quindi [Dio] lo occultava e lo velava fa-cendo di ogni manifestazione un giorno solenne, e tale giorno veniva chia-mato ‘festa’ (‘†d ). [Quindi] il significato di ‘†d' è il ‘ritorno’ (‘awda)163 del Signore il Messia dopo essersi svelato (kašf )’, poiché ciascuna di queste fe-
ste sta a significare una manifestazione del Signore il Messia”.
[177] Capitolo Diciassettesimo
Sulla conoscenza del [significato] esoterico della Domenica
Dio ha fatto esprimere alla tua lingua la Sua unicità (taw|†d ), e ha illumi-
nato il tuo cuore (Þan…n) con la Sua scienza (‘ilm): la Domenica è immagine
di Adamo. Essa è il giorno in cui il Messia si mostrò (bad…) ed è il giorno
della perpetuità164 (daw…m). Egli165 è colui che è soggetto ai ritorni periodici
(karr…t), ed è a Lui riferibile il significato degli indizi. Nessun luogo è privo
di Lui, ed [Egli] è come il sole166 che si congiunge con ogni cosa e con il
quale nulla si congiunge, giacché semmai si congiungesse con Lui qualcosa,
lo brucerebbe con il fuoco della sua luce. Il significato di “si congiunge con
ogni cosa” è il suo167 dar calore ad ogni cosa, ma senza che il suo corpo
(Þurmahu) lo tocchi.168 La Domenica è un’immagine del porre in esistenza
(†Þ…d) da parte del Suo Significato, ed Egli169 è Uno (a|ad ) e non primo
(w…|id); il primo, infatti, è il Signore il Messia fatto scaturire (unbi‘a) dalla
Potenza e corroborato (uyyida) di Sapienza (|ikma). È il Verbo compiuto
159 Dovrebbe corrispondere alla santificazione del crisma (mayr™n), uno dei riti
della settimana santa. 160 Direttamente collegato con celebrazione della settimana santa, cioè del cero
santo che si accende durante la liturgia del sabato santo. La traduzione alternativa sarebbe il Nawr™z.
161 Per il termine, cfr. supra, p. 21, nota 99. 162 Per il significato del termine in questione, cfr. supra, nota 61. 163 Qui l’autore opera un’interpretazione di tipo filologico, riferendosi alla radice
*‘wd. Cfr. anche Y. Friedman, The Nu¡ayr† - ‘Alaw†s, cit., p. 173, in cui viene fornita una spiegazione sommaria del termine ‘†d.
164 Per l’“Adamo perpetuo”, cfr. supra, p. 14. 165 Scil., il Messia. 166 Per la metafora del sole, cfr. supra, pp. 18, 21. 167 Scil., il sole. 168 La frase che segue è introdotta dall’espressione “un altro punto di vista”,
omessa in traduzione come di consueto. 169 Scil., il Significato.
Annunziata RUSSO 240
(al-kalima al-t…mma), lo Spirito Santo (al-r™| al-qudsiyya); la Parola Eterna
a parte ante (al-kalima al-azaliyya) che [Dio] affidò alla madre della luce, e
allorquando si manifestò alla gente stando in mezzo ad essi, ordinò loro di
magnificare la luce che in Lui [si era manifestata] loro, di costruire (‘im…ra)
la chiesa, di abbellirla,170 di illuminarla e di celebrarvi Messa (taqd†s) nella
ricorrenza del giorno di una Sua manifestazione (©uh™r). Chi ha conoscenza
(‘arifa) del suo171 esoterico diviene santo alla stessa stregua di Adamo, Noè,
Abramo, Mosè, il Messia e Mu|ammad, [178] mentre chi non ne ha preso
conoscenza resta un [puro e semplice] essere umano (…damiyyan faqa¥).
Capitolo diciottesimo
Sulla conoscenza dei martiri,
[e del] perché furono chiamati con questo nome
Sono stati chiamati šuhad…’ (“martiri”) perché hanno reso testimonianza (š…had™) al Signore il Messia, ché Egli è Colui che li corrobora (mu’ayyid ), tratto (muštaqq) dalla luce somma (al-n™r al-a‘©am).172 Lo hanno visto (š…had™hu) nello spirito (al-r™|…n†) e Lo hanno riconosciuto (aqarr™); Egli si
manifestò loro assumendo un corpo umano (f†’l-bašariyya), non lo rinnega-rono e pertanto meritarono tale nome.173 Il Signore, la m†m,174 a Lui la sot-tomissione (tasl†m), attestò loro il Suo ritorno periodico (karra), mostrò la Sua Potenza ed essi attestarono la Verità (ðaqq). Essi furono martirizzati e uccisi, e tuttavia l’uccisione non li sfiorò, al contrario essa ha luogo nei loro avversari (aÿd…d ) mentre essi ne sono ben al di là, perché così dice l’Altissimo: “E non chiamare morti coloro che son stati uccisi sulla via di Dio, anzi, vivi sono, nutriti di grazia presso il Signore!”.175 Verace è Iddio, l’Altissimo e il Glorioso.
Con l’aiuto e l’assistenza dell’Altissimo termina qui l’Epistola sul Mes-
sia, ricopiata per mano del sayyid Mu|ammad ‘A¥iyya [originario] di ¦ar¥™s, che riferisce di averla riportata per mano dello šay² ‘‡sà ‘Al† ‘Isà a Šab¥a, ed è lo scritto di chi ha bisogno del perdono di Dio e della preghiera dei suoi fratelli credenti, Ša‘ban ‘Al† Ša‘ban, ‘Al† ø…li| ðasan e A|mad Mu|ammad Mah™b, mercoledì 28 mu|arram del 1410 dell’egira, corrispondente al 30 agosto del 1989, che Iddio porti giovamento a noi e ai credenti.
170 Da riferire al “costruire”. 171 Da riferire alla Chiesa. 172 Seguono ora tre opzioni, tutte introdotte dall’espressione: “Da un altro punto
di vista”, che è stata come si consueto omessa in traduzione. 173 Secondo Y. Friedman, The Nu¡ayr† - ‘Alaw†s, cit., pp. 148-149, il significato
di šuhad…’ è qui da ricondurre alla prospettiva docetista. 174 Per cui cfr. supra, p. 21, nota 105. 175 Cor. III,169.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 241
Commento
Incongruenze
Come si può dedurre dal sunto sopra riportato, la struttura del testo
non presenta incongruenze. Per spianare le asperità dovute alla diffi-
coltà di interpretazione delle dottrine criptiche e dei dati qui riportati
ho cercato, per quanto possibile, di chiarire il testo nelle note. Rimane,
purtroppo, tuttora l’impossibilità di collocare storicamente e/o concet-
tualmente alcuni dei luoghi citati nell’Epistola, e anche di trovare la
corretta traduzione e/o identificazione di alcuni nomi. Desidero comunque procedere ad alcune considerazioni generali sul
testo, alla luce degli studi sulle dottrine ‘alawite da me svolti sinora.
Fonti
Da quanto risulta dalla traduzione, mi pare non si possa escludere un’influenza di testi appartenenti al contesto giudeo-cristiano quale il
corpus delle Pseudo-Clementine.
Di certo l’autore conosce i vangeli sinottici, dal momento che li cita anche se talvolta in maniera non del tutto esatta, e soprattutto recepen-
doli in un’ottica propriamente shi‘ita-ba¥inita. Sono presenti suggestio-ni provenienti dalla letteratura shi‘ita isma‘ilita176 e duodecimana.177
Da sottolineare anche la totale differenza tra le tesi del Nestorio storico178 e di quello citato nell’Epistola, riproposto in una luce com-
pletamente gnostica.
Sinergie
Quanto alle sinergie individuabili all’interno del testo, utili a darci possibili piste adatte a contestualizzare l’Epistola sul Messia, si pos-
sono rilevare possibili relazioni sia tra ‘alawiti ed isma‘iliti, che tra ‘alawiti e shi‘iti duodecimani, non senza escludere elementi propri di
giudeo-cristianesimo, rintracciabili qua e là nel testo. La prima suggestione trova una probabile conferma in quanto viene
detto a proposito della croce, il cui simbolo è spiegato attraverso un parallelo con le quattro parti che compongono la šah…da.179 Lo stesso
paradigma appare rintracciabile anche in ambito isma‘ilita,180 analo-
176 Su cui cfr. infra, pp. 33-34. 177 Su cui cfr. infra, pp. 34-35. 178 Si intende il Nestorio del Bazar d’Heracleide. 179 Cfr. il Capitolo Secondo dell’Epistola. 180 Esso si ritrova infatti nell’opera Kit…b al-yan…b†‘ [Libro delle fonti] di Ab™
Ya‘q™b al-SiÞist…n† (IV/X sec.), in cui viene trattato il rapporto esistente tra la croce e l’attestazione di fede, come si evince anche dal disegno riportato nell’edizione di
Annunziata RUSSO 242
gamente a quanto accade per la differenziazione tra il nome ‘‡sà e Mas†|, considerato il primo come il nome della dimensione corporea
(n…s™t), e il secondo della dimensione divina (l…h™t) del Messia.181 Su questo punto, sembra ci sia una somiglianza negli ambiti ‘alawita ed
isma‘ilita, anche se le rispettive trattazioni seguono vie diverse.182 In-fine vi è l’uso di i²tir…‘, che sembra implicare una relazione con
l’ibd…‘ di isma‘ilita memoria.183 Quanto, invece, al rapporto tra ‘alawiti e shi‘iti duodecimani, tra i
punti in comune c’è il nome Salsal dato a Salm…n al-F…ris†,184 e i vari riferimenti all’im…m ‘Al† e alla famiglia del profeta Mu|ammad.185
Inoltre non è da dimenticare il continuo ricorso ai numeri quattro, otto e dodici. Personalmente, ritengo che questo fatto rispecchi la situazio-
ne politica in cui agiva la propaganda ‘alawita. In particolare, il quat-tro indica il numero della gerarchia della chiesa bizantina con cui si
era costretti ad essere in relazione.186 Quanto al numero otto, esso indicherebbe che ci troviamo in
presenza di shi‘iti che vanno oltre il numero sette proprio della ism…‘†liyya e della w…qifa,187 e che hanno dunque optato per la posi-
zione della qa¥‘iyya, la quale “si impegnò” (qa¥a‘at ‘alà) a riconoscere l’ottavo im…m ‘Al† al-Riÿ… (m. 818) quale successore del padre M™sà
Henri Corbin. Qui è inoltre trattato il rapporto tra le estremità e gli angoli della croce e le sette lettere che compongono l’attestazione di fede, il tutto reso attraverso il confronto con i ranghi previsti dalla gerarchia fatimide. Cfr. H. Corbin, Trilogie ismaelienne, Teheran 1961, pp. 75-76, 100-102.
181 Cfr. il Capitolo Quarto dell’Epistola. 182 Per un approfondimento su tale differenziazione in ambito isma‘ilita, in cui è
chiaramente detto che fu crocifisso il nome della forma fisica ‘‡sà e non la “forma spirituale” Mas†|, si veda A. Straface, “An Ism…‘†l† interpretation of šubbiha lahum (Qur. IV, 157) in the Kit…b šaÞarat al-yaq†n”, in B. Michalak-Pikulska - A. Pikulski eds., Authority, privacy and public order in Islam, Proceedings of the 22nd Congress of L’Union Européenne des Arabisants et Islamisants (Orientalia Lovaniensia
Analecta, 148), Uitgeverij Peeters en Departement Oosterse Studies, Leuven - Paris - Dudley Ma, 2006, pp. 95-100.
183 Vedi infra, p. 42. Sappiamo, infatti, che il termine ibd…‘, pur rintracciabile in altri contesti, ad esempio filosofici, gioca un ruolo importante nell’ismailismo.
184 Su cui cfr. supra nel testo, p. 27, nota 135. 185 Su cui cfr. supra nel testo, p. 27, nota 134. 186 Vd. il Capitolo Nono dell’Epistola. 187 Con questo nome si indicano quei gruppi che arrestavano al settimo im…m,
M™sà al-K…©im, la linea di discendenza e sostenevano che fosse il Resurrettore e che dopo di lui non ci sarebbero stati altri im…m. Cfr. Sa‘ad b. ‘Abd All…h al-Aš‘ar† al-Qumm†, Kit…b al-maq…l…t wa’l-firaq, Ma¥ba‘at ðaydar†, ¦ahr…n 1963, p. 90, nota 5.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 243
al-K…©im (m. 799), settimo nella linea di discendenza della shi‘a duo-decimana.188
Il numero dodici indicherebbe infine che ci troviamo in un contesto di shi‘a duodecimana, il che appare confermato dal ricorso al numero
tredici, che pure incontriamo nel testo,189 per il quale è evidente che si tratta del numero che si identifica con il saf†r, vale a dire il luogote-
nente che agiva in vece dell’im…m nascosto in seguito al suo occulta-mento, e dodicesimo in linea di successione. Identificato con diverse
personalità,190 tale ruolo interessò gli ‘alawiti dal momento che Mu|ammad b. Nu¡ayr fu uno dei tanti a rivendicare questo titolo.191
Inoltre, come si evince dall’opera in questione, tale dottrina richiama proprio il tema dell’occultamento del Messia/im…m che, in quanto
luogotenente, rappresenta il tredicesimo polo, vale a dire la metafora del Messia/Porta.
Infine, di fondamentale importanza è il concetto della metemfotosi (tan…su²),192 in cui la luce profetica/imamitica sotto forma di spirito di
santità trasla da profeta a profeta, quindi da profeta a im…m e da im…m a im…m. A tal proposito vorrei far notare che l’autore usa l’espressione
“Adamo perpetuo” (ţdam al-daww…m) attribuito al Messia,193 ag-giungendo che la domenica indica il ritorno del Messia.194 Ora, tenen-
do conto che siamo in ambienti ba¥initi provenienti dal ‘Ir…q e stanzia-tisi nella Siria del Nord, è molto probabile che essi abbiano subìto
suggestioni, anche se dopo secoli, dei sabei delle paludi dalle zone da cui costoro provenivano. Si tratta di ßunbul…, piccolo centro posto tra
W…si¥ e K™fa, oltre che della Celisiria, donde provenivano emissari di Elchasai, figura che affermava il ritorno dello spirito nei diversi profe-
ti.195 Tale concetto si ritroverà più tardi nel corpus delle Pseudo-
188 Ibid., p. 89. 189 Vd. supra, p. 16. 190 Con il termine saf†r si suole indicare un rappresentante dell’im…m nascosto
durante l’occultamento minore (al-Ðayba al-¡uÐrà) (874-941). Durante questo perio-do infatti ci furono quattro personalità che esercitarono il ruolo di mediatori tra l’im…m occultato e i credenti. Tra quelli che si contendevano tale ruolo pare ci sia stato anche Mu|ammad b. Nu¡ayr, eponimo dei nu¡ayriti/‘alawiti. A tal proposito vd. A. Russo, “Denominazione e origini della corrente ‘alawita”, in Un testo
sapienziale ‘alawita, cit., pp. 19-20. 191 Cfr. supra, nota 190. 192 Su cui cfr. supra, p. 140. 193 Vd. il Capitolo Primo dell’Epistola. 194 Vd. ibid. 195 Per ulteriori approfondimenti, si veda L. Cirillo, Elchasai e gli elchasaiti. Un
contributo alla storia delle comunità giudeo-cristiane, Marra Editore, Cosenza 1984;
Annunziata RUSSO 244
Clementine con la dottrina del Verus Propheta, vale a dire il profeta che è il solo a detenere la verità. Egli è l’Adamo che attraversa le varie
epoche, prendendo nomi e forme diversi fino ad apparire con Gesù, in cui trova il riposo definitivo.196 Questo tipo di profetologia è entrato
nella shi‘a facendo del verus propheta o propheta aeternus il Messia omologo dell’Im…m, il Christus aeternus che arriva ad essere imper-
sonato dallo stesso Mu|ammad, sigillo dei profeti197 - e quindi, ag-giungerei, anche dallo stesso Messia dell’Epistola qui trattata.
Analisi di alcuni temi rilevanti
I temi trattati nell’Epistola sono molteplici, ma alcuni, cui l’autore
attribuisce particolare importanza, sono ripresi più volte nei vari capi-
toli. Desidero, fra questi, evidenziare i seguenti:
a) lo Spirito di Santità (r™| al-quds) che trasla;
b) l’eternità a parte post originata dalla luce dell’essenza
dell’eternità a parte ante;
c) la gnosi acquisita dal credente.
a) Lo Spirito di Santità (r™| al-quds) che trasla
Quanto al primo punto, troviamo detto in diversi passaggi dell’Epi-
stola che lo Spirito di Santità è Salsal, vale a dire Salm…n al-F…ris†198
che, come tale, si identifica anche con Giovanni il Battista, l’arcangelo
Gabriele199 e Adamo.200
R. Conte, Presenza giudaico-cristiana nell’Isl…m, 2 voll., Orientalia Parthenopea Edizoni, Napoli 2013.
196 Cfr. P. Geoltrain - J.-D. Kaestli (éds.), Écrits apocryphes chrétiens, II, Galli-mard, Paris 2005, pp. 1184-1185.
197 Sul Messia/Im…m, cfr. H. Corbin, Il paradosso del monoteismo, Marietti, Casale Monferrato 1986, pp. 39-40. Il tema del Verus Propheta in ambito ‘alawita resta ancora oggi di difficile soluzione, e sarà argomento di studio futuro.
198 Salm…n Pak, meglio noto come Salm…n al-F…ris†, è uno dei compagni della prima ora del profeta Mu|ammad. Per ulteriori ragguagli su tale figura, cfr. H.A.R. Gibb - J.H. Kramers, Shorter encyclopaedia of Islam, Brill, Leiden 1953, pp. 500-501, s.v.
199 L’arcangelo Gabriele è ritenuto la “porta” del primo ciclo di manifestazione dell’essenza divina. Ciò è confermato da quanto riporta al-³a¡†b† nella sua opera al-
Ris…la al-Rastb…šiyya, p. 164, l. 5, che, a proposito del tempo in cui la “porta” si occulta, dice che, dopo Mu|ammad b. Nu¡ayr, essa tornerà a manifestarsi col suo primo nome e con la prima persona con cui si è manifestata, vale a dire con l’arcangelo Gabriele (wa-i÷… ©ahara ©ahara bi’l-ša²¡ al-awwal wa’l-ism al-awwal
wa-huwa ßibr…’†l ). Ciò è confermato anche in un altro manoscritto ‘alawita del XIV secolo, ascritto ad Ibr…h†m al-¦™s†, al-Qa¡†da al-‘ayniyya, che a p. 13, ll. 11-12 dice, a proposito della cupola in cui si manifestarono Adamo e i suoi figli Caino e Abele,
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 245
Per chiarire questo concetto è utile rifarci a quanto sostiene al-
³a¡†b†, maestro di al-ßill†, che nella Ris…la al-Rastbašiyya [Epistola di
Rastbaš], dopo aver spiegato il ruolo svolto dal Significato, dal Nome
e dalla Porta nella triade ‘alawita, afferma che Salsal è Salm…n.201 Ma prima di procedere è necessario spiegare, per sommi capi, in
cosa consista la triade ‘alawita in cui Salm…n/Salsal ha un ruolo fon-
damentale. Costituita dalle tre ipostasi del Significato (ma‘nà), il Nome (ism) e
la Porta (b…b), tale triade vede nel Significato una manifestazione
dell’essenza divina attraverso sette epifanie, mentre il Nome è l’ipo-stasi identificabile col Profeta, vale a dire colui che assolve al compito
di comunicare agli uomini la Rivelazione. La Porta è, infine, il mes-saggero che trasmette al Nome la Rivelazione divina e quindi, per me-
tonimia, essa stessa impersona la Rivelazione.202 Ora, stando a quanto afferma al-³a¡†b†:
I nomi delle sette [epifanie] del Significato nella [Sua] essenza
non toccano né il Nome né la Porta, ed esse sono nella realtà Abele, Seth, Giuseppe, Giosuè, ţ¡if, Simeone e il principe delle api,203 e [si identificano con] Colui che dà il nome agli altri nomi, mentre i nomi sono il Nome, come [il Nome] è anche il luogo [in cui si ma-nifestano] le qualità e gli attributi [del Significato], così come la Porta è il luogo dei nomi di Mu|ammad,204 delle sue qualità e dei suoi attributi, poiché Mu|ammad non è compreso da alcuno del suo creato, né [alcuno] lo limita, né conosce la sua essenza tranne il suo Creatore, l’Eterno a parte ante, l’Eterno a parte post, l’innovatore del Nome, della Porta e di altro da loro.205
che la porta di quella cupola e di ogni manifestazione nelle altre cupole è stato ed è l’arcangelo Gabriele, il quale partecipa dello stesso spirito del Nome Adamo (wa-
ţdam k…na’l-ism wa’l-r™| t…bi‘ ka÷…’l-b…b ßibr…’†l f† kulli ma©harin). 200 Per tali accostamenti, si rimanda a quanto segue. Cfr. infra. 201 Al-³a¡†b†, al-Ris…la al-Rastbašiyya, p. 166, l. 4: wa-Salsal fa-huwa Salm…n. 202 Per ulteriori ragguagli, cfr. A. Russo, “Insegnamenti ermetici e dottrine
‘alawite”, cit., pp. 357-358. 203 Epiteto dell’im…m ‘Al†. 204 Vale a dire, “del nome”. 205 Al-³a¡†b†, al-Ris…la al-Rastbašiyya, p. 160, ll. 1-9: asm…’ sab‘a li’l-ma‘nà
bi’l-÷…ti lam taqa‘ ‘alà Ðayrihi min ism wa-l… b…b wa-hiya bi’l-|aq†qa H…b†l wa-Š†t wa-Y™suf wa-Y™ša‘ wa-ţ¡if wa-Šam‘™m wa-Am†r al-na|l wa-huwa al-musamm† li-
Þam†‘ al-asm…’ wa’l-asm…’ hiya al-ism wa-ka÷…lika huwa mawÿi‘ al-¡if…t wa’l-nu‘™t wa-ka÷…lika al-b…b mawÿi‘ asm…’i Mu|ammadin wa-¡ifatihi wa-nu‘™tihi li’anna
Mu|ammadan l… yudrikuhu a|ad min ²alqihi wa-l… ya|udduhu wa-l… ya‘rifu
kunhahu Ðayr b…r†hi’l-azal al-qad†m al-mu|diti li’l-ismi wa’l-b…b wa-min d™nihim….
Annunziata RUSSO 246
Quindi, a proposito di queste manifestazioni dell’essenza divina nel Significato, Nome e Porta, al-³a¡†b† aggiunge:
E [in] queste sette tappe che abbiamo menzionato poc’anzi e la
cui proprietà abbiamo spiegato, [Iddio] è esistito attraverso l’essen-za e non in una forma o in una persona che il Significato [abbia] cancellato, apparendo similmente a quella forma, analogamente [a come] ha cancellato le forme nelle tappe della profezia e della mis-sione, ed esse sono i settanta nomi, [vale a dire] i nomi del Nome da Adamo fino al Signore (sayyid ) Mu|ammad nella profezia e nelle tappe dell’imamato fino al Mahd†, poi nelle undici tappe della Por-
ta; ciò [avvenne] perché, quando il Significato, eterno a parte ante ed eterno a parte post, ha conferito dignità al Nome mostrandosi come la forma di quello, il Nome ha onorato la Porta mostrandosi attraverso di essa.206
Dato che al-³a¡†b† cita il nome di Mu|ammad e di ‘‡sà tra i nomi del Nome, ne deriva che il Profeta ha onorato la Porta mostrandosi at-
traverso Salm…n/Rivelazione, uno dei nomi delle tappe della porta (maq…m…t al-b…biyya).207 In tal senso, il Nome partecipa dell’essenza
dello Spirito di Santità che si manifesta in Salm…n. Ciò è comprensibi-le se interpretato secondo una lettura neoplatonizzante, in cui la se-
conda e la terza ipostasi rappresentano i luoghi in cui sono contenuti nomi, attributi e qualità della ipostasi ogni volta immediatamente pre-
cedente, grazie a un processo di emanazione, in cui l’eternità a parte
post è originata dalla luce dell’essenza dell’eternità a parte ante. In tal
modo lo Spirito di Santità, in origine identificato nell’arcangelo Ga-briele,208 essendo unito all’essenza divina, diviene il luogo in cui si
manifesta l’eternità a parte post del Nome/Profeta, destinatario della Rivelazione/Porta. È, infatti, lo stesso al-ßill† che, parlando nella
Ris…lat al-bay…n della luce originata dall’essenza dell’eternità a parte
ante, riporta:
206 Cioè, attraverso la Rivelazione/Porta. Cfr. al-³a¡†b†, al-Ris…la al-Rastbašiyya,
pp. 161, l. 10-162, l. 3: wa-h…÷ihi al-sab‘ maq…m…t allat† qaddamn… ÷ikrah… wa-
šara|n… na‘tah… q…ma f†h… bi’l-÷…t l… bi-¡™ra wa-l… bi-ša²¡ az…lahu al-ma‘nà wa-
©ahara bi-miÅli ¡™ratihi kam… az…la al-¡uwar f† maq…m…t al-nubuwwa wa’l-ris…la wa-hiya al-sab‘™na isman asm…’ al-ism min ţdam ilà al-sayyid Mu|ammad f†’l-
nubuwwa wa-f† maq…m…t al-im…ma ilà’l-Mahd†, Åumma al-a|ad ‘ašr maq…m…t al-
b…biyya wa-÷…lika lamm… šarrafa al-ma‘nà al-azal al-qad†m al-isma bi’l-©uh™r bi-miÅli ¡™ratihi šarrafa al-ism al-b…ba bi’l-©uh™r bihi.
207 Al-³a¡†b†, al-Ris…la al-Rastbašiyya, p. 163. 208 Cfr. nota 152.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 247
E se dici: “Questa luce originata chi è?” [risponderai] che è il Si-gnore (sayyid ) Mu|ammad – da lui la pace – perché [egli] è il Suo209 luogo se Si rivela, è la Sua casa a cui si aspira, il nome con cui Lo si invoca, la Sua sapienza in cui ci si cerca rifugio, la lingua Sua che parla’.210
Come si deduce dal passo, il Messia come Mu|ammad è la lingua che esprime la Parola di Dio, o meglio la Parola che è Dio e che si
identifica nello Spirito Santo che, a sua volta, è la Porta, vale a dire Salm…n e l’arcangelo Gabriele, entrambi messaggeri del Significato
che resta nascosto.211 È per tale motivo che lo Spirito di Santità è detto illimitato, non
percepito coi sensi e incompreso (Ðayr madr™ka)212 a differenza della forma che il Messia/Profeta assume per farsi riconoscere dagli esseri
umani, la quale risulta essere limitata, percepita coi sensi e compresa (madr™ka).
Lo Spirito di Santità, quindi, esiste col manifestarsi delle for-me,213 e ha ispirato l’evangelista Giovanni a proposito dell’Emanuele
(‘Imm…n™’†l), volutamente tradotto “il nostro Dio”, dal momento che il Significato occultato trova espressione nella persona del Mes-
sia/Profeta e nel nome della Porta Gabriele/Spirito di Santità.214 In quanto luogo dei nomi e delle qualità del Significato, il Messia è
Profeta, e pertanto in possesso dello spirito santo (al-r™| al-qudsiyya) proprio della Rivelazione; in quanto eternità a parte post, è la parola
209 Scil., del Significato, e quindi dell’essenza divina. 210 Al-ßill†, Ris…lat al-bay…n, contenuta in una raccolta di opere di al-ßill†, p. 3,
ll. 6-7, manoscritto inedito: fa-in qulta: h…÷… al-n™r al-mu²tara‘ man huwa? Fa-÷…lika
al-sayyid Mu|ammad – minhu al-sal…m – li-annahu mak…nuhu i÷… taÞallà, wa-
baytuhu alla÷† ilayhi yus‘à, wa-ismuhu alla÷† bihi yud‘à, wa-|ikmatuhu allat† ilayh… yulÞa’u, wa-lis…nuhu al-n…¥iq.
211 Al-³a¡†b†, al-Ris…la al-Rastbašiyya, p. 164, ll. 2-6, tra i nomi della porta cita Salm…n, fino ad arrivare a Mu|ammad b. Nu¡ayr. Quindi riprende dicendo: “E ciò perché l’ultima tappa del nome fu Mu|ammad b. Nu¡ayr. E la Porta si occultò nel tempo in cui si manifestò il Nome in Mu|ammad b. Nu¡ayr mentre era occultato il Significato. E quando si manifestò lo fece nella prima persona e nel primo nome, vale a dire in Gabriele, il quale si manifesta con il manifestarsi dello svelamento e con il ritorno alla chiamata” (wa-÷…lika anna …²ir maq…m…t al-ism Mu|ammad b.
Nu¡ayr. Wa-Ð…ba al-b…b f† waqt ©uh™r al-ism bi-Mu|ammad b. Nu¡ayr bi-Ðaybati al-ma‘nà. Wa-i÷… ©ahara ©ahara bi’l-ša²¡ al-awwal wa’l-ism al-awwal wa-huwa
ßibr…’†l ya©huru bi-©uh™r al-kašf wa-ruÞ™‘ al-da‘wa). 212 Vd. l’Introduzione dell’Epistola. 213 Ibid. 214 Vd. il Capitolo Primo dell’Epistola.
Annunziata RUSSO 248
eterna a parte ante affidata da Dio alla madre della luce.215 Soggetto a ritorni periodici (karr…t), il Messia si identifica con il vero Profeta,
l’Adamo perpetuo,216 fatto di luce,217 quella stessa luce dell’eternità a
parte ante dalla cui essenza è stato originato, e che coincide con lo
Spirito di Santità che trasla da un profeta all’altro, a partire da Adamo fino ad arrivare a Mu|ammad.
Tale trasmissione dello spirito o, in ambito propriamente shi‘ita,
della luce profetica/imamitica nel suo traslare attraverso i tempi e i
luoghi, interessa tanto gli a’imma quanto i profeti, ed è nota come me-
temfotosi (tan…su²).218 Si tratta, infatti, della trasmissione della luce
mu|ammadica da profeta a profeta, e quindi agli a’imma sin dalla
preeternità, vale a dire da quando il profeta Mu|ammad e ‘Al† forma-
vano una sola e unica luce. È quindi una sorta di legato testamentario
(wa¡iyya) che si ha già prima di Adamo, da quando la luce divina è
stata depositata nei lombi dei vari a’imma.
Nel nostro caso è chiaramente lo Spirito di Santità che passa da un
profeta all’altro fino a raggiungere Salm…n al-F…ris†, nel processo de-
stinato a continuare fino all’arrivo del Q…’im (Resurrettore).
Identificato con Salsal/Messia,219 lo spirito unisce i quattro evange-
listi, rendendoli veritieri.220 Al-ßill† infatti dice che il Messia è spiri-
tuale quanto a conoscenza, santo quanto a nome, eterno a parte ante
quanto alla forma.221
Ciò indica che Salsal, terzo nella triade ‘alawita, è colui che di-
spensa conoscenza a chi ne è degno. L’autore dell’Epistola afferma
che Salsal, in quanto espressione del Significato occultato, diviene lo
spirito che, a sua volta, è espressione del santo, che è Mu|ammad.222
Lo Spirito di Santità, inoltre, come si è manifestato in Gabriele, lo è
stato anche in Giovanni il Battista.223
215 Vd. il Capitolo Diciassettesimo dell’Epistola. 216 Vd. il Capitolo Primo dell’Epistola. 217 Vd. il Capitolo Terzo e l’Introduzione dell’Epistola. 218 Cfr. Muhammad Ali Amir-Moezzi, Le guide divine dans le shî‘isme originel.
Aux sources de l’ésotérisme en Islam, Verdier, Paris-Lagrasse 1992, p. 313; Id., La
religion discrète. Croyances et pratiques spirituelles dans l’Islam shi’ite, Vrin, Paris 2006, p. 131.
219 Vd. il Capitolo Quinto dell’Epistola. 220 Ibid. 221 Vd. il Capitolo Terzo dell’Epistola. 222 Vd. il Capitolo Tredicesimo dell’Epistola. 223 Vd. il Capitolo Nono dell’Epistola.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 249
Il Salsal islamico rappresenta, in ambito cristiano, l’altare e il tem-
pio;224 il sapiente è Dio attraverso colui che attua lo svelamento, vale a
dire il Messia/profeta che fornisce la conoscenza dell’eterno a parte
ante attraverso Salsal, la cui metafora è l’altare su cui è l’offerta rap-
presentata dalla persona di ‘Ali.225 Anche l’olio del battesimo diviene metafora dello Spirito di Santità
che il credente riceve arrivando ad avere la conoscenza dell’esoterico attraverso il battesimo,226 e ciò perché riceve la Parola divina o la Ri-
velazione/Porta rappresentata dall’olio.
Nella sua funzione di espressione del Santo, a sua volta nome del
Significato occultato e quindi Profeta, lo Spirito parlò alle genti in tut-
te le lingue rendendo udibile il verbum del principio.227
In quanto Porta, lo Spirito di Santità è sostanza di ogni cosa e soc-
corre i credenti;228 esso è contenuto nel turibolo in quanto similitudine
della luce da cui è stato originato.229
All’interno dei vari occultamenti dell’essenza divina, anche il si-
gnificato della festa viene reso in base al processo di reiteramento del-
lo Spirito di Santità originato dalla luce dell’eternità a parte ante, per
cui la festa indica il ritorno del Messia,230 quel Messia che è il primo
(w…|id ) proveniente dall’Uno (a|ad ) e, come Profeta, è corroborato
di Sapienza.231
La realtà vera del Messia/Profeta è stata recepita soltanto dai marti-
ri, che lo hanno visto nello spirito e lo hanno riconosciuto.232
b) L’eternità a parte post originata dalla luce dell’essenza dell’eternità
a parte ante
Per questo secondo punto, vale a dire l’eternità a parte post origina-
ta dalla luce dell’essenza a parte ante senza dar luogo a suddivisioni in
parti e senza che vi sia stata nascita da Maria,233 l’autore sostiene che
la nascita dell’eterno a parte post è impossibile a descriversi, dato che
224 Vd. il Capitolo Undicesimo dell’Epistola. 225 Ibid. 226 Vd. il Capitolo Tredicesimo dell’Epistola. 227 Vd. il Capitolo Ottavo dell’Epistola. Si tratta di un richiamo all’Introduzione
del Vangelo di Giovanni. 228 Vd. il Capitolo Tredicesimo dell’Epistola. 229 Vd. il Capitolo Quindicesimo dell’Epistola. 230 Vd. il Capitolo Sedicesimo dell’Epistola. 231 Vd. il Capitolo Diciassettesimo dell’Epistola. 232 Vd. il Capitolo Diciottesimo dell’Epistola. 233 Vd. l’Introduzione dell’Epistola.
Annunziata RUSSO 250
non ci fu nascita, ma solo una manifestazione.234 Ricollegandoci a
quanto detto in precedenza riguardo a Mu|ammad in quanto luce ori-
ginata, e volendo trovare da un punto di vista linguistico un significato
proprio di tale espressione, constatiamo una convergenza di significa-
to tra il verbo i²tara‘a e abda‘a come ci viene testimoniato da alcuni
passaggi nel testo di al-ßill† Ris…lat al-bay…n:
Lode a Dio il quale originò un essere dalla sua essenza per coloro
che conoscono.235
Sempre a proposito di questo nuovo essere originato, egli aggiunge:
Egli è una luce che non si separa da Colui che gli dà luce, un mi-stero che non si svela tranne che al suo Significato, un essoterico che non fu originato da una cosa definita, poiché Egli236 lo rese ma-nifesto [a partire] dalla Sua essenza e non da cosa compresa,237 poi-ché Egli lo creò dalla Sua sostanza, e non si è separato da Lui quan-
do lo ha fatto apparire, anzi lo ha originato [a partire] da Lui.238
Ciò significa che il Nome/Profeta non è creato da qualcosa che sia
materia, strumento o tempo, ma è originato (mu²tara‘), nel senso di “instaurato” (mubda‘ ) senza mediazione e direttamente da Dio. L’esi-
stenza dell’eterno a parte post, infatti, non può che procedere in modo naturale da qualcos’altro, l’eternità a parte ante, a cui è semplicemente
collegata senza che vi sia mediazione di altro. L’originazione (i²tir…‘), infatti, come l’instaurazione (ibd…‘), coincidono per l’immediatezza
dell’atto divino portato a compimento da un Dio del tutto trascenden-tale239 che fa esistere la cosa dal nulla240 o, meglio ancora, la “inventa”
234 Vd. il Capitolo Primo dell’Epistola. 235 Al-ßill†, Ris…lat al-bay…n, p. 2, l. 13: al-|amdu li-ll…hi alla÷† abda‘a min
kiy…nihi kawnan li’l-‘…rif†na. 236 Scil., Dio. 237 Nel senso di “limitata”. 238 Scil., Dio. Al-ßill†, Ris…lat al-bay…n, p. 3, ll. 2-5: n™r an l… yanfa¡ilu ‘an
mun†rihi, wa-sirr an l… yankašifu ill… li-ma‘n…hu, wa-©…hir an lam ya²tari‘hu min
šay’ in ma|d™d in, li-annahu min ÷…tihi a©harahu l… min šay’ in madr™k in li-annahu min Þawharihi fa¥…rahu, wa-lam yabin ‘anhu |†na abd…hu, bal abda‘ahu minhu.
239 Cfr. A Straface, L’origine del mondo nel pensiero islamico, cit., p. 65. 240 Cfr. ibid., p. 72, in cui sono ripresi passi dalle Epistole 32 e 42 dei Fratelli
della Purità. Per ulteriori ragguagli, vd. C. Baffioni, “Ibd…‘, Divine Interpretation and Prophecy in the Ras…’il Ikhw…n al-øaf…’”, in O. Ali-de Unzaga ed., Fortress of
the Intellect. Ismaili and other Islamic Studies in Honour of Farhad Daftary, I.B.
Tauris - Institute of Ismaili Studies, London New York 2011, pp. 213-226.
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento 251
dal nulla.241 Il nulla relativo di cui stiamo trattando, aggiungerei, coin-cide in questo caso con la luce dell’essenza dell’eternità a parte ante
che, per sovrabbondanza, porta in essere l’eternità a parte post in essa contenuta, analogamente alla metà che è contenuta nel doppio, che è
tale in quanto facente parte di quel doppio. Il senso di “dare un’origine” (a¡l ) lo si ritrova nella stessa introdu-
zione dell’Epistola, per cui al-ßill† riporta a proposito del Messia:
È l’origine di tutte [quelle] cose grazie alle quali [Egli] rese atto la potenza, è il principio di ogni moto, è il punto da cui ebbe origine (naša’a) il numero come il punto del compasso (nuq¥at al-b†k…r), poiché l’eternità a parte post (al-abad ) è principiata (mu²tara‘) dal-la luce dell’essenza dell’eternità a parte ante (al-azal ) senza dar luogo a suddivisioni in parti (tab‘†ÿ ), senza che vi sia nascita dalla signora delle donne di questo mondo (sayyidat nis…’ al-‘…lam†na), Maria, su di Lei la benedizione e il saluto di Dio.242
E subito dopo aggiunge:
Ella altro non è che una cortina (sitr) sotto cui avviene la manifesta-zione (©uh™r) della forma corporea (al-¡™ra al-Þusmaniyya), e la forma [in quanto tale] non è universale (totale kulliyya). La forma, infatti, è [di per sé] limitata (ma|d™da), percepita coi sensi (ma|s™sa) e compre-
sa (madr™ka), mentre lo Spirito di Santità è illimitato, non percepito coi sensi e non compreso. Si è manifestato sotto forma umana pur essendo luminoso e sostanziale (n™r…niyya Þawhariyya).243
Ne segue che l’eternità a parte post è identificata con lo stesso Spi-rito di Santità, mandato da Dio in quanto derivante dalla Sua essenza e avente inizio da Se stesso poiché lo spirito non è una quiddità del ge-nere divino,244 dato che la divinità in assoluto è posseduta solo da Co-lui che è congiunto con lo Spirito di Santità.245
c) La gnosi acquisita dal credente
Per il terzo punto, bisogna ricordare che ci troviamo in un ambiente shi‘ita, in cui una forte valenza ha la conoscenza salvatrice, la quale è
il frutto della scoperta della luce della guida divina interiore. Tale co-noscenza si raggiunge solo se si seguono i dettami dell’Imam che,
241 Ibid., p. 214. 242 Vd. supra, p. 10. 243 Cfr. p. 11. 244 Per il significato di “quiddità” (m…hiyya), vd. supra, p. 11, nota 31. 245 Vd. il Capitolo Quarto dell’Epistola.
Annunziata RUSSO 252
sebbene nell’Epistola non venga mai citato, è presente attraverso la dottrina della Ðayba, in questo caso riferita al Messia.246 In tal caso il
Messia rappresenta l’Im…m che aiuta il credente ad avvicinarsi alla vi-ta eterna. Riconoscendo la manifestazione di Dio nel Messia, si riesce
ad avere un approccio al piano divino che non si può realizzare attra-verso un ragionamento analitico o mediante un processo razionale, ma
avviene soltanto attraverso l’esperienza interiore di ciò che di Dio può essere conosciuto e vissuto. Soltanto attraverso la visione del Mes-
sia/Im…m storico, quindi, si può avere la visione dell’Im…m di luce,247 vale a dire quella conoscenza che porta alla vita eterna.
Tale esperienza si ha per gradi, come ci informa l’autore, e non può essere affidata a chi non ne è degno. Per questo si parla del senso di
conoscenza esoterica di alcune abitudini cristiane, come il far crescere i capelli ai monaci,248 che significa la conoscenza dell’eterno a parte
ante/Significato, data da chi attua lo svelamento dell’esoterico nasco-sto, ovvero dal Messia/Profeta/Im…m.249
Tale conoscenza, in particolare quella del significato esoterico della chiesa, rende santi come santi sono i profeti/im…m Adamo, Noè,
Abramo, Mosè, il Messia e Mu|ammad, mentre chi non la raggiunge è destinato a restare un puro e semplice essere umano.250
246 Come in precedenza riportato, il Messia partecipa della doppia valenza di
Nome/Profeta e Porta/Rivelazione e rappresenta, aggiungo, l’essoterico del Signifi-cato/Dio nascosto. Per poter ottenere la gnosi salvatrice è dunque necessario rivol-gersi al Messia storico, vale a dire al Nome che ha il ruolo di sapienza divina, ossia di logos ed è quindi l’unico mediatore che potrà rendere appieno il mistero dell’es-senza nascosta dell’“esoterico dell’esoterico” del Significato. Per approfondimenti, cfr. A. Russo, “Insegnamenti ermetici e dottrine ‘alawite”, cit., p. 359.
247 Per ulteriori ragguagli sul rapporto tra conoscenza e Im…m, cfr. Amir-Moezzi, Le guide divine, cit., pp. 142-143.
248 Vd. il Capitolo Nono dell’Epistola. 249 Vd. il Capitolo Undicesimo dell’Epistola. 250 Vd. il Capitolo Diciassettesimo dell’Epistola.
ذظ هللا جزق جزق١ [148]
جزطحس جظ١ك١س
[ جزطحس جظ١ك١س149]
ليعص ضأ١ف جعح جفحػ جكمك جىح جشي١ جػميس يذي جكظي١ كيع ذي جي جؿي
.هللا رق
ذظ هللا جزق جزق١
جع ي١ ،جكع هلل رخ جعح١ جي قم١ميس –رقيه هللا – طيأص ،ال ليز ئال ذيحهلل جعي
ط١عح جظ١ف ج١ح ذوز جظال ف جرج١يس، جي ورجضي يك في جرشيز٠س، جي
طييفحض جطيي وييز ذييح ذحؿظييح١س ضأ١ظييح ميي يي فيي جكم١مييس ١ييز ؾظيي، ذيي يي يير
، ج٤خ جزق١، جإدخ جكى١، جظرز جط ضرع جح جد جكىس، ي طعج
قزويس، ي جمليس جطي شيأ يط ج٤ش١حء وح جط يوز ح جمز ئ جفع جذطيعجء وي
ضى ج٤ذع طزع ر ذجش ج٤سي ذال ضرع١غ ١ز ي ح جععد وملس جر١ىحر، ٤
يي ويير ئييح يي طييطز ج –الدز يي طيي١عز ظييحء جعييح١ ييز٠ طيي هللا ج١ييح طيي
جظيرز كيعدز كظطيس عرويس، رـ جظرز جؿظيح١س، جظيرز ١يز و١يس، ٤
– ١ز كعدز ال كظطس ال عروس، ئح وز ذحظرز جرشز٠س [150]جمعص
ضأ١ظيييح مييي، رقيييس ييي ئشيييفحلح جييي١، ئذ ليييع جييي يييي ييي١ض فييي –رج١يييس ؾز٠يييس
٠ػر طج ئذج وز ي ق١يع ي، ي ويز ذىيحي رج١طيجططلحجط ي1٤ؽفيأأ ير
يح جي ؾي ج٤رع، ويح ذيه ١يز ؾيحتش ج٤جر ج٤ذظحر ج ر، يقزق وي
يال ج٤سي ال طيي ال فظيي، ال –ضعح –ف جكىس ال غحذص ف جععي
ذ ذ : يح عي ال طيي حسـ ج، ال ، فا لحي لحت ذع جؿشء جى
ال فظي؟ لح: ال طي قط ي ال فظي قطي يي ١يز، ال محذي، ال يحء
ذ >...<. ج، ال
عحع لزص جشض جمز ذع جالضظحي جالفظحي، جش فحؿجخ ذحهلل جطف١ك: ئ
ييح ال ٠مييع ج١يي جطيي ج يير، ئييح وييز ويي ذحظييرز ٦غرييحش ؾييد ج١حيي ضػر١طيي ٤
ضه جظرز جط يوزح يك جؾيد ئغريحش ؾيد، ال ٠ى ش١ثح، فمي ئ ٠شه ي
[ ج آ حء قط ئذج ؾيحء ي ٠ؿيع 151وظزجخ ذم١عس ٠ك١ظر ]”لع ػزخ ػال ف ل:
“يع ففيح قظيحذ هللا طيز٠ع جكظيحخش١ثح ؾيع هللا ج2فيزـ جميعص ؾيدز جيع وير
جظر، ١ز كظرز ال كظطس ال طس ئح ز جعح ئ١ ق١يع شيحوط3
ذحلرجس: ذحىحي وز ذرج١ط. 1 .-39 -جر 2 . جلزي: شحوط.ىذج ف ج لؽس 3
Annunziata RUSSO
254
وحييحوز فيي جييزرز ٠ ييز ئيي فظيي، ئييح وييز ئيي جحيي ذحظييرز إجظييس جؿحظييس
جلعييح شييزخ جييحء ذح٤طييحء جظييفحش، جقطؿييد ذييح٤ يوييز يويي4يي ق١ييع حطييض١ط
عح ١مزخ جم، ويز عيح ي ق١يع الض١طي، ي ٠يأض ذي جعيح ي ٠ػرطيج
ج ذيه وي، ئيح ذيه ج ير ٦غريحش زؤ٠ط، ئح وز ذذه ١أض ذ ج ك ٠ؿ
س جي١ ذفظي، في ذيحؽ ئ ويز، ويحز ئ ذلي، ئيح دجيح ي جكؿس ضكؿ١ؽ جكؿ
جفض جكم١م١س ئ جفض5 رطيي ذحؽي هللا جالض١س جذجض١س جظزع٠س جى١س، ويحز ري
رخ جعح١، طفحش هللا جط عص ذح فظي: هللا طي١ع ذظي١ز جي١ قي١ رقي رقي١
ج٤سي ضعح ال ضم [ ج١ قعد ال ٠عخ ضكص جى١ف١حش، ال ٠عخ في جيعد، ال 152ع ]٤
ضعزف ح٠س ال ٠طػ6ح جقيعج قطي ٠ىي يطي ج٤جيعجد، ي ال ذحرتي طي في لظيس، ٤
يح، ي ذيعء عيح ئي “ يف”ضز يه لص ال ذع ي جزؾيع ئي ججقيع جيذ ي ي
ع ئ١ جه، ٠ ك ٠زسق ١٠ص ٠كال جف7 ليع٠ز، يويز ش ج و
جعؿييش وييح يوييز جعييحؾش، ج ييك جييشؼ ري8ذييه جؿييشج يي ق١ييع جؿييش، ييي
جظييفحء جرظييحتز ريج ذييه قىييس لييعرز يي ق١ييع درؾييحض ييحس طييال هللا جيي١
يؾع١.
جرحخ ج٤ي
ور ز٠
يطكحخ جظحدز جطك يرع فظل١ ذ١ص جميعص ؽرز٠يس ح خرز ذ ئ
جغزخ ج٦طىعر٠س، جم١ظيح فىيح: يح خريز ذي ٠قيح ي ي١الد جعيذرجء جشح وزط
ز٠ ف ذ١ص ك، ح طعط ف ج٤رد يع ٠قيح جعيعج ٠ي جيشذ 9يح يويز جظي١ع
ح دخ ] شع ح 153ئ ذ١ص جميعص، طي [ جشيعح١، يح ذويز ٠ي طيعد طي
ح “ جظالق” ٠ طعد ئ جظحء ح جخطرز ذ لر ل١ح جيذ قميك ف١ي جرعيع طي
ح “ ذ ١ييزج”"جفظييف" ييح جييطك ذيي ج ييك ٠يي ييشي رـ جمييعص جيي جكييجر١٠ طيي
جظي١د جيذ يويز ضع١مي ج١ي – ٠ جعظزز “ جمظلل١” ح وز ٠ي ؾيد
ح يح جضرعيي طيي١عح “ ج١ييع جظيي١د”طي ضكييذ٠ز رييض جييطك “ ير١ييح”ييح فظييز لييح
ف١ ذغ١ز قي، ذ ٠طؿظع ذغ١يز ي ٠ىي ؾظيعج ي ”جعجحء هلل رخ جعح١ ئظحح ٠ك ي
“ يز٠”ي قطي جعيذرجء “ دجد” ظ جطؿيد “ لفجذزج١ جظ“ ١ز ج طحرز
لظييس يي١الد ج٤ذييع يي قييحي ٠عؿييش جيي طييف ي طييالس د٠ييس، ؾييزش ج١ييح جفؼيي١س ٤
ييس الدز، ئييح يي ويير، ييز٠ ججطييف، ٠مظييز جيي شييزق جشييحرق، ئذ يي١ض غ
جظ١ع ج ال ٠طيف جذطيعجؤ –ي جظيال –ظي١ف قؿحخ ج لخ جعحرف١ جؿحقع٠ ٤
٠قيح جذي س٠يع ”ال ٠عزف جطحؤ ال ٠كم و١ف ذكىح٠طح، ال طي طل١طيح ييح طيف
يز٠ جعيذرجء 154ذكظد ح ي رـ جمعص يق ذ ئ١ ]“ ج٦ؿ١ [ يح خريز ذي ي
جطي: يػيح عيح ئيح“ جحت١ي”٠رع ى ح ير ي ير ٠ظي10جعؿيد، جريع٠ع
ف جلرجس: جشزجخ. 4 ئ فظ.ف جلرجس: 5 ال ٠ش.لرجس: ف ج 6 جلزي: ٠ك١. ىذج ف ج لؽس. 7 . جلزي: ريج.ىذج ف ج لؽس 8 ف جلرجس: جشؽ. 9
. جلزي: يػحء.ىذج ف ج لؽس 10
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento
255
١حجؼيس، جظعد جزشع جزش١ع يذ جعح١، ط١عح جظي١ف ويز ي ١يز لفيس 11
يي “ طيي ييزلض”يي رد جييعج >...< لييحي ييي ج ييحز ئيي رد جػييح، جييذ لييحي:
جىطحخ12 ١يحي ي ج يحز جؿز جعزع جظح جكعظ ذ جظي١ف، جشيرف ج
يذ١ جؾد لحر١، قحي خليحخ جعيح١ ٤يض جكمي١13ف١ي، ئشيحرز ظطزشيع٠،
ضح جىس جط شي ذح ع ؽي ج٤ذع ئ رخز ج٤ع.
فييحهلل يي جىييس، جظييح جطكييعظ ذيي يي جظيي١ف جقييع يذييعج ييال ج٤قييع، وييز يي
جي ع٠يس جعي طيركح ج٤طحء ئ١يح جيح د ي رخ جعيح١ ذيذج يطيطز جمحيس ي
جر١يع، ئيح جظي١عز يز٠ طيطز جي ضعح، ئذج وح ذه وذه ف جحيه يه، جعيح
: ئح عض لي: ي ؾريحرج شيم١ح”ذه. فا لحي لحت جؿيجخ: “ ذيزج ذيالدض ي ٠ؿع
ط١ع ح يوز حطيض١س 155ح ]ئ [ جظ١ف طع ال ٠لع ر ال ٠طؿظ ئح يوز جالدز
، جسدجد ذيي جعييحرف جططرظييحرج الدضيي ،
14جسدجد ذيي جؿييح ض فييح ئىييحرج، يي وييحز
يحؽك في قيحي جيالدز ي١ض يذج في فعي ي قطي جيزيز في ػي١ك ج٤قشيحء فطريحرن ي
ر ذجض وح شحء.جخطزج
جرحخ جػح
ف عزفس جظرد جؾد ف يوحر جظ١د
جظ١د يط خشرطح، ئذج ػعطح ذعؼيح جي ذعيغ طيحرضح ئشحرز، يال ضز ي
يط يرذع وحش.“ ال ئ ئال هللا”يرذعس يؽزجف ٤
ج جط جظ١د يرذعس يقزف، جطج لرحتع جط ضجعف ؾ رخز: ئ15يح جعيح
ف يط ج ك.
جعيح جىر١يز وحفيه جكي١ؾ في طيحتز جظ١د ػ جعح جىر١ز، فيا ف ؾ رخز: ئ
رح، فىذه يرذعس يللحر، وذه جظ١د يرذعس قعد، ] [ 156ج٤فالن جظرعس ٤ ع
ػ جي يط جظ١د ي قعج قع، جكعج ج كع وح ج٤ز جش١ثس، جكع جػحع
ج٤سي جش جش ويذه جظي١د يطي خشيرطح يح لليد ٠ؿعيح، د١ي ذيه ييه ضميي:
جقع ف جقع جقع،16فذ غالغس قعد طظس ١ز فظس ئال يه ضز ئذج لص: جقع في
جقع جقع17ي ػيزخ جكظيحخ، فيحج يح يشيزش ذي ذطععد فظي، ي ٠ؼيحف ئ١ي شيء
ئ١ه.
جظ١د غيح ريح١ ئ ح جعح جظغ١ز جذ ؾعص جظ١د و، غ ي18جي
حطح، فطى جزح١ ؽزف ر و19ج٤رذعس قعد، جغ جشيز قيعج جي جيعد جغي جشيز
ظ١ع جظ١ف ج١ظ جظ١د ال طرلح جذ٠ وحج ط، ج جعد جكجر١٠ جذ٠ وحج
ف جلرجس: رحجؼس.عح: رحػعس. 11 ف جلرجس: ي جىطحخ. 12 جكمم١.ف جلرجس: 13 ١ظص ؾدز ف جلرجس. 14 ف جلرجس: ضع. 15 ١ظص ؾدز ف جلرجس. 16 ١ظص ؾدز ف جلرجس. 17 ال ضؾع جملس ج ج ج٤ي. ف جلرجس: ر١. 18 ال ضؾع جملس ج ج ج٤ي. ف جلرجس: ر١ 19
Annunziata RUSSO
256
ذييع يي يي للييد ٠ىيي حطييىح يي20ف١ىيي جملييد جػحييع جشييز ييح ضمييع يييز يي جػييح
يح١ جز21ج٤رذعييس جكييعد جطي يي قحييس زيح١
22جملييد جػحييع جشيز، ػيي جظيي١ع
شء، فاذج ضؿ١يص جظي١د ؾعضي يرذعيس يقيزف دجيس جي يرذعيس، جظ١ف جذ ذ لج و
[ ط، زلض، لح ٠قح.157 يطكحخ ج٤حؾ١ جذ٠ ضمع ذوز ]
ؾ رخز: جه ئذج ؾعص يقيزف ج٤طيحء: طي ج١ظي، كيع، ؾيعض جغي
جشيز قزفيح، وحزيح١23جػيح جكيعد ج٤رذعيس جطيي ي ج١يح، فيذج قيع جظيرش فيي
جرحخ.جرحؽ فحف ذه ض
جرحخ جػحع
جظ١ف ظ١كح؟ ط ف عزفس
ح هلل طز ئال ؾحر ج يظ ي فمحي: ئ خظظطه ذذه طظطزشع ذ ضع24خمي
ؾ ذ. جكع٠ع ج جزت١ض جمع٠ض ي ؽز٠يك ي جيزف جظي١ع يقظ ح قظ
ط شء ظيكس، ي١ض ف١ي ظيكس جظ١ف ي لحي: ف و جظ١ف ظ١كح؟ فمحي: ٤
شء.
ظكس ي جظي١ف ي١ض ف١ي ظيكس ي ١يز، ي ر ف و لحي ف ؾ رخز: ئ
ي وس هللا ضشي ذ ع ؽي ج٤ذع ئ رخز ج٤ع، فحهلل جىس جظيح جطكيعظ
جظ١ف.
ظف فظ ضأقع ذ. [ ؾ رخز158] ح غ : ي الش يقعظ حطضح ضح
ؾ رخز: ي وح ظقح ١ض ح ٣د١١، فاذج وح ذه ويذه في اليش ضيأض
ئ حطش جعح١25ذحط وأطحت طيفس وظيفحض طمطيزخ جظيرز ي جمي ٦غريحش
جكؿس ج١.
جظيي١ع طيي ج ي ييح رد ئيي ذ١ييص جمييعص ري لزييح ٠زشييف س٠طييح ر ١يي جظييال:
لحي ر ئطيزجت١: ئي طي١أض١ى ي ذعيع فظف ط ذ١ع ج ذه جمز فحملع جش٠ص غ
ح وز جظ١ع جظ١ف ظف ذ١ع ج جمز، فعر جش٠يص ٠ظف ذ١ع ج١، ف١عر جش٠ص، ف
رع.
ذ١ثطي فطؿي ؾ رخز: ي ظف جيح جعح جزقح ذحعح جؿظح ف يز في وي
ذطؿ١ط26 وز ف جرشز وحرشز ؾظح١ح.
. رذح طعج جح ؾ رخز: ي وح ظقح ١ض ذوز ال دذز ذ رج
فيي ج ييحز، [ ؾي رخييز: ييي وييح وػ١ييز جظيي١حقس ل١ي جزجقييس، ٠عيي جر١ييع جعيي159]٠كػ ج١ ٠عزف جزـ جع جزـ جؿ ج حز
27 . جشو
يرع طيحء يزيح ليعر في وي ؾ رخز: ي ظف ج٤رع جظحء، يق ف و
رسلح يلجضح.
ف جلرجس: حطى. 20 ف جلرجس: ر١. 21 ١.. جفزي: رىذج ف ج لؽس 22 ال ضؾع جملس ج ج ج٤ي. ف جلرجس: ر١. 23 ف جلرجس: يظس. 24
ف جلرجس: رخ جعح١. 25
ف جلرجس: ذطؿ١. 26
ف جلرجس: جلحز. 27
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento
257
ؾ رخز: ي وح ظ١كح حص ج٤طمح شفح ي ج٢ال، جيع١ جي ذيه لي
“.يذزب ج٤وس ج٤ذزص يق١ جض ذاذ هللا”ضعح:
ييح شيي ؾيي رخييز: ييي 28يشييز جيي جؿييذع، فظييحرش جل١يير جظييرحع ضطظييف
ذعد ضرزن29 جظرز، طرض وحشض جعزفس ئطح جمعص، يس ف١، وح رقح
جقييع ي ق١ييع يي، ال ٠طغ١يز جيي و١حيي ٠زجيح ويي ، في جمييعرز جطيي ضيعي جيي جمييحدر. ضيي
جرحخ.30
جرحخ جزجذع
جظ١ف جط جالش ج١ظ جط جحطش ط ف عزفس
جظيي١ف، فىييح جلح ١ييس 160] جظيي١ف ظييف ج٤رع ييح ج١ييح، فييذه طيي [ فمييحي: ئ
جذ يرجد و١ع ط١عح جظ١ف لط طر31 ع هللا. “ ؽ٠ذج جالط ز٠”
ضأقيع جعيس يح ي ق١يع جميز ئي جفعي غي يوز حطيضح ضح جالش جطح ؾ رخز: ئ
ضمزخ ئ جعح فىحص ضه جظرز جط ضمزخ ذيح ئي١ ذححطش، غ32وححطيش، جفعي
جذ ٠أض١ فع جالش.
لحي ذعغ جمع٠ظ١:33 جالش جطح ، وير ذححطيش ال ئ جقطؿد ذححطيش جطيح
ج طر١ جحسؾس ال ؿحسز ال شيحوس، ٤ي ي ويح ويذه طالشي عي ىي يويز
جالط جظفس ١مزخ ذح خم، ذه ٦غرحش جععي ف١ وذه ج حض ٠ى ج فظي34
٠غ١يزمش ف١ ط ذ ق١ع ٠مي 35ز ٠ يز ذحظيرز ال ض يز جظيرز ذي، ي ال ٠طغ١ي
جملس جكزف جط ال ضطؿشي ؽزجتك ج ج٤ف *ج٤جزجع ، ويح ي ذه ي
[ مليس*161جملس ضى يفح ١ض ٥ف ي ٠ىي ]36ويذه جاليش ٠ يز ذححطيش،
*١ض حطش ي ٠ ز ذحالش*.37طىي١ليع طيث ذعيغ ج
38 فم١ي: و١يف ؾيد ي
٠ ز ك ذححطش؟ فمحي: ي ذعج ذغ١ز ىح ١ز ججؾد، جؾيد جي١ عزفيس
جغ١ييز، ىيي ذعييع ئيي١ رـ جمييعص يي ذجضيي قيي١ جالذطييعجء ييح ال ح١ييس يي ؾظيي ٤
جالش لع دص جعمي ج لفص ي ؾيض جطظ ذزـ جمعص يض جكزوس ئ ي
ج ص وذه جشء جشء. جكزوس ئ39
.ىذج ف ج لؽس 28 . جلزي: ش . جلزي: ضطرزن وح ف جلرجس.ىذج ف ج لؽس 29
ز ف جلرجس.١ظص ؾد 30 . جلزي: طر.ىذج ف ج لؽس 31
ف جلرجس: ج١د. 32
ف جلرجس: لحي ف جذد. 33
ف جلرجس: فظس. 34 . جلزي: ٠غ١ز.ىذج ف ج لؽس 35
ف جلرجس: ج ٠ى ملس. 36
١ظص ؾدز ف جلرجس. 37
ف جلرجس: ظلرص. 38
ؾض جشء. ف جلرجس:39
Annunziata RUSSO
258
جرحخ ج حض
ف عزفس ج٤لح١ جطال١ذ
لييحي ظييلرص جيي عيي جزقييس قىيي١ ج٤ييس: ئيي ييه ج٤لييح١ ج٦غيي جشييز ؾعيي
١ ج٦غي جشيز في ليص ي جغي جشيز ض١يذج يفيذ ئي ج٤ليح –ضال١ذ يعذزز ١عزفيج
جقع، يوز ف ج٤لح١ ج٦غ جشز طير،40 جقيع ي ذعي، عي وي ؾعي وي
ئلي١ ذغيط يويز ي يي ٠ز٠يع جغ١ريس خحؽد ي وي ي ال –جقع ذظرز غ ؾي
٠غ١د.
ض١يذ ئي ىحي، فيح جملعيص جي162] جيدز جخطفيج في [ فح يوز جغ١رس رد و
ي يطيكحخ –مح رؾيع ج٤رذعيس في ؽري ج٤رذعيس ي: ٠قيح طي ليح يزلض
فح طج ئ جػع جذ وح ف١ جظ١ف ذعج رـ جميعص ي ذجضي ي –ج٤حؾ١
جظي١ع جظي١ ف يذيز طظ فغ١ر طظ ضكص يجر، فلمج ذح٤حؾ١ي ج٤رذعيس ذويزج ي
ذزـ جمعص، فلمص ج يظط ج٤رذعس ج٤حؾ١، طظ ذزـ جمعص.
جرحخ جظحدص
ف عزفس ١رس ط١عح جظ١ف
لحي:41ذ١ ج ط١عح جظ١ف جظال و١ف ؾز ؟ فميحي: ئي ضميزخ طأي ذعغ جمز
ليع جي فظي ػي يح ليع جي١ ريفيس ئ جعح ذغ١ز ج٤خ، ذػ ذج يوز ئ جعح ي
٠ؼيزخ جي جظيحد٠، في١ض ي ذحيحر غي ئشفحلح ج١ رفمح ذ، لع ري٠ح جكع٠ع ٠ك
[ جظي١ف ئيح يويز163جحر جط ضطأ، ئح ٠عخ ج٤ ج ف جحر، وذه ط١عح ]42
ئح جلع ذحؼع ٤ ضعح جش ج ذه، ئح جطغ١١ز ف جيحوز، ليع ح يوز لط
ضىظف جشض ػءح43ف جعح جؿظح، ؾز ذظ١ؾ ٠طم لع ري٠يح ج٦ظيح
٠عطع ػزخ جشض ذحظ١ف، ١ظص جشض جط ضملع ئح ٠مليع يح ج١ي جشيض،
ج يد جلييع ذحؼيع ٤ ٦طي ج١ي يي جظيال ئذج يويز ١رطي ذحمطيي ويذه جظي١د جظ
ييع ئظييح ػييزخ جشييض شيير جيي جؼييع، يي ضع ، يميي جيي يميي شيير جيي جيي
ذحشيض، الذحظ١ف ضى جؼزذس إغزز ذحشض ذ وحص ذح٤رع ضإغز، ذح ويح جلعيح
ؾ١ع ح يلع ذفظ جمط جظد وح ضر١ظح، ح يلع ذحؼع وذه ط١عح جظ١ف، ئ
ويح قم١ميس، ٤يح ري٠يح جشيض في جعيح جعي جزجذيع ي يج ي يح فليح يح ضكطييح،
. فا جقطؽ كطؽ جظيحر وذه جظ١ع جظ١ف ف جعح جع قىط ف جعح جظف
[ ج يي. 164ع جظي١ف مطيال ظيذح جي ؾيذع ]جيذ٠ ي ١يز ذيحغ١ يي شيحعج جظي١
جحوز ئ ط١عح جظ١ف ئح حوز ئ ١ثطي، يح ف١ي ي جعؿيش ئي فحؿجخ: ج ي
جؿش خ١ ح رر، ١ض ج١ يح ويح ١يز قم١ميس يرالف جظيفس قيع جعزفيس، فظ ٤
ج٦ظييح ٠ييز جرع١ييز جيي ذعييع ف١كظيير شييحز، ٠ييز جشييؿزز ف١ ييح وػ١ييزج ييح ٠ىييذخ، ٤
يح ٠ىيذخ ج يز ويذه جيحوز ئي رؾال، ٠مف ج شحؽة ز ف١ز فظ ىظح، ي
جعؿيش ي جميحدر ليعرز، ئيح ط١عح جظي١ف ليع رر يي مطيي ظيخ. ؾي رخيز: ئ
ىذج ف ج لؽس. جلزي: طرز وح ف جلرجس. 40
١ظص ؾدز ف جلرجس. 41
١ظص ؾدز ف جلرجس. 42
ف جلرجس: ػؤح. 43
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento
259
يمييي طيييرز جييي شييير يمييي طيييرز جظييي١ف جييي جييي44٠يييذج ”جييي جؼيييع
“.ج٤ط ز٠ؽ
ر يذ ٠عمخ *ي لحي: ليحي ظيلرص ذجش ٠ي:*45 و١يف ضشجي ييح ميي: ئ
ح وح ي ييز يح ويح ليحي: يا جظ١ف هللا ج٤ج جذ ال فل شء؟ ك ز ي
عيح ي٠ي ضيذد ضيعج ٠ عي ذي رذي. فميحي: ضرظيص ليص ال ئ ي٠ يذيد ٠يح جي
[ : ح ع ذه؟ فمحي: جط يطحء هللا دجح165]46 ذ.
جرحخ جظحذع
طفس جكجر١٠ ع جظ١ف
وريحر طيغحر فياذج طفس جطال١ذ جكجر١٠ ػي جظي١ف ػي قيحتؾ ف١ي وي جج ي
ز ي ػيء جشي وي ض ذميعجرح، ويذه *ويح جكجر٠ي ؽعص جشيض ج١ي يخيذش وي
جقع * ٠ثذ ٠أخذ و47 ٠ ز ذمح ١ض ي جظ١ع جظ١ف ذمعجر ظ١ف ي
٠ زج ذمح. ي
جرحخ جػح
ف عزفس ور جظ١ف ذحػحظ
ي ور ذع١ظي غي ذيعج١حي لحي ظلرص ج ور جظ١ع جظ١ف ذحػحظ: ١ض ف ي وز جظ١ف فعجح ؾ١ع ج٤طرحؽ فحؾطعج ئ١ ذعع فزجل فأليح خيزجخ ذأر١ح غ ذأشع١ح غ غ
ي ييشي جميزجذ١ ذعيع جرضفحجيح، يجيحد جىيس ج٤ي جر١ص جػح ذعع خزجخ جر١يص ج٤
جييح فأؾييحذج خييحؽر [ ضر١ظييح، ئييح لييع جطريي١ض ٤يي وييح ٠يي جىشييف د166طيعح١س ]
ذغيط، يغريص جكؿيس جي١ ذيي، لي ٠ حؽيد وي ذؿ١يع جغيحش، ويح ذيه جيعال ي ي
ف١عج ي جظز٠ح ذغط ذه ي دجح فح يؾحذج *فيذه جطيطكمج جعمذيس >...<*48 غي
جشيز، فميع جطيطكك ذعزفطي لحي ظلرص: ف جزف جظ١ع جظ١ف ف ؾ١ع ج٤لح١ ج٦غ
جظي١ف ليع . ليع ليحي ظيلرص: ئ ذحعيح جيرج كلي ئ٠ح جمس ئي جعيح جزقيح
ج٤ف ذه، فح٤ف جقع ذحشحعز ف جععد غالغس يقزف ٤ وز ذحػحش، فال ضىز
زف دجس ج جػالغس جط ؾز جقع.لحت ذذجض ف جشحعز، ف جؿحء غالغس يق
طث ذعغ جطى١ ج جػحظ فمحي: ج٤ف جقع ف ج ؾ غالغس ذحع١ح جفي،،
ي 167وذه جىح ال ٠ طى لحت ذذجض، ح ذ١ح ي جطيأ١ف ج٤ؾظيح ] [ ال ضع
زوطح.ذذجضح ئح جع ذحؿجز جط ف١ح ذك
جرحخ جطحطع
ف عزفس جالذطعجء ذحشحر ذحؽ ذه
لع سج ٠قح ذي س٠يع ج٦ؿ١ي يي ويز رـ جميعص يرض فيزز ي ؾيد جغي شيع
ذيز جؿيحي ويح في ٠يع ويأص جريع جير ٠طميزخ ذي. فظيأ جي يذي١ طل ذىشط١ش
ف جلرجس: شر. 44
ف جلرجس: ج ظلرص ي فحي.45
ف جلرجس: دجح. 46
١ظص ؾدز ف جلرجس. 47
١ظص ؾدز ف جلرجس.48
Annunziata RUSSO
260
يذ يذحو ف جظ حء لع ؾع ى ػال ج كي دي >...< فؿعي جظي١ك١ فمحي: ئ
ذح ئ١. ضمز
يص وآذطي، يح يرؾ ي جؿيس ئي ج٤رع ؽيحي قشي، ج ج٤خ رد ح جشيحر: فيا فأ
طيل جيس ي جشيعز في فأؽحي جعرحدز جم١ح فطػ ؾرزجت١ ف طرز رجد ج١ي عر
ييح ييز ئ١يي لييحي يي: يي يييص؟ ييح ييذج جكييش جرييحدوشييط١ش يي جييذز، ف49ييه؟ لييحي
يح جيذ في طيل فأشيع ذي يح رظي: فطيذ زذي، ي ذري، ي ح قش فع ؾرزجت١: ي
ؾرزجت١ جمع جشحر زذعح فظأ ج ذه ] ي [ فميحي: ٤يز ٠ىي طيز 168يسر. ر
ييد، ئييح يرجد ي ٠ييذوز رد ٠ ؿرزجت١يي ذ جيير جظيي١عز جىرييز >...< يي ٠ىيي ييز يي ي
ح وز جظ١ع جظ١ف لحي كجر١٠: ر ١ىػز جططغفحر ٠شدجد ذذه لز ج جعرحدز ف ذذ
: خييذج ٤ فظييى فيي جي١ى ذشييع ج٤طييحؽ ذحشييح١ز قييك طييؾ جييزيص، ئييح يرجد ذييذه ي
س يطكحخ جمححش ذ١ ذ١ كع. عزفس ج٤ت
زج حص ذرحؽ ك جزيص عح: يال ض فك50 طي١عح جظي١ف خيزؼ جى. لع ل١: ئ
٠ح ج جكجر١٠ شز جطؾ جمع جشحر زذعيح، فيح رر جكجر٠ي51ليحج: ٠يح طي١عح
ضلر ف يرذع مححش. ح ع ذج ضأ٠؟ فمح ي: ع ذج ي
ؾيي رخييز: ئيي لييحي يي: ئيي يوييز يي ؾرييحي لييحرج فييأضؿ ذحمييعص يطييططز ذز١ييس
جىرز، ي ١د ف ج٤رد.
جمييع جشيحر زذعيح ؾي رخيز: ئ52 جي ج٤رذعييس جيذ٠ ي جييح جظيزج١س يي: ػيي
يال ي ويح ي ف١ظيطل ”ظ١ض ح لح جظ١ع جظ١ف: جرطزن جلزج ج٤طمف جم
“.١طشز
يج 169] ٠ل ي جزرح شعر شعج سح١ز، ويج ذيذه يي يشيحر ئي ي [ فل
شيعر ٠شيعج سييح١ز، يح جزفيج ييح يرجد، ال ئي ييح يشيحر ف١يح لييحي ي ئييح يرجد
ج ١ز ي ي ٠ظطز جرحؽ ططزج ح ج١ جرع ذذه: –وح ف١ىط جع
ح ل: “ ي ويح ي ف١طشيز”ي ذعؼي ذعؼيح قطي ال ٠ ي ٠يالس يشيحر ذيذه ي53ي
جشيحر دجتيزز ئذج دجر ج ٠أخذج قذر جؼيع، يال ضيز ي ميع يزج ال ضعخ ج١ ٠ع ي
جعمع ذلص جعجتزز. جقع فط جك ف ىح
ؾ رخز: ح لح جظ١ع جظ١ف:54سزج ذحشح١ز يجطلى ضشع يى ج ير، ٠يـ
ى جر.
جرحخ جعحشز
ف عزفس ذحؽ جمزذح
يي لييزخ جمزذييح حذ١يي، ٤ ي ي جمزذييح ل١يي جمزذييح يي قييع ج يي١ يييز ؾظيي١، فييا
ويير جظيي١ع جظيي١ف، وييح كييح ٠ييذذف ٠طييزن جيي ج١حويي فطييشي ييحر فطزفعيي جيي يجيي١
يح يرجد 170جشؾ١. ] جعيح جيزق١ ف وز جظ١ع جظ١ف جكي١ [ ف ٠شي وذه ئ ي
جكييس جطييس جغ١رييس لييحي كييجر١٠: ئيي ييف لزذحييح *يي كيي ىيي ذييح٤خ ج٤ورييز
ف جلرجس: جذ ذحد ه. 49
ف جلرجس: ف ذجؽ. 50 ف جلرجس: جكجر١٠. 51
ف جلرجس: يرذعس. 52
ف جلرجس: ٠ك. 53
ف جلرجس: ف ذج جظعد.ضؼحف 54
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento
261
لحي ف ػع رخز: ك د* >...< غ55فطظيىج ذي ئي ي ضمي >...< فيأرجد
ئال ي ذم: ذج وحز ذحؽ فطظىج ذ. ج رز ف جمزذيح قيع ج ي١، يح ي ري
. ويح رد ذأخيذ ي رق جؿيس، ي ٠ىي رليح ئيح ويح لزذحي، ئي طيح ر ذي ذير لزذح
جشؿزز جط ي جح ئذ١ض قط رج خ١زح.
شء سؾ١ جغ١، ضى جظيف١س خشيرح وح لزذح ـ طف١ط جط ق ذح و
جظف١س خشيد جقطؿيج ذميي جالطي: طيف١س ”ذ ضى ش ظح وز٠ح. لحد ؽحتفس: ئ جي
ض ف جح ظي قي “ هـ رود ذح ؿح جظيف١س ط لحص ؽحتفيس يخيز: ئ
شيء سؾي١ جغي١: ج٠٤طيح جمريحء جؿريحء ج طظي١ ج ظي١ جطكي١، و
يطكحخ جزجضد.
[ وح لزذح جذزج١ لع جذ وظز ذ ج٤طح ٠ى قع٠عج ذي ويح ش ظيح 171]
وز٠ح ئطحج١.
س جحص ل ضعح:وح لزذح ع٠ جذ ؾع ج١ ي ط حء 56ح رد حء ”
س جحص ٠ظم، ؾع د جزيض١ ضذدج لحي ح خلرىح لحطح ؾع ج١ ي ع٠ فمحي رخ ئ ض ئ ج ح ال ظم قط ٠ظعر جزجحء يذح ش١ ور١ز فظم ح غ
خ١ز فم١ز يشص ئ57فححء جع جذ وح جإ ٠ع١ش ذ. وح لزذح
“.ج١ظ: ح ضمع ذوز، وح جمي ف١ ذحؽ وحز
ج١يي –ويح لزذييح جظيي١ع كييع يي جظييال: جىي58جطييططحر يشييرحق: فييحؽز جكظيي
ر ضمطزخ ئ – هللا جكظ١ كظ. فىحص يس و لزذحح ذح خف ر١يح ف١يح –جش ؾح لي جظ١ع جظ١ف ف جمزذح: ذج ك فى ذج دي فحشيزذ، فعي ذيه: يذج – فأ
جطكج ذحطض ] ف ىض، ع ل: 172ك ي “ يذج دي فحشيزذ”[ ضظزقج ج ؽحجس جظرز جزت١س *ضك ١ جك١حز ج٤ذع٠س*.ي دج
59
جرحخ جكحد جشز ف عزفس ج١ى جذذف
١ى ػ ج ج١ى جذ وح ج١ لزذح حذ١ وح ج١ى طظ، و جذذف ج١حو طظ جظطز جذ ٠ظطز
60 ٠ذجع ذ ج ذ ج١ى ػ ج جرحؽ جذ ال ٠ى ي
ؤص ج٥، ٠ى ظطرج جمزذح جذ فق ج١ى ف جش ض جذرؤص ج٤شحد ر ج طحقد جىشف جذ ٠ؿع جحص ج وس ػ طز ج جحص ذؿع جمزذح، جظ
٠ى جحص لع ضشطص ش ٠ى جكى١ هللا جقعز عزفس ج٤سي ذعع ي61 جع ١.
جرحخ جػح جشززؼ جمحد٠ف عزفس ذحؽ جظ
ح جمحد٠ ف جر جيذ ٠ يز يع جيع ي جير ج٤قيع ] [ ضعيح ذويز، 173ي
رج ذ١يش طيالضى ضعيز ليذى”لع لحي جظ١ع جظ١ف: ليع يشيعص جظيحر جمحد٠ي “
ف جلرجس: ك د.55
٠ لحي جظ رذ ي ٠ع٠ طجءجظر١.ضؼحف ف جلرجس: ح ضؾ ضمحء ع 56
.24 -23 –جمظض 57
ف جلرجس: ج١. 58
١ظص ؾدز ف جلرجس. 59
ف جلرجس: ططز. 60
ضؼحف ف جلرجس: جع. 61
Annunziata RUSSO
262
جد ذذه: يؽ١عج يطكحخ مححش ف جر١ص ٠عزفج ذحؽ جمي جظ١ع جظ١ف، ئح ير
ر لذى ذكىط. جر جذ٠ ذ١ش جظالز ض
جرحخ جػحع جشز
ف عزفس ذحؽ جعد٠س
، ٤ي ئذج ٠ظيف ج جك١حز جعجتس، عزفس جإ جرضميحؤ ئي ي ػ جعد٠س
ح جعد٠س ف جي شي١ة. ليع ويح جظي١ع طفح ال ٠ش يذعج. ي جريحؽ جيذ ذي ق١يحز وي
جيير يجيي ييح يوييز جييالدز، جقطؿييد ذييأ ييي ج ييحز “ ٠قييح جعييعج”جظيي١ف ي
يػال جذ جزف يق١ح جك١يحز ج٤ذع٠يس، ؾعي جش٠يص ج ج ػ حز ذحؽح، ي
هللا يير جظييحجش ”جر، يال ضييز ئيي ليي ضعييح: جيي رـ جمييعص جطيي ذييح ي١ييزش ج٤يي
ر وشىحز ػ ف١ح ظرحـ جظرحـ ف سؾحؾيس جشؾحؾيس وأيح وويد [ 174]ج٤رع
در ٠لع شؿزز رحروس س٠طس ال شزل١س ال زذ١س ٠ىحد س٠طح ٠ؼة ضظظ يحر
شيء جي١ر ج ر ٠ع هللا ر ٠ “شحء ٠ؼيزخ هللا ج٤ػيحي يحص هللا ذىي62
فحمعص كع جزـ طظ،63 جزـ جعرزز ج جمعص.
ح يوز جالدز، جفيطف ذيحخ في جظيحء شيص ي ٠يع قطي ديص ي جظي١ع ي ر
ر ف فظ ح ير، لحي كجر١٠: ج عج لذى ضظج ئ جك١حز ج٤ذع٠س.جظ١ف، فأ
جرحخ جزجذع جشز
ف عزفس جظرز جر١عس
ج٤جي ػي يح ج ح ويز ذي جظي١ع جظي١ف، ي ػ جظرز جط ضى ف جر١عس
شيء، ي ] جي جريحخ جيذ ي يحدز وي [ جيذ يع 175ور ف ج٤لح١ جر١عس ػي
إ١ ذحع جرحؽ١س ط١عح جظ١ف ج64 جظال جزقس.
جرحخ ج حض جشز
ف عزفس جرز جر ر
يح يي ويز جظي١ع جظي١ف وحز ذه ي جرز ذحؽ ج ١ خل١ز ٠كظ65 ي ي
ر يزز ي إيإز ذ١ؼيحء ي جش١س ف ٠ع ح طظيس ي ٠يحلش جر وح ؾرزجت١ ٠م و
يقز ف١ح حر ر جمعص ذ ير ي ؾيس جفيزدص،66 جير جظي١عز جمعطي١س ف١ر يز ي
ح وز جظ١ع جظ١ف لحي كيجر١٠: جرفعيج جيعخحخ١ في ذ١يش جميزجذ١، يلزيج جير ف
ج *ج جظ١عز ز٠، جرحخ جيذ ف١ي ػي ي جير جيذ ويز يح، ذحر ر, جرز ػ
جر ر جرز*67 ج جل١د جذ يوز ذيح يويز جظي١ع جظي١ف ي عزفيس عيح ػ
ضعح ذوز.
- 35 -جر 62
١ظص ؾدز ف جلرجس. 63
١ظص ؾدز ف جلرجس. 64
ف جلرجس: يوز. 65
ؾدز ف جلرجس. ١ظص 66
١ظص ؾدز ف جلرجس. 67
L’Epistola sul Messia. Introduzione, traduzione e commento
263
[ جرحخ جظحدص جشز176]
ف عزفس ذحؽ ج٤ج١حد
ج٤ج١ييحد ييح ذييحؽ شييز٠ف جيي ل١ييف يي: ج١ييع جظييالق، جغلييحص، جم١ييس، ج١ييع
ىحت١، ج١ع جظيرش، يأرخ يز٠، ج١يع ٠ي جزليحع، ج١يع جشيعح١، ؾرزجت١ ج١ع ١
ج١ع جحر، جحر جؿع٠عز جفظف؛ فإالء جغح جشز ج١عج ورحرج دجخيس في يج١يحد جشيعجء
جظي١ع يه هللا ي جظي١ف وحيص ي ١ريحش ير ي ويحز ج رز ذيذه في ذحؽيح: ججي رق
ويير يشيرحق ذحؽي ذحالر ئي يير جاليش، ويح فيي وي ضفييحع ئي جىيش رؾجيي
وير ٠يح ٠غ١ري ٠ظيطز ف١ؿعي ىي ٠ ز ذعع ١رط ف طرز ي طير جكيجر١٠ غي
ج١ع ي يذ ذه ج١ ج١عج ع جع١ع جدز جظ١ع جظ١ف ذعع جىشف، و ج ١ح ٠ظ
.ج٤ج١حد ف ور جظ١ع جظ١ف
[ جرحخ جظحذع جشز177]
ذحؽ ٠ ج٤قع ف عزفس
ج رد، ج١ي جيذ ٠ ج٤قع ػ يلك هللا ذطق١ع ظحه، يحر ذع ؾحه ئ
ذعج ف١ جظ١ف، ٠ جعج، طحقد جىزجش ئ١ ع ج٦شيحرجش، ي ٠ ي68ي
شيء ال ٠طظي ذيح شيء، ٤يح ي جضظي ذيح شيء ىح في وحشيض جطي ضطظي ذىي
شء ال ٠م ٤قطزلط ذ١د رح. ع ضطظ ذى شء ٠ع قزح ج و69ج١يح
ججقيع ي جي ئ٠ؿيحد عيح ي يقيع ال جقيع، ٤ ٠ي ج٤قيع ػي ؾز. ؾ رخز: ئ
رييع يي جمييعرز ي٠ييع ذحكىييس ، يي جىييس جطحييس، جييزـ جمعطيي١س جىييس جظيي١ع جظيي١ف ي
يز ذطع ي١ جير جيذ ويز ي ح وز حص ف١يح ذ١ي ي جر، ف ج٤س١س يمحح ج ي
ف١، جحرز جر١عس س٠طح ض٠زح ئلحس جطمع٠ض ف١يح. ئذج ويح ٠ي وير، في جيزف
[ ٠عزف 178جذزج١١ح، ط٠ح، ظ١ك١ح، كع٠ح، ]ذحؽح وح رد١ح، لعط١ح، ق١ح،
ذه وح رد١ح فمؾ.
جرحخ جػح جشز
ج ذذج جالط؟ ط ف عزفس جشعجء
ج شعجء ئح ط70٤ شحعج جظ١ع جظ١ف ي جإ٠ع جشيطك ي جير ج٤ج ي.
قييح، يلييزج يي، وييز يي فيي جرشييز٠س فييح يىييز، ؾيي رخييز: ييي شييحع فيي جز
ض يرجي لعرضي جظ١ع ج١ ئ١ جطظ١ يشع وز فحططكمج ذذه ذج جالط. ؾ رخز: ئ
، ذ جمطي جليع ذأػيعجد، عج ذحكك. ؾ رخز: ج جططشعج لطج ح ظ جمط فش
جذ٠ لطج ف طر١ هللا يجضح ذ يق١يحء جيع رذي ” ضعح: ٠ؿ ج م ال ضكظر
طعق هللا جع جع ١.“. ٠زسل71
ف جلرجس: ٠ك. 68
ف جلرجس: ٠م. 69
ف جلرجس: ذذج جالط. 70
١ظص ؾدز ف جلرجس. 71
Annunziata RUSSO
264
ص ذع ضعح جح٠ط جزطحس جظ١ك١س مال ج خؾ جظ١ع كع جل١يس ؽزؽيص –ض
١يز عفي هللا ذ ؾ جفم –ذشرل –جذ ذوز ي م ج خؾ جش١ ج١ظ ج ج١ظ –
دجحء جخج جإ١ شعرح ج شيعرح جي طيحف قظي جقيع كيع يخ / في ٠ي
١الد٠ييس فعييح هللا ذييح ۱٢۱رخ ؿز٠ييس ججفييك كييز ٢جالرذعييحء ججلييع فيي
جإ١.
ABSTRACT
The paper aims at presenting the ‘alawite work al-Ris…la al-Mas†|iyya (The
Epistle on Messiah), ascribed to Mu|ammad b. ‘Al† al-ßill† (320-399/932-
1009). It is realized on a manuscript whose copy is made up of 18 chapters translated into Italian language and supplied with a comment and the analy-sis of some relevant themes peculiar to the work by contextualizing its con-tent and pointing out some synergies between the ‘alawite context and other different milieux (duodeciman shi‘a, isma‘ilites, judeo-christianismus tradi-tion about Verus Propheta).
RÉSUMÉ L’article présente l’œuvre intitulée al-Ris…la al-Mas†|iyya (Épître sur le
Messie) et attribuée à l’‘alawite Mu|ammad b. ‘Al† al-ßill† (320-399/932-1099). Ce travail a été réalisé d’après un manuscrit dont la copie est consti-tuée de 18 chapitres traduits par mes soins en Italien. Ils sont suivis d’un
commentaire et de l’analyse d’un certain nombre de thèmes principaux et ca-ractéristiques de cette œuvre à travers la mise en contexte de son contenu et le repérage de synergies existant entre le contexte ‘alawite et d’autres milieux de l’époque (shi‘isme duodécimain, ismaélisme, tradition judéo-chrétienne relative au Verus Propheta).