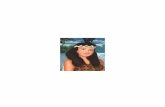Commento all'articolo 103 TFUE
Transcript of Commento all'articolo 103 TFUE
Le disposizioni di attuazione delle norme antitrust dell’UE(art. 103 TFUE)
Norma di riferimento: art. 103 TFUE (ex art. 83 TCE).........................................................................................................................................................................................
103 [1] I regolamenti e le direttive utili ai fini dell’applicazione dei principicontemplati dagli articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio, su proposta
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.[2] Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:a) garantire l’osservanza dei divieti di cui all’articolo 101, paragrafo 1, e all’articolo 102,comminando ammende e penalita di mora;b) determinare le modalita di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, avendo riguardoalla necessita di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, perquanto possibile, il controllo amministrativo;c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delledisposizioni degli articoli 101 e 102;d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea nell’applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo;e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni dellapresente sezione nonche quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall’altra.
Riferimenti normativi: artt. 3, 202 TCE, art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell’UE; artt. 5, 6,13, 16, 17, 19 TUE; artt. 3, 42, 43, 81, 83, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 218, 257, 261,263, 288, 289, 290, 291, 297, 300, 304, 307, 346, 352 TFUE; Protocollo n. 1, n. 2, n. 3, n. 27;Reg. CEE 6.2.1962, n. 17/62; Reg. CEE 4.4.1962, n. 26/62; Reg. CEE 2.3.1965, n. 19/65; Reg.CEE 19.7.1968, n. 1017/68; Reg. CEE 22.12.1986, n. 4056/86; Reg. CEE 14.12.1987, n. 3975/87; Reg. CEE 21.12.1989, n. 4064/89; Reg. CE 16.12.2002, n. 1/2003; Reg. CE 20.1.2004,n. 139/2004; Reg. CE 26.2.2004, n. 411/2004; Reg. CE 24.7.2006, n. 1184/2006; Reg. CE25.9.2006, n. 1419/2006; Reg. CE 26.2.2009, n. 246/2009.
Bibliografia: Bechtold, Brinker, Bosch, Hirsbrunner (a cura di), EG-Kartellrecht Kommentar,Munchen, 2007; Bellamy, Child, European Community Law of Competition, 6a ed., Oxford,2008; Blasi, Munari, sub artt. 84 e 85 Trattato CE, in Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unioneeuropea e della Comunita europea, Milano, 2004; Canino, La cooperazione internazionale, inTosato, Bellodi (a cura di), Il nuovo diritto europeo della concorrenza. Aspetti procedurali,Milano, 2004; Constantinesco, Jacque, Kovar, Simon (a cura di), Traite instituant la CEE.Commentaire article par article, Paris, 1992; Daniele, Diritto dell’Unione europea, 2a ed., Milano,2007; De Smijter, Kiølbye, The enforcement system under regulation 1/2003, in Faull, Nikpay (acura di), The Ec Law of Competition, 2a ed., Oxford, 2007; de Witte, Legal instruments and law-making in the Lisbon Treaty, in Griller, Ziller (a cura di), The Lisbon Treaty. EU constitutio-nalism without a Constitutional Treaty?, Wien, 2008; Di Federico, Diritto comunitario antitrust:procedimento amministrativo e prerogative della difesa, Bologna, 2008; Drauz, Introduction, inDrauz, Jones (a cura di), EU Competition Law, II, Mergers and acquisitions, Leuven, 2006;Draetta, sub art. 87 Trattato CEE, in Quadri, Monaco, Trabucchi (a cura di), Commentarioal Trattato istitutivo della Comunita economica europea, II, Milano, 1965; Fonderico, sub art. 83Trattato CE, in Ubertazzi (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprieta intellettuale econcorrenza, 4a ed., Padova, 2007; Gaja, sub art. 6, in Adinolfi, Daniele, Nascimbene, Amadeo
(a cura di), L’applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Commentario al regolamento(CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, Milano, 2007; Gimeno-Verdejo, sub art. 83,
103 Parte I - Tutela della concorrenza
136
in Leger (a cura di), Commentaire article par article des traites UE et CE, Paris, 2000; Kerse,Khan, EC Antitrust Procedure, 5a ed., London, 2005; Komninos, The EU White Paper fordamages actions: a first appraisal, in Concurrences, 2008, 2; Kovar, Code europeen de la Concur-rence, 2a ed., Paris, 1996; Jones, Sufrin, EC Competition law. Text, cases, and materials, 3a ed,Oxford, 2008; Lane, EC Competition Law Post-Lisbon: a matter of Protocol, in Bulterman,Hancher, McDonnell, Sevenster (a cura di), Views of European Law from the Mountain. LiberAmicorum Piet Jan Slot, The Hague, 2009; Lenaerts, Desomer, Towards a hierarchy of legal actsin the European Union?: simplification of legal instruments and procedures, in European lawjournal: review of European law in context, 2005, 6; Liisberg, The EU Constitutional Treatyand its distinction between legislative and non-legislatives acts – Oranges into apples?, Jean Mon-net Working Paper 01/06, NYU School of law, 2006; Marino, sub art. 36, in Adinolfi, Daniele,Nascimbene, Amadeo (a cura di), L’applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Com-mentario al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, Milano, 2007;Milutinovic, Enforcement of Articles 81 and 82 EC before National Courts Post-Courage: En-hancing a Community Policy or Shifting a Community Law Paradigm?, Thesis of the EuropeanUniversity Institute, Firenze, 2008; Moavero Milanesi, Diritto della concorrenza dell’Unioneeuropea, Napoli, 2004; Neri, Sperl, Traite instituant la Communaute economique europeenne.Travaux preparatoires. Declarations interpretatives des six gouvernements. Documents parlemen-taires, Luxembourg, 1960; Nucara, I regolamenti di esenzione, in Tosato, Bellodi (a cura di), Ilnuovo diritto europeo della concorrenza. Aspetti procedurali, Milano, 2004; Pace, Diritto europeodella concorrenza. Divieti antitrust, controllo delle concentrazioni e procedimenti applicativi, Pa-dova, 2007; Id., I fondamenti del diritto antitrust europeo. Norme di competenza e sistemaapplicativo dalle origini alla Costituzione europea, Milano, 2005; Pappalardo, Il diritto comuni-tario della concorrenza. Profili sostanziali, Torino, 2007; Pocar (a cura di), Commentario breve aitrattati della Comunita e dell’Unione europea, Padova, 2001; Rapp-Jung, sub art. 83 Trattato CE,in Hirsch, Montag, Sacker (a cura di), Munchner Kommentar zum Europaischen und DeutschenWettbewerbsrecht (Kartellrecht), Munchen, 2007; Ritter, Braun, European competition law: apractitioner’s guide, 3a ed., The Hague, 2004; Schulze, Hoeren (a cura di), Dokumente zumEuropaischen Recht (Band 3) – Kartellrecht (bis 1957), Berlin, 2000; Schepisi, sub art. 31, inAdinolfi, Daniele, Nascimbene, Amadeo (a cura di), L’applicazione del diritto comunitario dellaconcorrenza. Commentario al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002,Milano, 2007; Smit, Herzog (a cura di), Smit & Herzog on The Law of the European Union,Newark, 2005; Stancanelli, Le systeme decisionnel de l’Union, in Amato, Bribosia, De Witte (acura di), Genese et destinee de la Constitution europeenne, Bruxelles, 2007; Tesauro, Dirittocomunitario, 5a ed., Padova, 2008; Van Solinge, Les procedures de decision, in Dony, Bribosia (acura di), Commentaire de la Constitution de l’Union europeenne, Bruxelles, 2005; Wils, Iscriminalization of EU competition law the answer?, in Cseres, Schinkel, Vogelaar (a cura di),Criminalization of competition law enforcement, Northampton, 2006; Wouters, Coppens, De
Meester, The European Union’s External Relations after the Lisbon Treaty, in Griller, Ziller (acura di), The Lisbon Treaty. EU constitutionalism without a Constitutional Treaty?, Wien, 2008..........................................................................................................................................................................................Sommario: 1. Introduzione. 2. Inquadramento storico-sistematico dell’art. 103. 3. Oggetto elimiti del potere normativo del Consiglio ai sensi dell’art. 103. 4. La portata non esaustiva dell’art.103 quale base giuridica in materia di concorrenza. 5. Regolamenti e direttive in materia diconcorrenza: natura giuridica e procedure di adozione. 6. Ammende e penalita di mora (art.103, par. 2, lett. a). 7. Modalita di applicazione dell’art. 101, par. 3, TFUE (art. 103, par. 2, lett.b). 8. La regolamentazione dei vari settori economici (art. 103, par. 2, lett. c). 9. La definizionedei rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 103,par. 2, lett. d). 10. Il rapporto tra diritto antitrust dell’UE e normative di concorrenza degli Statimembri (art. 103, par. 2, lett. e). 11. L’art. 103 TFUE quale possibile base giuridica per l’ado-
Le disposizioni di attuazione delle norme antitrust dell’UE 103
137
zione di disposizioni in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle normeantitrust dell’UE. 12. Gli accordi internazionali in materia di concorrenza..........................................................................................................................................................................................
1. IntroduzioneA Oggetto dell’art. 103 TFUE (ex art. 83TCE e, prima ancora, art. 87 Trattato CEE)e l’adozione di tutti i regolamenti o tutte ledirettive utili ai fini dell’applicazione dei prin-cipi sanciti dagli artt. 101 e 102 TFUE (ex artt.81 e 82 TCE e, prima ancora, artt. 85 e 86Trattato CEE), ossia delle regole di concor-renza dell’UE applicabili alle imprese (C.Giust. CE, 19.3.1991, C-202/88, par. 24).Il potere di adottare tali atti e conferito alConsiglio, su proposta della Commissione eprevia consultazione del Parlamento europeo.L’articolo in commento costituisce dunque laprincipale base giuridica (o fondamento giuri-dico) per l’UE per l’adozione delle disposizio-ni applicative delle norme antitrust contenutenel Trattato. In materia di aiuti di stato, esisteuna norma analoga, l’art. 109 TFUE (ex art.89 TCE), che attribuisce al Consiglio la com-petenza ad emanare, sempre su proposta dellaCommissione e previa consultazione del Par-lamento europeo, tutti i regolamenti utili aifini dell’applicazione degli artt. 107 e 108TFUE (ex artt. 87 e 88 TCE).Le finalita da perseguire mediante l’adozionedi tali atti sono indicate nell’art. 103, par. 2,TFUE e riguardano, in particolare, la necessitadi garantire l’osservanza dei divieti di cui al-l’art. 101, par. 1, e all’art. 102 TFUE, commi-nando ammende e penalita di mora [sub lett.a)]; di determinare le modalita applicative del-l’art. 101, par. 3, TFUE [sub lett. b)]; di pre-cisare il campo di applicazione degli art. 101 e102 TFUE, con riguardo ai vari settori econo-mici [sub lett. c)]; di definire i rispettivi com-piti della Commissione e della Corte di giusti-zia UE [sub lett. d)] e di definire i rapporti trale legislazioni nazionali e le norme UE in ma-teria antitrust [sub lett. e)].B Si tratta di un elenco che non e tassativone vincolante per il Consiglio. Peraltro, allematerie elencate nel par. 2 dell’articolo incommento, che dovrebbero formare oggettodella regolamentazione applicativa, non spettaalcun diritto di precedenza o priorita. Il Con-
siglio puo disciplinarle tutte o solo una parte,e puo disciplinarne anche altre prima di averprovveduto a quelle elencate nell’art. 103, par.2 [Draetta, sub art. 87 Trattato CEE, in Qua-
dri, Monaco, Trabucchi (a cura di), Com-mentario al Trattato istitutivo della Comunitaeconomica europea, II, Milano, 1965, 648].Come si vedra meglio in prosieguo, sul fonda-mento dell’articolo in commento sono statiadottati una serie di regolamenti relativi all’ap-plicazione delle regole di concorrenza. Si trat-ta, anzitutto, del Reg. CEE 6.2.1962, n. 17/62,primo regolamento d’applicazione delle nor-me comunitarie di concorrenza, poi sostituitodal Reg. CE 16.12.2002, n. 1/2003, concer-nente l’applicazione delle regole di concorren-za di cui agli [ex] artt. 81 e 82 TCE, checostituisce oggi la chiave di volta del sistemadi applicazione delle norme europee di con-correnza. Sulla base dell’art. 103 TFUE sonostati poi adottati regolamenti settoriali noncheregolamenti di esenzione per categoria (v. in-fra, sub par. 7). L’articolo in commento hacostituito inoltre la base giuridica, in combi-nazione con altre disposizioni del Trattato, perl’adozione di altri atti normativi in materia diconcorrenza, quali, segnatamente, il Reg. CE20.1.2004, n. 139/2004, relativo al controllodelle concentrazioni tra imprese (e ancor pri-ma il Reg. CEE 21.12.1989, n. 4064/89,v. infra, sub par. 4), nonche per la conclusionedi accordi internazionali tra Comunita e Statiterzi (v. infra, sub par. 12). Fanno eccezione iregolamenti riguardanti l’agricoltura che sonostati adottati sul fondamento degli odierni artt.42 e 43 TFUE (ex artt. 36 e 37 TCE, v. infra,sub par. 8).
2. Inquadramento storico-sistematicodell’art. 103Gli autori del Trattato prefigurarono, sin dallaprima stesura, due differenti sistemi alternati-vi di applicazione degli attuali artt. 101 e 102.B Il primo sistema, il principale, fondato sul-l’attuale art. 103, doveva essere definito daparte del Consiglio su iniziativa della Commis-
103 Parte I - Tutela della concorrenza
138
sione mediante l’adozione di atti di c.d. dirittoderivato, ossia regolamenti o direttive. Talesistema e stato realizzato mediante l’adozionedapprima del Reg. CEE n. 17/62 e successi-vamente del Reg. CE n. 1/2003 (per una rico-struzione accurata dell’evoluzione del sistemadi tutela antitrust disciplinato dai predetti re-golamenti, v. Pace, I fondamenti del dirittoantitrust europeo. Norme di competenza e siste-ma applicativo dalle origini alla Costituzioneeuropea, Milano, 2005).Nel contempo, il Trattato prevedeva – e pre-vede tuttora – agli attuali artt. 104 e 105TFUE (ex artt. 84 e 85 TCE e, prima ancora,artt. 88 e 89 Trattato CEE) un sistema alter-nativo, di carattere residuale, valido sino almomento e nella misura in cui mancassero ledisposizioni adottate ex art. 103, in grado digarantire la concreta applicazione delle regoledi concorrenza alle imprese sin dall’entrata invigore del Trattato medesimo [Fonderico,sub art. 83 Trattato CE, in Ubertazzi (a curadi), Commentario breve alle leggi su proprietaintellettuale e concorrenza, 4a ed., Padova,2007, 2501; Blasi, Munari, sub art. 84-85Trattato CE, in Tizzano (a cura di), Trattatidell’Unione europea e della Comunita europea,Milano, 2004, 574]. Tale sistema, che prevedeuna ripartizione delle competenze applicativedelle regole di concorrenza fra la Commissio-ne e le autorita degli Stati membri, essendodisciplinato, come detto, dagli artt. 104 e105 TFUE, e ampiamente esaminato nei com-menti relativi a tali disposizioni (v. commentisub art. 104 e sub art. 105 TFUE).La scelta di prevedere un sistema d’applicazio-ne delle norme comunitarie antitrust diretta-mente nel Trattato e di demandare al legisla-tore comunitario l’adozione delle disposizionidi applicazione degli allora artt. 85 e 86 Trat-tato CEE (oggi artt. 101 e 102 TFUE) fu es-senzialmente il frutto di un compromesso.Di tale compromesso si rese artefice il tedescoHans von der Groeben (tra i redattori dellac.d. Relazione Spaak e futuro primo direttoredella DG Concorrenza della Commissione), ilquale presiedeva il sottogruppo ‘‘MercatoUnico’’ competente per il diritto della concor-renza. Fu in tale veste che egli propose di
rinviare la decisione che era all’origine dellasituazione di stallo determinatasi tra le delega-zioni degli Stati partecipanti ai negoziati per laconclusione del Trattato CEE, vale a dire laquestione delle modalita di applicazione del-l’autorizzazione dell’allora art. 85, par. 3, Trat-tato CEE (ora art. 101, par. 3, TFUE), ad unregolamento successivo alla firma del Trattatostesso (Pace, I fondamenti, 96-99).In forza di tale compromesso, si stabilı chel’art. 85 Trattato CEE (ora art. 101 TFUE) –e, in particolare, il suo par. 3 –, analogamenteall’art. 86 Trattato CEE (ora art. 102 TFUE)sarebbe stato applicato, fino al momento del-l’entrata in vigore delle disposizioni adottate inapplicazione dell’articolo in commento, «dalleautorita degli Stati membri (...) in conformitadel diritto nazionale interno» (v. commento subart. 104 TFUE), in modo da lasciare tempora-neamente a questi ultimi la scelta delle moda-lita di applicazione dell’eccezione prevista dal-l’allora art. 85, par. 3 [Schulze, Hoeren (acura di), Dokumente zum Europaischen Recht(Band 3) – Kartellrecht (bis 1957), Berlin, 2000,XXVII e XXXI; Neri, Sperl, Traite instituantla Communaute economique europeenne. Tra-vaux preparatoires. Declarations interpretativesdes six gouvernements. Documents parlementai-res, Luxembourg, 1960, 211-221; Pace, Dirittoeuropeo della concorrenza. Divieti antitrust, con-trollo delle concentrazioni e procedimenti appli-cativi, Padova, 2007, 74-75 e 347].E opportuno inoltre rammentare che, nellaversione dell’articolo in commento precedentealle modifiche introdotte dal Trattato di Am-sterdam era previsto che il Consiglio, con de-liberazione unanime, sempre su proposta dellaCommissione e previa consultazione del Par-lamento, dovesse emanare disposizioni appli-cative degli allora artt. 85 (ora 101) e 86 (ora102) entro tre anni dall’entrata in vigore delTrattato (vale a dire entro il 31 dicembre1960). Qualora tali disposizioni non fosserostate adottate entro il suddetto termine (comeeffettivamente si verifico), il primo capoversodell’articolo prevedeva che il Consiglio potessedeliberare a maggioranza qualificata.Cio nonostante, il primo regolamento aventecome base giuridica l’articolo in commento,
Le disposizioni di attuazione delle norme antitrust dell’UE 103
139
ossia il Reg. CEE n. 17/62 (intitolato, per l’ap-punto, «Primo regolamento d’applicazionedegli articoli 85 e 86 del trattato»), fu adottatodal Consiglio con deliberazione unanime(Draetta, 647).Il Trattato di Lisbona non ha apportato par-ticolari modifiche all’enunciato del vecchioart. 83 TCE, fatti salvi gli inevitabili adatta-menti terminologici e di coerenza alla nuovasistematica d’insieme, tra i quali i rinvii aggior-nati alle altre disposizioni del Trattato sul fun-zionamento dell’Unione europea in esso ri-chiamate. Va, in particolare, evidenziato chel’art. 103 TFUE non contiene alcun riferimen-to al tipo di maggioranza necessaria per ladeliberazione da parte del Consiglio (contra-riamente all’ex art. 83 TCE, che prevedevaespressamente il requisito della maggioranzaqualificata). Tale soppressione altro non eche l’adattamento del testo al nuovo art. 16,par. 3, TUE, il quale, stabilendo che il Consi-glio delibera a maggioranza qualificata, salvonei casi in cui i trattati (TUE o TFUE) dispon-gano diversamente, ha reso superflua una sif-fatta precisazione nell’articolo in commento
3. Oggetto e limiti del potere normativo delConsiglio ai sensi dell’art. 103L’art. 103 TFUE attribuisce espressamente alConsiglio, come si e visto, il potere di adottarei regolamenti e le direttive utili ai fini dell’ap-plicazione dei principi contemplati dagli artt.101 e 102 TFUE. In virtu di tale articolo, ilConsiglio e dunque abilitato ad adottare siaregolamenti che direttive (che possono esserequalificati come atti legislativi, a norma del-l’art. 289 TFUE, solo se adottati medianteprocedura legislativa, sia questa ordinaria ospeciale; v. infra, sub par. 5).Ai sensi dell’art. 288 TFUE (ex art. 249 TCE),il regolamento ha portata generale, e obbliga-torio in tutti i suoi elementi e direttamenteapplicabile in ciascuno degli Stati membri,mentre la direttiva vincola gli Stati membricui e rivolta per quanto riguarda il risultatoda raggiungere, lasciando a questi ultimi unambito di discrezionalita nella scelta dei mezzie della forma piu adatti a conseguirlo entro itempi previsti dalla direttiva stessa.
Il Consiglio dispone di una certa discreziona-lita nello scegliere se utilizzare la forma delregolamento o della direttiva per l’adozionedelle disposizioni applicative delle norme anti-trust. Tale scelta implica peraltro una serie diconseguenze importanti in relazione al ruolodegli Stati membri e delle istituzioni dell’Unio-ne nell’elaborazione e applicazione della nor-mativa in questione. Il legislatore UE devequindi valutare caso per caso, secondo la suadiscrezionalita, se l’obiettivo da perseguire inconcreto possa essere meglio raggiunto attra-verso l’adozione di un regolamento, quindimediante disposizioni uniformi direttamenteapplicabili in tutta l’Unione, oppure per mez-zo di una direttiva che lasci ai singoli Statimembri la scelta degli strumenti legislativipiu opportuni per perseguire l’obiettivo inquestione.Un regolamento e, per definizione, piu ade-guato di una direttiva per contribuire adun’applicazione omogenea e unitaria del dirit-to europeo della concorrenza. E per questaragione che gli atti normativi adottati sinoradal Consiglio (sin dal primo di essi, ossia ilReg. CEE n. 17/62), in virtu dei poteri confe-ritigli dall’attuale art. 103, hanno sempre avu-to la veste giuridica del regolamento.B Come ricorda Draetta, 647, la scelta diadottare il primo atto normativo, avente comebase giuridica l’articolo in commento, sottoforma di regolamento fu determinata non solodalla valutazione che un regolamento era ingrado di garantire quella applicazione assolu-tamente uniforme degli allora artt. 85 e 86Trattato CEE (ora artt. 101 e 102 TFUE) intutti gli Stati membri, che una direttiva, inve-ce, non avrebbe assicurato, ma anche dallaconsapevolezza che, stante la disparita o addi-rittura la carenza delle disposizioni in tema diconcorrenza nei vari Stati membri, una diret-tiva si sarebbe rivelata uno strumento partico-larmente inidoneo dal momento che la suatrasposizione negli ordinamenti nazionali av-viene per il tramite di strumenti normativi sta-tuali.Con il Reg. CE n. 1/2003, il Consiglio ha con-fermato tale approccio scegliendo nuovamentedi usare un regolamento per l’adozione di di-
103 Parte I - Tutela della concorrenza
140
sposizioni applicative degli allora artt. 81 e 82TCE (ora artt. 101 e 102 TFUE). Cio ha avutocome conseguenza un’ulteriore estesa unifor-mizzazione dell’applicazione delle norme comu-nitarie di concorrenza che ha avuto anche unimpatto sui vari diritti nazionali della concorren-za (v., in particolare, commento sub art. 2, Reg.CE n. 1/2003).Se il Consiglio, come si e detto, dispone di unacerta discrezionalita nella scelta della formagiuridica delle disposizioni di applicazionedelle regole europee di concorrenza, nondime-no il potere normativo conferitogli dall’art.103 non e illimitato ma, come si desume daltesto stesso di tale articolo, e vincolato all’a-dozione di disposizioni «utili ai fini dell’appli-cazione dei principi contemplati dagli articoli101 e 102». A tale riguardo, occorre rilevareche una disposizione deve considerarsi «utile»allo scopo, ai sensi dell’articolo in commento,se e oggettivamente idonea a contribuire al-l’applicazione dei divieti contenuti negli artt.101 e 102 TFUE o all’interpretazione unitariadegli elementi delle fattispecie previste in talidue articoli. Il potere normativo del Consiglionell’adozione di tali disposizioni e pertantolimitato dal solo contenuto materiale degliartt. 101 e 102.In dottrina e stato rilevato che il Consigliodispone pertanto di un margine di discrezio-nalita molto ampio nell’elaborazione di dettedisposizioni applicative [Rapp-Jung, sub art.83 Trattato CE, in Hirsch, Montag, Sacker
(a cura di), Munchner Kommentar zum Euro-paischen und Deutschen Wettbewerbsrecht(Kartellrecht), Munchen, 2007, 1263 e dottri-na ivi citata].A D’altra parte, la Corte stessa ha avuto mo-do di precisare che l’«utilita» di cui all’attualeart. 103 TFUE puo anche riguardare un puntodeterminato, senza che il Consiglio sia tenutoad occuparsi interamente degli attuali artt. 101e 102 TFUE nel loro complesso (C. Giust.CE, 13.7.1966, 32/65).In definitiva, il Consiglio puo decidere, secon-do la sua discrezionalita, non solo se sia piuutile un regolamento o una direttiva allo scopoche intende perseguire, ma anche se in un de-terminato ambito sia necessaria una regolamen-
tazione esauriente e completa oppure se in unsingolo settore economico debba sussistere unaregolamentazione specifica per l’applicazionedelle norme antitrust (come e stato, ad es., ilcaso per il settore dei trasporti in cui per lungotempo e rimasta in vigore una normativa parti-colare di attuazione delle regole di concorren-za; v., in particolare, infra, sub par. 8).In ragione della limitazione del potere norma-tivo, derivante dal contenuto materiale degliartt. 101 e 102 TFUE, l’articolo in commentonon consente tuttavia al Consiglio di estendereo restringere l’ambito di applicazione dei pre-detti articoli con riferimento al loro contenutosostanziale o alla loro portata.In effetti, il Consiglio, qualora intenda perse-guire l’obiettivo di un ampliamento dell’ambi-to di applicazione del diritto antitrust europeosostanziale e intenda quindi modificare il con-tenuto e la portata degli artt. 101 e 102 TFUE,dovra servirsi di un fondamento giuridico ul-teriore rispetto a quello di cui all’art. 103TFUE (e stato il caso, in passato, del regola-mento sul controllo delle operazioni di con-centrazione tra imprese, v. infra, sub par. 4).B Come e stato correttamente rilevato daDraetta, 648, qualunque limitazione, restri-zione o relativizzazione della portata delle nor-me in materia di concorrenza non potrebbefondarsi sull’articolo in commento. Ad esem-pio, un regolamento che avesse per obiettivodi eliminare il gioco della concorrenza per undeterminato tipo di beni all’interno del merca-to interno o che sottraesse uno o piu settorieconomici alle regole di concorrenza non po-trebbe certamente fondarsi sull’articolo incommento. Per contro, le disposizioni di ap-plicazione emanate in forza di tale articolopossono prevedere una precisazione del con-tenuto o della portata delle norme sostanzialie/o procedurali di concorrenza dell’UE, oppu-re possono contenere una determinazioneesplicativa delle fattispecie cui tali disposizionipossono essere applicate (v. anche Rapp-Jung,1263). Secondo Pace, Diritto europeo, 53,inoltre, la chiarezza della sanzione previstadall’art. 101, par. 2, TFUE determina anch’es-sa una limitazione alla discrezionalita del Con-siglio riguardo al contenuto dei regolamenti o
Le disposizioni di attuazione delle norme antitrust dell’UE 103
141
delle direttive emanabili a norma dell’art. 103.Tali normative non possono, infatti, modifica-re le conseguenze dell’art. 101, par. 2, TFUE.
4. La portata non esaustiva dell’art. 103 qualebase giuridica in materia di concorrenzaCome gia precisato, l’articolo in commentocostituisce la principale base giuridica per l’U-nione europea per l’adozione delle disposizio-ni applicative delle sue norme antitrust.A Secondo la giurisprudenza, l’individuazio-ne della base giuridica e operata con riferi-mento agli elementi oggettivi e qualificantidell’atto normativo che siano suscettibili dicontrollo giurisdizionale, quali lo scopo e ilcontenuto dell’atto stesso (C. Giust. CE,29.4.2004, C-338/01, par. 54 ; C. Giust. CE,26.3.1987, 45/86, par. 12). Quando, ad esem-pio, l’atto investe piu settori occorre verificarese entrambi i profili sono essenziali ovvero sel’uno e principale o preponderante (il c.d.‘‘centro di gravita’’) e l’altro accessorio, al finedi stabilire se debbano utilizzarsi due basi giu-ridiche ovvero una sola (C. Giust. CE,28.6.1994, C-187/93, par. 23; C. Giust. CE,17.3.1993, C-155/91, parr. 19-21); ed e chiaroche, nell’ipotesi di piu basi possibili ma in-compatibili, sono gli elementi principali enon quelli solo accessori a determinare la basegiuridica (C. Giust. CE, 11.6.1991, C-300/89).Il cumulo di due basi giuridiche e tuttaviaescluso quando le procedure previste relati-vamente all’una e all’altra base giuridica so-no incompatibili (C. Giust. CE, 29.4.2004,C-338/01, par. 57).La scelta della base giuridica rileva sotto tredistinti profili. Il primo attiene alle competen-ze dell’UE, che almeno in via di principio so-no ispirate al criterio dell’attribuzione specifi-ca nei Trattati, fatta salva la previsione dell’art.352 TFUE (ex art. 308 TCE) [l’utilizzazionedi questa disposizione e consentita, secondo lagiurisprudenza, solo quando la competenza adadottare l’atto non possa fondarsi su alcun’al-tra disposizione (C. Giust. CE, 26.3.1996, C-271/94, par. 13); nonche quando i Trattatiindicano solo il fine da raggiungere e non con-feriscono all’Unione la competenza ad istituireun sistema per realizzarlo (C. Giust. CE,
18.11.1999, C-209/97, par. 33)]. Il secondoprofilo attiene al riparto di competenze trale diverse istituzioni secondo cui ciascuna svol-ge una propria specifica funzione nella strut-tura istituzionale dell’Unione e nella realizza-zione dei compiti affidatile (C. Giust. CE,2.3.1994, C-316/91, parr. 21-24).B Il terzo ed ultimo profilo, che ha dato luo-go ad un cospicuo contenzioso, e quello «pro-cedimentale», nella misura in cui la scelta del-l’una o dell’altra base giuridica puo implicareuna procedura diversa di formazione del con-senso in seno al Consiglio (unanimita o mag-gioranza, qualificata o semplice) e/o un diver-so coinvolgimento del Parlamento europeo(Tesauro, Diritto comunitario, 5a ed., Padova,2008, 154 ss.).In considerazione dei limiti al potere normati-vo attribuito al Consiglio dall’art. 103, cui si efatto cenno nel par. precedente, nel caso in cuiesso intenda adottare disposizioni che com-portano un’estensione dell’ambito di applica-zione delle norme in materia di concorrenza,l’art. 103 non costituisce una base giuridicasufficiente ex se, ma e necessario ricorrere aduna base giuridica ulteriore, il che implica pe-raltro la necessita di rispettarne le esigenzeprocedurali (v. infra, sub par. 5). Come si eaccennato, l’adozione del regolamento sulcontrollo delle concentrazioni fra imprese (ilReg. CEE n. 4064/89, poi abrogato e sostitui-to dal Reg. CE n. 139/2004), per il quale si efatto ricorso ad una doppia base giuridica,costituita dall’articolo in commento e dall’exart. 308 TCE (ora art. 352 TFUE), rappresen-ta un chiaro esempio di tal genere.A Al riguardo, va ricordato che il Trattatonon conteneva alcuna disposizione relativa alleconcentrazioni tra imprese. Di conseguen-za, sino all’entrata in vigore del Reg. CEEn. 4064/89, il controllo di tali operazioni av-veniva sulla sola base degli attuali artt. 101(v. C. Giust. CE, 17.11.1987, 142 e 156/84) e102 TFUE (C. Giust. CE, 21.2.1973, 6/72).Come precisato dal considerando 7, Reg. CEn. 139/2004 (che riproduce quasi alla lettera iconsiderando 7 e 8, Reg. CEE n. 4064/89),«gli articoli [101] e [102], pur potendo essereapplicati, secondo la giurisprudenza della Cor-
103 Parte I - Tutela della concorrenza
142
te di giustizia, a talune concentrazioni, nonsono sufficienti a controllare tutte le operazio-ni che rischiano di rivelarsi incompatibili conil regime di concorrenza non falsata contem-plato dal trattato». Per questa ragione e statonecessario introdurre un regolamento specifi-co volto a disciplinare, a livello comunitario, ilcontrollo preventivo delle operazioni di con-centrazione.B Per raggiungere siffatto obiettivo non ba-stava pero fondarsi sul solo articolo in com-mento, ma era necessario trovare un fonda-mento giuridico ulteriore in un’altra disposi-zione del Trattato, segnatamente nell’ex art.308 TCE (oggi art. 352 TFUE), ai sensi delquale la Comunita (oggi, l’Unione) puo dotarsidei poteri d’azione aggiuntivi necessari a rea-lizzare i suoi obiettivi [Drauz, Introduction, inDrauz, Jones (a cura di), EU CompetitionLaw, II, Mergers and acquisitions, Leuven,2006, 5]. A tale riguardo, Pace, Diritto euro-peo, 383 s., rileva che la decisione di fondare ladisciplina del controllo delle concentrazionisu una doppia base giuridica e stata determi-nata, da una parte, dalla necessita di prevedereuna misura che si applicasse anche a tipologiedi concentrazioni non rientranti nelle fattispe-cie di cui agli attuali artt. 101 e 102 TFUE e,dall’altra, dalla necessita di definire normati-vamente uno strumento che sarebbe stato ap-plicato esclusivamente, rispetto alle norme diconcorrenza previste dal Trattato, a tali fatti-specie.
5. Regolamenti e direttive in materia diconcorrenza: natura giuridica e procedure diadozionea) GeneralitaLa scelta della procedura decisionale dipendedalla base giuridica dell’atto che si intendeadottare, vale a dire dalla disposizione deiTrattati che attribuisce alle istituzioni UE ilpotere di adottare un determinato atto.Lasciando saldamente e prevalentemente nellemani della Commissione il potere di iniziativalegislativa (v. art. 17, par. 2, TUE), il Trattatodi Lisbona ha introdotto la distinzione tra pro-cedura legislativa ordinaria (art. 289, par. 1,TFUE) – che non differisce sostanzialmente
dalla vecchia procedura c.d. di codecisione –e procedura legislativa speciale (art. 289, par.2, TFUE), che e prevista dai Trattati in casispecifici e i cui meccanismi di funzionamentopossono variare in funzione della disposizioneche la prevede. I Trattati non offrono unadefinizione materiale degli atti legislativi, masi limitano a rinviare agli aspetti procedurali diadozione degli stessi. In particolare, ai sensidel par. 3 dell’art. 289 TFUE, sono consideraticome atti legislativi solo gli atti adottati me-diante procedura legislativa, sia essa ordinariao speciale. La nozione di atti non legislativinon e, per contro, definita nei Trattati (sebbe-ne gli artt. 290 e 297 facciano espresso riferi-mento ad essi), cosicche non puo che essereinterpretata in opposizione alla categoria degliatti legislativi.Tra gli atti non legislativi vanno sicuramenteannoverati i c.d. atti (regolamenti) delegati dicui all’art. 290 TFUE (a norma del quale«[u]n atto legislativo puo delegare alla Com-missione il potere di adottare atti non legisla-tivi di portata generale che integrano o modi-ficano determinati elementi non essenziali del-l’atto legislativo»), i quali sono concettualmen-te assimilabili mutatis mutandis ai decreti legi-slativi previsti dal nostro sistema costituziona-le. Sono inoltre, per definizione, atti non legi-slativi gli atti meramente esecutivi di cui al-l’art. 291 TFUE (la competenza di esecuzioneessendo di pertinenza generalmente dellaCommissione, e solo in casi eccezionali delConsiglio).b) Natura giuridica dei regolamenti e delledirettive di cui all’art. 103B Per quanto riguarda i regolamenti e le di-rettive stabiliti dal Consiglio in forza dell’art.103 TFUE, non essendo precisata in tale di-sposizione la procedura seguita per la loroadozione, non v’e alcun dubbio che si tratti,da un punto di vista formale, di atti non legi-slativi [de Witte, Legal instruments and law-making in the Lisbon Treaty, in Griller, Zil-
ler (a cura di), The Lisbon Treaty. EU consti-tutionalism without a Constitutional Treaty?,Wien, 2008, 100; Van Solinge, Les proceduresde decision, in Dony, Bribosia (a cura di),Commentaire de la Constitution de l’Union eu-
Le disposizioni di attuazione delle norme antitrust dell’UE 103
143
ropeenne, Bruxelles, 2005, 184-185; per unapproccio critico sul tema, in commento adanaloga previsione contenuta nel Trattatoche adotta una Costituzione per l’Europa del2004, meglio noto come ‘‘Costituzione euro-pea’’, mai entrato in vigore per via della dop-pia bocciatura referendaria franco-olandese, v.Lenaerts, Desomer, Towards a hierarchy oflegal acts in the European Union?: simplifica-tion of legal instruments and procedures, inEuropean law journal: review of Europeanlaw in context, 2005, n. 6, 754]. Lo stessodicasi, in materia di aiuti di stato, per i rego-lamenti del Consiglio attuativi degli artt. 107 e108 TFUE (ex artt. 87 e 88 TCE). Sul perchel’articolo in commento, analogamente all’art.109 TFUE per gli aiuti di Stato, non sia statoqualificato dagli autori del Trattato (recte dellaCostituzione europea) come base giuridicaavente una procedura legislativa speciale (e,di conseguenza, come atto legislativo) si inter-roga, avanzando alcune possibili risposte, Lii-
sberg, The EU Constitutional Treaty and itsdistinction between legislative and non-legisla-tives acts –Oranges into apples?, Jean MonnetWorking Paper 01/06, NYU School of law,2006, 28.La dottrina ha correttamente qualificato gliatti in parola come «autonomi» (definizionemutuata dal sistema costituzionale francese),rilevando contestualmente che l’esistenza dibasi giuridiche che ne prevedono l’adozionecostituisce un’eccezione di non poco contorispetto all’articolazione tra la funzione legisla-tiva e quella esecutiva tracciata nei Trattati [de
Witte, 100-101; Stancanelli, Le systeme de-cisionnel de l’Union, in Amato, Bribosia, de
Witte (a cura di), Genese et destinee de laConstitution europeenne, Bruxelles, 2007,517]. Si tratta, in sostanza, di un tertium genusdi atti attraverso i quali il Consiglio altro nonfa che dare esecuzione a degli orientamentipolitici definiti e inquadrati in modo piuttostorigoroso nei Trattati. Esso traduce, in tal mo-do, in atti le finalita espresse nei Trattati.Peraltro, la circostanza che regolamenti e di-rettive adottati ex art. 103 TFUE non sianoformalmente inquadrabili nella categoria degliatti legislativi, non e, a prima vista, priva di
conseguenze. Anzitutto, per questo tipo di at-ti, il Consiglio non sara tenuto – contrariamen-te a quanto accadeva prima del Trattato diLisbona, segnatamente, per gli atti la cui basegiuridica era l’ex art. 83 TCE (ora art. 103TFUE) – a deliberare in seduta pubblica (alriguardo, v. art. 16, par. 8, TUE). Inoltre, lamancata previsione di una chiara gerarchia trale norme, abbinata alla collocazione atipicadegli «atti autonomi», lascia spazio ad even-tuali ipotesi di conflitto tra norme. Un ulterio-re motivo di riflessione potrebbe riguardare leconseguenze del riferimento al termine «leg-ge» (non e chiaro se in senso formale o sostan-ziale) utilizzato dall’art. 52, par. 1, Carta deidiritti fondamentali dell’UE, proclamata solen-nemente a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dalmomento che atti di portata generale che nonsiano pero legislativi – quali, per l’appunto, iregolamenti adottati ex art. 103 TFUE – nonpotrebbero comportare alcuna limitazione al-l’esercizio dei diritti e delle liberta riconosciutidalla Carta, anche laddove siffatta limitazionesia necessaria per raggiungere le finalita di in-teresse generale riconosciute dall’Unione o perproteggere i diritti e le liberta altrui (Liisberg,40; Stancanelli, 518). Non si puo, inoltre,escludere, almeno sotto il profilo teorico,che, in virtu della nuova previsione di cui al-l’art. 263, par. 4, TFUE, gli atti in questionesiano impugnabili, quali atti regolamentari(nozione quest’ultima non definita nei Tratta-ti), dalle persone fisiche o giuridiche, qualorale riguardino direttamenente e non comporti-no alcuna misura di esecuzione (de Witte,102; Liisberg, 37-39; Stancanelli, 519).Infine, gli atti in parola sfuggono all’applica-zione del Protocollo (n. 1) sul ruolo dei Parla-menti nazionali nell’Unione europea e del Pro-tocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi disussidiarieta e di proporzionalita, dal momen-to che entrambi fanno chiaramente riferimen-to a ‘‘progetti di atti legislativi’’ (de Witte,101). Con riguardo a quest’ultimo aspetto,va tuttavia precisato che il principio di sussi-diarieta opera solo con riguardo ai settori chenon sono di competenza esclusiva dell’Unione(art. 5 TUE) e che, a norma dell’art. 3, par. 1,lett. b), TFUE, l’Unione ha competenza esclu-
103 Parte I - Tutela della concorrenza
144
siva nella «definizione delle regole di concor-renza necessarie al funzionamento del mercatointerno». Ne consegue che i protocolli in que-stione non sarebbero comunque applicabili, aprescindere dalla qualifica di atti legislativi omeno di regolamenti e direttive che abbianoper base giuridica l’articolo in commento.c) La procedura c.d. di consultazioneB La procedura indicata per l’adozione diregolamenti e direttive ex art. 103 TFUE resta,in definitiva, quella c.d. di consultazione (cosıcome peraltro prevedeva la Costituzione euro-pea, nonostante da piu parti si fosse auspicatal’attribuzione della competenza normativa incolegislazione a Consiglio e Parlamento, v.Moavero Milanesi, Diritto della concorrenzadell’Unione europea, Napoli, 2004, 50). Inve-ro, il ruolo del tutto marginale riservato alParlamento nella procedura decisionale in ma-teria di concorrenza, quale ennesima riprovadel c.d. deficit democratico immanente al si-stema istituzionale comunitario, ha formatooggetto di forti critiche da parte della dottrinain passato [v. Gimeno-Verdejo, sub art. 83, inLeger (a cura di), Commentaire article par ar-ticle des traites UE et CE, Paris, 2000, 743].Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbo-na, tali critiche non possono che acuirsi, nontanto e non solo per il fatto che la proceduradecisionale in materia di concorrenza continuaa relegare il Parlamento in un ruolo marginale,ma anche per la natura non legislativa degliatti adottati che, come si e detto, ne consegue.Nella procedura di consultazione, l’adozionedell’atto da parte del Consiglio e preceduta,per l’appunto, dalla consultazione del Parla-mento, che non e vincolante ma obbligatoria.Si tratta di un tipo di procedura, di carattereresiduale, che, prima del Trattato di Lisbona,era prescritta in pochi altri ambiti oltre a quel-lo della concorrenza e degli aiuti di Stato.Nell’ambito di tale procedura occorre che ilParlamento abbia espresso effettivamente lapropria posizione, non essendo sufficienteuna semplice richiesta di parere da parte delConsiglio, il che implica che il Consiglio nonpuo adottare un atto che non rifletta la propo-sta della Commissione come esaminata dalParlamento. Cosicche la procedura di consul-
tazione risultera rispettata solo nel caso in cui iltesto definitivo dell’atto adottato sia sostanzial-mente identico a quello su cui il Parlamentoaveva espresso il proprio parere (Tesauro, 66).L’articolo in commento non prevede alcun in-tervento nella procedura decisionale del Co-mitato delle regioni o del Comitato economi-co e sociale (organi consultivi dell’Unione aisensi dell’art. 300 TFUE). Tuttavia puo acca-dere che entrambi gli organi vengano consul-tati (v. artt. 304 e 307 TFUE, ex artt. 262 e265 TCE) in ragione dell’incidenza economicadegli atti da adottare [e stato il caso, ad es., delReg. CE 25.9.2006, n. 1419/2006, che abrogail Reg. CEE n. 4056/86 che determina le mo-dalita di applicazione degli artt. 85 e 86 TCE(ora artt. 101 e 102 TFUE) ai trasporti marit-timi, e che modifica il Reg. CE n. 1/2003,estendendone il campo di applicazione al ca-botaggio e ai servizi internazionali di trasportocon navi da carico non regolari (v. commentosub art. 104 TFUE)].Draetta, 647, ricorda che gia in occasione delprimo progetto di regolamento di applicazio-ne degli ex artt. 85 e 86 Trattato CEE (oraartt. 101 e 102 TFUE), poi ritirato a causadelle numerose critiche raccolte, il Consigliodecise di acquisire il parere del Comitato eco-nomico e sociale, sebbene l’allora art. 87 Trat-tato CEE (ora art. 103 TFUE) non ne preve-desse la consultazione come obbligatoria (ilparere del Comitato economico e sociale fuacquisito anche in occasione dell’adozionedel Reg. CE n. 1/2003).Come si e visto, nel caso dell’adozione delprimo e del secondo regolamento sulle con-centrazioni (v. supra, sub par. 4) si e fattoricorso all’articolo in commento congiunta-mente all’ex art. 308 TCE (ora art. 352 TFUE)(v. anche per gli accordi internazionali infra,sub par. 12), che prevede la deliberazione una-nime da parte del Consiglio.Come ricorda Rapp-Jung, 1265, qualora nel-l’atto che si intende adottare non sia possibiledistinguere le disposizioni per le quali e neces-sario far ricorso all’art. 352 TFUE, quale basegiuridica supplementare, da quelle per le qualiil ricorso a tale articolo non e necessario, allorail requisito dell’unanimita sara applicabile al-
Le disposizioni di attuazione delle norme antitrust dell’UE 103
145
l’intero atto normativo. Qualora sia invecepossibile effettuare tale distinzione, allora laregola della deliberazione all’unanimita varrasolo per quelle parti dell’atto contenenti di-sposizioni che ‘‘oltrepassano’’ i confini degliartt. 101 e 102 TFUE. Lo stesso dicasi perogni ulteriore ed eventuale fondamento giuri-dico avente carattere supplementare.La possibilita di ricorrere alla base giuridicacostituita dall’art. 352 TFUE viene ora espres-samente consentita dal Protocollo n. 27 sulmercato interno e la concorrenza (v. infra,sub par. 10) [Di Federico, Diritto comunitarioantitrust: procedimento amministrativo e prero-gative della difesa, Bologna, 2008, 41; Lane,EC Competition Law Post-Lisbon: a matter ofProtocol, in Bulterman, Hancher, McDon-
nell, Sevenster (a cura di), Views of Euro-pean Law from the Mountain. Liber AmicorumPiet Jan Slot, 2009, The Hague, 2009, 172].d) La procedura di adozione dei c.d. regola-menti di esenzioneNel sistema in vigore prima del Trattato diLisbona, il Consiglio poteva delegare allaCommissione, in virtu dell’ex art. 202 TCE,la competenza ad emanare regolamenti d’at-tuazione.Il Consiglio ha fatto ancora recentemente usodi tale possibilita nel Reg. CE n. 1/2003 e nelReg. CE n. 139/2004, ove ha attribuito allaCommissione l’autorizzazione generale a adot-tare le disposizioni utili ai fini dell’applicazio-ne di tali regolamenti (v. sub art. 33, Reg. CEn. 1/2003 e sub art. 24, Reg. CE n. 139/2004).A Del resto, la Corte ha gia da tempo avutomodo di pronunciarsi sulla legittimita delladelega alla Commissione del potere di emana-re disposizioni regolamentari necessarie perl’attuazione delle disposizioni adottate dalConsiglio ai sensi dell’articolo in esame (a taleriguardo v., ad esempio, C. Giust. CE,15.7.1970, 41/69, parr. 60-62).La procedura di delega e stata utilizzata, inparticolare, per l’adozione di regolamenti diesenzione per categoria ai sensi dell’art. 81,par. 3, TCE. Nel vigore del Reg. CEE n. 17/62, che conferiva alla Commissione la facoltaesclusiva di esentare le intese notificate qualo-ra sussistessero le condizioni previste dall’art.
81, par. 3, TCE (v. art. 9, Reg. CEE n. 17/62),la Commissione riteneva di avere la competen-za per intervenire in tal senso, in virtu delcombinato disposto dell’art. 81, par. 3, TCEe dell’art. 9, par. 1, Reg. CEE n. 17/62, inter-pretato in via analogica, e presento delle co-municazioni manifestando la propria intenzio-ne di adottare di propria iniziativa esenzioniper talune categorie di accordi.B A seguito delle numerose critiche raccolteda tale iniziativa, la Commissione dovette tut-tavia astenersi e presento al Consiglio un pro-getto di regolamento che la abilitava ad ema-nare regolamenti di esenzione per categoria,successivamente approvato come Reg. CEE2.3.1965, n. 19/65 (Pappalardo, Il diritto co-munitario della concorrenza. Profili sostanziali,Torino, 2007, 118). Da allora (e sino all’entratain vigore del Trattato di Lisbona), il procedi-mento per la concessione di esenzioni per ca-tegoria si e articolato in due fasi: in una primafase, il Consiglio emanava, conformemente al-l’ex art. 83 TCE, un regolamento di base in cuivenivano fissati i principi e le regole generaliper la concessione dell’esenzione per categoriae si autorizzava la Commissione a emanare di-sposizioni dirette a disciplinare specificamentele modalita di esenzione; in una seconda fase,la Commissione adottava un regolamento diesenzione conformandosi ai principi contenutinel regolamento di base del Consiglio [Nuca-
ra, I regolamenti di esenzione, in Tosato, Bel-
lodi (a cura di), Il nuovo diritto europeo dellaconcorrenza. Aspetti procedurali, Milano, 2004,196; Rapp-Jung, 1265].Va al riguardo rilevato che, a seguito dell’en-trata in vigore del Reg. CE n. 1/2003, la Com-missione ha mantenuto il potere di emanareregolamenti di esenzione, mentre i regola-menti esistenti rimangono in vigore (v. al ri-guardo il considerando 10 e l’art. 29, Reg. CEn. 1/2003).Il Trattato di Lisbona ha parzialmente inno-vato (e semplificato) la procedura di adozionedei regolamenti di esenzione, attraverso l’ag-giunta di un terzo par. al testo dell’ex art. 85TCE (ora art. 105 TFUE). Si tratta, in sostan-za, di una sorta di codificazione del sistemaprevigente attraverso il quale la Commissione
103 Parte I - Tutela della concorrenza
146
perveniva all’adozione di regolamenti con iquali concedeva un’esenzione a determinatecategorie di accordi. Il par. 3 dell’art. 105TFUE attribuisce, infatti, direttamente allaCommissione il potere di adottare regolamen-ti concernenti le categorie di accordi per lequali il Consiglio abbia gia adottato un rego-lamento o una direttiva conformemente al par.2, lett. b), dell’articolo in commento (v. com-mento sub art. 105 TFUE). In definitiva, nonoccorre piu, come in precedenza, che il Con-siglio autorizzi espressamente la Commissionea disciplinare le modalita dell’esenzione me-diante regolamento, in quanto la Commissionetrae questo potere direttamente dal Trattato.La ratio dell’introduzione di una siffatta di-sposizione nell’art. 105 TFUE risiede proprionella semplificazione della procedura di ado-zione dei regolamenti di esenzione, sottraen-doli al loro naturale ambito di applicazionedelle norme TFUE che disciplinano le proce-dure di adozione degli atti delegati e esecutivi(artt. 290 e 291 TFUE). Analoga previsione estata peraltro introdotta, per quanto riguardala disciplina degli aiuti di Stato, all’art. 108,par. 4, TFUE.
6. Ammende e penalita di mora (art. 103,par. 2, lett. a)A Secondo l’art. 103, par. 2, lett. a), TFUE,le ammende e le penalita di mora che possonoessere inflitte alle imprese nell’ambito dell’ap-plicazione del diritto europeo della concorren-za si propongono di garantire l’osservanza deidivieti di cui all’art. 101, par. 1, e all’art. 102TFUE. L’obiettivo di tale disposizione e quin-di, segnatamente, di garantire l’efficacia delcontrollo delle intese e degli abusi di posizionedominante. Come precisato dalla Corte, i sud-detti articoli devono essere intesi come facentiparte di un insieme complessivo di prescrizio-ni dirette a vietare e a sanzionare le praticheanticoncorrenziali (C. Giust. CE, 11.6.2009,C-429/07, parr. 33 e 34).La previsione della possibilita di comminareammende e penalita di mora si e resa necessa-ria per imporre l’effettiva cessazione delle vio-lazioni del diritto comunitario della concor-renza. In effetti, dal momento che le disposi-
zioni di cui agli ex artt. 84 e 85 TCE (ora artt.104 e 105 TFUE) non prevedevano esplicita-mente alcuna forma di sanzione amministrati-va o civile, esse non erano certamente suffi-cienti a garantire la piena osservanza delle nor-me antitrust comunitarie.Nel Reg. CE n. 1/2003, rispettivamente agliartt. 23 e 24 (come, del resto, precedentemen-te nel Reg. CEE n. 17/62, agli artt. 15 e 16), ilConsiglio ha attribuito alla Commissione, inforza dell’allora art. 83, par. 2, lett. a) [oraart. 103, par. 2, lett. a)], il potere di irrogarealle imprese ed alle associazioni di imprese (leazioni delle persone fisiche essendo imputatealle imprese che esse rappresentano), a titolodi sanzione, ammende e penalita di mora inrelazione a violazioni delle norme europee an-titrust e a comportamenti contrari ad alcunedisposizioni contenute nel medesimo regola-mento. Tale potere, che il Reg. CE n. 1/2003attribuisce alla Commissione, proviene dalleprevisioni del Trattato stesso ed e diretto aconsentire l’applicazione effettiva dei divietiprevisti negli artt. 101 e 102 TFUE (T. I g.CE, 5.4.2006, T-279/02, par. 87).Le sanzioni, e in particolare le ammende, as-sumono non solo la funzione di reprimere maanche quella di punire gli illeciti commessi,nonche quella di prevenire il ripetersi o il sor-gere di nuovi comportamenti anticoncorren-ziali. Sotto quest’ultimo profilo, la sanzioneagisce su un duplice piano, quello ‘‘specialpre-ventivo’’ (mira cioe a evitare il ripetersi di in-frazioni da parte della stessa impresa) e quello‘‘generalpreventivo’’ (mira cioe a dissuaderealtre imprese dal porre in essere infrazionidel tipo di quelle punite) [v. sub Orientamentiper il calcolo delle ammende inflitte in appli-cazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a),del regolamento CE n. 1/2003]. Le sanzioninon hanno invece carattere riparatorio o risar-citorio.Attraverso le sanzioni, la Commissione puni-sce non solo, come si e detto, gli illeciti ricon-ducibili agli artt. 101 e 102 TFUE (infrazionidi carattere sostanziale), ma anche le infrazionidi carattere procedurale [art. 23, par. 1, lett.da a) a e), Reg. CE n. 1/2003, che si riferisce,in sostanza, a violazioni connesse all’applica-
Le disposizioni di attuazione delle norme antitrust dell’UE 103
147
zione degli artt. 17-21, Reg. CE n. 1/2003]. Lesanzioni presuppongono la colpevolezza epossono quindi essere inflitte solo nei casi diviolazione dolosa (intenzionalita) o colposa(negligenza) delle norme in parola (sul con-trollo giurisdionale esercitato dalla Corte alriguardo, v. infra, sub par. 10).B Ai sensi dell’art. 23, par. 5, Reg. CE n. 1/2003 (v. commento sub art. 23, Reg. CE n. 1/2003), le decisioni mediante le quali la Com-missione infligge sanzioni non hanno infinecarattere penale. Al riguardo, Schepisi, subart. 31, in Adinolfi, Daniele, Nascimbene,Amadeo (a cura di), L’applicazione del dirittocomunitario della concorrenza. Commentario alregolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del16 dicembre 2002, Milano, 2007, 308, nel sot-tolineare il carattere ibrido della sanzione an-titrust – che ha natura amministrativa, ma per-segue finalita penalistiche e viene applicata nelrispetto di garanzie tipiche del processo pena-le (v., in proposito, T. I g. CE, 5.4.2006,T-279/02) –, precisa che nel caso di adesionedell’UE alla CEDU, come previsto dall’art. 6,par. 2, TUE, potrebbe essere difficile conti-nuare ad affermare la natura amministrativadelle sanzioni antitrust.Allo stato attuale, si pone, quindi, il problemadi stabilire se disposizioni adottate ai sensidell’art. 103 TFUE possano o meno introdur-re nell’Unione sanzioni di natura penale per laviolazione delle norme antitrust.A A tale riguardo, la Corte di giustizia haricordato in passato che, in linea di principio,la legislazione penale, cosı come le norme diprocedura penale, non rientravano nella com-petenza della Comunita (v. C. Giust. CE,16.6.1998, C-226/97, par. 19). Tuttavia, lastessa Corte ha altresı precisato che il fattoche le norme penali non rientrassero nell’am-bito di competenze della Comunita non impe-diva al legislatore comunitario, allorche l’ap-plicazione di sanzioni penali effettive, propor-zionate e dissuasive da parte delle competentiautorita nazionali costituiva una misura indi-spensabile di lotta contro gravi violazioni deldiritto comunitario, di adottare provvedimentiin relazione al diritto penale degli Stati mem-bri che esso ritiene necessari a garantire la
piena efficacia delle norme che emana nellamateria (C. Giust. CE, 13.9.2005, C-176/03,parr. 47 e 48). Tale giurisprudenza, sviluppa-tasi in relazione al diritto dell’ambiente, sem-brerebbe potersi applicare anche al diritto del-la concorrenza. Pertanto, non sembra esclusoche il Consiglio possa stabilire, nell’ambito didisposizioni di esecuzione adottate ai sensidell’articolo in commento, che il diritto degliStati membri preveda sanzioni anche di carat-tere penale per punire determinate violazionidegli artt. 101 e 102 TFUE, a condizione, be-ninteso, che siffatte violazioni oltrepassino undeterminato livello di gravita e siano ritenuteindispensabili per garantire l’efficacia dell’a-zione dell’UE in materia. Il quadro generalee peraltro parzialmente mutato con l’entrata invigore del Trattato di Lisbona, dal momentoche non solo gli autori del Trattato hannoinserito la cooperazione giudiziaria in materiapenale a pieno titolo tra le politiche dell’Unio-ne, ma ne hanno anche ampliato l’oggetto (in-fatti, l’art. 83 TFUE oltre a attribuire al legi-slatore UE il potere di stabilire norme minimerelative alla definizione dei reati e delle sanzio-ni nelle sfere di criminalita in esso indicate –suscettibili peraltro di essere, se del caso, am-pliate –, prevede, al par. 2, un potere analogoanche per i casi in cui il ravvicinamento dellelegislazioni degli Stati membri in materia pe-nale si riveli indispensabile per garantire l’at-tuazione efficace di una politica UE in un set-tore gia oggetto di misure di armonizzazione).B In dottrina si e osservato che se il Consi-glio dovesse effettivamente ritenere necessariointrodurre sanzioni di natura penale al fine diperseguire finalita di dissuasione e di deterren-za dal compimento di violazioni delle normeeuropee antitrust, il mancato riferimento nellalett. a) del par. 2 dell’odierno art. 103 TFUE atale tipo di sanzioni non costituirebbe un osta-colo alla previsione delle stesse, in considera-zione dell’ampiezza dei poteri normativi spet-tanti al Consiglio in virtu del par. 1 dello stes-so articolo, vale a dire di adottare le disposi-zioni «utili ai fini dell’applicazione dei principicontemplati dagli articoli 101 e 102». Si e inol-tre precisato che, in ogni caso, laddove sussi-stessero dubbi circa la possibilita di fondare la
103 Parte I - Tutela della concorrenza
148
previsione di sanzioni di natura penale perviolazioni delle norme europee antitrust sullasola base dell’art. 103 TFUE, sarebbe allorapossibile trovare un fondamento giuridico ul-teriore per siffatte disposizioni nell’odiernoart. 352 TFUE [Wils, Is criminalization ofEU competition law the answer?, in Cseres,Schinkel, Vogelaar (a cura di), Criminaliza-tion of competition law enforcement, Nor-thampton, 2006, 95].Occorre altresı rilevare che, a norma dell’art.5, Reg. CE n. 1/2003 (v. commento sub artt. 4,5, 6, Reg. CE n. 1/2003), le autorita garantidella concorrenza nazionali, competenti ad ap-plicare gli artt. 101 e 102 TFUE in casi indi-viduali, possono, tra le altre cose, adottare de-cisioni con le quali infliggono ammende, pe-nalita di mora o «qualunque altra sanzioneprevista dal diritto nazionale». Ne consegueche il Reg. CE n. 1/2003 consente alle predet-te autorita di comminare non solo ammende,ma anche altre sanzioni previste dal dirittonazionale, aventi, se del caso, natura penale,per violazione delle norme europee di concor-renza.A Al riguardo, la Corte ha peraltro precisato,in relazione ad una questione di deducibilitafiscale di un’ammenda irrogata dalla Commis-sione, che l’efficacia delle sanzioni inflitte dalleautorita garanti della concorrenza nazionali odell’Unione in forza della disposizione in com-mento costituisce una condizione per l’appli-cazione uniforme degli odierni artt. 101 e 102TFUE (C. Giust. CE, 11.6.2009, C-429/07,par. 37).Per quanto riguarda invece le penalita di mora(v. commento sub art. 24, Reg. CE n. 1/2003),esse servono, da un lato, a far cessare violazio-ni attuali del diritto europeo della concorrenzae, dall’altro, a prevenire violazioni future. Inlinea di principio, mediante le penalita di mora,la Commissione impone l’esecuzione delle suedecisioni amministrative. Occorre ricordare, ineffetti, che l’art. 24, par. 1, Reg. CE n. 1/2003dispone che la Commissione possa, mediantedecisione, irrogare alle imprese e associazionidi imprese penalita di mora il cui importopuo giungere fino al 5% del fatturato mediogiornaliero realizzato durante l’esercizio sociale
precedente per ogni giorno di ritardo a decor-rere dalla data fissata nella decisione. Le pena-lita di mora possono essere imposte al fine dicostringere l’impresa a porre fine a un’infrazio-ne agli artt. 101 e 102 TFUE, o a rispettare unadecisione che dispone provvedimenti provviso-ri o a rispettare un impegno reso obbligatoriomediante decisione ai sensi dell’art. 9, Reg. CEn. 1/2003, oppure, ancora, a fornire in manieracompleta ed esatta un’informazione richiestadalla Commissione o a sottoporsi agli accerta-menti da questa ordinati.B Rapp-Jung, 1266, fa osservare che, diver-samente dalle ammende, l’imposizione di pe-nalita di mora non presuppone, in linea diprincipio, una condotta dolosa o colposa daparte dell’impresa. Dalla natura giuridica dif-ferente delle ammende e delle penalita di mo-ra si desumerebbe quindi che esse possonoessere applicate simultaneamente alla stessacondotta senza integrare una violazione delprincipio del ne bis in idem.
7. Modalita di applicazione dell’art. 101, par. 3,TFUE (art. 103, par. 2, lett. b)La lett. b) del par. 2 dell’art. 103 TFUE attri-buisce al Consiglio la competenza a adottareregolamenti o direttive con lo scopo di deter-minare le modalita di applicazione dell’art.101, par. 3, TFUE. Ai sensi dell’art. 103,par. 2, lett. b), tali disposizioni devono aver«riguardo alla necessita di esercitare una sor-veglianza efficace e, nel contempo, semplifica-re, per quanto possibile, il controllo ammini-strativo».La seconda frase della lett. b) del par. 2 del-l’articolo in commento identifica quindi dueprincipi guida che il Consiglio deve seguireper l’adozione delle disposizioni relative allemodalita di applicazione dell’art. 101, par. 3,TFUE. Da un lato, e necessario che tali dispo-sizioni siano finalizzate a creare un sistema dicontrollo amministrativo efficace. Dall’altro la-to, e allo stesso tempo, esse devono tuttaviatenere conto della necessita che il sistema dicontrollo amministrativo sia il piu semplicepossibile.In merito a questo secondo elemento, e inte-ressante notare che, mentre la versione italiana
Le disposizioni di attuazione delle norme antitrust dell’UE 103
149
del testo (come, del resto, quelle francese espagnola), utilizzando l’espressione «perquanto possibile», sembra suggerire che l’o-biettivo della semplificazione del controlloamministrativo sia in qualche modo subordi-nato al primo principio, relativo all’efficaciadella sorveglianza, le versioni inglese e tedesca,invece, utilizzando i termini «to simplify admi-nistration to the greatest possibile extent» e«bei moglichst einfacher Verwaltungskontrol-le», sembrano piuttosto indicare l’essenzialitadell’obiettivo della semplificazione ammini-strativa nell’adozione di regole concernenti lemodalita di applicazione dell’art. 101, par. 3,TFUE. In effetti, e proprio avendo in mentetale obiettivo di semplificazione dell’attivitaamministrativa e di liberazione di risorse dellaCommissione che e stata concepita e messa inesecuzione la riforma del sistema di applica-zione dell’art. 81, par. 3, TCE (ora art. 101,par. 3, TFUE) nell’ambito della c.d. moder-nizzazione del diritto europeo della concor-renza coronatasi con l’adozione del Reg. CEn. 1/2003.Tale riforma ha, come noto, scardinato il mo-nopolio della Commissione nell’applicazionedell’ex art. 81, par. 3, TCE (ora art. 101,par. 3, TFUE) e nella concessione di esenzio-ni, attribuendo esplicitamente ai giudici nazio-nali ed alle autorita nazionali garanti della con-correnza la competenza ad applicare l’art. 101nella sua integralita. Come si desume dai con-siderando 2, 3, e 4, Reg. CE n. 1/2003, e statoproprio al fine di ristabilire un «equilibrio fraquesti due obiettivi» – equilibrio che non erapiu garantito dal vecchio sistema centralizzatodi applicazione dell’art. 81, par. 3, TCE, in-trodotto con il Reg. CEE n. 17/62 e fondatosulla notifica delle richieste di esenzione allaCommissione –, che tale sistema e stato «so-stituito con un sistema di eccezione diretta-mente applicabile, in base al quale le autoritagaranti della concorrenza e le giurisdizioni de-gli Stati membri [sono] competenti non soload applicare l’art. [101], [par.] 1, e l’art.[102], direttamente applicabili in virtu dellagiurisprudenza della Corte di giustizia, ma an-che l’art. [101], [par.] 3» (v. , in particolare,considerando 4, Reg. CE n. 1/2003).
B Giova ricordare che, in passato, proprio alfine di attenuare le difficolta derivanti dall’at-tribuzione alla Commissione della competenzaesclusiva a concedere delle esenzioni ai sensidell’allora art. 81, par. 3, TCE il Consiglio ave-va adottato, sulla base dell’ex art. 83, par. 2,lett. b), TCE, una serie di regolamenti con cuiautorizzava la Commissione ad adottare a suavolta dei regolamenti che concedevano un’e-senzione a determinate categorie di accordi,decisioni e pratiche concordate (Tesauro, 681).Nel nuovo sistema di applicazione, configuratodal Reg. CE n. 1/2003, gli accordi, le decisionidi associazioni di imprese e le pratiche concor-date che sono vietate ai sensi del par. 1 dell’art.101 TFUE, ma che soddisfino i requisiti di cuial par. 3 dello stesso articolo, sono ipso factoesentati senza che vi sia bisogno di una deci-sione d’autorizzazione, ne della Commissionene di alcuna altra autorita. I requisiti per l’e-senzione previsti nel par. 3 dell’art. 101 TFUEcostituiscono quindi una sorta di condizionenegativa la cui sussistenza comporta, automa-ticamente, l’esenzione dell’accordo vietato dal-la proibizione prevista dal par. 1 dell’art. 101TFUE. E compito dell’impresa valutare, a suorischio e pericolo, se tali condizioni per l’esen-zione dell’accordo sussistono o meno.Nel nuovo sistema, ai sensi dell’art. 10, Reg.CE n. 1/2003 (v. commento sub art. 10, Reg.CE n. 1/2003), la Commissione puo ancora«stabilire mediante decisione che l’art. [101][sia] inapplicabile a un accordo, a una deci-sione di un’associazione di imprese o a unapratica concordata (...) perche sono soddisfat-te le condizioni di cui all’art. [101, par. 3,TFUE]», ma solo in casi eccezionali dettatida ragioni di interesse pubblico dell’UE rela-tive all’applicazione degli artt. 101 e 102TFUE, ed esclusivamente al fine di renderechiara la legislazione e di garantirne un’appli-cazione coerente nell’Unione, in particolareper quanto riguarda nuovi tipi di accordi odi pratiche non consolidati nella giurispruden-za e prassi amministrativa esistenti. In tali casi,peraltro, la decisione della Commissione hanatura meramente dichiarativa e non costitu-tiva dell’esenzione (v. considerando 14 e art.10, Reg. CE n. 1/2003).
103 Parte I - Tutela della concorrenza
150
Il nuovo sistema fondato sull’«eccezione diret-tamente applicabile» non persegue esclusiva-mente finalita di semplificazione amministra-tiva, ma contribuisce anche al miglioramentodel primo requisito menzionato nella disposi-zione in esame, ossia l’efficacia della sorve-glianza, dal momento che la competenza adapplicare l’art. 101 TFUE nella sua interezzaappartiene non piu solo alla Commissione, maanche a tutte le istanze nazionali competenti,ossia le autorita nazionali di concorrenza e igiudici nazionali (Rapp-Jung, 1268).! In dottrina si e messa in dubbio la legitti-mita dell’attribuzione ai giudici nazionali dellacompetenza ad applicare l’odierno art. 101,par. 3, TFUE. In particolare, Pace, I fonda-menti, 446-451 , ritiene che l’art. 6, Reg. CEn. 1/2003, – che costituisce il fondamento giu-ridico dell’attribuzione ai giudici nazionali ditale competenza – si basi sul presuppostoche sia il regolamento stesso, ai sensi dell’art.103, par. 2, lett. b), TFUE, ad attribuire aigiudici nazionali la competenza ad applicarel’art. 101, par. 3, TFUE e che sia pertantoillegittimo per violazione dell’articolo in com-mento. Il testo e la genesi della lett. b) del par.2 dell’articolo in commento escluderebbero,infatti, che le giurisdizioni nazionali possanoapplicare l’art. 101, par. 3, in quanto tale di-sposizione non sarebbe ad esse diretta. In par-ticolare, l’art. 103, par. 2, lett. b), attribuireb-be la competenza per l’applicazione dell’art.101, par. 3, esclusivamente agli organi del si-stema amministrativo di tutela antitrust del-l’UE (vale a dire alla Commissione e, eventual-mente, alle autorita nazionali). Il Consiglio,emanando l’art. 6, Reg. CE n. 1/2003, avrebbedi conseguenza violato l’allora art. 83, par. 2,lett. b), poiche avrebbe adottato una normaper la quale esso non ha competenza (Pace,I fondamenti, 451). Dubbi esprimono al ri-guardo anche Kerse, Khan, EC Antitrust Pro-cedure, 5a ed., London, 2005, 61.Si mostra contrario a questa tesi Gaja, sub art.6, in Adinolfi, Daniele, Nascimbene, Ama-
deo (a cura di), L’applicazione del diritto co-munitario della concorrenza. Commentario alregolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del16 dicembre 2002, Milano, 2007, 83, secondo
cui il predetto art. 6, Reg. CE n. 1/2003 noneccede quanto previsto dall’articolo in com-mento, poiche quest’ultimo stabilisce generi-camente che la normativa di attuazione deter-mina «le modalita di applicazione dell’art.101, par. 3». In effetti, non sembra potersidesumere ne dallo stesso art. 101, par. 3, nedall’art. 103 TFUE, una proibizione dell’attri-buzione della competenza ai giudici nazionaliad applicare l’art. 101, par. 3, TFUE (Rapp-
Jung, 1268).Sul fondamento della lett. b) del par. 2 del-l’art. 103, il Consiglio dispone anche dellacompetenza ad esentare categorie di accordiai sensi dell’art. 101, par. 3 [per un richiamocongiunto alla lett. b) e alla lett. d) del par. 2dell’ex art. 83, v. tuttavia considerando 3, Reg.CE 26.2.2009, n. 246/2009, relativo all’appli-cazione dell’ex art. 81, par. 3, TCE, alle intesetra compagnie di trasporto marittimo di li-nea]. I regolamenti di esenzione per categoria,generalmente emanati in passato dalla Com-missione su delega da parte del Consiglio, pos-sono oggi, ai sensi del nuovo art. 105, par. 3,TFUE, essere adottati direttamente dallaCommissione (v. supra, sub par. 5; v. altresıcommento sub art. 105 TFUE).L’introduzione del nuovo sistema fondato sul-l’eccezione direttamente applicabile lascia im-modificata al riguardo tanto la competenza delConsiglio quanto la ripartizione delle compe-tenze tra Consiglio e Commissione. Come si egia rilevato (v. supra, sub par. 5), i regolamentidi esenzione esistenti restano in vigore e gliaccordi, le decisioni d’imprese e le praticheconcordate rientranti nei loro rispettivi ambitidi applicazione restano validi (v. considerando10 e art. 29, Reg. CE n. 1/2003).Tali regolamenti creano una presunzione dicompatibilita che puo, peraltro, essere revoca-ta in casi specifici. Infatti, ai sensi dell’art. 29,par. 1, Reg. CE n. 1/2003 (v. commento subart. 29, Reg. CE n. 1/2003), la Commissioneha il potere di revocare ex nunc il beneficio diun’esenzione per categoria nei casi in cui que-sta possa produrre in concreto effetti in con-trasto con l’art. 101, par. 3, TFUE. Se talieffetti sono circoscritti, la revoca puo esserelimitata ad uno Stato membro o comunque a
Le disposizioni di attuazione delle norme antitrust dell’UE 103
151
mercati geografici distinti, nel qual caso pos-sono disporla anche le autorita antitrust nazio-nali (Fonderico, 2503).In caso di revoca, spetta peraltro alle autoritagaranti della concorrenza interessate provareche l’accordo viola l’art. 101, par. 1, e che nonsoddisfa le condizioni di cui al par. 3 dellostesso articolo. Le giurisdizioni nazionalinon hanno invece il potere di revocare il be-neficio di un’esenzione per categoria (Nucara,218). Inoltre, nell’applicare i regolamenti diesenzione per categoria, queste ultime nonpossono modificarne il campo di applicazioneper estenderlo ad accordi che non rientranonel regolamento di esenzione per categoria dicui trattasi (v. sub Comunicazione della Com-missione – Linee direttrici sull’applicazionedell’art. 81, par. 3, parr. 35-37).
8. La regolamentazione dei vari settorieconomici (art. 103, par. 2, lett. c)La lett. c) del par. 2 dell’art. 103 TFUE pre-vede che le disposizioni applicative degli artt.101 e 102 TFUE debbano eventualmente pre-cisarne , per i vari settori economici, il campodi applicazione.B Puo infatti darsi che in un determinatosettore economico non sia possibile – o pre-senti gravi inconvenienti – l’applicazione delladisciplina antitrust delineata dagli artt. 101 e102 TFUE, e si rendano pertanto necessaridegli adattamenti che, pur lasciando inalteratala sostanza dei predetti artt. 101 e 102, li ren-dano piu aderenti alle caratteristiche di queldeterminato settore (Draetta, 652).A tale riguardo, va anzitutto ricordato che leregole europee di concorrenza sono, rationemateriae, di applicazione tendenzialmenteuniversale (Pappalardo, 859).A In effetti, come la Corte ha avuto modo diprecisare, tali regole si applicano a tutti i set-tori economici e quando il Trattato ha inteso«sottrarre talune attivita all’applicazione dellenorme di concorrenza, ha formulato una de-roga espressa a tal fine» (C. Giust. CE,27.1.1987, 45/85, parr. 12-15; C. Giust. CE,30.4.1986, 209/84-213/84, parr. 40-45).Deroghe espresse all’applicabilita delle normeeuropee di concorrenza sono contenute nel
Trattato per il settore dell’agricoltura (art. 42TFUE, ex art. 36 TCE), per le imprese inca-ricate di servizi di interesse economico gene-rale (art. 106, par. 2, TFUE, ex art. 86, par. 2,TCE) e per la produzione e il commercio diarmi e materiali da guerra (art. 346 TFUE, exart. 296 TCE) (v., a tale riguardo, T. I g. CE,28.3.2001, T-144/99, par. 67).B Come evidenziato da Rapp-Jung, 1269,trattandosi di deroghe al principio generaledell’applicazione universale delle regole diconcorrenza, esse vanno interpretate in manie-ra restrittiva.E importante, peraltro, rilevare che, nei settoriin cui vigono tali deroghe, il legislatore dispo-ne di un ampio margine di discrezionalita neldeterminare, mediante regolamenti o direttive,le modalita applicative delle norme europee diconcorrenza, conformemente alle relative di-sposizioni derogatorie contenute nel Trattato.Nei settori, invece, in cui le norme europee diconcorrenza trovano piena applicazione, gliatti normativi emanati, ai sensi della lett. c)del par. 2 dell’art. 103, devono limitarsi a pre-cisare il contenuto e la portata di tali norme (atale riguardo, v. supra, sub par. 3).A Tra i settori sottoposti a deroghe specifi-che, l’unico in cui il Consiglio ha emanato unaregolamentazione ad hoc e quello dell’agricol-tura. Del resto, la peculiarita di tale settorecon riguardo all’applicazione delle regole diconcorrenza trova espresso riconoscimentonell’art. 42 TFUE (ex art. 36 TCE) (v. C.Giust. CE, 9.9.2003, C-137/00, par. 58).Infatti, come precisato dalla Corte di giustizia,tale disposizione riconosce, da un lato, «la pre-valenza della politica agricola rispetto agliobiettivi del Trattato nel settore della concor-renza» e, dall’altro, «il potere del Consiglio didecidere in quale misura le norme sulla con-correnza devono applicarsi nel settore agrico-lo» nonche l’«ampio margine di discrezionali-ta» di cui questo gode nell’esercizio di talepotere (v. C. Giust. CE, 29.10.1980, 139/79,par. 23).B In applicazione di tale potere il Consiglioha quindi emanato il Reg. CEE 4.4.1962,n. 26/62, successivamente codificato nel Reg.CE 24.7.2006, n. 1184/2006, relativo all’appli-
103 Parte I - Tutela della concorrenza
152
cazione di alcune regole di concorrenza allaproduzione e al commercio dei prodotti agri-coli. Tale regolamento stabilisce che le regoledi concorrenza si applicano alla produzione edal commercio dei prodotti agricoli, nei limiti incui la loro applicazione non ostacoli il funzio-namento delle organizzazioni nazionali deimercati agricoli e non pregiudichi il raggiun-gimento degli obiettivi della politica agricolacomune (PAC). Esso prevede, in particolare,che gli odierni artt. 101 e 102 TFUE si appli-chino alla produzione e al commercio dei pro-dotti agricoli con tre tipi di eccezioni (Pappa-
lardo, 860-862).Ai sensi di tale regolamento, le regole europeedi concorrenza non si applicano, in primo luo-go, agli accordi, alle decisioni e alle praticheche costituiscono parte integrante di un’orga-nizzazione nazionale di mercato; in secondoluogo, agli accordi che sono necessari per ilconseguimento degli obiettivi della PAC e, in-fine, ad alcuni accordi tra imprenditori agrico-li, o tra associazioni di imprenditori agricoliappartenenti ad uno Stato membro, nella mi-sura in cui tali accordi non prevedano l’obbli-go di praticare un prezzo determinato, nonescludano la concorrenza e non comprometta-no gli obiettivi della PAC. Inoltre, anche alcu-ne organizzazioni comuni di mercato, comequelle dei prodotti ortofrutticoli e vitivinicoli,prevedono disposizioni specifiche che esclu-dono, a talune condizioni, le organizzazioniinterprofessionali dall’ambito di applicazionedell’odierno art. 101 TFUE.In passato, il Consiglio ha utilizzato la compe-tenza attribuitagli dalla lett. c), par. 2, dell’al-lora art. 87 Trattato CEE [ora art. 103, par. 2,lett. c) TFUE] per l’adozione di disposizionispecifiche concernenti l’applicazione delle nor-me antitrust nel settore dei trasporti. In parti-colare, per quanto riguarda, anzitutto, il setto-re del trasporto terrestre, il Reg. CEE19.7.1968, n. 1017/68, relativo all’applicazionedi regole di concorrenza ai settori dei trasportiferroviari, su strada e per vie navigabili, preve-deva una disciplina speciale per l’applicazionedelle norme comunitarie di concorrenza.Tale regolamento, pur se ancora parzialmentein vigore, ha tuttavia subito modifiche sostan-
ziali per opera dell’art. 36, Reg. CE n. 1/2003il quale ha ricondotto il settore del trasportoterrestre nell’alveo della disciplina generaledella concorrenza, cosicche esso non puo piuconsiderarsi oggi come un settore speciale[Marino, sub art. 36, in Adinolfi, Daniele,Nascimbene, Amadeo (a cura di), L’applicazio-ne del diritto comunitario della concorrenza.Commentario al regolamento (CE) n. 1/2003del Consiglio del 16 dicembre 2002, Milano,2007, 424-431].Analoghe considerazioni valgono sia per il set-tore dei trasporti marittimi che per il settoredei trasporti aerei. Infatti, per cio che riguardail primo di tali settori, per lungo tempo, invirtu del Reg. CEE 22.12.1986, n. 4056/86,sono rimaste in vigore, da un lato, disposizioniprocedurali relative all’attuazione nel settoredei trasporti marittimi delle regole comunitariedi concorrenza e, dall’altro, disposizioni speci-fiche e sostanziali in materia di concorrenzarelative al settore marittimo che prevedevano,in primo luogo, l’esenzione di categoria a favo-re delle conferenze di compagnie marittime dilinea consentendo a queste, a certe condizioni,di fissare i prezzi e di regolare la capacita, insecondo luogo, l’esclusione degli accordi me-ramente tecnici dall’applicazione dell’ex art.81, par. 1, TCE (ora art 101, par. 1, TFUE)e, in terzo luogo, una procedura per risolvere iconflitti di diritto internazionale.Gia il Reg. CE n. 1/2003 aveva modificato ilReg. CEE n. 4056/86 allo scopo di far rien-trare il settore dei trasporti marittimi nell’am-bito di applicazione delle disposizioni comunidi attuazione delle regole di concorrenza pertutti i settori. In virtu dell’art. 32, lett. a) e b),Reg. 1/2003, rimanevano tuttavia esclusi dalladisciplina generale i trasporti marittimi inter-nazionali non di linea e i trasporti marittimiche si effettuano esclusivamente fra i porti diuno stesso Stato membro. Con il Reg. CE25.9.2006, n. 1419/2006, sono stati abrogatitanto il Reg. CEE n. 4056/86 nella sua inte-gralita, quanto l’art. 32, Reg. CE n. 1/2003,talche anche il settore dei trasporti marittimirientra adesso integralmente nell’ambito di ap-plicazione delle disposizioni comuni di attua-zione delle regole di concorrenza.
Le disposizioni di attuazione delle norme antitrust dell’UE 103
153
Nel settore dei trasporti aerei, invece, la rego-lamentazione speciale era costituita dal Reg.CEE 14.12.1987, n. 3975/87, relativo alle mo-dalita di applicazione delle regole di concor-renza alle imprese di trasporti aerei. Tale re-golamento, che gia aveva subito importantiabrogazioni per effetto dell’entrata in vigoredel Reg. CE n. 1/2003, e stato definitivamenteabrogato dal Reg. CE 26.2.2004, n. 411/2004,che ha cosı ricondotto integralmente anche ilsettore dei trasporti aerei nell’alveo della disci-plina generale.
9. La definizione dei rispettivi compiti dellaCommissione e della Corte di giustiziadell’Unione europea (art. 103, par. 2, lett. d)Ai sensi della lett. d) del par. 2 dell’art. 103TFUE, il Consiglio, mediante le disposizioni dicui al par. 1 dello stesso articolo, definisce «irispettivi compiti della Commissione e dellaCorte di giustizia dell’Unione europea nell’ap-plicazione delle disposizioni contemplate dalpresente paragrafo». Tali rispettivi compiti so-no stabiliti in diverse disposizioni del Trattatostesso, nonche in alcune disposizioni di dirittoderivato. La definizione di tali rispettivi com-piti segue il principio generale delle competen-ze d’attribuzione (v. art. 13 TUE). Il riferimen-to alla Corte di giustizia dell’Unione europeava inteso come riferimento all’istituzione, checomprende, ai sensi dell’art. 19 TUE, la Cortedi giustizia, il Tribunale e i tribunali specializ-zati istituiti sulla base dell’art. 257 TFUE [almomento, l’unico esistente e il Tribunale dellafunzione pubblica dell’UE, v. allegato I alloStatuto della Corte di giustizia dell’UE (in Pro-tocollo n. 3 allegato ai Trattati)].Rientrano, in particolare, tra i compiti dellaCommissione l’applicazione alle singole fatti-specie degli atti adottati ex art. 103 TFUE,cosı come la preparazione di proposte per l’a-dozione di questi ultimi da parte del Consi-glio. La Corte di giustizia UE ha invece ilcompito, ai sensi dell’art. 19, par. 2, TUE, diassicurare il rispetto del diritto nell’interpreta-zione e nell’applicazione dei trattati.La definizione dei rispettivi compiti dellaCommissione e della Corte di giustizia UEpuo avvenire solo nei limiti consentiti dai trat-
tati. A tal riguardo, va ricordato che il Trattatosul funzionamento dell’Unione europea lasciaaperta la definizione dei rispettivi ruoli dellaCommissione e della Corte nell’ambito del-l’imposizione di ammende e di penalita di mo-ra. In particolare, ai sensi dell’art. 261 TFUE(ex art. 229 TCE), i «regolamenti adottati con-giuntamente dal Parlamento europeo e dalConsiglio e dal Consiglio in virtu delle dispo-sizioni dei trattati possono attribuire alla Cortedi giustizia dell’Unione europea una compe-tenza giurisdizionale anche di merito perquanto riguarda le sanzioni previste nei rego-lamenti stessi».La previsione di tali sanzioni deve dunquetrovare il proprio fondamento giuridico inspecifiche disposizioni del Trattato. L’art.103, par. 2 , lett. d), costituisce pertanto unabase giuridica appropriata per l’adozione diregolamenti quali quelli cui si riferisce l’art.261 TFUE. Il Consiglio puo in tal modo adot-tare disposizioni che sanciscono una compe-tenza di piena giurisdizione dei giudici UE conriguardo alle decisioni della Commissione con-cernenti l’imposizione di ammende o di pena-lita di mora (v. supra, sub par. 6).A tal proposito, giova ricordare che il consi-derando 33, Reg. CE n. 1/2003 recita: «[p]oi-che tutte le decisioni adottate dalla Commis-sione in applicazione [di tale] regolamento so-no soggette al controllo della Corte di giustizia[dell’UE] alle condizioni definite dal trattato,sarebbe opportuno attribuire alla Corte di giu-stizia [dell’UE], in applicazione dell’art. [261TFUE], la competenza giurisdizionale anchedi merito per quanto riguarda le decisioni me-diante le quali la Commissione infligge am-mende o penalita di mora».Cosı, l’art. 31, Reg. CE n. 1/2003 (che ripren-de integralmente l’art. 17, Reg. CEE n. 17/62)stabilisce riguardo alle sanzioni – in attuazionedegli attuali artt. 103, par. 2, lett. d), e 261TFUE – che «la Corte di giustizia [dell’UE]ha competenza giurisdizionale anche di meri-to per decidere sui ricorsi presentati avverso ledecisioni con le quali la Commissione irrogaun’ammenda o una penalita di mora. Essapuo estinguere, ridurre o aumentare l’am-menda o la penalita di mora irrogata». Ana-
103 Parte I - Tutela della concorrenza
154
loga previsione, per quanto riguarda le con-centrazioni tra imprese, e rinvenibile nelReg. CE n. 139/2004 (v. commento subart. 16, Reg. CE n. 139/2004).A In base all’art. 261 TFUE e all’art. 31, Reg.CE n. 1/2003 (v. commento sub art. 31, Reg.CE n. 1/2003), i giudici dell’UE, segnatamen-te il Tribunale (v. C. Giust. CE, 16.11.2000,C-248/98 P, par. 40), sono dunque abilitati, aldi la del mero controllo di legittimita dellasanzione, a sostituire la loro valutazione aquella della Commissione e, di conseguenza,a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammen-da o la penalita inflitta (C. Giust. CE,8.2.2007, C-3/06 P, par. 61).B Occorre tuttavia precisare che, sebbenepossano riformare l’importo della sanzione in-flitta, i giudici UE non possono invece riela-borare la parte della decisione contenente ilriferimento alla sanzione, essendo il loro pote-re limitato all’indicazione della riduzione odell’aumento della sanzione eventualmente ac-compagnata da un annullamento parziale delladecisione. Dal punto di vista formale, dunque,la statuizione dei giudici UE non si sostituiscealla decisione della Commissione, quest’ultimaresta, di conseguenza, legittimata a chiederegli interessi maturati dalla data indicata nelladecisione, calcolati sul nuovo importo deter-minato in sentenza (Schepisi, 383).
10. Il rapporto tra diritto antitrust dell’UE enormative di concorrenza degli Stati membri (art.103, par. 2, lett. e)L’art. 103, par. 2, lett. e), TFUE prevede l’e-manazione di norme atte a definire i rapportitra il diritto europeo della concorrenza e lelegislazioni nazionali.A Tale disposizione non e stata tuttavia attua-ta dal legislatore comunitario per lungo tem-po. Sino all’adozione del Reg. CE n. 1/2003, irapporti tra normativa comunitaria e normati-ve nazionali di concorrenza erano regolatiesclusivamente dal principio del primato deldiritto comunitario cosı come stabilito dallaCorte di giustizia CE nella nota sentenza Wil-helm (C. Giust. CE, 13.2.1969, 14/68).Nell’esaminare, in particolare, il problema chesi pone negli ordinamenti ove vige il c.d. prin-
cipio della ‘‘doppia barriera’’, nei casi in cui cisi trovi dinanzi a procedimenti paralleli inten-tati in forza del diritto europeo e del dirittonazionale contro una stessa fattispecie anti-concorrenziale, la Corte ha precisato che, sintanto che un regolamento adottato in forzadell’allora art. 87, par. 2, lett. e), TrattatoCEE [ora, art. 103, par. 2, lett. e), TFUE]non abbia disposto diversamente, nulla ostaa che le autorita nazionali instaurino un pro-cedimento nei confronti di un’intesa, secondoil loro diritto nazionale, anche qualora la Com-missione stia gia esaminando la posizione dellastessa sotto il profilo del diritto comunitario,restando fermo che il procedimento parallelodinanzi alle autorita nazionali non puo pregiu-dicare la piena ed uniforme applicazione deldiritto comunitario ne l’efficacia degli attiadottati in esecuzione dello stesso (C. Giust.CE, 13.2.1969, 14/68, par. 9).Sulla base dei poteri conferitigli dall’ex art. 83,par. 2, lett. e), TCE, il Consiglio ha dunqueinteso regolare, a distanza di oltre 30 anni dal-la sentenza Wilhelm, i rapporti tra normativaeuropea e normative nazionali di concorrenza.Come ricorda il considerando 8, Reg. CE 1/2003: «e (...) necessario definire, a norma del-l’[art. 103, par. 2, lett. e), TFUE], i rapportifra le legislazioni nazionali e il diritto comuni-tario in materia di concorrenza. A tal fine enecessario prevedere che l’applicazione dellelegislazioni nazionali in materia di concorrenzaagli accordi, decisioni o pratiche concordate aisensi dell’art. [101, par. 1, TFUE] non possacomportare il divieto di siffatti accordi, deci-sioni o pratiche concordate se essi non sonovietati anche a norma del diritto comunitarioin materia di concorrenza».B La disciplina di tali rapporti e ora conte-nuta nell’art. 3, Reg. CE n. 1/2003 (v. com-mento sub art. 3, Reg. CE n. 1/2003), checostituisce uno dei pilastri del sistema d’appli-cazione creato dal predetto Regolamento e chesi pone, in sostanza, sulla stessa lunghezzad’onda della citata sentenza Wilhelm [De
Smijter, Kiølbye, The enforcement system un-der regulation 1/2003, in Faull, Nikpay (acura di), The Ec Law of Competition, 2a ed.,Oxford, 2007, 96]. Tale articolo prevede a
Le disposizioni di attuazione delle norme antitrust dell’UE 103
155
carico di giudici e autorita nazionali di concor-renza un esplicito obbligo di applicare il dirit-to antitrust europeo ai comportamenti d’im-presa suscettibili di incidere sugli scambi traStati membri. Tale obbligo e diretto, oltre afavorire una piu ampia e sistematica applica-zione degli artt. 101 e 102 TFUE, a garantireche i procedimenti delle autorita nazionali diconcorrenza, riguardanti pratiche suscettibilidi pregiudicare gli scambi tra Stati membri,siano soggetti alle procedure di informazionee consultazione preventiva della Commissionepreviste dal Reg. CE n. 1/2003 (v. commentosub art. 11, Reg. CE n. 1/2003), al fine diassicurare un’applicazione omogenea e coe-rente del diritto antitrust europeo. Resta intal modo aperta la possibilita di un’applicazio-ne parallela delle legislazioni nazionali (Tesau-
ro, 747).! Si e osservato in dottrina che l’art. 3, par. 2,Reg. CE n. 1/2003 sarebbe contrario al prin-cipio di proporzionalita e, di conseguenza, il-legittimo. Infatti, essendo i regolamenti adot-tati ai sensi dell’ex art. 83 TCE (ora art. 103TFUE), secondo giurisprudenza costante, di-retti al raggiungimento delle finalita dell’exart. 3, par. 1, lett. g), TCE, vale a dire al rag-giungimento di «un regime inteso a garantireche la concorrenza non sia falsata nel mercatointerno», l’esercizio della competenza norma-tiva al fine di disciplinare i rapporti fra le legi-slazioni nazionali e il diritto antitrust comuni-tario sarebbe necessario solo laddove l’appli-cazione delle norme antitrust degli Stati mem-bri non permetta di conseguire le finalita dicui al suddetto art. 3 TCE. La previsione del-l’art. 3, par. 2, Reg. CE n. 1/2003, emanata aisensi dell’ex art. 83, par. 2, lett. e), TCE [oraart. 103, par. 2, lett. e), TFUE], non sarebbepertanto idonea al raggiungimento delle fina-lita indicate dal suddetto art. 3, par. 1, lett. g),TCE, dal momento che non esiste alcun rap-porto tra la tutela del mercato interno e lacompetenza esclusiva del diritto antitrust co-munitario con riferimento alle intese rientrantinel campo di applicazione dell’ex art. 81 TCE.L’applicazione uniforme degli artt. 101 e 102TFUE non richiederebbe infatti – contraria-mente a quanto previsto dall’art. 3, par. 2,
Reg. CE n. 1/2003 – anche l’applicazione uni-forme al diritto antitrust UE delle norme anti-trust statali in materia di accordi anticoncor-renziali (Pace, Diritto europeo, 201-203).Va segnalato, in proposito, che il Trattato diLisbona ha definitivamente soppresso il riferi-mento alla concorrenza contenuto nell’ex art.3, lett. g), TCE. (l’articolo 3 TCE e stato, in-fatti, abrogato). Cio nondimeno, il Protocollon. 27 allegato ai Trattati (v. supra, sub par. 5),parafrasando tale disposizione, precisa che ilmercato interno «comprende un sistema cheassicura che la concorrenza non sia falsata»,cosicche la concorrenza non falsata non appa-re piu come un obiettivo in se, ma piuttostocome uno strumento necessario per il buonfunzionamento del mercato interno.
11. L’art. 103 TFUE quale possibile basegiuridica per l’adozione di disposizioni in materiadi azioni di risarcimento del danno per violazionedelle norme antitrust dell’UEIn una prospettiva de iure condendo, e interes-sante osservare che, al momento in cui si scri-ve, la Commissione non ha ancora chiarito chetipo di proposta presentera per dar seguito al«Libro bianco in materia di azioni di risar-cimento del danno per violazione delle nor-me antitrust comunitarie» (Com. 2.4.2008,n. 2008/0165 def.). Non e peraltro noto se sioptera per una proposta articolata in atti dihard law (per disciplinare gli assi portanti del-la riforma) e atti di soft law, quali comunica-zioni e linee direttrici, per gli aspetti menoimportanti o suscettibili di essere meglio rego-lati a livello nazionale. Non e infine chiaro se,nell’ambito della prima categoria di atti, laCommissione procedera attraverso una propo-sta di regolamento o di direttiva avente, even-tualmente, come base giuridica l’articolo incommento. In proposito, va precisato che, an-che se sinora non si e mai fatto ricorso allostrumento normativo della direttiva per l’ap-plicazione degli ex artt. 81 e 82 TCE (oggi 101e 102 TFUE), tecnicamente cio sarebbe possi-bile in virtu dell’enunciato stesso dell’articoloin commento che si riferisce indistintamente a«regolamenti o direttive utili ai fini dell’appli-cazione dei principi contemplati negli artt. 101
103 Parte I - Tutela della concorrenza
156
e 102». Le peculiarita della materia, da unaparte, ed il potenziale vasto ambito d’applica-zione di un atto normativo diretto a discipli-narla, dall’altra, lasciano peraltro presagire chela Commissione optera verosimilmente peruna proposta di direttiva anziche di regola-mento.B Oltre all’articolo in commento, nella misu-ra in cui riguarda l’adozione di atti normativiaventi per obiettivo l’applicazione degli artt.101 e 102 TFUE, le altre possibili basi giuri-diche rinvenibili nel Trattato per legiferare inmateria di azioni di risarcimento del dannoper violazione delle norme europee antitrust(il c.d. private enforcement del diritto anti-trust) sono l’art. 81 TFUE (ex art. 65 TCE,riguardante la cooperazione giudiziaria in ma-teria civile), gli artt. 114 e 115 TFUE (ex artt.94 e 95 TCE, relativi al ravvicinamento delledisposizioni legislative, regolamentari ed am-ministrative degli Stati membri) ed infine l’art.352 TFUE (ex art. 308 TCE) (Milutinovic,Enforcement of Articles 81 and 82 EC beforeNational Courts Post-Courage: Enhancing aCommunity Policy or Shifting a CommunityLaw Paradigm?, Thesis of the European Uni-versity Institute, Firenze, 2008, 126-128).Stando a quanto affermato dalla Commissio-ne, il citato Libro bianco «analizza e presentaproposte relative a scelte politiche e misurespecifiche che garantirebbero, piu di quantoaccada attualmente, che tutte le vittime di vio-lazioni delle norme [europee] sulla concorren-za abbiano accesso a meccanismi di tutela ef-ficaci in modo da poter essere interamentecompensate del danno subito». L’obiettivoprimario del Libro bianco «e migliorare i ter-mini giuridici in base ai quali le vittime posso-no esercitare il diritto, garantito loro dal Trat-tato, al risarcimento di tutti i danni subiti inconseguenza della violazione delle norme [eu-ropee] antitrust. Il risarcimento completo edunque il primo e piu importante principioguida».Alla luce di siffatto obiettivo, l’art. 103, par. 2,sembrerebbe dunque la disposizione piu ap-propriata quale base giuridica di un’eventualeproposta ‘‘legislativa’’ della Commissione a se-guito della pubblicazione del Libro bianco in
materia di azioni di risarcimento del dannoper violazione delle norme antitrust. L’adozio-ne di un eventuale regolamento o direttiva inmateria sembra collimare, in particolare, con ildisposto della lett. e) del par. 2 dell’art. 103,secondo il quale scopo delle disposizioni di cuial par. 1 dello stesso articolo e di «definire irapporti fra le legislazioni nazionali da unaparte e le disposizioni della presente sezionenonche quelle adottate in applicazione delpresente articolo, dall’altra» (Komninos, TheEU White Paper for damages actions: a firstappraisal, in Concurrences, 2008, 2, 92). In al-tro contesto, la dottrina non ha peraltro esita-to a sollevare dubbi circa la possibilita di farleva sull’articolo in commento per interveniresulle disposizioni nazionali in materia proces-suale o di prove (Kerse, Khan, 299).Si orienta, tuttavia, in senso contrario la Riso-luzione del Parlamento europeo, del26.3.2009, sul Libro bianco in materia di azio-ni di risarcimento del danno per violazionedelle norme antitrust comunitarie [2008/2154(INI)], nella quale, dopo aver rilevatoche sinora la Commissione non ha specificatoqual e la base giuridica delle misure proposte eche occorre esaminare ulteriormente la que-stione di una base giuridica appropriata pergli interventi proposti a livello di procedurenazionali per danni extracontrattuali e dirittoprocessuale nazionale, si ribadisce la necessitadi coinvolgere il Parlamento europeo, nel qua-dro della procedura di codecisione (che corri-sponde alla procedura legislativa ordinariaistituita dal Trattato di Lisbona, v. supra, subpar. 5) [questo sarebbe, ad es., il caso qualorasi scegliesse come base giuridica l’ex art. 65TCE (ora art. 81 TFUE)], in relazione a qual-siasi progetto legislativo concernente i ricorsicollettivi. Tale posizione e in linea con la pro-posta di risoluzione della «Commissione per iproblemi economici e monetari» del Parla-mento europeo, nella quale si sollevanoespressamente dei dubbi circa la possibilitache la Commissione indichi come base giuri-dica l’articolo in commento.Le perplessita espresse dal Parlamento nonsembrano verosimilmente destinate ad atte-nuarsi con l’entrata in vigore del Trattato di
Le disposizioni di attuazione delle norme antitrust dell’UE 103
157
Lisbona, in considerazione, da una parte, dellaqualifica di atti non legislativi ora spettante airegolamenti e alle direttive aventi come basegiuridica l’articolo in commento (v. supra, subpar. 5) e, dall’altra, del ruolo ancora del tuttomarginale riservatogli nella procedura di ado-zione degli stessi, e cio nonostante l’ambito diapplicazione delle procedure nelle quali essocondivide la funzione legislativa col Consigliosia stato notevolmente ampliato.
12. Gli accordi internazionali in materia diconcorrenzaL’Unione europea ha la capacita di stipulareaccordi internazionali con uno o piu Paesiterzi o organizzazioni internazionali nell’insie-me dei settori disciplinati dai Trattati.La procedura per negoziare e concludere taliaccordi e disciplinata dall’art. 218 TFUE (cheha sostituito l’ex art. 300 TCE). I negoziati siaprono in seguito ad autorizzazione del Consi-glio, sono svolti dalla Commissione, assistita daeventuali comitati speciali designati dal Consi-glio, e successivamente conclusi da quest’ulti-mo, previa approvazione o consultazione, a se-conda dei casi, del Parlamento europeo.Conformemente al par. 6, lett. a), dell’art. 218TFUE, e lecito dedurre che la decisione diconclusione di un accordo in materia di con-correnza e adottata dal Consiglio, a maggio-ranza qualificata (art. 218, par. 8), previa con-sultazione del Parlamento europeo. L’appro-vazione anziche la consultazione di quest’ulti-mo e, infatti, richiesta solo in alcuni casi spe-cifici e nei casi di accordi che riguardano set-tori ai quali si applica la procedura legislativa,ordinaria o speciale, il che come si e visto none il caso delle norme di diritto derivato inmateria di concorrenza (v. supra, sub par. 5).A Come ricordato dalla Corte, la competenzadella Comunita (ora dell’Unione) a stipulareaccordi internazionali non deriva soltanto daun’esplicita attribuzione da parte del Trattato,ma puo anche risultare da altre disposizionidel Trattato e da atti emanati, in forza di talidisposizioni, dalle istituzioni comunitarie (c.d.principio del parallelismo dei poteri internied esterni). Di conseguenza, la Comunita(ora l’Unione), in forza delle regole di concor-
renza del Trattato e degli atti emanati per laloro applicazione, e competente a concludereaccordi internazionali in tale settore. Talecompetenza comporta necessariamente la pos-sibilita per la Comunita (ora per l’Unione) diaccettare norme convenzionali sulla ripartizio-ne delle rispettive competenze delle parti con-traenti nel settore della concorrenza, nella mi-sura in cui tali norme non alterino le compe-tenze della Comunita (ora dell’Unione) e dellesue istituzioni, quali sono concepite nel Trat-tato (C. Giust. CE, 10.4.1992, Parere 1/92,parr. 39-41).E dunque l’art. 103 che (in combinazione conl’art. 218 TFUE e con l’art. 352 TFUE, lad-dove l’accordo riguardi anche le concentrazio-ni tra imprese, v. supra, sub par. 4) costituiscela base giuridica per la conclusione di accordiinternazionali tra l’Unione e Paesi terzi in ma-teria di concorrenza. Attraverso la stipula ditali accordi, l’Unione persegue sostanzialmen-te l’obiettivo di evitare potenziali conflitti didiritto internazionale con Paesi terzi, le cuiimprese siano state fatte oggetto di proceduredi infrazione delle regole europee di concor-renza, e viceversa.Sebbene la Commissione sia competente, sulpiano interno, ad adottare decisioni individua-li di applicazione delle norme sulla concorren-za, essa non e tuttavia competente a conclude-re con uno Stato terzo un accordo internazio-nale in questo stesso settore. Infatti, questacompetenza interna non e tale da modificarela ripartizione delle competenze tra le istitu-zioni comunitarie in materia di conclusione diaccordi internazionali, ripartizione che e fissa-ta dall’ex art. 300 TCE (ora art. 218 TFUE)(C. Giust. CE, 9.8.1994, C-327/91, par. 41).Tra gli accordi di cooperazione bilaterale che laComunita ha stipulato in materia di concorren-za, utilizzando, tra le altre, quale base giuridical’articolo in commento, si segnala, in primo luo-go, l’accordo con gli Stati Uniti del 23 settem-bre 1991 (annullato dalla Corte di giustizia perdifetto di competenza a stipulare della Commis-sione, v. C. Giust. CE, 9.8.1994, C-327/91).B L’accordo e stato stipulato di nuovo il10.4.1995 (Dec. 10.4.1995, n. 95/145/CE/CE-CA, v. commento sub art. I, Acc. 23.9.1991),
103 Parte I - Tutela della concorrenza
158
con procedura corretta, e fatto retroagirequanto agli effetti dalla data di conclusionedell’accordo annullato, e poi completato dal-l’accordo del 4 giugno 1998 (Dec. 29.5.1998,n. 98/386/CE/CECA, v. commento sub artt.I-V, Acc. 4.6.1998), sull’utilizzazione dei prin-cipi della comitas gentium attiva nell’applica-zione del diritto della concorrenza (Tesauro,84). Esso prevede, tra l’altro, impegni di in-formazione, di assistenza reciproca nell’appli-cazione delle regole di concorrenza, di indagi-ne su impulso dell’altro contraente, nonche, adeterminate condizioni, di rinvio e sospensio-ne delle indagini quando siano gia in corsoprocedimenti paralleli potenzialmente interfe-renti (Fonderico, 2502).Un accordo sull’applicazione dei rispettivi di-ritti della concorrenza e stato stipulato anchecon il Canada (Dec. 29.4.1999, n. 1999/445/CE/CECA, v. commento sub artt. 1-12, Acc.17.6.1999).Si segnala, inoltre, l’accordo con il Giapponeper la cooperazione in materia di atti anticon-correnziali, approvato dal Consiglio con Dec.16.6.2003, n. 2003/520/CE (v. commento subartt. 1-6, Acc. 10.7.2003), avente per scopo dicontribuire all’efficace applicazione del diritto
della concorrenza di ciascuna parte contraen-te, promuovendo la cooperazione e il coordi-namento tra le rispettive autorita preposte allaconcorrenza, e di eliminare o ridurre la possi-bilita di controversie tra le parti in tutte lequestioni relative alla rispettiva applicazionedel diritto della concorrenza.Da ultimo, un accordo sostanzialmente analo-go e stato siglato il 23.5.2009 con la Repubbli-ca di Corea (previamente approvato dal Con-siglio con Dec. 16.2.2009, n. 2009/586/CE).Tali accordi, come ricorda Canino, La coope-razione internazionale, in Tosato, Bellodi (acura di), Il nuovo diritto europeo della concor-renza. Aspetti procedurali, Milano, 2004, 259,si ispirano essenzialmente a due modelli dicooperazione antitrust. Da una parte, essi siispirano agli accordi gia conclusi dagli StatiUniti con altri Paesi; dall’altra, sviluppanoquanto previsto dalle raccomandazioni emana-te dall’OCSE, in particolare le raccomandazio-ni del 1986 e del 1995 sulle pratiche anticon-correnziali aventi effetto sul commercio inter-nazionale e del 1998 su un’azione efficace con-tro i cartelli hard core.
Daniele P. Domenicucci
Poteri delle autorita degli Stati membri(art. 104 TFUE)
Norma di riferimento: art. 104 TFUE (ex art. 84 TCE).........................................................................................................................................................................................
104 [1] Fino al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni adottate inapplicazione dell’articolo 103, le autorita degli Stati membri decidono in
merito all’ammissibilita di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominantenel mercato interno, in conformita del diritto nazionale interno e delle disposizionidell’articolo 101, in particolare del paragrafo 3, e dell’articolo 102.
Riferimenti normativi: art. 4 TUE; artt. 42, 101, 102, 103, 105, 106, 267, 346 TFUE; Reg. CEE6.2.1962, n. 17/62; Reg. CEE 19.7.1968, n. 1017/68; Reg. CEE 22.12.1986, n. 4056/86; Reg.CEE 14.12.1987, n. 3975/87; Reg. CE 16.12.2002, n. 1/2003; Reg. CE 20.1.2004, n. 139/2004;Reg. CE 26.2.2004, n. 411/2004; Reg. CE 25.9.2006, n. 1419/2006.
Bibliografia: Adinolfi, sub art. 16, in Adinolfi, Daniele, Nascimbene, Amadeo (a cura di),L’applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Commentario al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, Milano, 2007; Bechtold, Brinker, Bosch, Hirsbrunner
Poteri delle autorita degli Stati membri 104
159
























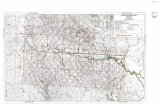



![1 / 24 @[103] Körper Arm # pudscham Auge # kann Bein ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631972571e5d335f8d0b2880/1-24-103-koerper-arm-pudscham-auge-kann-bein-.jpg)