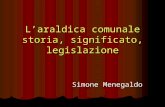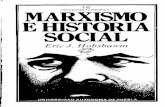Filostrato Sull'Allenamento (Introduzione storico-filosofica)
-
Upload
morningside -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Filostrato Sull'Allenamento (Introduzione storico-filosofica)
Attribuito a Filostrato (vissuto tra il 160-170 ed il 249 d. C.), "losofo so"sta docente di retorica dapprima ad Atene e poi a Roma, dove visse alla corte dell’imperatore Settimio Severo, ed autore di diverse opere tra le quali Le vite dei sofisti e la Vita di Apollonio di Tiana, il trattato Peri gymnastikés (qui tradotto con il titolo: Sull’allenamento) rappresenta un’opera di straordinario interesse dal punto di vista storico e culturale. Sull’allenamento
è infatti una delle poche opere dell’antichità giunta "no a noi che ci fornisce in modo sistematico informazioni di prima mano sulle tecniche e sulle modalità di pratica dello sport nel mondo antico. Il trattato condensa il sapere e le conoscenze sullo sport antico offrendo interessanti spunti di ri%essione "loso"ca e pedagogica, che vengono raccolti e sviluppati dai curatori di questa edizione, la prima pubblicata in Italia con testo greco e traduzione italiana a fronte completamente rivista e aggiornata secondo la più recente letteratura "lologica. Questa edizione ha lo scopo di diffondere nel vasto pubblico dei ricercatori, degli studenti e delle persone colte l’interesse per il trattato di Filostrato, mostrando come le implicazioni "loso"che e pedagogiche che esso presenta possano fornire spunti di ri%essione per la comprensione dello sport e dei suoi valori nella contemporaneità.
BIBLIOTECA 32
SE
TT
E C
ITT
À
BIBLIOTECA 32
euro 12,00
Filostrato
SULL’ALLENAMENTOcon testo greco a fronte
a cura di Paolo MadellaHeather L. ReidEmanuele IsidoriAlessandra Fazio
con una prefazione di Fernando García Romero
Fi
lostra
to
SU
LL’A
LLEN
AM
EN
TO
Biblioteca 32Serie Teoria e storia dell’educazione
Direttore della serieEmanuele Isidori (Università di Roma “Foro Italico”)
Comitato scienti$co della serieMirca Benetton (Università di Padova)
Ru#no Cano González (Università di Valladolid)Furio Pesci (Università di Roma “Sapienza”)
Maura Striano (Università di Napoli “Federico II”)
Comitato scienti$co della collana
Olivier Poncet (École Nationale des Chartes)Roberto Perin (York University)Francesco Bono (Università di Perugia)Matteo San#lippo (Università della Tuscia)Giovanni Pizzorusso (Università di Chieti)Manuela Martellini (Universà di Macerata)
SULL’ALLENAMENTOcon testo greco a fronte
a cura di Paolo MadellaHeather L. Reid
Emanuele IsidoriAlessandra Fazio
con una prefazione di Fernando García Romero
Filostrato
I edizione luglio 2015
isbn: 978-88-7853-382-0isbn ebook: 978-88-7853-581-7
Riproduzione vietata ai sensi di legge(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)
Edizioni � � � � � � � � � �
Via Mazzini 8701100 Viterbotel 0761 304967fax 0761 1760202
Questo volume è stato realizzato con il contributo di:
Fondazione Universitaria Foro Italico
Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute dell’ Università di Roma ‘Foro Italico’
Sommario
Prefazione 7Fernando García Romero
Introduzione storico-$loso$ca al Gymnasticus di Filosotrato 13Heather L. Reid
Filostrato e l’allenamento: per una pedagogia neo-antica dello sport 35Emanuele Isidori, Alessandra Fazio
Nota introduttiva: l’autore, il titolo, il testo 51Paolo Madella
Sull’allenamento 62
Postfazione dedicatoria 155
Bio-bibliogra$a dei curatori 157
13
Introduzione storico-filosofica al Gymnasticus di Filostrato1
Heather L. Reid
1. PremessaIl Gymnasticus di Filostrato viene descritto spesso come
l’unico testo antico in nostro possesso completamente dedicato all’atletica, che per gli antichi greci equivaleva al nostro “sport”. In genere, comunque, è considerato come un manuale tecnico per allenatori, di scarso valore per i sociologi e i %loso% dello sport. Gli allenatori e gli atleti moderni, inoltre, considerano il testo di poca utilità pratica. Persino gli esperti di letteratura potrebbero provare repulsione per la dubbia narrazione di Fi-lostrato sulla storia e sulla mitologia dello sport. In breve, gli esperti di sport, sia antichi che moderni, si sono chiesti che cosa si possa imparare dal Gymnasticus.
Non è una domanda di facile risposta per chi è interessato al potenziale sociale e didattico dello sport. In e(etti, una prima lettura del testo suscita più domande che risposte. Siamo col-piti tanto da ciò che il Gymnasticus non dice quanto da ciò che dice. In primo luogo, ci sono ben pochi consigli sull’allenamen-to quotidiano degli atleti per un testo che si presenta come un manuale per allenatori. In secondo luogo, risultano stranamen-te assenti le questioni della nudità e dell’erotismo nei ginnasi
1 Voglio ringraziare il National Endowment for the Humanities, la Andrew W. Mellon Foundation, e l’American Academy in Rome per il loro supporto. Qualsiasi opinione, risultato, conclusione o raccomandazione espressa in questo saggio non ri+ettono neces-sariamente quelle della National Endowment for the Humanities.
14
greci – un argomento di grande interesse nella letteratura ro-mana precedente. In terzo luogo, benché la ginnastica greca sia tradizionalmente associata con l’educazione alla virtù (arete), l’argomento viene a malapena a(rontato nel testo.
Invece di ciò che ci aspettiamo di trovare in un trattato sull’atletica antica, Filostrato dice molte cose inaspettate. Prima tra queste è che la ginnastica (cioè l’arte dell’allenamento atle-tico) è una forma di sapere (sophia), paragonabile alla %loso%a, alla poesia, alla musica, alla geometria e all’astronomia. Secon-da cosa, Filostrato o(re un ampio catalogo di tipologie di corpi di atleti, con lo scopo di rivelare non solo la loro idoneità per le speci%che gare, ma anche la loro natura morale. Terza cosa, egli descrive l’atletica greca come in uno stato di declino; si tratta di un’a(ermazione contraddetta dalle testimonianze storiche, che mostrano invece il III secolo d.C. come un momento di massi-mo livello per la partecipazione e l’apprezzamento dell’atletica greca. Come ad illustrare questo declino immaginato, Filostra-to, inoltre, dedica gran parte del suo testo ad un tipo di storia olimpica “revisionista”, vale a dire meno incentrata sulla verità che sul valore motivante delle storie che racconta.
Quindi, ritornando alla domanda precedente, che cosa ha da o(rire il Gymnasticus agli studenti e agli studiosi moderni di sport? Per scoprirlo, è necessaria una seconda lettura che pro-vi a rispondere alle domande suscitate dalla prima; vale a dire una lettura che consideri il contesto storico, la paideia greca e il rapporto tra natura e cultura. Per comprendere il Gymnasticus di Filostrato dobbiamo andare oltre le apparenze super%ciali e sintonizzarci sui simboli e i signi%cati su cui si fonda l’atleti-ca greca. Facendo ciò, impareremo che la ginnastica non è solo una forma di intrattenimento salutare, ma un’attività signi%ca-tiva che richiede educazione e sviluppa un'estetica che possia-mo de%nire “etica”. Scopriremo poi che, oltre alla competenza tecnica, è necessaria la sophia per trarre il meglio dalla nostra esperienza sportiva. E soprattutto, arriveremo a comprendere che coloro che praticano e apprezzano l’atletica costituiscono
15
una comunità con un’identità speci%ca improntata su una storia antica e gloriosa.
Tutte queste lezioni sono altrettanto importanti oggi quanto lo erano nella Roma Imperiale. Ma non si coglierà nessuna di tali lezioni dal testo se continuiamo a leggerlo solo come un ma-nuale di allenamento, cercando in esso soltanto suggerimenti per gli esercizi e metodi segreti per vincere una competizione. Il volume è di poca utilità per coloro che sono interessati solo alla vittoria e alla prestazione. Il Gymnasticus, alla %n %ne, è un tentativo di nobilitare l’atletica come pratica sociale per mez-zo della sua eredità greca e del suo potenziale didattico. Tale progetto è rilevante oggi quanto lo era nella Roma Imperiale, e merita la nostra attenzione e il nostro interesse.
2. Elementi attesi che non compaiono nel testo
2.1 Perché ci sono così pochi consigli pratici sull’al-lenamento?La prima cosa che ci aspettiamo di trovare in un volume del
periodo della Roma Imperiale che abbiamo intitolato in questa nuova traduzione italiana Sulla ginnastica è una serie di consigli pratici sull’allenamento per i gladiatori e gli aurighi così come per gli atleti di stile greco tradizionale. Il fatto che troviamo pochi consigli di questo tipo ci dovrebbe far chiedere quale sia il vero scopo del trattato e per chi è stato scritto. La decisione dell’autore di ignorare gli sport tradizionali romani non signi%-ca che non fossero popolari nel III secolo d.C., o che egli non li conoscesse. Ci indica che ciò che interessa Filostrato è l’atletica di stile greco e l’istituzione del ginnasio dello stesso stile. Que-ste due cose gli interessano precisamente perché sono greche, non nel senso che appartengono ad una particolare area geo-gra%ca o che sono prerogativa di un gruppo etnico particolare, ma piuttosto perché simboleggiano e personi%cano un sistema di valori e un atteggiamento verso la vita – un’identità socia-
16
le – che fu esso stesso un importante argomento di dibattito e negoziazione all’epoca nell’Impero romano.
Tale fenomeno storico-letterario è stato denominato Secon-da So%stica (dal titolo di una delle opere di Filostrato) e può essere considerato parte della rinascita della cultura greca tra le elite romane in un impero sempre più multiculturale. La di-nastia severiana (193-235 d.C.) inizia con il regno di Settimio Severo, un nordafricano che si schierò con un’illustre famiglia siriana sposando Julia Domna. Il loro %glio, Caracalla, eliminò la distinzione politica tra membri italici e non italici dell’Impe-ro con la Costituzione Antoniniana. Il periodo severiano vide una proliferazione di festival atletici, arte e architettura di stile greco in tutto l’Impero – inclusi i sontuosi Bagni di Caracalla a Roma. L’ultimo della dinastia, Alessandro Severo, %nanziò il re-stauro di quei bagni insieme a quello dello Stadio di Domiziano (oggi Piazza Navona), sede dei Giochi Capitolini di stile greco, e inaugurò lì i nuovi giochi in onore di Eracle – dio patrono della famiglia dei Severi e del Ginnasio greco (Ael. Sp. S.A. 35.4). Non solo l’atletica greca prosperò in questo periodo – superando persino l’Epoca Classica in termini di eventi e partecipazione – ma Julia Domna fu anche una grande patrona di %loso% e altri intellettuali, e lo stesso Filostrato fece parte della sua cerchia.
La cultura e l’educazione greca, la paideia, divennero segni di un’identità sociale d’elite in questo ambiente multiculturale,
e il Gymnasticus sembra indirizzato a quel tipo di lettore piut-tosto che a coloro che lavorano faticosamente ogni giorno in palestra con gli atleti. Filostrato si aspetta che il suo pubblico non solo sappia leggere il greco, ma sia anche a conoscenza della mitologia, della storia e della %loso%a greca – opere a cui al-lude nel suo libro con intelligenti riferimenti. Allo stesso tem-po, prova a istruire i suoi lettori, persuadendoli nella direzione di una comprensione e di un apprezzamento più approfonditi dell’allenamento e della ginnastica contemporanea, radicando entrambi nella gloriosa tradizione del passato greco. Ciò che Fi-lostrato fa è, da una parte, invitare il lettore a comprendere me-
17
glio la particolarità dell’atletica greca; d’altra, invece, è mettersi in competizione con alcuni intellettuali rivali – primo tra tutti Galeno – per costruire un’identità d’elite all’interno del mondo romano tramite la de%nizione di cosa signi%chi ricevere come persona una educazione greca – essere un pepaideumenos2. Il Gymnasticus è un manuale di istruzioni non tanto per atleti e allenatori quanto per coloro che desiderano raggiungere una comprensione veramente greca dello sport.
2.2 Perché non si discute di nudità, erotismo e pede-rastia? Questa comprensione greca dell’atletica sembra principal-
mente di tipo visivo piuttosto che partecipativo, cosa che suscita di nuovo la questione del motivo per cui il Gymnasticus parli così poco della nudità e per niente di pederastia o dell’erotismo in generale associati con il ginnasio greco. Questo è stato il fat-tore di preoccupazione principale di scrittori romani precedenti quali Cicerone e Seneca. Nelle parole di Plutarco, «I Romani era-no particolarmente sospettosi riguardo allo spalmarsi di olio, e ancora oggi credono che nient’altro sia stato tanto responsabile dell’asservimento e dell’e(eminatezza dei Greci quanto i loro ginnasi e le loro scuole di lotta, che generano nelle città molta indolenza, spreco di tempo e pederastia» (Plut. Quaes. Rom. 40, 274de). O, come espresso in modo coinciso dallo scrittore di era repubblicana Ennio, «L’inizio della vergogna è lo spogliarsi dei corpi maschili in pubblico» (Cic. Tusc. 4,70). È possibile che gli atteggiamenti siano cambiati nel III secolo d.C. e che Filostrato non senta alcun bisogno di rispondere a queste preoccupazioni. Più probabilmente, le respinge con un silenzio totale come in-comprensioni di persone incapaci di comprendere il signi%cato greco della ginnastica. Se quello che vedi, quando guardi uomi-
2 J. König (2009), Training athletes and interpreting the past in Philo-stratus’ Gymasticus, in E. Bowie, J. Elsner (eds), Philostratus, Cam-bridge University Press, Cambridge, pp. 251-283.
18
ni nudi che si spargono di olio e lottano nel ginnasio, è un’atmo-sfera carica di sensualità – c’è qualcosa di sbagliato in te. Non sei in grado di comprendere il vero signi%cato della nudità, della ginnastica, o persino della pederastia istituzionalizzata.
In molte città greche antiche, le relazioni erotiche di natura educativa tra maschi più anziani e adolescenti erano incorag-giate pubblicamente. Come mostra il Symposium di Senofonte, questi rapporti avevano l’approvazione dei genitori del ragazzo e lo scopo esplicito di sviluppare la virtù (arete). Il loro legame con il ginnasio ha più a che fare con la connessione tra atletica e arete che con la nudità e l’olio di oliva – almeno questo è il modo in cui una persona educata in stile greco la considerereb-be. In realtà, una persona che comprendesse le idee platoniche saprebbe che l’eros è un tipo di amore che spinge ognuno verso ciò che gli manca. Nel Symposium di Platone, l’amore erotico inizia con una comprensione dei corpi belli, poi procede con le anime belle, e in%ne si volge alla forma della bellezza e della bontà stesse. La pratica romana dello sfruttamento di giovani schiavi atletici per il piacere sessuale, però, s%da apertamente il paradigma della pederastia greca3. Il pepaideumenos compren-derebbe tutto ciò e vedrebbe nella bellezza di un giovane atleta il ri+esso dell’arete e della bontà stessa. L’attrazione puramente sessuale, al contrario, mira in basso verso il mondano e il car-nale – e non ha alcun posto nella comprensione del ginnasio da parte di una persona ben educata.
Le poche volte in cui Filostrato parla di sesso nel Gymna-sticus, usa varianti del verbo aphrodisiazo (fare sesso) e lo de-nigra come una forma di lussuria che corrompe ed è inappro-priata e dannosa per gli atleti (§45, 48). «Infatti si possono forse de%nire uomini», si chiede di coloro che scambierebbero «un piacere vergognoso con corone e araldi?» (§52). Ad un occhio greco allenato, la bellezza della ginnastica è associata con la
3 Z. Newby (2007), Greek Athletics in the Roman World Victory and Virtue. Oxford University Press, Oxford, pp. 125-134.
19
modestia e la castità – entrambe caratteristiche della virtù nota come sophrosyne (autocontrollo). Questo è l’ideale ri+esso nel-le immagini e nelle pratiche dei ginnasi greci. Gli altri scritti di Filostrato, soprattutto le Lettere d’amore e le Immagini, mo-strano un grande apprezzamento erotico per la giovane bellezza maschile e arrivano a denigrare come anerastos l’uomo che è insensibile ad essa (§4, 33, 52, 59). La chiave di tutto, comunque, è controllare sempre il proprio eros, come dice nella Lettera 43, «Essere innamorato e resistere all’amore rivela più autocontrol-lo che non innamorarsi a(atto». L’amore, come la forza, è una cosa grande quando è mirata a scopi virtuosi come l’atletica. Fi-lostrato omette le discussioni erotiche dal Gymnasticus per non dare la dignità di una risposta alle crude preoccupazioni degli autori Romani precedenti, e anche per plasmare una più elevata comprensione greca della bellezza atletica e dell’autocontrollo. Cosa vedevi e provavi guardando gli atleti greci rivelava moltis-simo chi eri e se eri stato educato in stile greco o “barbaro” (da straniero).
2.3 Perché così pochi riferimenti allo sviluppo dell’arete?Il terzo elemento che ci si aspetta sia discusso in un antico
trattato sulla ginnastica greca è la sua funzione come educazio-ne morale – l’uso delle attività atletiche per coltivare la virtù (arete) nei giovani. L’atletismo era stato preso come segno di arete molto prima dell’epica di Omero e della fondazione dei Giochi Olimpici4. Ciò che rese i Giochi Olimpici rivoluzionari fu il loro uso di una gara imparziale per selezionare un singolo vincitore. Come spiega Filostrato, «I corridori si trovavano ad una distanza di uno stadio5 dall’altare, davanti al quale stava in
4 H. Reid (2011), Athletics and Philosophy in the Ancient World: Con-tests of Virtue, Routledge, London, pp. 11-21.
5 Circa 200 metri.
20
piedi il sacerdote che fungeva da arbitro con una piccola %acco-la. Quello che riuscì a prevalere e ad appiccare il fuoco alle vit-time risultò essere il vincitore olimpionico» (§5). Questo mecca-nismo della gara imparziale avrebbe rivelato col tempo non solo che anche i non nobili potevano avere l’arete, ma anche che essa poteva essere coltivata tramite l’allenamento6. Dato che anche i %loso% greci classici (Socrate, Platone e Aristotele) promuo-vevano l’arete, essi (come Pitagora prima di loro) esercitavano il loro mestiere nei ginnasi, adattando le tecniche atletiche alla ricerca della sophia7. Ai tempi di Filostrato, l’educazione atletica era ancora ampiamente praticata, almeno nelle aree ellenizzate dell’impero8. È possibile che i %loso% siano rimasti nel ginnasio, come suggerito dalle immagini di statue e mosaici, nonché dall’inclusione di biblioteche e spazi simili ad aule nei ginnasi e nei complessi balneari romani 9.
Ciò che andò perso, apparentemente – almeno agli occhi di Filostrato – fu la fede popolare nella connessione tra atle-tismo e arete. Alla %ne del §2 egli spiega che questo problema non è colpa della natura. «La natura (physis) non ha sottratto agli atleti le virtù (aretai) di cui una volta erano provvisti, in-fatti ancora accompagna nella crescita uomini coraggiosi, di bell’aspetto, perspicaci: queste sono prerogative della natura; ma sistemi di allenamento non svolti secondo principi sani e pratiche poco vigorose hanno privato la natura della sua stes-sa forza» (§. 2). Questo brano suggerisce che il testo continuerà spiegando il tipo di allenamento atletico necessario per ridare alla natura la sua forza. Ma invece l’autore si lancia in un’analisi fantasiosa delle “origini” (aitias) di vari sport. Il termine arete
6 Per tutti questi argomenti cfr: H. L. Reid (2011), pp. 22-31.
7 Ivi, pp. 43-80.
8 Cfr. Z. Newby (2007), pp. 141-201.
9 A. Caruso (2013), Akademia: Archaeologia di una scuola $loso$ca ad Atene da Platone a Proclo (387 a.C.- 485 d.C.), Pandemos, Scuola Archaeologica Italiana di Atene, Paestum.
21
appare solo in altri due punti del testo; una volta in riferimento all’eroe Peleo (§3), ed un’altra come a qualcosa in cui “fanno commercio” allenatori senza scrupoli (§45). I termini che usa qui per mercante (kapelos) e fanno commercio (kapeleuo) sono esattamente quelli usati da Platone nel Protagora (313cd) per de-scrivere i so%sti che vendono ingannevolmente l’arete, quando invece essa è una cosa che deve emergere – come l’eccellenza atletica – in seguito all’allenamento10. Eppure, Filostrato o(re ben poco in termini di istruzioni per tale allenamento – segno forse dell’essersi arreso sulla connessione classica tra ginnastica ed educazione morale?
Come per le omissioni inaspettate precedentemente menzio-nate, penso che questa si possa spiegare in base alla natura del pubblico di Filostrato ed in base al tipo di educazione morale che egli sta impartendo. Il Gymnasticus è una forma di paideia, ma il suo pubblico non sono né i giovani atleti né i loro allena-tori, e la sua comprensione dell’arete è basata più sull’osserva-re, sul conoscere e sul parlare di atletica, che sull’allenamento e nella partecipazione ad essa. Il volume ha senso come prodotto culturale destinato a uomini d’elite romani per sviluppare un tipo di discernimento virtuoso da esercitare in occasioni sociali importanti, come le loro visite periodiche ai complessi termali-ginnasiali romani. Simile all’opera più famosa di Filostrato, le Imagines, in cui il narratore insegna ad un gruppo di giovani uomini i signi%cati culturali da trarre dai dipinti di una vil-la reale o immaginaria, il Gymnasticus sta insegnando ai suoi lettori a comprendere i signi%cati culturali reali e immaginari incarnati nelle immagini dal vivo e nelle immagini artistiche dell’atleta greco. La virtù che Filostrato ha in mente è non tanto il tipo di arete competitiva associata con gli eroi omerici e gli atleti olimpici, quanto un’arete estetica che consiste nell’esse-re in grado di apprezzare e agire conformemente alla bellezza inerente alla pratica atletica. Questo concetto può sembrare un
10 Vedi anche Platone, Gorgia, 517d e 518b.
22
approccio allo sport di stile tipicamente romano, basato sulla spettatorialità, ma in realtà è un altro ideale classicamente gre-co: quello della kalokagathia (bella bontà), la virtù appropriata per l’uomo nobile. Filostrato sta provando a costruire un mo-dello del pepaideumenos romano come kaloskagathos.
3. Elementi inattesi che compaiono nel testo
3.1 La ginnastica è una sophiaL’idea che la paideia di Filostrato miri alla kalokagathia è
confermata dagli elementi inattesi che compaiono nel testo. Il primo di questi è la primissima parola che compare nel testo: sophia (forma di sapere), e il primo esempio di sophia: philoso-phia; vi è poi l’audace a(ermazione che la Gymnastike sia una sophia, non inferiore a nessun’altra tecnica (techne). Il lettore attento noterà tre cose a questo punto. La prima cosa è che il riferimento di Filostrato alla musica, alla geometria e alla %lo-so%a richiama la Repubblica di Platone (376e-537b), in cui Socra-te si fa sostenitore dell’idea che un’istruzione in equilibrio tra gymnastike e mousike destinata ai futuri re-%loso% della città ideale, deve essere integrata con la geometria (dopo alcuni anni dedicati alla preparazione atletica/militare). Seconda cosa, il pe-paideumenos romano riconoscerà qui la presenza di una rispo-sta in contrasto con il pensiero di Galeno, che aveva denigrato l’allenamento atletico abbassandolo a pura tecnica (techne) sog-getta alla sophia della medicina, ritenuta molto più quali%cata a prendersi cura dei corpi e delle anime dei giovani (Protr. 14). La terza cosa, che riguarda entrambe le discussioni, è il più ampio dibattito %loso%co presente nell’antica %loso%a greca riguar-do la relazione tra techne (tecnica) e arete (virtù). Già ai tempi dell’Apologia di Platone, Socrate aveva detto che la conoscenza della tecnica era utile ma non produceva arete (22de). La cono-scenza più appropriata per l’arete sembra essere una sophia.
Alla luce di tutte queste allusioni %loso%che, è interessan-
23
te notare come Filostrato si consideri un so%sta piuttosto che un %losofo – distinzione che aveva ancora peso nel terzo secolo d.C.11. Tuttavia, egli distingue i %loso% dai so%sti non in base all’argomento o allo scopo, ma in base al fatto che un %losofo dichiara di non avere «nessuna conoscenza certa», mentre un so%sta «presume una conoscenza di ciò di cui parla» (VS 1.1).
Chiaramente, Filostrato ammira i %loso%. Loda Platone in una lettera a Julia Domna, a(ermando che egli prende in prestito i trucchi dei so%sti (Ep. 1.73). Ma il so%sma è più adatto alla situa-zione sociale di Filostrato. Il pepaideumenos romano deve non solo conoscere «ciò di cui parla», ma deve essere anche un per-sonaggio distinto che sa reggere il confronto in una società d’e-lite. I %loso%, quasi per de%nizione, erano intrusi irregolari che coltivavano la virtù confutando pubblicamente i loro interlocu-tori12. Filostrato, al contrario, sta seducendo il suo pubblico ad andare verso la paideia greca con la promessa che essa conferirà uno status di elite nella competizione sociale per l’onore (phi-lotimia) all’interno dell’Impero Romano. Era necessario essere personaggi distinti per avere successo in questo gioco sociale, ed era necessario fare più che seguire le regole – era necessario possedere la sophia.
Nel Gymnasticus la distinzione tra sophia e techne è sviluppata tramite la distinzione tra gymnastes e paidotribes nel §14. Entrambi i vocaboli si possono tradurre come “allenatore” e paidotribēs è il termine di solito più usato; ma Filostrato usa il termine gymnastes per indicare un allenatore che possiede la sophia oltre alla tecnica del paidotribes13. Egli dice chiaramente che il gymnastes deve conoscere tutte le tecniche e le strategie
11 H. Sidebottom (2009), Philostratus and the symbolic roles of the sophist and philosopher, in E. Bowie, J. Elsner (eds), Philostratus, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 69-99.
12 Cfr. H. Sidebottom (2009), pp. 94-95.
13 Qui Filostrato allude forse alla distinzione di Aristotele tra il gym-nastes ed il paidotribes fatta nel Politico, 4, 1288b.
24
pratiche del paidotribes, e avere anche la conoscenza medica di cose come «eliminare gli umori» e «ammorbidire le parti sec-che del corpo». Spiega poi che anche se il paidotribes conosce tali cose, «o, se ne avesse qualche cognizione, se ne servirà male nei confronti dei giovani, tormentando la libertà di un sangue innocente». Ciò suggerisce che la saggezza del gymnastes non è solo una combinazione di technai multiple, ma consiste piut-tosto nell’abilità di applicare la conoscenza tecnica in un modo che produca il bene – un’implicazione che risuona dell’idea pla-tonica che la virtù richiede la conoscenza del bene, e della de-%nizione di Aristotele di kalokagathia (Eud. Eth. 1.1216b19-25).
La ripresa di questa idea da parte di Filostrato è confermata nel §54, in cui il saggio gymnastes ri%uta la tecnica di allenamento “tetrade”, in+essibile e tecni%cata, che aveva condotto alla mor-te di un giovane lottatore. Egli conclude il capitolo (e forse il volume) con la predizione che una rinascita della sophia nella ginnastica e nell’allenamento «darà forza agli atleti e gli stadi recupereranno la loro gioventù». È l’estetica “etica” della sophia e non la techne che salverà lo sport e l’allenamento.
3.2 Fisiognomica e declino dello sportL’idea che la sophia sia un tipo di discernimento etico aiuta a
spiegare il secondo aspetto inatteso del volume – la sua preoccu-pazione per la %siognomica e il declino. Subito dopo l’a(erma-zione che l’allenamento è una sophia, Filostrato contrappone il triste stato della gymnastike contemporanea agli atleti eroici del passato quali Peleo, Teseo ed Eracle (§1). «Mi sembra opportuno indicare le cause per le quali si è sviluppata questa decadenza» continua nel §2, «e difendere la natura, di cui si sente parlare male perché gli atleti di oggi appaiono molto distanti da quelli antichi». Non è la natura che rende inferiori gli atleti contem-poranei, sostiene, ma piuttosto gli allenatori e le convenzioni dell’allenamento (nomoi) che mancano di sophia. Il declino è un tema greco di vecchia data che risale almeno al mito di Esio-
25
do delle età dell’oro, dell’argento, del bronzo e del ferro (WD 109-201)14, ma il Gymnasticus lo collega al dibattito %loso%co permanente sulla natura (physis) e sulla convenzione/regola (nomos). Filostrato a(erma che la ginnastica è innata, collegan-dola al mito della creazione di Prometeo (§16). Loda inoltre gli atleti antichi per la loro forza naturale nonostante la mancanza di allenatori e di conoscenze mediche. Ma Filostrato non sta promuovendo il ritorno a questo tipo di natura – dormire per terra e allenarsi gareggiando con le lepri (§43) –; ciò che ha in mente, invece, è un nomos di ginnastica so%sticata che agisca in armonia con la natura per perfezionarla.
L’idea che la virtù sia il perfezionamento della natura ha radici profonde nella %loso%a greca. Tuttavia, per perfeziona-re la natura bisogna prima conoscerla a fondo. Perciò la sophia dell’allenatore include l’abilità %siognomica per discernere la “natura” di un atleta – per spogliarlo ed esaminarlo prima che inizi l’allenamento (§26). Ciò spiega l’interpretazione estesa dei tipi di corpo atletico nei §29-42. Lo scopo qui non è (come pos-sono presumere i lettori contemporanei) scegliere gli atleti per il successo in gara. L’allenatore di Filostrato discerne non solo l’adeguatezza degli atleti per le diverse competizioni e i diver-si sport, ma sa anche giudicare il loro carattere morale (ethos) (§25). In contrasto con i giudici olimpici (hellanodikai), le cui regole (nomoi) limitano il loro giudizio a questioni di età, pro-venienza e classe sociale, il saggio gymnastes riesce a vedere se un atleta possiede autodisciplina e coraggio o se è ipocrita e impetuoso (§25). Per capire l’ethos di un atleta è necessario per prima cosa studiarne gli occhi, ma anche osservare l’armonia e la proporzione delle parti del suo corpo, come si fa con una statua15. Sebbene l’individuazione del carattere morale tramite
14 Per saperne di più sul tema del declino dello sport nel Gymna-sticus, si veda: C. Stocking (2013), “Ages of Athletes: Generational Decline in Philostratus’ Gymnasticus and Archaic Greek Poetry”, CHS Research Bulletin 1, 2.
15 J. Konig (2014) riconosce questo come un’allusione al canone di
26
l’osservazione del corpo sia una tecnica tradizionale della %sio-gnomica – una scienza risalente a Pitagora, collegata alla scuo-la di Aristotele e praticata da Galeno – Filostrato la porta un passo avanti. Applicando la %siognomica per capire se gli atleti sono adatti a certe competizioni e, mettendoci in mezzo idee estetiche come la simmetria e la proporzione, Filostrato non solo fa un esplicito richiamo al famoso canone dello scultore Policleto, ma anche alla fusione della bellezza con l’arete e con l’essere all’altezza di un compito dello stoico Epitteto (Disc. 3.1), ed anche all’elogio di Aristotele alla bellezza del pentatleta come conseguenza della sua adeguatezza alla speci%ca competizione (Rhet. 1361b.11). In sintesi, il corpo dell’atleta rivela la qualità della sua anima.
Se la bellezza e la virtù sono perfezionamenti della natura e la ginnastica è una cosa naturale, allora qual è il nomos che l’ha corrotta? Nel §44, Filostrato dice che il declino è iniziato con l’allontanamento degli atleti dalla pratica della guerra, che li ha fatti diventare pigri e %acchi. In seguito, quando preval-se la di(usione della gastronomia siciliana, «gli stadi vennero privati del vigore, soprattutto quando l’arte adulatoria si me-scolò all’allenamento». Questa allusione richiama il Gorgia di Platone (464b-66a) in cui l’arte adulatoria (kolakeia) ha causa-to la corruzione e il declino della medicina e della ginnastica. In particolare, era la cosmetica che in%acchiva la ginnastica – una techne che creava una bellezza puramente super%ciale. Ed era la cucina che in%acchiva la medicina – una techne mirata al piacere piuttosto che alla salute. Nel Gymnasticus è stata la promozione di cibi lussuriosi da parte della medicina che ha in-%acchito la ginnastica e ha causato il suo declino. Questo amore per la lussuria, in seguito, ha corrotto la castità degli atleti e in-%ne la loro devozione, come illustra Filostrato con un esempio
Policleito, una formula semi-matematica per produrre belle scul-ture (oggi scomparsa). Anche Aristotele collega la bellezza con la proporzione e l’armonia nella Meta%sica, 13, 1078a-32037: τοῦ δὲ καλοῦ μέγιστα εἴδη τάξις καὶ συμμετρία καὶ τὸ ὡρισμένον.
27
di atleti avidi che di fatto giurano sugli dei di aver comprato e venduto la vittoria. Anche gli allenatori sono diventati osses-sionati dal pro%tto e hanno %nito per fare commercio dell’arete atletica (§45) – un peccato quasi identico a quello di cui Socrate era solito accusare i so%sti. Il problema qui è che la lusinga mira al piacere o al pro%tto invece che all’eccellenza: perciò corrom-pe la natura invece di perfezionarla. Filostrato chiede un nuo-vo nomos atletico che – come dice nella sua seconda Dialexis – «stabilisca per gli uomini dei premi per la virtù (arete), come per onorare la Natura»16. Lo sport non dovrebbe semplicemente premiare la prestazione o i risultati, e gli atleti non dovrebbero competere per la fama ed il successo, ma piuttosto per il tipo di virtù (arete) che è un perfezionamento della loro natura.
3.3 Storia e interpretazione Il riavvicinamento di nomos e physis, al pari della sophia che
nobilita la techne, dipende dalla comprensione del passato greco da parte dell’allenatore. La sua abilità nell’interpretare l’atletica contemporanea in base a quel passato ha inoltre la capacità di far rivivere le virtù antiche. Filostrato descrive e dimostra que-sto processo tramite la sua ricostruzione fantasiosa del mito e della storia dello sport. Inizia con una narrazione lunga dieci capitoli sulle origini, o meglio, sulle ragioni (aitiai) delle tradi-zionali competizioni atletiche greche. Giusti%ca la narrazione nel §12 a(ermando che le competizioni furono tutte inventate l’una dopo l’altra e perfezionate dagli allenatori. Io credo tutta-via che le vere intenzioni dell’autore in questa speci%ca parte del suo trattato siano didattiche: vuole istruire i suoi lettori romani sull’atletica greca in modo che essa possa essere collocata in una storia più ampia della gloriosa storia greca (per lo più militare).
16 φύσις μὲν ἔννουν δημιουργεῖ τὸν ἄνθρωπον καὶ λογικὸν καὶ εὐφυᾶ πάντα, νόμος δὲ παιδεύει καὶ ὁπλίζει καὶ ὑποδεῖ καὶ ἀμφιέννυσιν, ἐπειδὴ γυμνὸς αὐτῷ παρὰ τῆς φύσεως πέμπεται, προτίθησι δὲ ὁ νόμος καὶ ἀρετῆς ἆθλα ἀνθρώποις, οἷον τιμῶν τὴν φύσιν.
28
Perciò egli evidenzia come il dolichos (gara di resistenza) derivi dai messaggeri in tempo di guerra (§5); la gara degli opliti com-memora battaglie mitologiche oltre che storiche (§7); il pugilato proviene dall’abitudine degli Spartani di combattere senza elmi (§9), e la lotta e il pankration sono collegati alla famosa battaglia di Maratona (§10). Lo scopo qui non è la verità storica. Molte narrazioni di Filostrato non hanno riscontro o sono contrad-dette da altre fonti. Per la gara degli opliti, elenca una serie di spiegazioni e poi ne inventa una sua (§7). Il suo scopo è raccon-tare una storia che convinca il suo pubblico del valore dell’at-letica, sia in senso pratico sia come parte integrante di quella identità culturale greca d’elite che essi desiderano conseguire.
L’originale stratagemma di accattivarsi il pubblico tramite la descrizione e l’interpretazione è anche compito del gymna-stes. Dopo aver elencato una schiera di campioni nei §12 e 13, Filostrato a(erma che le loro vittorie appartengono in egual modo ai loro allenatori. Capiamo il perché nei capitoli che vanno dal §17 al 24, che sono pieni di storie moralizzanti sui giochi antichi, inclusi i racconti in cui gli allenatori ispirano i loro atleti incoraggiandoli, rimproverandoli, minacciandoli o persino ingannandoli (§20). In essi, emozioni giovanili quali la malinconia, l’amore, l’orgoglio familiare e la lealtà personale, vengono trasformati in prestazioni virtuose tramite l’inventiva dell’allenatore. Così leggiamo di un tale innamorato, Promaco di Pellene, il cui allenatore lo ispirò alla vittoria con la bugia che la sua amata lo avrebbe ricambiato se avesse vinto ad Olim-pia (§22). Il racconto è narrato come elogio dell’allenatore, che ha interpretato la situazione correttamente e ha trasformato la debolezza erotica del suo atleta in virtù. Filostrato sembra al-trettanto disposto a dire bugie per %ni virtuosi – come dimostra scegliendo la storia di un allenatore che uccide un atleta pigro con uno strigile aÍlato, come sua spiegazione preferita del fatto che gli allenatori portano con sé tale utensile. «Io credo a questo racconto», a(erma, «infatti è meglio prestar fede che dubitare. Si rivolga dunque lo strigile come spada verso i cattivi atleti e ad
29
Olimpia l’allenatore sia considerato superiore agli Ellanodici» (§18). La descrizione e l’interpretazione del passato traggono il loro valore non dalla verità, ma dalla loro capacità di ispirare virtù.
Le strategie retoriche di Filostrato possono irritare la sensi-bilità morale moderna (soprattutto alla luce del ri%uto di Kant di permettere le bugie in qualsiasi circostanza), e possono ricor-darci il motivo per cui Platone era così critico verso i so%sti. Ma l’Ippia Minore dello stesso Platone suggerisce che mentire è un vizio solo quando viene usato contro il bene (371d); e la famosa “nobile bugia” della Repubblica (415a-d) viene difesa sulla base del fatto che farà interessare di più i cittadini alla città e l’uno all’altro. Il problema è una mancanza di sophia che, come ab-biamo visto, rappresenta il fallimento nel guidare la gymnastike – o qualunque altra pratica, inclusa la retorica – verso il bene. La gymnastike di Filostrato, come anche i so%sti e i protagoni-sti delle altre sue opere, praticano le loro arti con sophia: vale a dire, con comprensione e apprezzamento dell’antica cultura greca adeguati per un pepaideumenos. In realtà, un vero pepai-deumenos può e(ettivamente riportare in vita il passato greco. L’Eroico di Filostrato riporta una conversazione tra un mercan-te fenicio ed un viticoltore, la cui conoscenza e comprensione dell’eroe della Guerra di Troia Protesilao gli rende possibile in-teragire con lo spirito dell’eroe morto (Her. 9.5-11.7). La rinasci-ta di spiriti eroici tramite la rievocazione (mimesis) delle loro virtù è una spiegazione plausibile per l’invenzione delle com-petizioni atletiche17. In e(etti, le ripetute allusioni e riferimenti di Filostrato agli eroi, alle idee e alla lingua del passato greco potrebbero essere un tipo di mimesis pensato per riportarli in vita. Nel Gymnasticus, la retorica e l’interpretazione sono usate per far apparire gli atleti contemporanei come incarnazioni di virtù antiche, e perciò per far rinascere lo spirito greco classico
17 Cfr. G. Nagy (2013), 4e Ancient Greek Hero in 24 Hours, Harvard University Press, Cambridge, MA.
30
nei giochi, nei ginnasi e nei complessi termali della Roma Im-periale.
4. Elementi rilevanti per lo sport di oggi
4.1 Un’estetica “etica”Le omissioni inaspettate nel Gymnasticus sulle questioni
dell’allenamento, dell’erotismo e dell’arete rivelano che il suo %ne era educare le elite romane ad un tipo di comprensione vi-siva, ad un’estetica che abbiamo de%nito “etica” che li rendesse in grado di comprendere e agire secondo la bellezza inerente alla pratica atletica. Nella Grecia antica questa comprensione era chiamata kalokagathia (essere sia belli che buoni), e descri-veva persone che avevano una comprensione talmente profonda della bellezza e di ciò che è bene, che i loro sentimenti e le loro azioni si orientavano spontaneamente verso di essa. Ciò signi-%ca che tali persone rinunciavano a interessi mondani quali il pro%tto e il piacere %sico, in favore di ideali superiori, come la virtù. Benché lo sport sia cambiato dai tempi antichi, ciò che è buono e bello negli atleti resta uguale. Non è il denaro, o la sti-ma, o persino la vittoria che è bene: è l’ideale di virtù incarnato nella bellezza dell’atleta che è alla base del valore di tutti questi elementi. Senza il suo perdurante legame con la virtù, lo sport non attrarrebbe mai popolarità e pro%tti come fa oggi. Occor-re però educazione ed una adeguata preparazione culturale per comprendere tutto questo. Chiunque può capire la desiderabili-tà della vittoria che porta premi e popolarità, così come chiun-que può capire l’attrattiva sessuale del corpo di un atleta (ma-schio o femmina che sia) ben allenato o allenata. Occorre però educazione per andare oltre la super%cie delle cose e cogliere i veri beni alla base di esse. L’abilità di comprendere tali beni e la bellezza che danno allo sport è la kalokagathia, vale a dire lo scopo della paideia di Filostrato.
4.2 Nomos, techne e sophia
31
Gli antichi dibattiti tra natura e convenzione (nomos con-tro physis) e techne contro arete permangono nelle questioni sul ruolo che le tecnologie e le attrezzature che migliorano le pre-stazioni dovrebbero svolgere nel conseguimento della vittoria sportiva. Il pensiero di Filostrato che la virtù era il perfeziona-mento della natura, e che perciò le convenzioni (nomoi) e le tec-nologie dovevano promuovere la natura e la virtù piuttosto che sminuirle, richiede la guida della sophia. Benché tecniche come il sistema di allenamento de%nito tetradi, o delle diete speciali, possano migliorare la prestazione dell’atleta, esse potrebbero ignorare e persino corrompere la sua vera natura con risulta-ti disastrosi. Le s%de che gli sport escogitano – oggi come nei tempi antichi – sono fatte apposta per stimolare l’amore della bellezza (kalon) e della virtù (arete). Fintanto che le tecnologie che migliorano le prestazioni ridurranno queste s%de quanti%-cando il compito o rendendolo più semplice, esse ridurranno la capacità dello sport di promuovere bellezza e virtù. Ad esem-pio, in una gara ciclistica che prevede la salita su di una grande montagna, un atleta potrebbe migliorare i propri risultati senza virtù o sforzi ulteriori usando semplicemente una bicicletta più leggera o assumendo una certa sostanza.
Fintanto che queste attrezzature, integratori, o medicina-li che migliorano le prestazioni ridurranno il ruolo della vir-tù nel successo sportivo, esse diminuiranno anche la capacità dello sport di produrre un bene sociale. Allo stesso tempo, la semplice misurazione elettronica della prestazione in termini di frequenza cardiaca, assorbimento di ossigeno, sviluppo di potenza muscolare e altri dati numerici, promuove la pericolosa idea che lo scopo dello sport sia solo il miglioramento di queste misurazioni, piuttosto che l’ottenimento della virtù. Anche i Pi-tagorici erano interessati ai numeri, ma essi cercavano di otte-nere un equilibrio armonioso, simmetrico, piuttosto che misure estreme in continuo aumento. L’avanzamento della techne non è necessariamente una cosa negativa per lo sport, ma ha bisogno della guida della sophia per rimanere %nalizzato al bene. Le re-
32
gole sportive e le convenzioni (nomoi) dello sport devono essere in linea con la natura (physis) – inclusa la natura fondamental-mente limitata degli esseri umani – per poter servire allo scopo della virtù (arete).
4.3 Storia e identitàL’uso del so%sma da parte di Filostrato per promuovere
un’identità speci%ca potrebbe in realtà essere una soluzione ra-gionevole per far rinascere lo sport contemporaneo. Essere un pepaideumenos in possesso di una educazione greca non è certo più un lasciapassare per un certo status sociale come lo era nella Roma Imperiale. In questi tempi di globalizzazione, tuttavia, gli sport in se stessi costituiscono spesso delle comunità – comu-nità sociali di pratiche, per usare il termine tecnico coniato dal %losofo Alaisdair MacIntyre18. Una comunità sociale di pratiche è un gruppo di persone unito da una pratica comune come la medicina, il lavorare a maglia, o il calcio. Come nella Roma di Filostrato, queste comunità conferiscono ai loro membri identi-tà e status, e costruiscono norme etiche – elaborano soprattutto concezioni di virtù morale – basate sui beni e sui valori interni alla pratica stessa.
Per comprendere in pieno una pratica come il calcio, e per capire i beni e i valori interni ad esso, si deve non solo praticarlo (ad un qualunque livello), ma si deve anche capire la sua storia e la sua mitologia19. Benché gli standard di verosimiglianza og-gigiorno siano probabilmente superiori a quanto lo fossero per
18 Cfr. A. MacIntyre (1981), A6er Virtue, Notre Dame University Press, Notre Dame, IN. La teoria di MacIntyre è stato applicata allo sport da studiosi come Graham McFee (2004), Sports, Rules and Values, Routledge, London, e William J. Morgan (1994), Le6ist 4eories of Sport, University of Illinois Press, Chicago.
19 Per sapere come applicare la teoria di MacIntyre allo sport, vedi Heather Reid (2012), Introduction to the Philosophy of Sport, Rowman and Little%eld, Lanham, MD, pp. 57-68.
33
Filostrato, la scelta delle storie che raccontiamo e il modo in cui le raccontiamo implicano molto spesso un tipo di mitizzazione che sarebbe familiare anche agli antichi greci. Il recente %lm su Jackie Robinson, 42 (uscito nel 2013), ad esempio, in cui si racconta la storia realmente accaduta del primo giocatore afro-americano a giocare nella Major League di Baseball negli Stati Uniti, lo ha presentato in una luce idealizzata, sorvolando o ri-visitando fatti storici. Il %lm ha fatto ciò per promuovere i valori interni dello sport, forse persino in risposta ad un declino per-cepito del baseball contemporaneo. Possiamo a(ermare certo che la paideia greca classica promossa da Filostrato può anche non essere particolarmente importante per uno sport come il baseball, essere magari centrale per i valori dei Giochi Olim-pici e, %no ad un certo punto, per tutti gli altri sport. Tuttavia sono convinta che il progetto di comprendere lo sport antico e il suo collegamento con la cultura greca classica può in realtà aiutare a far rinascere lo spirito dello sport contemporaneo allo stesso modo in cui Filostrato sperava che il suo Gymnasticus ridesse vita allo sport del suo tempo. Leggere di nuovo il Gym-nasticus con mente aperta e con attenzione è un ottimo punto di partenza*.20
* La traduzione dall’Inglese all’Italiano del testo di Heather Reid è stata fatta da Michela Menghini del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Roma “Foro Italico”.