Il concetto di 'consenso': una scala di transizioni dalla simpatia all'intesa ideale
Riformulare il concetto di potere bancario alla luce dell'analisi filosofica
Transcript of Riformulare il concetto di potere bancario alla luce dell'analisi filosofica
! 3!
INDICE
Introduzione e metodo………………………………………………………….. p. 7 I. IL POTERE BANCARIO: LE QUESTIONI FONDAMENTALI……… p. 11
1.1 Del potere…………………………………………………………………... p. 12
1.2 Definire il potere bancario………………………………………………….. p. 18
1.2.1 Debito e colpa…………………………………………………………... p. 19
1.2.2 Lo spettro del denaro…………………………………………………… p. 27
1.2.3 Il banchiere è un disertore……………………………………………… p. 35
II. CAPITALISMO FINANZIARIO E SOGGETTO……………………… p. 43
2.1 Sostanza e apparenza nel capitalismo finanziario………………………… p. 43
2.2 La mano invisibile………………………………………………………… p. 52
2.3 Il debito come strumento di potere………………………………………… p. 60
III. IL TERRIBILE INGANNO…………………………………………….. p. 71
3.1 Oltre l’oppressione, oltre lo sfruttamento…………………………………. p. 73
3.2 Inter homines………………………………………………………………. p. 83
Conclusioni……………………………………………………………………. p. 101
Bibliografia…………………………………………………………………… p. 105
! 4!
!
! 5!
Il soggetto che parla in questo discorso non può occupare la posizione del giurista o del filosofo, vale a dire la posizione del soggetto universale. All’interno della lotta generale di cui parla, egli è necessariamente situato da una parte o dall’altra: è nella battaglia, ha degli avversari, si batte per ottenere una vittoria. Cerca senza dubbio di far valere il diritto; ma è del suo diritto che si tratta […]. E se anche parla della verità, sarà di quella verità prospettiva e strategica che gli permette di riportare la vittoria. […] Il suo ruolo non è quello sognato dai legislatori e dai filosofi, da Solone a Kant: stabilirsi tra gli avversari, al centro e al di sopra della mischia, imporre un armistizio, fondare un ordine che riconcili. Si tratta di stabilire un diritto marcato dalla disimmetria, e che funzioni come privilegio da mantenere o da ristabilire; si tratta di far valere una verità che funzioni come un’arma. Per il soggetto che tiene un simile discorso, la verità universale e il diritto generale sono illusioni o trappole.
(M. FOUCAULT, “Bisogna difendere la società”)
! 6!
! 7!
Introduzione e metodo
Analizzare il potere bancario negli anni della crisi sembrerebbe, a un primo
avviso, un’operazione ridondante rispetto a una letteratura (giornalistica, sociologica,
economica ecc.) che mostra di occuparsene già ampiamente.
La natura e l’articolazione del potere bancario sono però due questioni che
soffrono di un pregiudizio costante. Che sia un pregiudizio positivo (come nella
teoria economica classica) o negativo (come nelle teorie critiche dal medioevo in
poi) in ogni caso impedisce in partenza di rendere giustizia di un fenomeno così
influente rispetto alla nostra capacità di autodeterminarci.
Il tentativo di questa trattazione è esattamente questo: compiere un percorso ideale
nella letteratura sociologica e filosofica per restituire a questa nozione – il potere
bancario – un contenuto attuale e spendibile per le riflessioni che nell’immediato
futuro interesseranno il sistema dominante nei paesi occidentali e che, non a caso, va
sotto il nome di capitalismo finanziario.
La crisi del 2008, che costituisce un punto di partenza e di arrivo per il nostro
ragionamento, tra i molti innegabili aspetti negativi ha comunque fornito a chi si
occupa del proprio tempo la rara opportunità di osservare direttamente i più intimi
meccanismi del nostro sistema economico e politico, sia attraverso un’informazione
dettagliata e continua, sia dalla viva voce dei diretti interessati.
Le possibilità che si offrivano per analizzare il potere bancario erano quindi
molteplici: la ricostruzione giornalistica, l’analisi giuridica, l’analisi politica o quella
più specificamente economica. La nostra scelta è stata però quella di intraprendere
un’analisi filosofica, che insistesse sull’oggetto da più punti di vista, privilegiando il
pensiero critico anche a costo di non trovare una risposta certa alle questioni che via
via si andavano ponendo.
L’approccio che abbiamo scelto di adottare si può riassumere in due punti.
! 8!
Il primo deriva dall’idea straussiana di educazione liberale1, che presume non solo
l’ascolto delle grandi menti di ogni tempo, ma soprattutto la consapevolezza che esse
possano dialogare tramite la nostra mediazione.
Il secondo è l’idea hegeliana, pienamente recepita dalla moderna ‘pop-filosofia’,
che la filosofia sia «il proprio tempo appreso col pensiero»2, che essa cioè non debba
rinunciare, accanto alle istanze più tradizionali del logos, a servirsi anche del mythos3
per rendere conto dei fenomeni contemporanei (in cui si può ascrivere a pieno titolo
anche il capitalismo finanziario).
Chiarito questo, il nostro proposito è stato quello di rispondere a due domande:
«esiste una specificità del potere bancario?» e «il potere bancario si può considerare
in quanto politico?».
Per rispondere nel modo più esauriente possibile ci siamo quindi avvalsi di
molteplici fonti che spaziano dalla sociologia, alla filosofia politica, al giornalismo,
al marketing. Gli apporti teorici fondamentali sono comunque facilmente
individuabili nel corso della trattazione.
La rosa di autori comprende pensieri distanti nel tempo, anche se affini sul piano
dell’analisi. In particolare ricordiamo Schmitt per il concetto di politico e di potere;
la sistemica di Luhmann come punto di riferimento per l’interpretazione di alcune
dinamiche attuali; la governamentalità di Foucault nell’analisi del potere e delle
relazioni con il soggetto; il pensiero di Arendt per tracciare un confine tra sfera
pubblica e sfera privata; l’opera di Žižek per riattivare alcuni strumenti interpretativi
propri della psicanalisi lacaniana; la teologia economica4 come termine di paragone
costante.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 «liberal education consists in listening to the conversation among the greatest minds. But here we are confronted with the overwhelming difficulty that this conversation does not take place without our help - that in fact we must bring about that conversation.» L. Strauss, What is Liberal Education?, 6 giugno 1959 2 G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Bari, 1965, p. 15 3 «mythos e logos non formano una coppia di opposti, ma alludono a modalità per molti aspetti equivalenti per condurre una dimostrazione. Dall’altro lato, nel mythos risulta più immediatamente individuabile il rapporto con il “numinoso”, con quell’elemento fascinans et tremendum, estresso nel thauma.» in U. Curi, Prolegomeni per una popsophia, Mimesis, Milano, 2013, pp. 44-45 4 «Il modello utilitaristico diventa, nel XVIII secolo, il paradigma dell’autofondazione della sovranità dell’economia sulla politica […], l’economia diventa causa sui o, da una diversa prospettiva, resta un principio incausato […]. Ne scaturisce un modello religioso: l’economia di mercato, come la divinità monoteistica, non è creata ed è, al contempo, all’origine della creatio ex nihilo del cosmo socio-politico. Il capitale tende, fin dal suo momento genetico, ad assumere una strutturazione teologica […]» D. Fusaro, Minima Mercatalia: filosofia e capitalismo, Bompiani, Milano, 2012, p. 228
! 9!
A complemento della teoria, nel corso della trattazione abbiamo spesso fatto
riferimento a una considerevole mole di materiale audiovisivo risalente ai mesi
immediatamente successivi alla crisi e in particolare agli interrogatori svolti da una
commissione federale preposta a indagare sulle ragioni e le responsabilità del
tracollo economico, che sono integralmente visionabili online.
Avendo già a disposizione quasi cinque anni di materiale giornalistico, l’unica
intervista che abbiamo ritenuto interessante realizzare è stata quella a un esponente
del movimento Occupy Wall Street, il cui punto di vista privilegiato su come si sono
svolti gli eventi dell’occupazione ci ha aiutato a inquadrare ulteriormente la natura
dei rapporti tra potere finanziario e società.
Il lavoro si articola in tre parti.
Nel primo capitolo si fornisce una definizione del binomio ‘potere bancario’ e
vengono poste, come da titolo, le questioni fondamentali. Dopo aver fornito una
definizione preliminare dei termini ‘potere’ e ‘bancario’, l’analisi si concentra quindi
su alcuni aspetti fondamentali dello stesso, cioè il debito (in relazione alla colpa), lo
status del denaro in rapporto alla catena mezzi-fini e infine una prima analisi della
figura moderna del banchiere/finanziere.
Nel secondo capitolo invece l’attenzione è focalizzata sul contesto in cui il potere
bancario opera, cioè quello del capitalismo finanziario, in relazione al soggetto nella
doppia veste di soggetto razionale (homo oeconomicus) e pulsionale, per
argomentare in che modo il debito si costituisca come uno strumento di potere.
Nel terzo e ultimo capitolo invece si tenta di delineare la questione più
propriamente politica. Partendo dalla definizione classica di Schmitt, passando per le
categorie dell’impolitico di Esposito, l’interrogativo principale riguarda il rapporto
tra potere statale, comunità e potere economico, soprattutto alla luce delle dinamiche
conflittuali scatenate dalla crisi finanziaria.
! 10!
! 11!
I.
IL POTERE BANCARIO: LE QUESTIONI FONDAMENTALI
C.S. Consideriamo le cose da un altro punto di vista: di chi contempla e descrive in modo disinteressato il potere. G. E’ il punto di vista di un terzo o dell’intelletto astratto? C.S. Che intelletto e intelletto. Non cominciamo per favore con questi preconcetti. Cerchiamo di osservare almeno una volta in modo corretto una manifestazione storica del potere che tutti viviamo e subiamo; e otterremo un risultato.
(C. SCHMITT, Dialogo sul potere)
Partiamo dalle parole, dal binomio costituito dai termini ‘potere’ e ‘bancario’.
Cos’è infatti questo particolare tipo di rapporto asimmetrico che pure si definisce
potere? In che modo viene a costituirsi? Dal momento che non ogni forma di potere è
certamente bancaria né ogni soggetto creditore può dire di esercitare potere bancario,
chiarirsi sulla definizione è fondamentale.
Non si può semplicemente affermare che il potere bancario è quello esercitato
dalle banche, come pure fanno certi ordinamenti.
A livello filosofico, non farebbe altro che arenare il ragionamento contro una
tautologia indistricabile, con il rischio di coltivare, a partire da premesse troppo
vaghe, un facile pregiudizio nei confronti di una finanza già additata come causa di
tutti i mali contemporanei.
Esiste un fil rouge che collega tutti gli autori delle cui parole ci avvarremo in
questo primo capitolo. E cioè il fatto che quasi nessuno di loro parli mai
esplicitamente di banche né di potere bancario. Il potere bancario non viene mai
nominato per quello che è, ma rientra sempre nell’economico, nel tecnico, o nel
burocratico.
Ricostruire un senso filosofico del potere bancario vuol dire quindi ricostruire
un’assenza e allo stesso tempo riconoscerne, se esiste, la specificità.
Data la complessità dell’operazione in questo primo capitolo abbiamo cercato di
porre alcune questioni fondamentali e fornire alcune definizioni che verranno riprese
più avanti per rendere dovuto conto non solo degli aspetti squisitamente teorici, ma
soprattutto degli eventi che attengono alla riflessione sul potere bancario e
finanziario in senso più ampio.
! 12!
§1.1 Del potere
Carl Schmitt, le cui parole aprono il capitolo, ci fornisce un’utile riflessione in
merito alla natura del potere, pur senza definirlo in termini univoci. Il potere è
innanzitutto un fatto umano, «tutto ciò che riguarda il potere e la sua prassi si svolge
tra uomini. I detentori del potere di fronte a coloro che non lo hanno, i potenti di
fronte agli impotenti sono più semplicemente uomini di fronte a uomini»5.
Il potere è qualcosa che si da tra uomini, ma non per questo può essergli attribuita
una qualità morale particolare dipendente dal detentore o da chi lo ha investito di tale
potere, esso infatti «è una grandezza indipendente, anche di fronte al consenso che lo
ha creato […] è una grandezza oggettiva ed autonoma rispetto a qualsivoglia
individuo umano, che, di volta in volta, lo detenga nella proprie mani.»6
La realtà del potere passa sopra la realtà dell’uomo. Io non dico che il potere dell’uomo su un altro è buono. Non dico neanche che è cattivo. Dico però che è neutro. E mi vergognerei come essere pensante di dire che è positivo, se sono io ad averlo e negativo se a possederlo è il mio nemico. Mi limito ad affermare soltanto che il potere è per tutti, anche per il potente, una realtà a sé stante e lo trascina nella propria dialettica. Il potere è più forte di ogni volontà di potere, più forte di ogni bontà umana e fortunatamente anche di ogni malvagità umana.7
Questa premessa ci consente sicuramente di liberarci – almeno per il momento - dal
peso di un’analisi personalistica, cioè del chi detiene il potere. Infatti, pur
manifestandosi necessariamente in una relazione, il potere è una realtà che eccede le
parti: «[…] il potere anche là dove viene esercitato con il pieno assenso da parte di
tutti, ha un proprio significato, qualcosa di molto simile a un plusvalore; e ciò in
quanto vale più della somma di tutti i consensi ottenuti e anche più dei risultati che
consegue.»8
Se il potere è relazione e per forza di cose si manifesta in un rapporto, esso è tale
solo nel momento in cui può essere esercitato, «il potere non si dà» insomma «non si
scambia né si riprende, ma si esercita e non esiste che in atto»9. «Il potere è sempre,
vorremmo dire, un potere potenziale e non un’entità immutabile, misurabile e
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5 C. Schmitt, Dialogo sul Potere, Il Melangolo, Genova, 1990, p. 16 6 Ivi, p. 21 7 Ivi, p. 48 8 Ivi, p. 20 9 M. Foucault, “Bisogna difendere la società”, Feltrinelli, Milano, 2010, p. 22!
! 13!
indubbia come la forza o la potenza materiale. Mentre la forza è la qualità naturale di
un individuo separatamente preso, il potere scaturisce fra gli uomini quando agiscono
assieme, e svanisce appena si disperdono».10
E questo fatto fondamentale è vero per qualsiasi tipo di potere, anche solo
occasionale. Se manca la possibilità di realizzare tale potere il termine non è più
adatto a descrivere la relazione. Nel momento in cui questa potenzialità del potere è
accertata, il problema diventa individuare il contenuto di tale relazione.
Ogni volta che si parla di potere, infatti, di un potere qualsiasi che sia o non sia
propriamente ‘politico’, le sue interconnessioni con l’ambito del politico in senso
ampio sono comunque da giustificare.
Anche il potere bancario non può che essere analizzato in rapporto con il potere
politico con cui, necessariamente, si allea per sopravvivere. Questo però alla luce del
fatto che «il campo di relazione del ‘politico’ muta continuamente, in base alle forze
e ai poteri che si uniscono o si separano fra loro al fine di conservarsi»11.
Con il termine ‘politico’ quindi intendiamo la definizione classica12 e non una sua
declinazione particolare, come può essere ‘il governo’, ‘il sovrano’ e così via.
Secondo Schmitt la stessa equiparazione di ‘statale’ e ‘politico’:
è scorretta ed erronea nella stessa misura in cui Stato e società si compenetrano a vicenda e tutti gli affari fino allora statali diventano sociali e viceversa tutti gli affari fino allora «solo» sociali diventano statali [...]. Allora tutti i settori fino a quel momento «neutrali» - religione, cultura, educazione, economia – cessano di essere «neutrali» nel senso di non-statali e non-politici. […] compare lo Stato totale proprio dall’identità fra Stato e società […]. Di conseguenza, in esso, tutto è politico, almeno virtualmente, e il riferimento allo Stato non basta più a fondare un carattere distintivo specifico del ‘politico’.13
Sia se accogliamo la lettura di Schmitt o letture alternative del rapporto tra Stato e
società14, la posizione risultante del ‘politico’ non cambia: esso, in ogni caso, non
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10 H. Arendt, Vita activa, Bompiani, Milano, 2011 (1958), p. 147 11 C. Schmitt, Le categorie del «politico», Il Mulino, Bologna, 1972, p. 89 12 Passim 13 Ivi, pp. 105-106 14 La separazione tra Stato e società, che comunque Schmitt rileva quando indica che è «lo Stato totale, che non conosce più nulla di assolutamente ‘non-politico’, che deve allontanare le spoliticizzazioni del XIX secolo e particolarmente deve por termine all’assioma dell’economia libera dallo Stato (non politica) e dello Stato che non si occupa dell’economia.» Ivi, p. 108 Laddove Arendt, Foucault e Luhmann sembrano arrivare alla stessa conclusione nel momento in cui, contrariamente a Schmitt, affermano l’assimilazione di economia e società.
! 14!
risiede più in un unico e riconoscibile soggetto. Entriamo cioè nel campo di una
specifica governamentalità.
Ciò che attiene al rapporto tra il potere bancario e il ‘politico’ sarà comunque
oggetto del terzo capitolo. In questo momento il nostro interesse primario è ancora
quello di gettare delle ancore concettuali per orientarsi al meglio in uno scenario
sofisticato quale è il bancario. Come si vedrà, infatti, è quasi impossibile scindere
ordinatamente gli aspetti di tale potere. L’unico modo che abbiamo di osservarlo e
individuarne le caratteristiche è farle emergere tutte insieme e gradualmente,
valutando cosa comporterà ogni aggiunta al quadro generale.
Prendiamo quindi in esame ulteriori assunti sul potere e sulla relazione che è in
grado di instaurare.
Foucault affronta il potere in modo ‘genealogico’15, dunque non a partire dalle
istituzioni o dalle generalità più evidenti e immediate del potere bensì orientando
l’analisi «verso la dominazione (e non verso la sovranità), verso gli operatori
materiali, le forme di assoggettamento, le connessioni e le utilizzazioni dei sistemi
locali dell’assoggettamento, e infine verso i dispositivi di sapere.»16
La relazione di potere è dunque un rapporto di forza, di dominazione. Centrale è
la riflessione sul tipo di discorso che si sta osservando e che «stabilisce un legame
fondamentale tra rapporti di forza e relazioni di verità»17. Il problema foucaultiano
diventa «quello di stabilire quali sono le regole di diritto che le relazioni di potere
mettono in opera per produrre dei discorsi di verità; di determinare quale sia il tipo di
potere che è suscettibile di produrre discorsi di verità che sono, in una società come
la nostra, dotati di effetti così potenti.»18
Il potere a cui Foucault farà riferimento durante il corso del periodo 1978-1979
sarà quello della governamentalità liberale, ovvero quello della «verità economica
all’interno della ragione di governo.»19 Nel caso del potere bancario che, come
avremo modo di spiegare, fonda il suo particolare dominio20 sul debito e sul
godimento, si tratta quindi di capire se questo tipo di potere sia anch’esso «ciò che
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15 Cfr. M. Foucault, “Bisogna difendere la società”, op. cit., p. 17 16 Ivi, p. 37 17 Ivi, p. 51 18 Ivi, p. 29 19 Ivi, p. 33 20 Passim
! 15!
non esiste» e che «sia diventato comunque qualcosa, qualcosa che tuttavia continua a
non esistere.»21
In che modo intendere una non-esistenza? Foucault afferma che «si tratta di
qualcosa che non esiste e che tuttavia è iscritto nel reale, che appartiene a un regime
di verità che separa il vero dal falso.»22 Così l’economia, la politica non esistono ma
sono impresse, dal potere, nel reale.
Possiamo intendere il ‘Reale’, al di là della volontà dell’autore, nel senso con cui
ce lo consegna la riflessione di Jacques Lacan; «Ci imbattiamo qui nella differenza
lacaniana tra la realtà e il Reale: la prima è la realtà sociale delle persone concrete,
interagenti e coinvolte nel processo produttivo, mentre il Reale è la logica
inesorabile, spettrale, «astratta» del Capitale che determina ciò che accade nella
realtà sociale.»23 Del resto è proprio in questo scarto, come vedremo, che si
determinano l’esistenza e la criticità del sistema economico attuale, cioè «lo scarto
tra il Reale della circolazione speculativa del capitale e la tetra realtà delle masse
ridotte in povertà.»24
Luhmann dal canto suo analizza il potere nell’alveo della ‘differenziazione
funzionale’ della società: il potere «’è’ una comunicazione regolata da un codice»25,
o meglio «una struttura di mezzi di comunicazione trasmessa attraverso negazioni»26.
La negazione, in quanto ‘sanzione negativa’, è un aspetto rilevante nell’analisi. Le
cosiddette sanzioni positive «l’amore, il denaro, la persuasione al consenso rispetto a
determinati valori» secondo l’autore non possono essere specificate come casi di
potere. L’accento di Luhmann sulle sanzioni negative tende comunque ad essere
attenuato nel momento in cui sottolinea che «evitare l’uso di sanzioni […] è
indispensabile per la funzione del potere. […] E’ nell’interesse del potere evitare che
le cose si evolvano in tal senso. Già a livello strutturale (e non solo sul piano
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!21 M. Foucault, Nascita della biopolitica: Corso al Collège de France (1978-1979), Feltrinelli, Milano, 2012 (2004), p. 30 22 Ivi, p. 31 23 S. Žižek, Meno di Niente: Hegel e l’ombra del materialismo dialettico, Ponte delle Grazie, Milano, 2013, p. 209 24 Ivi, p. 301 25 N. Luhmann, Potere e complessità sociale, Il Saggiatore, Milano, 2010, p. 15 26 Ivi, p. 25
! 16!
giuridico) il potere si fonda quindi sul controllo dell’eccezione. Esso crolla se si
verifica la realizzazione delle alternative da evitare.»27
Per Luhmann, ad esempio, l’uso della violenza corrisponde all’annichilimento del
potere (o meglio, di un potere), in quanto: «[…] esso è tanto più grande quanto più
riesce ad affermarsi anche nei confronti di alternative allettanti sul piano degli atto o
delle omissioni […], può essere accresciuto soltanto congiuntamente ad un aumento
delle libertà da parte di coloro che sono sottoposti all’esercizio del potere. Il potere
va quindi distinto dalla costrizione» perché «le possibilità di scelta di colui che è
costretto sono ridotte a zero. Nel caso limite la costrizione diventa sinonimo di
esercizio di violenza fisica e conduce quindi alla sostituzione dell’azione propria
all’azione altrui non ottenibile.»28
Riecheggiano in questo passaggio le riflessioni foucaultiane sul liberalismo, che è
tale perché «consuma libertà. Se consuma libertà è obbligata anche a produrne, e se
la produce è obbligata anche a organizzarla»29.
Tuttavia la violenza, che è ancora oggi monopolio dello stato, è una prerogativa
centrale del potere, insieme alla costrizione, anche se ne costituisce il limite:
«l’esplosione della violenza “reale” è condizionata da un punto morto simbolico. La
violenza “reale” è una specie di acting out, di passaggio all’atto, che emerge quando
la fiction simbolica, che garantisce la vita di una comunità, è in pericolo».30
Così come non si dà il ‘politico’ senza la possibilità della guerra31 non sì da il
potere senza la possibilità che l’ordine venga imposto, in ultima analisi, con la
violenza.
Proviamo ad applicare questo ragionamento al caso del potere bancario. La
‘violenza’ in sé non è qualcosa che gli è proprio. Il monopolio della violenza fisica
infatti è ancora statale. Mentre la ‘costrizione’, cioè l’annichilimento delle alternative
di chi è soggetto al potere, è sicuramente tra le possibilità del potere bancario, ma se
lo Stato non presta fede all’eventualità della violenza, anche la costrizione diventa
vana.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!27 Ivi, p. 24 28 Ivi, p. 7 29 M. Foucault, Nascita della biopolitica, op. cit., p. 65 30 S. Žižek, Il Grande Altro, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 19 31 §infra !
! 17!
Inoltre «il potere che viene espresso esplicitamente assume entro il processo
comunicativo il carattere di minaccia, esponendosi all’eventualità di una esplicita
negazione. Poiché esso costituisce quindi già un primo passo verso la realizzazione
delle alternative da evitare, cioè un primo passo verso la distruzione del potere, si
evita possibilmente questa soluzione»32.
Se consideriamo quello che è accaduto, ad esempio, tra il governo ungherese e
l’Unione Europea, questo ragionamento diventa ancora più chiaro. L’UE, se da un
lato è un potere economico che trova la sua massima espressione nelle politiche
monetarie della Banca Centrale Europea, dall’altro circoscrive un’area di
appartenenza che ha prevalentemente a che fare con una certa idea di Stato e con il
rispetto dei diritti umani. Nel momento in cui l’Ungheria disconosce la sua adesione
ai valori europei33 nei fatti, e in particolare rendendo chiare le sue intenzioni di
minare l’indipendenza della propria Banca Centrale, dovremmo osservare nel pieno
della sua funzione la politica come ‘guerra proseguita con altri mezzi’.
Invece il risultato è che alle dichiarazioni di Viktor Orbàn non è dato replicare.
Un giornalista italiano commenta «Sempre severissima per i conti allo sbando
contro Grecia e Spagna, la Ue tace indifferente contro l'addio di Budapest a trattati e
valori costitutivi dell'Europa e del mondo libero.»34
Pur non essendo affatto vero, il punto che il giornalista non coglie è un altro. Nel
momento in cui l’Ungheria si chiama fuori dall’Unione, l’Europa non ‘tace’. Anzi,
proprio nel suo non tacere, nell’esprimere esplicitamente il suo potere, assistiamo
all’«eventualità di un’esplicità negazione» che svolge pienamente i suoi effetti sulla
relazione tra le parti in causa. La vera domanda, che il giornalista elude, è piuttosto
per quale motivo Grecia e Spagna (e in generale tutti i paesi oggetto dell’austerity),
accettino di ripagare il debito pubblico con le modalità prescritte dalla BCE e dal
Fondo Monetario Internazionale.
C’è qualcosa nel debito in sé che troviamo sia nella strategia ungherese sia in
quella europea e che prescinde dallo scenario politico e valoriale dei singoli paesi
che stiamo considerando. Essendo il debito di cui stiamo parlando, quello monetario,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!32 N. Luhmann, Potere e complessità sociale, op. cit., p. 28 33 A questo proposito Cfr. I valori fondativi dell’unione, Europa.eu 34A. Tarquini, “L’Ungheria di Orban sfida l’Ue e il Fmi. A rischio indipendenza Banca Centrale”, Repubblica.it, 1 marzo 2013!
! 18!
una prerogativa delle banche, è necessario però prima stabilire a cosa ci riferiamo
quando parliamo di ‘potere bancario’.
§ 1.2 Definire il potere bancario
Anche in assenza di altri elementi, possiamo comunque fornire una descrizione
preliminare del potere bancario che renda conto della sua specificità.
Per farlo depuriamo la funzione da tutto ciò che non le è propriamente specifico.
Ad esempio, concedere un prestito, che all’apparenza costituisce la funzione primaria
delle organizzazioni che chiamiamo banche, non è il contenuto specifico di tale
potere. Anche il monopolio dell’emissione di moneta, prerogativa attuale delle
banche centrali, è solo una capacità, un evento, tutto sommato recente, destinato
forse ad esaurirsi.
C’è un fatto che va tenuto sempre a mente, cioè che prima dell’economia
monetaria esistevano le banche, e prima delle banche esistevano i banchieri, e prima
ancora di tutto questo esisteva il debito.
Il potere bancario cioè si è innestato su qualcosa di molto più oscuro e arcaico – il
debito – e si è dato primariamente tra uomini, come qualsiasi tipo di potere che
possiamo considerare. Diverso dall’economico in senso stretto, che fa riferimento al
sistema dei bisogni, il bancario si innesta su un tipo diverso di contingenze.
A partire dai trapezisti35 dell’antica grecia, infatti, l’attività principale della
persona che chiameremo per semplicità banchiere è stata da un lato quella di
trasformare il debito in rappresentazioni simboliche, dall’altro quella di agire
contemporaneamente su una molteplicità di debiti per rimandarne l’effetto nel
tempo.
Il ‘bancario’ sembra, almeno a una prima analisi, instaurarsi sulla possibilità di
stabilire ciò che può essere promesso e ciò che non può esserlo, così come il politico
e l’economico, anch’esso divide ordinatamente la realtà complessa in un’antitesi
particolare. Garantire ciò che è promesso è già una questione che esula dal bancario
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!35 I trapezisti, nell’antica grecia, erano solitamente liberti che conservavano, prestavano denaro e si occupavano del cambio tra diverse monete nei pressi dei porti e del mercato. Prendono il nome dal banco su cui lavoravano, trapeza (tavola).
! 19!
in senso stretto ed entra nel campo del diritto. Alla base, come per tutti gli altri poteri
che entrano in gioco, troviamo sempre e comunque il mantenimento del patto sociale
e la sopravvivenza della comunità politica.
Ciò che comunica il banchiere che prende l’oro al commerciante che sta per
imbarcarsi verso i mercati internazionali è proprio questo: ti prometto che, in virtù
della mia alleanza particolare con la legge e con il governo, ciò che ti consegno e
che rappresenta simbolicamente l’oro, avrà valore ora e in futuro, tra tutti coloro che
ritengono valida questa promessa. Ti prometto che la carta, il conio, la mia firma,
varranno ad estinguere il debito e che il tuo corpo non verrà mutilato, i tuoi beni non
saranno confiscati, la tua libertà si conserverà intatta dopo la transazione.
Se il mercante fallisce, però, se la promessa non è mantenuta, il debito deve
comunque svolgere il suo effetto ed essere ripagato. L’equivalente simbolico non è
sempre sufficiente ad arginare gli effetti distruttivi del debito, ed è a partire da questa
evidenza che a nostro avviso si costituisce e si sviluppa fino a come lo conosciamo
oggi, il potere bancario.
§ 1.2.1 Debito e colpa
Afferma Foucault commentando Ferguson: «Il fatto del potere […] precede il
diritto destinato a instaurare, giustificare, limitare o intensificare questo potere.
Prima ancora di stabilirsi, prima ancora di divenire delegato, prima ancora di
definirsi giuridicamente, il potere esisteva già.»36
Quale fosse il tipo di potere, il rapporto di forza primigenio su cui si è impostato
lo sviluppo del potere bancario, l’abbiamo accennato poco fa: si tratta del potere
scaturito da una situazione di debito. Il debito inteso sia in termini monetari che
morali.
Il debito rimanda, dal latino debitus, a qualcosa che si è obbligati a fare, al dover
fare qualcosa. In greco due termini vengono tradotti con debito: ὀφείληµα (che è
dovuto, legalmente dovuto, ‘peccato’ in senso figurale); χρέος (il dovuto, come nella
favola di Esopo del debitore ateniese τὸ χρέος). Il debito cioè rimanda alla legge, al
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!36 M. Foucault, Nascita della biopolitica, op. cit., p. 249
! 20!
peccato (viene così tradotto in alcuni passi del Nuovo Testamento), ma soprattutto a
qualcosa che è dovuto in senso lato.
Riguarda da vicino il mantenimento del patto sociale ed è forse la prima
configurazione del potere attraverso il legame morale della gratitudine, come ricorda
anche la definizione dell’Oxford English Dictionary: «1. somma di denaro che si
deve; 2. La condizione in cui si deve del denaro; 3. Un sentimento di gratitudine per
un favore o un servizio».
Il debito quindi è prima di tutto un debito morale, umano, esistenziale. Prende
forma con la relazione. David Graeber, commentando l’atteggiamento delle religioni
antiche nei confronti del debito, afferma:
Da un lato, nella misura in cui tutte le relazioni umane implicano un debito, gli attori coinvolti sono moralmente compromessi, entrambi colpevoli per il fatto stesso di essere entrati in relazione […]. D’altro canto, quando diciamo che qualcuno agisce «come se non dovesse niente a nessuno», difficilmente ci riferiamo a un esempio di virtù. Nel mondo secolarizzato, moralità significa adempiere ai propri doveri verso gli altri, e noi abbiamo sviluppato una cocciuta tendenza a immaginarci questi obblighi come debiti.37
Si rende evidente il fraintendimento che guida il ragionamento alla base, e cioè che il
debito – pur riconosciuto come qualcosa di profondamente arcaico – venga poi
annoverato tra i mali del pensare moderno. Il debito infatti sembra sempre presente a
prescindere dal contesto storico o sociale:
il sistema del riconoscimento/redistribuzione porti sempre con sé un elemento di riconoscenza o di gratitudine, a testimonianza del fatto che l’altra faccia del donarsi agli altri è un indebitamento collettivo (un debito reciproco positivo) : in ciò che siamo e per quello che siamo divenuti, quanto dobbiamo alla generosità e alle prestazioni degli altri ? Così pure, l’obbligo di ricevere è altrettanto un imperativo sociale : nelle società arcaiche respingere un dono significa manifestare la paura di dover ricambiare, di non essere all’altezza del contraccambio e, quindi, il timore di aver perduto o perdere la stima sociale, il “peso del proprio nome”, di essere annientati nella lotta per il riconoscimento.38
Il debito originale porta con sé tutta la violenza dell’impossibilità di saldarlo
completamente: è il concepimento, è il dono, è l’amicizia, è l’amore.
Il debito verso l’altro, insondabile, non quantificabile, non può essere ripagato che
con la vita stessa o essere interrotto pagando il prezzo dell’inimicizia e del distacco
violento, (come nel famoso caso di Ernest Thompson che a venticinque anni si vede !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!37 D. Graeber, Debito. I primi 5000 anni, Il Saggiatore, Milano, 2012, p. 17-18 38 F. Fistetti, “Prefazione” in A. Caillé, Critica dell’uomo economico. Per une teoria anti-utilitarista dell’azione, Il Melangolo, Gênes, 2010
! 21!
presentare dal padre il registro delle spese sostenute durante la sua infanzia e
giovinezza, salda il conto e interrompe il rapporto con il genitore).39
Nel Seminario Lacan a proposito dell’onorario dell’analista afferma: «Ognun sa
che il denaro non serve solo per acquistare oggetti, ma che i prezzi che, nella nostra
civiltà, sono calcolati con più precisione possibile, hanno la funzione di smorzare
qualcosa di infinitamente più pericoloso del pagare in moneta, che è il dovere
qualcosa a qualcuno.»40
Il debito che non vuole essere saldato, un debito reciproco perenne, è infatti tipico
delle società egualitarie. «Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un
amore vicendevole» scrive Paolo di Tarso ai Romani, raggiungendo il culmine di un
percorso biblico che fin dai libri della legge aveva consegnato a Dio stesso il divieto
di prestare ad interesse e di ridurre quindi in schiavitù i propri ‘fratelli’ – perché il
debito produce tale effetto sul debitore facendo entrare il suo corpo nelle
disponibilità del creditore.
Se il debito non viene negato dalla struttura sociale, dalla tradizione o dalla
morale dominante, si rende necessario istituzionalizzarlo, regolarlo e, in ultima
analisi, materializzarlo (o smaterializzarlo, a seconda dei punti di vista) in un
equivalente simbolico, che assuma su di sé e in qualche modo neutralizzi la sua
ambivalenza morale.
Non a caso Simmel contrappone alla logica della gratitudine la logica del denaro,
la prima presuppone un’apertura all’altro, la seconda invece si fa portatrice del male
dell’uomo che troppo ha visto, l’atteggiamento blasé per cui ogni cosa si rende
equivalente smaterializzandosi nel denaro.
Il tema del debito non è certamente nuovo nel panorama filosofico e assume nella
letteratura i caratteri quasi teologici del peccato originale biblico, come ricorda
Roberto Esposito:
Benjamin riconosce nella produzione di colpa il dispositivo centrale di questo «capitalismo divino»: «Il capitalismo è verosimilmente il primo caso di culto che non purifica ma colpevolizza. […] Un’immane coscienza della colpa, che non sa purificarsi, fa ricorso al culto non per espiare in esso questa colpa, ma per renderla universale». […] Se per Freud di Totem e Tabu, la colpevolezza dei fratelli patricidi è il presupposto
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!39 L’episodio è raccontato in M. Atwood, Payback: Debt And The Shadow Side Of Wealth, House of Anansi Press Inc., Toronto, 2008 e riportato anche da Graeber. 40 J. Lacan, Il seminario, II, “La lettera rubata”, 26 aprile 1955, Einaudi, Torino, 1991, p. 259
! 22!
dell’ordine politico, Nietzsche è ancora più circostanziato nell’individuare l’origine della colpa nell’antica pratica del debito, accomunato ad essa dal medesimo termine Schuld. Come per Benjamin, anche per lui la prima colpa è costituita dall’insolvenza nei confronti di un creditore legittimato a vendicarsi con ogni mezzo sull’animo e sul corpo del debitore.41
Tuttavia equiparare il debito e il peccato non è del tutto esatto. Il debito infatti non è
una colpa in senso stretto. Il debito e la colpa possono incontrarsi in determinate
circostanze – e vedremo quali - ma sicuramente non nascono dalla stessa radice
concettuale.
Il fatto che le religioni, come ci ricorda Graeber, si approprino del lessico
economico, non rende l’eventuale equivalenza meno problematica. Stabilirne una tra
debito e colpa - metafisicamente intesa - sembra infatti condurre all’inevitabile
conclusione che il capitalismo stesso non sia altro che il nuovo volto senza
redenzione del peccato originale42. Tale approccio al debito va però criticato e
contestualizzato, a partire proprio dall’etimologia dove i due concetti sembrano, dal
principio, confondersi.
L’immediato senso del termine debito si può cogliere nella sua stretta connessione
con ‘dovere’, dal latino de abeo ‘avere da qualcuno’. Il tema indoeuropeo
dell’‘avere’ è gahabh come ‘entrare in possesso’, cioè un avere come conseguenza
durativa dell’azione del prendere. Ma il dovere non è sempre e solo un dovere di
restituzione, come ci ricorda Derrida:
far qui l’economia di una lenta, indiretta, incerta analisi di ciò che, in certe aree linguistiche e culturali determinate […] radica il dovere nel debito. Prima di impegnarvicisi, non possiamo distrarci da un sentimento di cui è difficile sapere se è o no condizionato da una lingua o da una cultura. E’ senza dubbio più che un sentimento […], ma sentiamo bene questo paradosso: un gesto sarebbe amorale […], se esso è realizzato per dovere nel senso di <<dovere di restituzione>> da un dovere che si ridurrebbe al pagamento di un debito, da un dovere come un dover-rendere ciò che è stato prestato o preso in prestito da qualcuno. La moralità pura deve eccedere tutti i calcoli, coscienti o inconsci, tutte le mire, tutti i progetti di restituzione o riappropriazione. Questo stesso sentimento ci dice, forse senza dettare alcunché, che bisogna andare al di là del dovere, almeno del dovere in quanto debito: il dovere non deve niente, non deve dover niente, dovrebbe in ogni caso niente dovere. Ma c’è un dovere senza debito? […] Qui si annuncia una rottura discreta e silenziosa con la cultura e il linguaggio; ciò è, questo sarebbe questo dovere. Ma se il debito, l’economia del debito, continua ad assillare ogni dovere, diremo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!41 R. Esposito, “Teologia politica e teologia economica”, Micromega, n.1 anno 2013, pp. 86-87!42 «Tuttavia la leggenda del peccato originale teologico ci narra come l'uomo sia stato condannato a guadagnare il pane col sudore della propria fronte; la storia del peccato originale economico ci mostra invece come mai esistano delle persone che non hanno assolutamente una tale necessità.» K. Marx, Il Capitale, Vol. I, cap. 24; Tra le pubblicazioni degli ultimi anni Cfr. E. Stimilli, Il debito del vivente, Quodlibet, Macerata, 2011
! 23!
noi che il dovere ordina di portarsi al di là del dovere? E che fra questi due doveri nessuna comune misura deve resistere al dolce ma intrattabile imperativo del primo? Ora, chi dimostrerà mai che questa ossessione del debito può o deve mai cessare di preoccupare il sentimento del dovere?
A questo punto Derrida propone alcuni percorsi di analisi del termine, dai già citati
Nietzsche e Freud a Kant, per poi avvalersi di due importanti definizioni. La prima di
Benveniste:
Il senso del lat. Debeo “dovere” sembra risultare dal termine de+habeo, composizione che non lascia alcun dubbio poiché il perfetto latino arcaico è ancora dehibui […]. Che vuol dire debeo? L’interpretazione corrente è “avere qualche cosa (che si è ricevuto) da qualcuno”: è molto semplice, forse troppo. Una difficoltà si presenta infatti subito: non si può spiegare la costruzione col dativo, debere aliquid alicui. In latino, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, debere non costituisce l’espressione propria per “dovere”, nel senso di “avere un debito”. La designazione tecnica, giuridica, del “debito” è aes alienum, per dire “avere dei debiti, estinguere un debito, in prigione per debiti”. Debere nel senso di “avere debiti” è poco frequente: è solo un suo derivato. Il senso di debere è un altro, benché si traduca come “dovere”. Si può “dovere” qualche cosa senza averla presa in prestito: per esempio l’affitto di una casa, che si “deve” benché non costituisca la restituzione di una somma presa in prestito. In virtù della sua formazione e della sua costruzione debeo deve interpretarsi a partire dal valore che gli deriva dal prefisso de, cioè “preso su, ritirato a”: quindi “avere (habere) qualche cosa che si è preso a (de) qualcuno”. […] L’obbligo del dare risulta solo dal fatto che si è depositari di ciò che appartiene a un altro. Ecco perché in epoca antica debeo non è il termine adatto per “debito”. C’è invece una relazione molto precisa tra “debito”, “dare in prestito” e “prendere a prestito” che si dice mutua pecunia: mutuam pecunia soluere “pagare un debito”. L’aggettivo mutuus definisce la relazione che caratterizza il “prestito”. […] L’aggettivo mutuus indica insieme il prestito che si fa e quello che si chiede, a seconda di come l’espressione è determinata. Si tratta sempre di denaro, restituito come è stato ricevuto.
Il debito ha insomma più a che fare con la reciprocità che con il dovere in senso
stretto. La reciprocità del rapporto che si instaura tra due soggetti che si considerino
alla pari al momento di contrarre un rapporto di debito. Il debito sarebbe dunque
«l’accordo tra uguali che non sono più uguali (almeno per un certo
tempo)».43L’uguaglianza può essere stabilita da vari fattori, non ultimo la legge (ad
esempio stabilendo che non si può prestare a minori o invalidi, o che comunque il
prestito non sarà garantito). Essa è altresì un elemento fondamentale per
comprendere il motivo per cui il debito e la colpa sono così spesso associati. Se
infatti la situazione di debito è scaturita da soggetti considerati o che si considerano
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!43 D. Graber, op. cit., p. 165
! 24!
uguali, «se il debitore non può fare ciò che lo restituirebbe all’uguaglianza, allora c’è
qualcosa di sbagliato in lui: dev’essere in colpa.»44
La colpa indica a partire dal greco kello dapprima “la spinta al mal fare”,
l’occasione di danno, un atto di volontà con il quale l’uomo offende la morale o le
leggi. Il significato di ‘colpa’ nelle leggi invece indica il danno cagionato per
mancanza di prudenza o diligenza, in contrapposizione al dolo dove invece la
volontà di fare del male è deliberata. Procedendo con la seconda definizione fornitaci
da Derrida, di Malamound:
Nel debito si combinano il dovere e la colpa: connessione che mette in evidenza la storia delle lingue germaniche: il tedesco Schuld significa parimenti “debito” e “colpa”, e schulig in una volta “colpevole” e “debitore”. Ora Schuld deriva da una forma gotica skuld che essa stessa si ricollega ad un verbo, skulan “avere l’obbligazione”, “essere in debito” (traduce, nel Vangelo, il verbo greco opheilo, che ha le due accezioni) ed anche “essere in colpa”. D’altra parte dalla stessa radice germanica *skal, ma anche con un altro trattamente dell’iniziale, derivano il verbo tedesco sollen “dovere (fare)” e l’inglese shall che, specializzato oggi nell’espressione del futuro, significava, in un più antico stadio della lingua, “dovere” nel senso pieno. […] Che l’uomo, secondo il brahmanismo, nasca “in quanto debito”, che questo debito sia la marca della sua condizione di mortale non significa che la natura dell’uomo sia determinata da un peccato originale. Come la parole sanscrita rna, “debito”, può talvolta cangiare in “colpa”, i filologi tedeschi dell’ultimo secolo, influenzati forse dall’ambiguità della parola Schuld, contemporaneamente “debito” e “colpa”, hanno suggerito di far derivare rna dalla stessa radice indo-europea latina: reus “accusato”, “colpevole”. L’etimologia è erronea, come pure sarebbe ingannevole una similitudine tra il debito fondamentale ed il peccato originale. Il debito non è né il segno né la conseguenza di una caduta, né, del resto, di un evento qualsiasi. Non risulta da un contratto, ma istalla immediatamente l’uomo nella condizione, lo statuto di debitore.45
Il problema, se si vuole scindere il debito dalla colpa, è a questo punto inserire una
terza discriminante nella definizione. Il debito infatti vive questo tipo di percorso:
uguaglianza/disuguaglianza/uguaglianza. Ma anche la colpa percorre le stesse tappe
di allontanamento e riavvicinamento alla parità (anche dove la parità riconquistata
significa morire per espiare la propria colpa). E in entrambi la conquista
dell’uguaglianza finale è incerta nel tempo e nei modi.
Abbiamo osservato come il debitore diviene colpevole nel momento in cui non
può ripagare il debito. Ma i motivi per cui non può? Ci addentriamo nel complesso e
insidioso sentiero del terzo termine, cioè quello della responsabilità.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!44 Ivi, p. 166 45 J. Derrida, Il segreto del nome. Tre saggi, Jaca Book, Milano, 1997, nota 5, pp. 96-100
! 25!
«Non possiamo pagare il debito perché non siamo responsabili del debito. Non
possiamo pagare il debito perché, al contrario, gli altri ci devono ciò che le più
grandi ricchezze non potranno mai ripagare: il debito di sangue.»46
Il caso del debito Africano, così come il caso del debito dei paesi Europei, fa
riflettere su un tipo particolare di responsabilità cosiddetta indiretta, cioè quello della
responsabilità collettiva.
La responsabilità collettiva è ammessa da alcuni ordinamenti in casi quali la
guerra, ma rimane comunque un’imputazione controversa nel momento in cui è
attuata nei confronti dell’intera comunità. Per mantenere una metafora biblica, la
responsabilità collettiva è la stessa che scatena il diluvio universale contro
un’umanità che certamente non è nella sua totalità colpevole. Si tratta sempre dei
molti che pagano per i pochi, in una sorta di livellamento statistico che divide
equamente le colpe tra tutti. E’ una responsabilità che ricade su tutti, per generazioni,
come nel caso della stirpe di Pelope.
Pelope, mitologico padre di Atreo e Tieste, attira la maledizione di Hermes – dio
dei commerci - non per aver vinto con l’inganno e con l’assassinio, ma per aver
mancato alla parola data all’auriga che l’ha aiutato, per non aver rispettato il patto.
Le conseguenze della maledizione sono note.
Così non è il patto, il debito, a configurare di per sé la colpa, ma l’impossibilità di
ripagarlo, che sia per volontà propria o per circostanze sopravvenute.
La peculiarità del debito però, nel momento in cui diventa colpa, è quella di una
irresistibile tendenza a moltiplicare i suoi effetti temporalmente e numericamente:
dal padre ai figli, di generazione in generazione, dallo Stato alla società civile, dalle
Banche ai governi. Il debito che non viene ripagato tende insomma ad accumularsi
anche a spese di chi non è direttamente responsabile dell’evento che lo ha originato.
Se questo è vero negli esempi biblici e mitologici, ancora di più si rende evidente
nei più attuali debiti monetari.
La moltiplicazione del debito monetario ha a che fare prima di tutto con un
particolare status culturale del denaro e cioè l’accordo che il denaro possa generare
interesse.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!46 T. Sankara, Discorso all’ONU del 4 ottobre 1984. Una traduzione è disponibile sul portale thomassankara.net
! 26!
Il problema dell’interesse e della fruttuosità del denaro è antico quanto il debito.
Ne troviamo già traccia a partire dall’Antico Testamento, e informa la maggior parte
delle riflessioni religiose di cui abbiamo conoscenza47. Se però fino ad ora abbiamo
osservato, almeno nelle etimologie germaniche, una stretta connessione tra il
debitore e il colpevole/peccatore, questo è meno vero per quanto riguarda il debito
monetario nelle fonti bibliche e coraniche. In questo caso è il creditore colui a cui si
applica la legge, la morale, che non deve prestare a interesse. Il problema della
moltiplicazione del debito monetario è insomma sempre attuale, va scongiurato
eradicando la stessa pratica che gli consente di replicarsi.
Perché se il debito morale può comunque affliggere il singolo o discendere per
generazioni familiari, il debito monetario contiene in sé la possibilità di assoggettare
tout court le masse popolari, di renderle insomma schiave. Prendiamo a titolo di
esempio alcuni passi dell’Antico Testamento:
«Se presti denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che vive con te, non devi fare l'usuraio: non puoi imporgli interesse.» Esodo, 22: 24 «Quando fate un prestito a un vostro connazionale – in denaro, cibo, o qualsiasi altra cosa – non esigerete da lui interessi. Potete esigere interessi da uno straniero, ma non da un connazionale.» Deuteronomio, 23: 20-21 «Non prenderete in pegno le due pietre che uno usa per macinare il grano, e neppure una sola di esse, perché in questo modo si prende in pegno quel che gli è necessario per vivere.» Deuteronomio, 24: 6 «Ogni sette anni saranno condonati tutti i debiti. […] Si potrà esigere da uno straniero il pagamento dei debiti; ma quelli che avrete con un connazionale saranno condonati. […] Se ubbidirete al Signore […] non ci saranno poveri tra voi […], sarete così in grado di fare prestiti a molti popoli, e voi non ne avrete bisogno. Dominerete su molti popoli, ma essi non riusciranno a dominarvi.» Deuteronomio, 15: 1-6
Troviamo ancora in relazione il debito, la colpa e il potere, ma con un nuovo sentiero
analitico che ci consente di scindere il debito e la colpa e di osservare forse con più
oggettività gli eventi economici degli ultimi anni. Si affaccia l’idea che il debito sia
stato utilizzato in un certo modo, ma che il debito in sé, anche quello economico così
gravido di minacce, non sia altro che uno strumento a disposizione di chi detiene il
potere di crearlo e manipolarlo, in un senso o nell’altro.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!47 Cfr. D. Graeber, op. cit.
! 27!
§ 1.2.2 Lo spettro del denaro
Parlare di debito richiama subito alla mente la forma più diffusa che esso prende
storicamente tra gli uomini, cioè quella del denaro.
Lo status del denaro e quello del debito sono identici al fine del mantenimento del
patto sociale. Aprendo qualsiasi libro di Economia Monetaria una delle prime
nozioni di cui si viene messi a parte è quella che il denaro vale tra gli uomini solo
perché c’è la ‘promessa’ che esso varrà anche in futuro, altrimenti nessuno
scambierebbe un bene qualsiasi per un oggetto o un simbolo che in sé non trattiene
nessun valore tangibile. Il valore del denaro infatti, allo stato attuale, è fisicamente
nullo – laddove ancora si mantiene un aggancio ad una forma fisica – potenzialmente
incommensurabile e ordinatamente categorizzato da chi ha il potere per stabilire tale
ordine a livello quanto più possibile globale.
Il concetto di promessa, già richiamato più volte, trova una sua specifica
definizione nell’opera di Arendt:
Il rimedio contro l’irreversibilità e l’imprevedibilità del processo avviato dall’azione non scaturisce da un’altra facoltà superiore, ma è una delle potenzialità dell’azione stessa. […] Rimedio all’imprevedibilità, alla caotica incertezza del futuro, è la facoltà di fare e mantenere delle promesse. […] il vincolarsi con delle promesse, serve a gettare nell’oceano dell’incertezza, quale è il futuro per definizione, isole di sicurezza senza le quali nemmeno la continuità, per non parlare di una durata di qualsiasi genere, sarebbe possibile nelle relazioni tra gli uomini.48
Così quella riguardante il denaro, come altre promesse simili49, è garantita da e
garantisce allo stesso tempo la continuità degli affari umani.
Se il capitalismo è risolutamente «materialista» (ciò che importa in definitiva è la ricchezza, il potere reale, i piaceri, tutte le altre cose sono solo «nobili menzogne», chimere che nascondono questa dura verità), questa saggezza cinica deve basarsi su una vasta rete di fede: tutto il sistema capitalistico funziona solo nella misura in cui si sta al gioco e si «crede» nel denaro, lo si prende sul serio, e si ha una fondamentale fiducia negli altri, che sono anch’essi supposti partecipare al gioco.50
E’ interessante che Žižek definisca l’economia come un ‘gioco’; da un punto di vista
dell’analisi, infatti, anche il gioco nella sua origine etimologica è una «gara giocata
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!48 H. Arendt, Vita activa, op. cit., p. 175 49 Anche il diritto, secondo Luhmann, garantisce il senso durativo degli eventi.!50 S. Žižek, In difesa delle cause perse: Materiali per la rivoluzione globale, Ponte delle Grazie, Milano, 2009, pp. 377-378
! 28!
secondo determinate regole». Così anche nel gioco economico, per partecipare,
ancora più che rispettarle è necessario ‘credere’ a tali regole.
Il denaro non ha valore per chi non attribuisce valore, per qualsiasi ragione, ai beni ottenuti per mezzo del denaro, cos’ come per chi non ha bisogno di denaro per ottenerli. In breve, il denaro è espressione e mezzo della relazione, della reciproca dipendenza degli uomini, della loro relatività, che fa sempre dipendere il soddisfacimento dei desideri degli uni dall’interazione con gli altri; non trova quindi posto dove non c’è relatività, sia perché non si desidera più nulla dagli altri uomini, sia perché ci si colloca ad un’altezza assoluta al di sopra di essi – quindi senza alcuna relazione con essi – e si può ottenere il soddisfacimento di ogni desiderio senza controprestazione.51
Chiarito questo, consideriamo alcune caratteristiche principali del denaro, a partire
dalla definizione, ormai classica, che ci fornisce Aristotele: «e come mezzo di
scambio per soddisfare il bisogno è nata, per convenzione, la moneta. E per questo
essa ha il nome di νοµισµα [moneta], perché non esiste per natura ma
per νοµος [legge], e perché dipende da noi cambiarne il valore o renderla senza
valore.»52
E’ utile considerare l’origine della parola greca che viene tradotta con ‘moneta’
perché è forse l’unica ad aver mantenuto una connessione non tanto con l’oggetto o
la sua fabbricazione53, quanto con il significato simbolico del denaro. Oltre al già
citato nomos, l’altra origine del termine è infatti il verbo νοµίζω che letteralmente si
traduce ‘credere’ o ‘essere soliti’. Conferma ulteriore che oltre la legge anche l’uso
concorre a stabilire lo status del denaro.
Una precisazione inoltre è d’obbligo. Contrariamente a quanto si possa pensare e
a quanto molti hanno ritenuto corretto a livello storico, il denaro non è primariamente
moneta. Secondo Graeber, nella sua minuziosa ricostruzione della storia del debito, il
denaro è stato concepito sin dall’inizio come credito:
tutte le versioni comunemente circolanti sulla storia monetaria «girano» all’incontrario. Noi non abbiamo cominciato col baratto, per poi scoprire la moneta e alla fine sviluppare un sistema di credito. E’ successo proprio l’opposto. Il cosiddetto «denaro virtuale» è venuto prima. Le monete sono arrivate molto dopo e il loro uso si è diffuso in maniera disomogenea, senza mai riuscire a sostituire completamente il sistema di credito.54
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!51 G. Simmel, Filosofia del Denaro, Utet, Torino, 1984, p. 232 52 Aristotele, Etica Nicomachea, Bompiani, Milano, 2000, p. 203 53 Come in ‘coin’ che si riferisce all’azione ‘to coin’, o ‘moneta’, che deriva probabilmente dal tempio di Giunone Moneta, dove fu edificata la prima zecca di Roma antica. 54 D. Graber, op. cit., p. 305!
! 29!
Le conclusioni di Graeber prendono avvio dagli studi di Mitchell Innes, economista
il cui lavoro ha permesso di gettare una nuova luce sulla storia dei sistemi monetari:
From the earliest days of which we have historical records, we are in the presence of a law of debt, and when we shall find, as we surely shall, records of ages still earlier than that of the great king Hamurabi, who compiled his code of the laws of Babylonia 2000 years B.C., we shall, I doubt not, still find traces of the same law. The sanctity of an obligation is, indeed, the foundation of all societies not only in all times, but at all stages of civilization; and the idea that to those whom we are accustomed to call savages, credit is unknown and only barter is used, is without foundation. From the merchant of China to the Redskin of America; from the Arab of the desert to the Hottentot of South Africa or the Maori of New Zealand, debts and credits are equally familiar to all, and the breaking of the pledged word, or the refusal to carry out an obligation is held equally disgraceful.55
Nella storia europea possiamo rintracciare un chiaro esempio di ciò che afferma
Innes nella Londra del XVII e XVIII secolo dove gli orafi londinesi, precursori dei
banchieri, crearono un tipo di banconota privata che corrispondeva nella sostanza ad
un debito.56 I commercianti inglesi infatti, non potendo fare affidamento sull’arbitrio
della corona in merito alla politica monetaria, si rivolsero ad un mercato parallelo,
basato sulla consuetudine, per garantire stabilità ai loro scambi. Gli orafi,
accorgendosi che le ricevute di deposito venivano utilizzate in sostituzione del
pagamento in moneta, compresero di poter dar vita ad un nuovo tipo di prestito
diverso dalle monete in oro e in argento.
L’esistenza di un tale mercato nel cuore dell’economia occidentale – Londra – in
un periodo così critico per lo sviluppo economico, ci riconduce alla questione più
filosofica del potere bancario, cioè alla capacità del banchiere nelle sue diverse
incarnazioni di stabilire con la sua attività ciò che vale come promessa, al di là delle
istituzioni che la giustificano. La forza della promessa fu tale che nel 1704 si rese
necessario un atto del Parlamento per annullare le decisioni giudiziarie che
stabilivano, nonostante la consuetudine, che le ricevute prestate dagli orafi non
potevano essere negoziate in luogo della moneta.
Queste recenti scoperte storiche ci consentono di leggere diversamente la
virtualizzazione del denaro, che appare come un fenomeno piuttosto recente e invece
non lo è affatto:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!55 A. M. Inness, “What is Money?”, The Banking Law Journal, maggio 1913, p. 391 56 Cfr. D. Graeber, op. cit.!
! 30!
Ed è solo a questo stadio, quando si traduce in un punto di riferimento puramente virtuale, che il denaro assume la forma di un’indistruttibile presenza spettrale: ti devo mille dollari, e indipendentemente da quante banconote materiali io possa bruciare, ti dovrò comunque mille dollari, poiché il mio debito è inscritto in qualche recesso dello spazio digitale virtuale.57
Il denaro è insomma da subito «un’indistruttibile presenza spettrale» e, come per
ogni ‘spettro’58 ci troviamo di fronte al «paradosso di un elemento fantasmatico che,
più viene annientato nella realtà, più ritorna forte nella sua presenza spettrale.»59
Quale sia il nucleo indistruttibile del denaro, quel «qualcosa in più di se stesso»
che ne determina la dinamica appena descritta, non è facile da definire60.
Simmel ad esempio riconosce che «il denaro svolge nel migliore dei modi le
proprie funzioni, se non è soltanto denaro, cioè se non rappresenta unicamente in
pura astrazione l’aspetto di valore delle cose.»61La virtualizzazione del denaro si
accompagna necessariamente, secondo l’autore, alla sua tendenza opposta, dovuta
alla mediazione della realtà tra concetti puri; in questo caso tra il puro concetto di
denaro e il suo valore intrinseco:
Il puro concetto di denaro, come espressione, estranea ad ogni valore intrinseco, del valore reciprocamente misurato delle cose, risulta del tutto giustificato, anche se nella realtà storica tale concetto appare sempre compenetrato e circoscritto dal concetto opposto che assegna al denaro un valore intrinseco. Il nostro intelletto può afferrare la misura della realtà soltanto come limitazione del campo di applicazione di concetti puri, che si legittimano, anche se si scostano dalla realtà, per il servizio che offrono alla sua interpretazione.62
Ma non è forse proprio il valore intrinseco del denaro a costituirne quel «qualcosa in
più»? Rispetto alla sua forma virtuale, al suo concetto puro, non sono forse proprio le
sue manifestazioni materiali a rappresentare l’’eccesso’ del denaro? Non a caso
Simmel afferma, coerentemente con questo ragionamento, che «le riserve auree,
conservate nelle cantine delle banche a copertura delle banconote, dimostrano
concretamente come il denaro produca effetti globali solo in virtù della sua pura
rappresentazione psicologica.»63
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!57 S. Žižek, Meno di Niente, op. cit., p. 302 58 Il riferimento è allo ‘spettro’ lacaniano. 59 S. Žižek, Il Grande Altro, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 21 60 Infra §3 61 G. Simmel, op. cit., p. 244 62 Ivi, p. 248 63 Ivi, p. 253!
! 31!
Che potrebbe essere anche letto come «il denaro svolge i suoi effetti globali in
virtù della sua pura rappresentazione psicologica nonostante le riserve auree, che
rappresentano l’eccesso del reale del denaro».
Il caso che meglio esemplifica questa affermazione è quello del broker che si vede
recapitare le mucche che aveva acquistato per speculare sulla differenza dei prezzi.
In questo caso possiamo capire cosa intendevamo prima e cosa intende Žižek
quando afferma che «la suprema forma di ideologia non consiste nel cadere preda
della spettralità ideologica, dimentichi delle persone reali e delle loro relazioni, ma
precisamente nel trascurare questo Reale della spettralità pretendendo di rivolgersi
direttamente alle “persone reali con le loro preoccupazioni reali”»64.
Qual è la conseguenza di questa prospettiva nell’analisi mezzi-fini?
Il denaro, scrive Georg Simmel, concede la chance di scegliere. Opportunità fatale, perché questa possibilità di scelta si paga ben oltre il valore del denaro. Non avendo infatti il denaro alcun rapporto con uno scopo, «ne ottiene uno con la totalità degli scopi». Il denaro, nota Simmel, non ha identità con l’oggetto e dunque non ha forma. Ecco allora che il denaro appare come «lo strumento la cui possibilità nelle applicazioni non previste ha raggiunto il massimo grado».65
Se il denaro sia un fine o un mezzo è difficile da stabilire. Certamente l’economia,
nel suo prendere sempre più una forma matematica, ha contribuito all’idea che
l’utilità sia prima di tutto un’utilità monetaria66 e che sia questo numero risultante a
essere la misura per giudicare la bontà di un’operazione economica (e in senso
ampio, di qualsiasi operazione). Molto banalmente, si tratta della convinzione che il
desiderio primario dell’individuo sia un guadagno monetizzabile. Tuttavia partire da
queste teorie (fondate più che altro su una necessità di semplificare in un modello il
comportamento umano67), per affermare che il denaro a livello generale sia un fine,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!64 S. Žižek, Meno di niente, op. cit., p. 300 65 M. Dotti, “Bisogno e desiderio, gli inganni del denaro”, ilmanifesto.it, 25 ottobre 2012 66 Cfr. A. Sen, Etica ed economia, Laterza, Bari, 2006. Libro in cui Sen si dedica proprio alla messa in discussione di alcuni assunti sulle preferenze degli individui e sulle motivazioni alternative che operano nelle scelte mercato, oltre a quelle più classicamente utilitariste. 67 Cfr. M. Draghi, Gli economisti e la crisi, Intervento del Governatore della Banca d’Italia, in Società italiana degli economisti, 50a Riunione scientifica annuale, Roma, 22 ottobre 2009 «Andare avanti, nella ricerca economica, sulla strada di una maggiore aderenza al contesto istituzionale e storico, alle caratteristiche strutturali del mondo reale, è imperativo. Dovremo per questo rinunciare a rigore, coerenza logica, quantificazione? Ovviamente no. Rimane fondamentale continuare a sviluppare strumenti (i modelli) che permettano di quantificare le relazioni tra variabili e la loro distribuzione di probabilità e valutare questi strumenti per la loro capacità esplicativa dei dati in nostro possesso. Non basta l’intuizione per capire un mondo in cui le interconnessioni tra le variabili sono semplicemente troppe e troppo complesse. I modelli sono essenziali per capire i meccanismi che sono all’origine dei
! 32!
cioè che la maggior parte delle persone consideri tutto il resto strumentale al denaro,
è probabilmente una falsa convinzione.
La confusione nasce piuttosto dal fatto che il denaro ‘misura di tutte le cose’ e il
mercato come luogo di veridizione68 tramite i meccanismi del prezzo costituiscono le
modalità principali con cui gli uomini leggono la propria realtà. Ma la misura di tutte
le cose non è da intendersi nel senso che il denaro sarebbe diventato il fine ultimo.
Siamo convinti infatti che il paradigma in cui ci stiamo muovendo sia molto più
complesso rispetto alla limitazione imposta da un simile assunto.
l’agire finalistico significa la consapevole compenetrazione delle nostre energie soggettive con un’esistenza oggettiva e che questo intreccio consiste in una duplice estensione e penetrazione della realtà nel soggetto: una prima volta nell’anticipazione del suo contenuto nella forma dell’intenzione soggettiva e una seconda volta nella ripercussione della sua realizzazione nella forma di una sensazione soggettiva. A partire da queste determinazioni si sviluppa il ruolo del fine nel sistema della vita.69
Il fatto che il denaro mini la realizzazione del fine, Simmel lo attribuisce
rispettivamente a ragioni di ordine socio culturali e a ragioni psicologiche, da
individuare nel fenomeno che l’autore chiama ‘estensione delle qualità nella serie dei
fini’; «Aumentando il suo valore in quanto mezzo, aumenta anche il suo valore di
mezzo.»70
Il rapporto tra il denaro è la cosalità del mondo è un tema ricorrente, a tal punto da
farci pensare che il risultato psicologico del denaro – l’uomo blasé – non sia la vera
catastrofe annunciata da Simmel quanto la perdita di questa cosa oggettiva su cui
l’agire finalistico insiste.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!comportamenti e del funzionamento dei mercati e quindi anche degli interventi correttivi di politica economica che dovessero essere necessari.» pp. 7-8 68 La veridizione è una forma di ‘dir vero’: «Se si dà il nome di filosofia critica a una filosofia che parta non dallo stupore per il fatto che ci sia dell’essere, ma dalla sorpresa per il fatto che ci sia della verità, si può allora vedere che esistono due forme di filosofia critica. Da una parte c’è quella che si domanda a quali condizioni possono esistere enunciati veri […]. E dall’altra c’è quella che s’interroga sulle differenti forme del dir vero.» M. Foucault, Mal Fare Dir Vero: funzione della confessione nella giustizia, Einaudi, Torino, 2013, p. 11; e ancora «la verità non è al di fuori del potere, né senza potere […]. La verità è di questo mondo; essa vi è prodotta grazie a molteplici costrizioni. E vi detiene effetti obbligati di potere. Ogni società ha il suo regime di verità, la sua «politica generale» della verità: i tipi di discorsi cioè che accoglie e fa funzionare come veri; i meccanismi e ele istanze che permettono di distinguere gli enunciati veri o falsi, il modo in cui si sanzionano gli uni e gli altri; le tecniche e i procedimenti che sono valorizzati per arrivare alla verità; lo statuto di coloro che hanno l’incarico di designare quel che funziona come vero» M. Foucault, Microfisica del Potere: interventi politici, Einaudi, Torino, 1977, p. 25 69 G. Simmel, op. cit., p. 302 70 Ivi, p. 339
! 33!
Se «le cose oppongono una resistenza sempre minore al denaro […] ad un punto
tale che il denaro vale come valore in senso assoluto e la coscienza del fine si arresta
definitivamente in esso»71, ciò che scompare non è l’Io che, anzi, si espande libero
dagli attriti dovuti al carattere stesso delle cose, ma il mondo stesso: Nelle condizioni di un mondo comune, la realtà non è garantita principalmente dalla “natura comune” di tutti gli uomini che lo costituiscono, ma piuttosto dal fatto che, nonostante le differenze di posizione e la risultante varietà di prospettive, ciascuno si occupa sempre dello stesso oggetto. […] La fine del mondo comune è destinata a prodursi quando esso viene visto sotto un unico aspetto e può mostrarsi in una sola prospettiva.72
Nel momento in cui Simmel utilizza apertamente i termini ‘fine’ e ‘valore’ in modo
indistinto, riconoscendoli come «lati diversi di uno stesso fenomeno, cioè della
rappresentazione della cosa»73 il mondo di cui parla Arendt è già svanito, le cose
«esisteranno solo in relazione a qualche altra cosa che può essere acquistata al loro
posto»; e dal momento che «il denaro […] non possiede l’esistenza indipendente e
oggettiva, capace di trascendere tutti gli usi e di sopravvivere a qualsiasi
manipolazione, che caratterizza invece ogni sistema di misurazione rispetto alle cose
che hanno lo scopo di misurare»74 si perderanno le misure assolute e con esse
l’’oggettivo’.
Ma il denaro così pensato ancora non si costituisce come ‘fine in sé’ in maniera
convincente.
«L’avere definito la bellezza come une promesse de bonheur rinvia
all’uguaglianza formale a livello psicologico tra il fascino estetico e quello del
denaro: perché in che cosa può consistere quest’ultimo se non nel promettere le gioie
che il denaro può procurarci?»75 L’accostamento interessante non è tanto quello della
bellezza al denaro, quanto il loro comun denominatore, la promessa della felicità.
Arendt spiega la persistente richiesta di felicità nella nostra società attraverso la
categoria dell’animal laborans, che pone come fine ultimo - misura di tutte le cose -
le necessità della vita biologica. Si profila qui un doppio problema del fine, a
prescindere dal ruolo che il denaro gioca al suo interno, è cioè il problema di ‘porre
fini’, tipico dell’utilitarismo, e il problema della «distinzione fra l’uomo e i suoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!71 Ibidem 72 H. Arendt, Vita Activa, op. cit., p. 43 73 G. Simmel, op. cit., p. 335 74 H. Arendt, Vita Activa, op. cit., p. 119 75 G. Simmel, op. cit., p. 470
! 34!
fini»76 dovuto, sempre secondo l’autrice, al «processo in cui lo stesso movimento del
lavoro agisce da forza unificante […] fra l’uomo e i suoi utensili.»77 In termini simili
Simmel descrive l’idealtipo dell’avaro e del prodigo, incapaci, come i protagonisti di
Vita Activa, di comprendere coscientemente i loro fini.
Però, laddove l’oggettivo di Arendt si sgretola, quello di Simmel trova invece un
suo punto di indifferenza tra la persistenza e il movimento: «Mentre come
individualità tangibile il denaro è la cosa più effimera del mondo pratico esterno, in
base al suo contenuto è la più stabile.»78
In questo senso la ‘spettralità’ del denaro è pienamente confermata dalle pagine
che chiudono l’ampio volume di Simmel. L’autore, che non aveva dubbi sulle
circostanze storiche e psicologiche da cui deriva l’attuale concezione di denaro, e che
non aveva esitato a definire «formula demoniaca» un certo atteggiamento nei
confronti di questo mezzo che assimila in potenza ogni fine, finisce con il
riconoscere nel denaro «il simbolo storico del carattere di relatività dell’essere.»79 Il
denaro in definitiva verrebbe a costituire un mondo stabile per gli uomini.
Ma il denaro non esce comunque dal meccanismo che lo incorpora; se «la formula
del fine è ternaria, quella del meccanismo soltanto binaria. […]»80 il problema
sussiste ancora. Per individuare un fine, non inteso come ‘valore’ ma come
‘significato’, sarebbe quindi necessario individuare il terzo elemento81 della formula.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!76 H. Arendt, Vita Activa, op. cit., p. 104 77 Ibidem 78 G. Simmel, op. cit., p. 717 79 Ibidem!80 Ivi, p. 303 81 «In un mondo strettamente utilitaristico, ogni fine è destinato a essere di breve durata e venir trasformato in mezzo per qualche altro fine. Questa difficoltà […] può essere definita teoreticamente come un’innata capacità di comprendere la distinzione tra utilità e significato espressa linguisticamente nella differenza tra le espressioni “al fine di” e “in nome di”. […] La difficoltà dell’utilitarismo è che rimane preso nella catena interminabile dei mezzi e dei fini senza arrivare mai a un principio che giustifichi la categoria di mezzi e fini, cioè dell’utilità stessa. L’espressione “al fine di” è diventata il contenuto di “in nome di”. In altre parole, l’utilità posta come significato genera l’assenza di significato.» H. Arendt, Vita Activa, op. cit., pp. 109-110. Il problema del terzo elemento in realtà non si può risolvere. La stessa Arendt non fornisce una visione alternativa al vuoto di senso generato dall’utilitarismo, limitandosi a esporre le due versioni antiche del problema: il detto di Protagora «l’uomo misura di tutti gli oggetti d’uso» (precursore del fine in sé kantiano) e l’intenzionale correzione di Platone «dio è la misura [anche] dei meri oggetti d’uso» (Leggi, 716 D)!
! 35!
§1.2.3 Il banchiere è un disertore
Un’altra questione, che abbiamo già in parte affrontato nel descrivere la natura del
debito, è la connessione problematica che da sempre unisce denaro e tempo e che
prende comunemente la forma dell’interesse.
Il denaro che genera denaro è pratica antica quanto additata come dannosa e
innaturale:
è compito della natura fornire il nutrimento all'essere che nasce e, in realtà, ciascun essere trae il nutrimento dal residuo di materia da cui è nato. Perciò è secondo natura per tutti la crematistica che ha come oggetto i frutti della terra e gli animali. Essa, come dicemmo, ha due forme, l'attività commerciale e l'economia domestica: questa è necessaria e apprezzata, l'altra basata sullo scambio, giustamente riprovata (infatti non è secondo natura, ma praticata dagli uni a spese degli altri); perciò si ha pienissima ragione a detestare l'usura, per il fatto che in tal caso i guadagni provengono dal denaro stesso e non da ciò per cui il denaro è stato inventato. Perché fu introdotto in vista dello scambio, mentre l'interesse lo fa crescere sempre di più [...]: sicché questa è tra le forme di guadagno la più contraria a natura.82
Anche Platone distingue l’‘arte di guadagnare denaro’ da altre arti che pure
comportano ricompense monetarie: «Questa nuova arte non è in nessun modo intesa
come l’elemento del lavoro in arti altrimenti libere, ma, al contrario, come quell’arte
per cui l’”artista”, il professionista, come diremmo noi, si mantiene libero dalla
necessità di lavorare.»83
Com’è noto, il denaro fruttifero costituisce in sé una delle forme più diffuse di
debito. In questa sua veste lo abbiamo incrociato nei passi dell’Antico Testamento e
anche nella versione di Aristotele il quale con usura si riferisce necessariamente ad
un debito su cui grava un certo interesse. Mentre nel primo esempio, come abbiamo
visto, il divieto serve a prevenire la riduzione in schiavitù tra connazionali, nel
secondo caso, così come in molti altri esempi in cui la prescrizione compare, il solo
assoggettamento non riesce a giustificare la persistenza del divieto.
Stiamo parlando di una condanna già presente nei testi sacri fondamentali,
sopravvissuta al declino delle civiltà, alla tecnica, ad ogni cambio di paradigma
economico, e che prima di tutto dimostra una divisione sociale fondamentale tra chi
lavora e chi vive di rendita.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!82 83 H. Arendt, Vita Activa, op. cit., p. 91!
! 36!
Ma la rendita dell’usuraio, per qualche motivo, è più odiosa di quella del
feudatario che pure è a spese del corpo dell’agricoltore e della sua famiglia.
Il guadagno del denaro che si svolge nel tempo (l’interesse) è eversivo, l'usuraio è
un disertore84 rispetto ad un sistema che riconosce al lavoro, all’economia reale, un
valore positivo e salvifico. Chi guadagna sul tempo apparentemente non fatica, vive
nell’ozio, vive insomma a spese di quel tempo che se nel Medioevo apparteneva a
Dio, ai giorni nostri non può che appartenere anche all’uomo.
Nella teoria economica classica la rendita è definibile come il reddito percepito in
virtù della proprietà di una risorsa naturale scarsa (che fosse la terra, il lavoro o il
capitale). La rendita del denaro, tipica dell’attuale potere bancario85, ha certamente a
che fare con tutte e tre le tipologie di risorse, ma è nel tempo che primariamente
trova la sua risorsa principale.
La questione a questo punto sarebbe quella di stabilire, come nel caso di tutte le
altre rendite, a spese di chi o di cosa il denaro si moltiplica. La risposta tuttavia non è
semplice né scontata. Per adesso quindi ci limiteremo ad evidenziare il fatto che la
rendita del denaro non si limita ad estrarre valore da una risorsa, ma allo stesso
tempo rende, nel suo senso originario di restituire, questo valore quando addirittura
non crea – dove prima non c’era – ulteriore valore.
Per questo motivo, nel delineare in apertura le caratteristiche fondamentali del
bancario, ci siamo riferiti alla capacità del banchiere di agire contemporaneamente
su una molteplicità di debiti per rimandarne l’effetto nel tempo.
Il debito monetario giunto a scadenza può ottenere infatti solo due effetti: la parità
o l’assoggettamento. Il debito monetario perpetrato nel tempo invece possiede la
capacità di moltiplicare la ricchezza esistente in modo potenzialmente illimitato.
Prima di analizzare ulteriormente il debito, occore però risolvere una questione; se
l’usuraio era un disertore rispetto alla comunità medievale, il banchiere o finanziere
moderno chi o che cosa starebbe disertando?
Come sempre, ci conviene partire dal duplice senso del verbo ‘disertare’ che in
primo luogo richiama proprio l’azione di ‘fare deserto’, con cui condivide
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!84 A questo proposito Cfr. J. Le Goff, La borsa e la vita, Laterza, Bari, 2003 85 Parliamo ovviamente della maggioranza delle banche, ma è pur vero che esistono sempre più realtà dove il divieto di praticare interesse è tornato in auge. Come nel caso recente della finanza islamica o in altre banche che hanno trovato vie praticabili di concedere credito e trovare comunque un guadagno senza la necessità di applicare apertamente un interesse sul denaro prestato o ricevuto.!!
! 37!
interamente le radici etimologiche. Disertare è infatti l’intensivo di ‘desèrere’
abbandonare, composto della particella ‘de’ che dà senso contrario e ‘sèrere’
intessere, legare insieme, annodare.
Far fruttare denaro è sempre stata prerogativa dello straniero, dell’outsider che
poteva trovare nel commercio – e in particolare nel commercio di denaro – l’unica
via per il riscatto sociale, alternativa al possesso di terra o all’appartenenza di classe.
In questo senso, nella sua estraneità alla comunità, si potrebbe leggere la pratica
dell’interesse dall’antichità a oggi. Un’antichità indefinita dal momento che, come
abbiamo visto, l’interesse ha occupato da sempre un posto privilegiato nella
riflessione politica e religiosa.
«La vita comunitaria si sviluppa in una relazione durevole con il campo e con la
casa»86 sono le parole con cui Tonnies apre l’opera dedicata al passaggio da
comunità a società, da un punto di vista storico e antropologico. Per quanto si
riconosca una certa pecca di nostalgia nell’argomentazione di Tonnies, oggi
assistiamo a fenomeni che dovrebbero farci riflettere sulla portata della sua
definizione. Il cosiddetto ritiro nella natura, per cui persone o intere comunità
rigettano la società il più possibile dedicandosi all’autosostentamento. La stessa
teoria della decrescita87 si iscrive in questa tendenza, tipicamente comunitaria per il
senso che abbiamo detto, di rifiuto della società. Ma la società e la comunità che
abitano le fantasie comunitariste sono ancora, paradossalmente, quelle di Tonnies. A
conferma di questo, il rifiuto della società prende sempre più spesso la forma di
rifiuto del capitalismo e di ciò che esso ha da offrire a tutti i livelli: la medicina, la
tecnologia alimentare, l’allevamento intensivo, l’informazione di massa e così via.
Ovviamente questo rifiuto si attualizza nel suo paradosso, nel caso ad esempio
dell’acquisto di prodotti biologici o etici che alimenta il processo produttivo e allo
stesso tempo fornisce un palliativo ai suoi mali. Ma anche il caso limite
dell’autosostentamento non arriva a ricostituire ‘la comunità’ non più di quanto
possa riuscirci una setta.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!86 F. Tonnies, Comunità e Società, Laterza, Bari, 2011 (1887), p. 49 87 Cfr. S. Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati Boringhieri, Torino, 2008!
! 38!
E’ il costituirsi di quello che viene definito il mito del momento-verità88, che torna
nel pensiero comune proprio nel momento di decadenza del suo opposto, il
progresso. Allora la comunità di Tonnies deve ancora interessarci non tanto per le
sue potenzialità storiche, ma soprattutto per la portata mitica che aveva all’epoca
dell’autore e continua ad avere tutt’oggi. Stesso discorso per la società.
Il secondo senso della parola ‘disertare’ è militare e indica il soldato che
furtivamente abbandona la bandiera contro il giuramento della milizia. Scriveva
Erodoto dei Lacedemoni:
E così i Lacedemoni, che ad uno ad uno non sono inferiori in combattimento ad alcun popolo, uniti insieme sono i più valorosi uomini del mondo. Perché sono liberi, ma non del tutto. C’è un padrone su di loro, la Legge: che essi temono molto più ancora che i tuoi non temano te; ed è certo che ne eseguono il comando, il quale è sempre lo stesso: divieto di sfuggire a qualsiasi numero di uomini in battaglia, e ordine di rimanere al proprio posto per vincere o morire.89
Ciò che distingue un uomo libero da uno schiavo (tra un greco e un persiano, e
quindi tra ‘noi’ e lo ‘straniero’), si ravvisa quindi nella Legge, diversamente intesa,
ma che è comunque una legge che riconosce qualcosa e limita qualcos’altro a livello
individuale. Nel caso moderno possiamo parlare dell’«ordine sociale esistente» come
«orizzonte ultimo in cui il soggetto scopre il proprio contenuto sostanziale ed è
riconosciuto in quanto tale […]» e dove «la libertà soggettiva può realizzarsi
soltanto nella razionalità dell’ordine etico universale.»90
Mentre tra il greco e il persiano intercorre una differenza sostanziale, nell’’ordine’
hegeliano «l’elemento non riconosciuto […] è così un prodotto necessario di questo
stesso ordine, è inerente ad esso, pur essendo sprovvisto di una precisa collocazione
al suo interno.»91
In questo caso la negatività dell’ordine esistente di cui si sta parlando è il concetto
di ‘plebe’ nei Lineamenti di Filosofia del Diritto di Hegel. Tirare in ballo la plebe
hegeliana per parlare della figura del banchiere potrebbe sembrare un azzardo, ma è
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!88 «E’, come vedete, una rivoluzione completa nel modo di pensare, una rivoluzione “copernicana” che sbocca nella querelle des anciens et des modernes e conduce, tra la fine del ‘600 e l’inizio del ‘700, a ben definiti ripudi del mito del momento-verità nel passato, e all’affermarsi della mentalità illuministica e del concetto di “progresso” nella storia umana.» F. Chabod, Storia dell’Idea di Europa, Laterza, Bari, 2003 (1961), p. 60 89 Erodoto, VII 104 90 S. Žižek, Meno di niente, op. cit., p. 531 91 Ibidem
! 39!
comunque interessante notare che proprio a questa ‘plebe’ - «dispensata da
qualunque obbligo verso la società»92 proprio in virtù del mancato riconoscimento da
parte della sostanza etica – autori come Frank Ruda93 ascrivano sia il troppo povero
che il troppo ricco. «Chi è eccessivamente ricco fa parte così di una specie di plebe,
nel senso che viola le regole della (o si esclude dalla) sfera dei doveri e delle libertà:
non solo pretende che la società provveda alla sua sussistenza senza dover lavorare,
ma questa sussistenza gli è fornita de facto.»94
Il detto Too big to fail esemplifica perfettamente la situazione. Se leggiamo la
‘plebe’ nei suoi sviluppi marxisti ci troviamo però di fronte a un’empasse. Per Marx
la plebe divenuta proletariato rappresenta infatti un eccesso di irrazionale rispetto
alla razionalità del sistema. La specie di plebe che si configura invece nel caso
dell’eccessiva ricchezza, del ‘giocatore d’azzardo’ di Ruda, non conosce tanto un
problema di irrazionalità quanto uno, più hegeliano, di riconoscimento. Ciò che
caratterizza la plebe è infatti il limitarsi a un generico sentimento del torto subito.
Nel 2010 Richard Fuld, interrogato dalla Financial Crisis Inquiry Commission
sorprendeva tutti con il suo atteggiamento tutt’altro che remissivo nei confronti degli
eventi che avevano portato l’economia americana al collasso: «Lehman […] fu
lasciata fallire non perché si rifiutò di agire con responsabilità; né perché non volle
cercare soluzioni alla crisi […] In realtà fu a causa di una decisione, basata su
informazioni sbagliate, di non sostenere la banca con le stesse misure che furono
adottate, di lì a pochi giorni, in favore dei suoi competitor e di altre società non
finanziarie».95
Anche nello stesso anno della crisi, interrogato dalla commissione federale, Fuld
rivelava un profondo scontento per il trattamento subito dalla Lehman, al di là delle
sue dichiarazioni di apertura secondo cui si attribuiva la piena responsabilità di ciò
che era avvenuto. Anche il film della BBC The Last Days of Lehman Brothers apre
con una domanda formulata dal narratore – uno stretto collaboratore di Fuld – che si
chiede per quale motivo la gente odi quelli che fanno il suo lavoro.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!92 Ibidem 93 Cfr. F. Ruda, Hegel’s rabble: an investigation into Hegel’s Philosophy of right, Continuum, 2011 94 Ivi, p. 534 95 V. Carlini, “L’ex ceo di Lehman Brothers Richard Fuld accusa: ci lasciarono fallire. Agli altri gli aiuti negati a noi”, Ilsole24ore.com, 1 settembre 2010!
! 40!
A partire da questo insieme di osservazioni possiamo formulare un duplice ordine
di ipotesi. L’ ipotesi più scontata potrebbe essere questa: il banchiere moderno è un
disertore rispetto a una fantasia, nel senso proprio del termine, di comunità. La
diserta prima di tutto facendone deserto, vampirizzandone le risorse per alimentare i
suoi traffici e in secondo luogo la diserta disconoscendone i valori e rendendo
insignificanti i suoi sforzi alla luce della preponderanza della virtualità sulla realtà
del lavoro. La comunità, che vede sé stessa in un certo modo, o vorrebbe essere in un
certo modo, deve intimamente negare ciò che il banchiere rappresenta e che
sottopone a una costante minaccia tutto quanto c’è di umano nel sistema. Il banchiere
moderno, similmente all’usuraio antico, non farebbe altro che ripetere l’ebreo
mentale’, per cui l’odio inscenato nei confronti del banchiere non sarebbe altro che il
tentativo finale di mantenere intatta la fantasia che sorregge la comunità:
La fantasia1 e la fantasia2, finzione simbolica e apparizione spettrale, sono così le due facce della stessa medaglia: finché una comunità fa esperienza della propria realtà in quanto regolata e strutturata dalla fantasia1, deve sconfessare la sua intrinseca impossibilità, l’antagonismo nel suo stesso cuore, e la fantasia2 (la figura dell’”ebreo mentale” per esempio) dà corpo a tale sconfessione. In breve, la concretezza della fantasia2 è la condizione affinché la fantasia1 mantenga il suo predominio.96
Finanza contro lavoro vivo, ozio contro operosità, amore per il denaro, moralità
ambigua, come un tempo giustificavano l’odio verso l’usura o verso gli ebrei, oggi
sarebbero le motivazioni principali per avversare il potere bancario. Anche il film
sopra citato rivela lo stesso pregiudizio quando pone al centro di una conversazione
un dipinto che ritrae il bacio di Giuda. Fuld sarebbe niente più niente meno che uno
Shylock contemporaneo solo che, al posto di una libbra di carne, gli sarebbe spettato
il salvataggio con soldi pubblici.
Il secondo ordine di ipotesi si muove dalle stesse premesse, ma arriva a un
conclusione sensibilmente diversa. Ciò che il banchiere diserta non è tanto una serie
di valori della comunità per come siamo abituati a intendere (le persone prima delle
cose, le relazioni umane prima dei soldi, il lavoro prima della finanza e così via).
Scriveva Adorno che uno dei compiti del dialettico è «consentire alla verità del
pazzo di pervenire alla coscienza della propria ragione»97, per cui uno dei modi che
abbiamo per spiegare la supposta diserzione del banchiere è osservare la natura delle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!96 S. Žižek, Il Grande Altro, op. cit., p. 27 97 T. W. Adorno, Minima moralia, Einaudi, Torino, 1979, p. 76
! 41!
critiche che gli vengono mosse e scardinarle per restituirne un senso utile all’analisi
che stiamo conducendo.
Una delle critiche più radicali e allo stesso tempo più eccentriche al sistema
capitalistico e in particolare finanziario è quella del complotto. Si potrebbe obiettare
che anche il sopra citato ‘ebreo mentale’ era ugualmente una teoria del complotto
che funzionava nel senso di giustificare l’ideologia nazionalsocialista per cui «finché
ci saranno ebrei la Germania non può ritornare alla grandezza di un tempo»98; allo
stesso modo si potrebbe dire «finché esisterà il potere finanziario, colluso con i
potenti della terra, le cose non funzioneranno perché loro le manovreranno affinché
non funzionino».
Ma c’è qualcosa di più terrificante del complotto; anzi si potrebbe dire che lo
stesso complotto nasce per riempire un vuoto di senso che sarebbe molto più
destabilizzante dell’idea di un club segreto che amministra il mondo con manovre
micidiali. Si tratta della proposizione per cui «nessuno regge le fila del mondo».
La rabbia scatenata dalla crisi non è dovuta al decadere della fantasia1, qualunque
essa sia (comunità, lavoro, politica ecc.) ma allo svuotamento della fantasia2, cioè la
rivelazione palese che non solo nessuno manovra l’economia da dietro le quinte ma
che, fatto ancora più grave, nessuno sa.
Ciò che il potere bancario diserta, abbandona, spopola, non è quindi la comunità,
la società o l’umanità del mondo, quanto la stessa idea che il potere bancario sia in
qualche modo la controparte malvagia del bene. Un bene che prima di essere un bene
morale è innanzitutto il bene della razionalità. La crisi apre esattamente questo
scenario: la razionalità non abita più il mondo, quello che accade non ha senso.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!98 M. Senaldi, “ Žižek e l’immaginario”, International Journal of Žižek Studies, Vol. 1.4, 2007, p. 12
! 42!
!!!!!!!!!
! 43!
II.
CAPITALISMO FINANZIARIO E SOGGETTO
Una volta indicati gli elementi principali del potere bancario procediamo con un
ulteriore approfondimento analitico degli stessi, questa volta tenendo presente che
pur avendo discusso della natura del debito e del potere, non siamo ancora riusciti a
cogliere il nesso psicologico e sociale che si stabilisce tra potere bancario, potere
politico e società.
Per farlo, in questo capitolo, partiremo dal contesto economico in cui il potere
bancario prolifera e che chiameremo, generalmente, capitalismo finanziario o
turbocapitalismo. Riteniamo infatti impossibile rendere adeguatamente conto della
natura del potere bancario senza questo passaggio, sia che si consideri la
preponderanza della finanza una causa o un effetto dell’attuale configurazione del
capitalismo.
Questo ci consentirà inoltre di chiudere alcune questioni che avevamo lasciato in
sospeso, in particolare in merito al rapporto tra il potere e la comunicazione, tra il
debito e la ricchezza e tra sapere e responsabilità.
§ 2.1 Sostanza e apparenza nel capitalismo finanziario
A partire da Luttwak molta letteratura critica ha preso a definire l’attuale
configurazione economica con il termine turbocapitalismo.
In sostanza, secondo l’autore, i motori di tale capitalismo sono principalmente
quattro (in ordine di importanza): privatizzazione, liberalizzazione, cambiamento
tecnologico e globalizzazione. Ma il vero punto di originalità di Luttwak, sul quale
vale la pena soffermarsi, è un altro. La caratteristica principale del turbocapitalismo
statunitense non andrebbe tanto ricercata nei processi economici quanto in una
diffusa e a tratti inconsapevole adesione all’etica calvinista, per cui «i vincenti
riescono a contenere il dilagare dell’invidia praticando la morigeratezza, il grosso dei
perdenti se la prende con se stesso per il proprio destino ed entrambe le categorie
! 44!
danno sfogo a frustrazioni personali chiedendo il castigo inflessibile dei perdenti che
osano ribellarsi.»99
Questa implicita accettazione delle Tre Regole (la ricchezza è un segno divino; la
povertà è una disgrazia divina; chi non accetta le prime due regole è destinato al
carcere), combinata con la morigeratezza dei ‘vincenti’ farebbe sì che «tutto ciò che
resta da invidiare è quindi la soddisfazione di lavorare duro, la ricompensa morale di
lasciti e donazioni a scopo benefico, il prestigio sociale. E’ indubbiamente molto, ma
non abbastanza per ispirare livore e violenza, né le comuni manifestazioni politiche
del risentimento sociale».100 E aggiunge:
I supervincenti sono oggetto di rispetto e ammirazione non solo per ciò che fanno ma anche per ciò che sanno, o meglio, che si presume che sappiano. Spesso vengono chiamati a pronunciarsi sui grandi temi d’attualità, seppure per nulla attinenti al loro campo di competenze. […] Chi li intervistava dava per scontato che il loro grado di benevola saggezza fosse direttamente proporzionale all’ammontare delle loro fortune. Un atteggiamento tanto reverenziale scaturisce direttamente dalla Regola Numero Uno, che va oltre la giustificazione morale dell’arricchimento.101
Le premesse di questo ragionamento – il fatto che chi ha avuto successo economico
sembra dotato di una conoscenza superiore – hanno però radici molto diverse rispetto
alla triade individuata da Luttwak. Allo stesso modo, non si sbaglia quando rileva
l’inedita importanza dei presidenti delle banche centrali, ma manca il punto della
questione nel momento in cui limita il loro ruolo in quanto ‘sacerdoti’ del nuovo
culto del monetarismo, e designa come loro scopo principale il contenimento
dell’inflazione. Tutti gli elementi presentati per quanto veritieri e verificabili, non
compongono un’equazione.
Si delinea qui un primo problema rilevante per l’analisi del potere bancario,
quello della supposta sapienza dei ‘supervincenti’, che può essere allargata non solo
ai grandi imprenditori (come Bill Gates), ma anche ai grandi esperti di finanza. E’ lo
stesso problema che abbiamo posto in chiusura del primo capitolo: è meglio che
sappiano, perché se non sanno nessun'altro può sapere.
Ovviamente il problema del sapere non è da intendersi nella sua massima
estensione. E’ un problema, se vogliamo, prettamente economico. Ma il sapere
economico si profila in tutta la sua importanza in veste di sapere antropologico (a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!99 E. N. Luttwak, La dittatura del capitalismo, Mondadori, Milano, 1999, p. 38 100 Ivi, p. 34 101 Ivi, p. 32
! 45!
partire dalla formulazione di homo oeconomicus di Mill), cioè del sapere del e in
merito al soggetto; e di conseguenza come sapere euristico, come procedimento del
sapere per eccellenza, in un mondo che si suppone governato dall’economia. Si
suppone, perché in effetti il problema del governo economico è stato spesso
considerato una vicenda strettamente storica, se non addirittura ideologica102.
Per rendere adeguatamente conto del problema del sapere economico, partiamo
dal principio, cioè dalla formulazione stessa del capitalismo finanziario.
Marx rileva che il capitalismo incomincia quando il «vendere per comprare» cede il passo al «comprare per vendere». […] Quando si compera per vendere […] si cede del denaro, in cambio di merci, per ottenere una maggiore quantità di denaro dalla vendita delle merci acquistate. In questo secondo caso il denaro si trasforma in capitale e lo scopo dello scambio è il profitto. Cioè Marx definisce il capitalismo indicandone lo scopo.103
Così Emanuele Severino riassume il passaggio da merce-denaro-merce a denaro-
merce-denaro. Marx definiva il capitalismo indicandone lo scopo, da un punto di
vista che l’autore definisce prettamente aristotelico, mentre Weber compie un
ulteriore passaggio:
Chi agisce è convinto di avere la capacità di realizzare scopi […]; lo scopo specifico che chi agisce di propone di realizzare costituisce l’essenza dell’azione. […] Ma la differenza delle azioni è determinata non solo dalla differenza degli scopi, ma anche dalla differenza dei mezzi, giacché la differenza dei mezzi determina la differenza degli scopi. […] Che per raggiungere un certo scopo si sia o meno disposti a usare certi mezzi mostra che cos’è lo scopo che si vuole realizzare, ne mostra l’essenza. Come o scopo è l’essenza e la forma dell’azione, così il mezzo ne è la materia e il contenuto.104
Abbiamo già descritto il motivo per cui il denaro e il debito/credito possono essere
assimilati in un unico concetto, ma lo sviluppo del mercato del credito risulta
comunque un’evoluzione particolare del sistema economico. Infatti l’oggetto sul
quale la transazione insiste non è più un bene materiale, un servizio, una prestazione,
ma il credito stesso. Anche Tonnies sottolinea in modo simile la crucialità di questo
sviluppo:
Ma il creditore diventa una specie particolare di commerciante non appena esercita la sua impresa sistematicamente e in vista del guadagno. Così il credito, sotto la forma della cambiale, diventa esso stesso una merce trasferibile, di cui è possibile fare incetta a scopo di rivendita, e il cui consumo ha luogo mediante la sua vendita finale, che ne costituisce la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!102 Nel senso di contrapposta alla verità. 103 E. Severino, Il declino del capitalismo, Rizzoli, Milano, 2007, p. 130 104 Ivi, pp. 130-131!
! 46!
realizzazione. In tal modo il credito si sviluppa come affare sussidiario del commercio vero e proprio.105
Il capitalismo finanziario si configura come tale in virtù della preponderanza di un
mezzo sugli altri – la finanza è la quintessenza del denaro – ma ottiene, al contrario
di quanto affermato da Severino nel Declino del Capitalismo, lo spostamento del fine
senza la distruzione del contesto. Il profitto infatti diventa uno dei fini possibili,
come dimostrato dallo sviluppo di finanze e modelli bancari alternativi che invece di
comprare profitto, comprano un’idea, senza mai uscire dall’alveo del paradigma
finanziario che stiamo considerando. Il credito, insomma, non è più «affare
sussidiario», ma la colonna portante dell’economia. Le imprese non vivono più
grazie alle vendite reali, ma grazie all’abilità dei loro manager e sottoposti di
interagire sul mercato finanziario106.
In questo contesto avviene qualcosa di particolare e apparentemente
contradditorio che non riguarda l’economia, ma le relazioni tra uomini.
l’obbligazione è in tutto e per tutto una potenza giuridica. Nel mondo dei fatti non è possibile avere in mano la prestazione futura di un altro: ciò è possibile soltanto nel diritto. […] ricevere pagamenti di denaro sulla base della proprietà di una merce (qual è l’obbligazione), e senza consegnarla, è una situazione socialmente soprassensibile. Qui si crea infatti un legame durevole, in contrasto col concetto della società – un legame che non vincola le cose, ma le persone. Il rapporto, già momentaneo nel semplice contratto di scambio, viene qui concepito come illimitato nel tempo.107
Anche Luttwak rileva tale ‘paradosso della società’:
Sul piano umano le conseguenze del turbocapitalismo sono al contempo liberatorie e profondamente disorientanti. La perdita di autenticità individuale che Friederich Nietzsche aveva previsto ci ha investito in tutta la sua forza. Inizia con l’assimilazione inconscia di un linguaggio da meretricio […] e finisce nella spersonalizzazione vera e propria, nella perdita dell’umanità più genuina.108
Che cosa intenda Luttwak quando fa riferimento all’«umanità più genuina» non è
chiaro. E’ invece chiaro un altro punto, che avevamo già sottolineato nell’opera di
Simmel, e cioè il fatto che l’insieme di questi autori, in termini diversi e in contesti
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!105 F. Tonnies, op. cit., p. 81 106 Cfr. L. Gallino, Finanzcapitalismo: la civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino, 2013 107 F. Tonnies, op. cit., pp. 73-74 108 E. N. Luttwak, op. cit., p. 261!
! 47!
diversi, riconosce che «gli oggetti sono sempre più dissolti in esperienze fluide,
mentre le sole cose stabili sono le obbligazioni simboliche virtuali».109
Ma il passaggio dall’oggetto al simbolico non è da intendersi solo e unicamente in
termini morali, in perdita di autenticità. Se pure si può supporre uno spostamento
dalla sostanza all’immagine, questo non dipenderà da un cambiamento delle qualità
morali su larga scala, quanto da un meccanismo proprio dell’economia.
La caratteristica principale del capitalismo finanziario, che ne definisce per così
dire la qualità essenziale, non è infatti una caratteristica morale. Anzi, rispetto a
questo meccanismo, che andiamo a definire, la morale dominante in entrambi i sensi
(corsa al profitto o economia etica), appare del tutto superata:
Il paradosso di questa virtualizzazione del capitalismo è in ultima istanza lo stesso che caratterizza la dinamica dell’elettrone nella fisica delle particelle. La massa di ogni particella elementare è costituita dalla sua massa a riposo più il surplus fornito dall’accelerazione del suo stesso movimento; tuttavia, la massa di un elettrone a riposo equivale a zero, e dunque la sua massa complessiva è costituita unicamente dal surplus generato dall’accelerazione: come un nulla che assume una qualche parvenza di sostanza tessendo magicamente sé stesso in un eccesso di sé. Il capitalista virtuale odierno non funziona forse nello stesso modo? Il suo «valore netto» è zero, egli opera solo con il surplus, prendendolo in prestito dal futuro.110
Questa perenne accelerazione del capitale non è però da leggersi unicamente nel
senso dell’interesse. Non è certo la presenza o l’assenza di interesse a determinare,
storicamente, l’ascesa del capitalismo. Certamente, la facilita. Ma è un insieme molto
più complesso di fattori (geografici, legali, tradizionali e così via), a decretare nel
corso della storia la fortuna delle nazioni111.
Nel caso del capitalismo finanziario ciò che sposta valore dal futuro al presente
non è tanto l’interesse, quanto una categoria che assume nel contesto globalizzato e
dominato dal mercato finanziario un’importanza inedita, cioè quella delle
aspettative. Sia in sociologia che in economia l’aspettativa riguarda le previsioni
dell’individuo sul comportamento degli altri individui in un contesto di incertezza o,
nel caso di imprese o istituzioni, le previsioni riguardo alcuni elementi come il
profitto, i tassi di interesse, l’emanazione di una certa legge.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!109 S. Žižek, Meno di niente, op. cit., p. 303 110 Ivi, pp. 301-302 111 Cfr. D. S. Landes, La ricchezza e la povertà delle nazioni, Garzanti, Milano, 2002!
! 48!
In ambito finanziario le aspettative si sono estese a ambiti sempre più vasti, tanto
da far dubitare in merito alla differenza tra il gioco d’azzardo e l’investimento in
borsa. Anche il profitto, che viene sempre indicato come un fattore decisivo, è in
ultima analisi sottoposto al regime delle aspettative. E’ solo in questo modo che si
spiega un tracollo finanziario che ha luogo nel giro di un week-end lasciando
macerie dove prima sorgevano stabili imperi economici.
La teoria delle aspettative si lega a doppio filo con il problema della razionalità112
e del sapere economico. Quando parlavamo del potere abbiamo affermato che una
delle sue definizioni è quella di «comunicazione tra uomini», ed è in questo modo
che primariamente si formano le aspettative tra attori economici. Per questo Luttwak
aveva torto in merito alla definizione del compito dei presidenti delle banche
centrali. Il loro scopo principale infatti non è il contenimento dell’inflazione ma la
formazione nel pubblico di aspettative adeguate113.
Sono le aspettative infatti a reggere il gioco del mercato, anche del mercato basato
sulla speculazione. Ad esempio i CDS, il cui svuotamento di valore ha scatenato
l’attuale crisi, nascevano già in partenza come la vendita del nulla in cambio di
qualcosa ma erano le aspettative (e il rischio associato) a determinarne il rendimento
nel tempo.
Se prendiamo un caso più attinente con le banche centrali, come il problema dei
debiti sovrani, notiamo come ogni dichiarazione (non ogni manovra effettiva, ma
anche la semplice dichiarazione che una politica verrà intrapresa) sia volta a
‘rassicurare i mercati’, e quindi a stabilizzare le aspettative.
Ciò che appare sul mercato, l’informazione che passa tra gli attori, diventa quindi
molto più importante di ciò che realmente accadrà in futuro o sta accadendo nel
presente. Traslando una domanda teoretica nella realtà economica: «non potrebbe
essere che le apparenze non siano al servizio del processo vitale ma, viceversa, che il
processo vitale sia al servizio delle apparenze? Dal momento che viviamo in un
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!112 Cfr. J. Sonnemansa,, C. Hommesb, J. Tuinstrab, H. van de Veldenb, “The Instability of a Heterogeneous Cobweb economy: a Strategy Experiment on Expectation Formation”, Journal of Economic Behavior & Organization, Volume 54, Issue 4, agosto 2004, pp. 453–481 113 Cfr. W. Tiolfi, “Il «credetemi» di Draghi e le aspettative dei mercati”, Il Sole 24 Ore, 27 luglio 2012!
! 49!
mondo che appare, non è molto più plausibile che ciò che è rilevante e significativo
in questo nostro mondo debba essere situato proprio alla superficie?»114
In questo senso, certamente, il mercato attuale privilegia l’apparire all’essere, ma
dobbiamo cogliere questo dato in modo neutrale, piuttosto che caricarlo di toni
catastrofisti. Del resto se nella critica all’economia si fa pesare sempre più spesso la
dicotomia tra essere e apparire, tra la sostanza e la forma, il pensiero contemporaneo
(come nel caso della Arendt), ha già da tempo problematizzato queste categorie:
Oggi, nell’universo digitalizzato della simulazione, l’Immaginario si sovrappone al Reale, a spese del Simbolico (Jean Braudillard, Paul Virilio). Il punto di forza di questa tesi consiste nel sottolineare la differenza tra apparenza e simulacro: “apparenza” non ha nulla in comune con la tesi postmoderna secondo la quale stiamo entrando nell’era dei simulacri universalizzati in cui la realtà stessa diventa indistinguibile dal suo doppio simulato. […] Ciò che si perde nell’odierna “epidemia delle simulazioni digitali” non è la realtà solida, autentica, non simulata, ma l’apparenza stessa. Cos’è dunque l’apparenza? […] L’”apparenza” non è dunque semplicemente il regno dei fenomeni, ma rappresenta quei “momenti magici” nei quali un’altra dimensione, noumenica, “appare” istantaneamente in (“splende attraverso”) un fenomeno empirico/contingente.115
Un simulacro è un’apparenza che non rinvia ad alcuna realtà sotto-giacente e
pretende tuttavia di valere per quella stessa realtà. Come nell’esempio che Luttwak
utilizza nella sua argomentazione:
Ma si fatica a trattenersi dal concludere che l’immagine ha spodestato la sostanza. Vent’anni fa, per esempio, l’ospite ritenuto degno di essere ricevuto da un presidente o da un primo ministro per un colloquio riceveva in seguito una fotografia commemorativa del suo incontro con una figura tanto di spicco, debitamente firmata e, talora, perfino con dedica. Al giorno d’oggi, a molti ospiti ricevuti vengono concessi 120 secondi in tutto, rigorosamente riservati allo scatto della fotografia, poi firmata a macchina e inviata a commemorare un colloquio che, in realtà, non ha mai avuto luogo. […] La spinta alla competizione comportata dal turbocapitalismo non richiede necessariamente la particolare fattispecie della demolizione dell’autentico. Ma questa non sarebbe assurta a prassi consolidata se tutti gli interessi non fossero già più che avvezzi, grazie alle manipolazioni commerciali, ad accettare immagini bugiarde in luogo della sostanza, anzi come la sostanza.116
Se osserviamo attentamente il fenomeno finanziario però notiamo che non è con
simulacri che abbiamo a che fare, ma ancora con apparenze, nel momento in cui i
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!114 H. Arendt, La vita della mente, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 108 115 S. Žižek, Il godimento come fattore politico, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001, pp. 149-151 116 E. N. Luttwak, op. cit., p. 262!
! 50!
prodotti di tale potere non sono ‘immaginari’, ma ‘simbolici’, cioè – nel senso
originario del termine – forniscono una sintesi tra l’apparenza e la realtà sottostante.
L’informazione, la fiducia e la trasparenza, che costituiscono i fondamenti della
comunicazione del potere finanziario e quindi della sua trasmissione, si iscrivono
ancora in un rapporto diretto con la realtà, anche laddove tentano di eluderla; ciò che
producono non è mai un simulacro.
E’ al di sopra della massa inerte della vita quotidiana che l’economia di mercato ha lanciato le sue reti e mantenuto i suoi canali di comunicazione. Generalmente, è al di sopra della stessa economia di mercato che prospera il capitalismo. Sotto questo profilo l’economia dell’universo può essere considerata come una successione di differenti livelli di altitudine, che disegnano una mappa di rilievo.117
Né deve trarci in inganno il continuo riferimento al cyberspazio nell’analisi
economica di Žižek, che al contrario coglie perfettamente l’ambivalenza di un
capitalismo sempre più virtualizzato:
In opposizione ad entrambe le interpretazioni del “cyberspazio come fine dell’Edipo”, alcuni rari ma acuti teorici affermano la continuità tra cyberspazio e forma edipica della soggettivazione: il cyberspazio manterrebbe la struttura edipica fondamentale di un Terzo Ordine intermedio che, nel suo reale potere di agente di mediazione/mediatizzazione, supporta il desiderio del soggetto, fungendo allo stesso tempo da agente della Proibizione che ostacola una sua diretta e completa gratificazione. A causa dell’intervento di questo Terzo, ogni gratificazione/soddisfazione parziale è connotata da un fondamentale “non è QUESTO”. L’idea che il cyberspazio come mezzo di iperrealtà sospenda l’efficacia simbolica e determini una falsa trasparenza totale dei simulacri immaginari coincidenti con il Reale, […] dissimula il reale funzionamento di quest’ultimo [il cyberspazio ndr], che non solo continua ad affidarsi al dispositivo elementare della Legge simbolica, ma lo rende ancora più evidente nella nostra esperienza quotidiana.118
Nel caso del capitalismo finanziario ci troviamo quindi nuovamente di fronte al
binomio indistricabile tra realtà e reale, tra il virtuale e il fattuale, con il rischio da un
lato di trarre facili conclusioni da un’osservazione diretta, dimentichi del fatto che
«la verità ha la struttura della finzione»119, dall’altro di illudersi che il capitalismo
finanziario, il capitalismo senza attriti, possa configurarsi e evolversi senza nessuna
conseguenza fisica sulle persone che abitano il mondo.
Il potere bancario, nelle sue molteplici manifestazioni, si trova nel cuore stesso
della questione, proprio perché si occupa di simboli (come il denaro e il debito), ma
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!117 F. Braudel, La dinamica del capitalismo, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 46 118 S. Žižek, Il godimento come fattore politico, op. cit., p. 153 119 S. Žižek, Meno di niente, op. cit., p. 309!
! 51!
lo fa come se il loro movimento non dovesse mai incontrare ostacoli lungo il
percorso. La classica immagine del banchiere, ereditata dall’icona colonialista, del
grasso maiale che divora una fetta di mondo, deriva proprio da questa apparente
estraneità del potere finanziario nei confronti del mondo. E’ il capitalismo
parassitario, che ara dove non ha seminato: «Oggi […] noi sappiamo che la forza del
capitalismo sta nella straordinaria ingegnosità con la quale esso cerca e scopre specie
ospitanti nuove ogni volta che le specie sfruttate in precedenza diminuiscono di
numero o estinguono; e nell’opportunismo e nella velocità, simili a quelle di un
virus, con le quali si riadegua alle idiosincrasie dei suoi nuovi terreni di pascolo»120.
Ma se la vera ideologia, come afferma Žižek, è quella che si occupa delle persone
reali con i loro problemi reali, non è altrettanto ideologico occuparsi del capitalismo
come se fosse un ente estraneo ai soggetti che lo promuovono attivamente con le loro
decisioni?
Si realizza quindi un cortocircuito ideologico tra le due manifestazioni del divario tra realtà e virtualità: il divario tra produzione reale e l’ambito virtuale o spettrale del Capitalismo, e il divario tra l’esperienza reale e la realtà virtuale del cyberspazio. Il vero orrore del motto «capitalismo senza attriti» [definizione di Bill Gates ndr] è che, sebbene gli «attriti» reali continuino a esistere, li si rende invisibili, li si ricaccia in un mondo infero al di fuori del nostro universo «postmoderno» e postinudstriale; è per questo che l’universo «senza attriti» della comunicazione digitalizzata, dei gadget tecnologici, ecc., è costantemente tormentato dall’idea di una catastrofe globale in agguato dietro l’angolo, che minaccia di esplodere in qualsiasi momento.121
Secondo Braudel, non si da capitalismo «senza la complicità attiva della società. […]
è necessario, perché esso proliferi, che la società intera ne accetti, in un certo qual
modo, più o meno coscientemente, i valori». 122 Per quanto semplice tale
affermazione è invece molto problematica. Si tratta infatti di stabilire cos’è, anche
per generalizzazioni, una società e che cosa vuol dire che la società accetta i valori
del capitalismo, ovvero in cosa consistono questi valori e chi ne è il promotore.
Indagare filosoficamente il capitalismo, o scrivere una storia del capitalismo - che
esula comunque dallo scopo di questa trattazione - significa perciò muoversi a partire
da un duplice punto di vista. Il punto di vista del potere, che sovrasta i soggetti pur
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!120 Z. Baumann, Capitalismo parassitario, Laterza, Bari, 2009, pp. 5-6 121 S. Žižek, Meno di niente, op. cit., p. 301. Nel merito si esprime anche A. Tagliapietra, “Metafisica e apocalittica del denaro”, in D. Fusaro, op. cit. 122 F. Braudel, op. cit., p. 65!
! 52!
esistendo tra loro, e il punto di vista dell’etica, che invece è strettamente inerente ai
soggetti. Non si possono negare o omettere le individualità che hanno reso tale il
capitalismo in conformità a scopi e mezzi mai del tutto individuabili o
categorizzabili. Questo è valido anche e soprattutto per il potere bancario, laddove il
debito, come abbiamo potuto notare, e allo stesso modo il denaro, neutralizzano
l’ambivalenza morale a fondamento del potere che vanno a instaurare.
Nel momento in cui tale neutralizzazione ha luogo, cioè quando l’ambito politico
viene assorbito da quello economico e in particolare finanziario, contrariamente a
quanto accade per il potere tradizionale, non riesce a configurarsi con chiarezza una
forza, all’interno della società, che sia avversa a tale potere, cioè che ne costituisca la
negazione senza essere inglobata e neutralizzata come prodotto del sistema stesso.
Non affermiamo questo perché il nostro obiettivo sia quello di definire le
caratteristiche di tale negazione, problema già affidato alla vasta letteratura critica in
merito, quanto piuttosto per mettere al servizio della nostra analisi gli approdi teorici
di tale critica.
Una volta chiarito questo e stabilito in via generale il contesto in cui ci stiamo
muovendo, possiamo dedicarci al problema del soggetto prodotto da tale contesto
nella sua doppia veste di soggetto razionale e soggetto pulsionale.
§2.2 La mano invisibile
Torniamo quindi al problema posto dalla proposizione di Braudel, cioè quello di
definire di quale società e di quale soggetto stiamo parlando, partendo dalla
definizione di quella che Foucault chiama società civile:
Che cos’è la società civile? […] Come trovare una ragione e un principio razionale per limitare non mediante il diritto, o mediante il dominio di una scienza economica, una pratica di governo che deve farsi carico dell’eterogeneità dell’economico e del giuridico? La società civile non è dunque un’idea filosofica. La società civile è un concetto di tecnologia governamentale […] la cui misura razionale deve ancorarsi giuridicamente a un’economia intesa come processo di produzione e di scambio.123
Anche Arendt fornisce una spiegazione simile:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!123 M. Foucault, Nascita della biopolitica, op. cit., p. 243
! 53!
E’ il conformismo stesso, e cioè l’assunto che gli uomini si “comportano” e non agiscono gli uni rispetto agli altri, che si trova alla radice della moderna scienza economica, la cui nascita coincise il sorgere della società e che, insieme con il suo principale strumento tecnico, la statistica, divenne la scienza sociale per eccellenza. L’economia […] poteva conseguire un carattere scientifico solo quando gli uomini fossero diventati esseri sociali e seguissero unanimemente certi modelli di comportamento, e quando chi non ne accettasse le regole potesse essere considerato asociale o anormale.124
La storia della società diventa insomma quella dell’economia, come ricorda anche
Luhmann :
Ogni teoria politica è […] guidata dalle premesse di una teoria della società, perché la politica è un fenomeno sociale. Contro l’accettazione veteroeuropea di un fondamento politico della società, si è imposta, nel XIX secolo, la tesi di una separazione di stato e società, il prezzo fu alto: una limitazione del concetto di società al sistema dei bisogni, in altre parole all’economia.125
Allo stesso modo possiamo rilevare dalle conclusioni teoriche degli autori citati, di
quale tipologia umana stiamo parlando.
L’uomo che preferisce il comportamento all’azione126 è simile all’essere umano
che diventa ambiente per la società luhmaniana (che invece è fondamentalmente
comunicazione tra). Se accettiamo inoltre la premessa che non sono i soggetti a
formare il potere ma è la comunicazione del potere a dare una forma all’individuo127,
riconosciamo da subito che il soggetto nascente della società altri non è che l’homo
oeconomicus.
homo oeconomicus: Astratta semplificazione della complessa realtà umana […] che pone come soggetto dell’attività economica un individuo astratto, del cui agire nella complessa realtà sociale si colgono solo le motivazioni economiche, legate alla massimizzazione della ricchezza. Questa categoria della teoria economica, usata in particolar modo in microeconomia come premessa dell’analisi deduttiva, si pone come universale, in quanto le scelte rilevanti dell’h. non sono condizionate dall’ambiente in cui si trova, e razionale, nel senso che il suo comportamento, volto a raggiungere dati obiettivi con i minimi mezzi, rispetta criteri di coerenza interna a partire da certi assiomi.128
Sembrerebbe anacronistico continuare a utilizzare questa categoria sociologica, già
ampiamente criticata da autori quali Sen: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!124 H. Arendt, Vita activa, op. cit., p. 31 125 N. Luhmann, Teoria politica nello stato del benessere, Franco Angeli, Milano, 1987, p. 52 126 Azione nel senso del termine che troviamo in H. Arendt, Vita activa, op. cit. 127 Cfr. M. Foucault, N. Chomsky, Della natura umana. Invariante biologico e potere politico, DeriveApprodi, Roma, 2005 128 Definizione di Treccani.it. La definizione integrale indica in J. S. Mill il primo ad aver utilizzato il termine. Anche se, secondo una diversa ricostruzione, il primo a fare riferimento all’h.o. sarebbe stato W. Pareto nel 1906. In merito Cfr. J. Persky, “Retrospectives: The Ethology of Homo Economicus.” The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 2 (Spring, 1995), pp. 221-231
! 54!
stiamo cominciando ad assistere allo sviluppo di tutta una gamma di teoria alternative circa il comportamento economico adeguato al fine di raggiungere il successo industriale, teorie basate su studi comparativi di società diverse, con diversi sistemi di valori predominanti. […] Il vasto impiego dell’ipotesi estremamente restrittiva di un comportamento mosso dall’interesse personale ha seriamente limitato […] la portata dell’economia predittiva, e ha reso difficile l’indagine di un certo numero di importanti relazioni economiche che operano attraverso la versatilità comportamentale.129
Tuttavia se è vero che la teoria economica ha recentemente visto messe a dura prova
le sue impostazioni teoriche130, quella di homo oeconomicus è ancora una definizione
utile per interpretare il presente, soprattutto se la utilizziamo con le precauzioni di
metodo di Foucault:
In altre parole, considerare il soggetto in quanto homo oeconomicus non implica un’assimilazione antropologica di ogni suo comportamento al comportamento economico. Tutto ciò dimostra semplicemente qual è la griglia d’intellegibilità che si adotterà rispetto al comportamento di un nuovo individuo. Il che significa anche che l’individuo potrà essere sottoposto alla governamentalità, ovvero si potrà aver presa su di lui, solo e unicamente nella misura in cui egli è un homo oeconomicus. L’homo oeconomicus è l’interfaccia tra il governo e l’individuo. Ma ciò non vuole affatto dire che ogni individuo, ogni soggetto, sia un uomo economico. […] L’homo juridicus, infatti, dice al sovrano: io ho dei diritti, te ne ho affidato alcuni, e non devi toccare gli altri, oppure: ti ho affidato i miei diritti per questo o quel fine. L’homo oeconomicus non dice questo. Certo, anche lui dice al sovrano: non devi. Ma glielo dice in questa forma: non devi, perché non puoi. E non puoi nel senso che “sei impotente”. E perché sei impotente, perché non puoi? Non puoi, perché non sai e non sai perché non puoi sapere.131
La società che accetta in sé i valori del capitalismo è dunque una società
fondamentalmente economica, e i promotori di tali valori sono individui razionali
che privilegiano il mercato come luogo di oggettività e veridizione.
Se prendiamo l’homo oeconomicus in questa formulazione e lo leggiamo nel
tessuto economico del capitalismo finanziario ci accorgiamo però che il rapporto tra
governo e società si gioca allo stato attuale a parti inverse: «Lo stato moderno, che
non ha costruito il capitalismo ma lo ha ereditato, talora agisce a suo favore, talaltra
ne ostacola i propositi; a volte gli permette di espandersi liberamente, ma in altri casi
distrugge le sue risorse. Il capitalismo può trionfare solo quando si identifica con lo
stato, quando è lo stato.»132
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!129 A. Sen, Etica ed economia, Laterza, Bari, 2006, pp. 27, 98 130 Cfr. P. Krugman, “How did Economists Get It So Wrong?”. The New York Times, 2 Settembre 2009!131 M. Foucault, Nascita della biopolitica, op. cit., pp. 207, 232!132 F. Braudel, op. cit., p. 65
! 55!
L’homo oeconomicus appare nel gioco della comunicazione enunciando ancora il
suo “Non devi perché non puoi” ma il suo status è cambiato. Dalla società è passato
al governo ed è a questo livello che opera, soprattutto per quanto riguarda il potere
bancario.
Il monismo etico dell’homo oeconomicus caratterizza infatti la maggior parte
degli individui che operano a livello finanziario, come dimostrano svariate
testimonianze tra cui ricordiamo per importanza quelle risalenti al 2008133 quando,
subito dopo la crisi, una commissione federale ha interrogato per svariati giorni i
protagonisti diretti e indiretti del tracollo finanziario dei mutui subprime e dei credit
default swaps.
Il problema fondamentale dello spostamento del soggetto economico dalla società
al governo (o comunque in direzione delle élites che detengono il potere) è tuttavia
un altro. Se il mercato è mosso da una mano invisibile, l’invisibilità134 resta tale per
tutte le parti in causa e inoltre essa «è assolutamente indispensabile. E’ un’invisibilità
che fa in modo che nessun agente economico debba e possa cercare il bene
collettivo.»135 La formulazione Smithiana del mercato e degli interessi, per quanto
appaia superata, spiega ancora tanto il comportamento dell’homo oeconomicus
quanto quello dei governi, politici o economici che siano.
Paradossalmente Adam Smith utilizza la stessa metafora della mano invisibile che
muove gli interessi particolari verso il bene collettivo, per creare nella Teoria dei
sentimenti l’immagine del politico:
Il politico si ritiene onnisciente, superiore e potente, e quindi nega agli altri ogni possibilità di agire autonomamente. Anche in questo passo è una mano gigantesca, questa volta quella della politica personificata, a guidare il destino degli uomini secondo un piano prestabilito. Nessun singolo pezzo degli scacchi ha una buona visione di tutto il piano nel suo complesso, nessuno vede al di là del proprio campo visivo diretto e delle proprie limitate capacità. Solo il politico crede di poter guidare con mano potente, come un gigante sovrumano, gli altri uomini. […] Tenendo conto dei vari significati che essa assume [la mano invisibile ndr], non si può dare una chiave di lettura univoca, neppure per la Ricchezza delle nazioni. Ma a chiunque appartenga quella mano invisibile, in primo piano c’è l’uomo che essa muove.136
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!133I video integrali delle sedute sono visionabili sul canale youtube “HouseResourceOrg” che riporta i lavori del Congresso degli Stati Uniti d’America. Le trascrizioni invece sono disponibili nel portale Fednews.com 134 Cfr. M. Foucault, Nascita della biopolitica, op. cit., pp. 228-229 135 Ivi, p. 229!136 H. Winter, T. Rommel, La ricchezza delle nazioni: guida e commento, Garzanti, Milano, 2001, p. 88
! 56!
In chiusura del primo capitolo, prospettavamo esattamente l’opposto di questo
scenario, cioè l’eventualità che nel momento in cui gli uomini siano liberi dalle
manovre di un altro, che sia il politico personificato, la provvidenza o l’economia,
essi siano in realtà abbandonati a loro stessi, e quindi al loro parziale se non
irrazionale punto di vista.
Oramai, a causa dell’inconvertibilità che caratterizza il sistema monetario internazionale, l’equilibrio mondiale dipende solo dalla scienza, dalla saggezza e dall’indipendenza delle autorità monetarie. […] Finché non verrà ristabilito un regime di convertibilità monetaria corretto dalle perversioni che il sistema monetario a cambio aureo aveva apportato al sistema creato da Bretton-Woods, il mondo resterà votato allo squilibrio delle bilance di pagamento, all’insicurezza monetaria, alle erratiche fughe di capitali, all’instabilità dei corsi di cambio ed a tutti i disordini che nascono dall’ignoranza degli uomini e dalla debolezza delle istituzioni.137
Con queste parole Rueff chiudeva la sua opera dedicata alla delicata questione della
convertibilità in oro, sottolineando proprio come l’ignoranza, nel senso di non poter
sapere, avrebbe determinato i maggiori problemi dell’economia a venire.
La risposta alle domande ancora aperte in realtà quindi è unica. Il non sapere dei
soggetti che detengono, a vari livelli, il potere bancario, che coincide con
l’impossibilità strutturale dei vertici di avere un punto di vista ‘sovrano’
sull’economia, è particolarmente grave nel momento in cui la risorsa che essi
gestiscono e da cui ricavano la loro rendita è l’insieme universale delle mediazioni
che avvengono sul mercato:
la caratteristica essenziale del capitalismo contemporaneo non è solo l’egemonia, ma anche la (relativa) autonomia del capitale finanziario: potrebbe sembrare che le banche si dedichino semplicemente alla sepculazione, mescolando numeri a casaccio, senza dover sfruttare nessuno, dal momento che lo sfruttamento può avvenire solo nella produzione «reale». Ma allora per quale motivo abbiamo dovuto finanziarle con miliardi di dollari tra il 2008 e il 2009? Perché senza un sistema bancario funzionante l’intera economia (capitalista) collasserebbe. Anche le banche devono dunque essere considerate come beni comuni privatizzati: nella misura in cui le banche private controllano i flussi di investimento e rappresentano quindi, per le aziende individuali, la dimensione universale del capitale sociale, il loro profitto è in realtà una rendita derivante dal ruolo di mediatrici universali da esse svolto.138
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!137 J. Rueff, L’errore monetario dell’occidente, L’oro e la guerra delle monete, Universale Etas, 1971, pp. 173-174!138 S. Žižek, Meno di niente, op.cit., p. 303
! 57!
Lo stesso Tonnies osservava giustamente che «se i commercianti sono mediatori
dello scambio, i banchieri costituiscono i mediatori della mediazione.»139 Il problema
che colpisce l’economia nel momento in cui il sistema bancario fallisce è allora
simile a quello che colpisce le merci nel momento in cui il denaro si svaluta. Cioè
l’eventualità già osservata da Marx che in tempo di crisi «non è il denaro […] a
perdere il proprio valore, cosicché non dovremmo fare altro che rivolgerci al valore
«reale» delle merci; sono le merci stesse (l’incarnazione del «valore [d’uso] reale») a
diventare inutili, perché non c’è nessuno che le compri.»140
Non solo le merci ma anche l’individuo subisce lo stesso destino, come spiega
Elias Canetti in Massa e Potere, nel paragrafo intitolato Inflazione e Massa:
E’ vero però che di questo antico rapporto con il denaro, se ne è sviluppato un altro. L’unità monetaria ha acquistato in ogni paese un valore più astratto. Non per questo la si sente meno come unità. Se le monete un tempo avevano in sé qualcosa dell’organizzazione strettamente gerarchica di una società chiusa, ora con il denaro cartaceo ciò accade più che mai fra gli abitanti delle grandi città. Dal tesoro oggi è scaturito il milione. […] Cosa accade in un’inflazione? Improvvisamente l’unità di denaro perde tutta la sua personalità, e si trasforma in una massa crescente di unità; queste ultime hanno sempre meno valore, quanto più grande è la massa. Si hanno d’improvviso in mano i milioni che si sarebbero posseduti così volentieri; ma essi non sono più tali, conservano soltanto il nome. […] L’identificazione fra il singolo individuo e il suo marco è così confermata. Il marco ha perduto la sua solidità e il suo limite, e varia di minuto in minuto; non è più come una persona, e manca totalmente di stabilità. Ha sempre meno valore. L’uomo che vi aveva riposto la sua fiducia non può fare a meno di sentire come proprio il suo svilimento. Per troppo tempo si era identificato con esso, la fiducia in esso era come la fiducia in se stesso. Non solo, a causa dell’inflazione, tutte le cose esteriori sono coinvolte nell’oscillazione, nulla è sicuro, nulla rimane per un’ora allo stesso posto – ma, a causa dell’inflazione, l’uomo stesso è sminuito. Egli stesso o ciò che egli era sempre non sono più nulla, il milione che egli aveva sempre desiderato non è più nulla. Ognuno lo possiede. Ma ognuno è nulla.141
Nell’epoca della tecnica, del ‘saper fare’, del soggetto che tramite essa conquista e
quasi distrugge l’ambiente circostante, assistiamo paradossalmente alla perdita, da
parte del potere, della capacità di controllare la tecnica che lui stesso ha creato per
servire i suoi scopi.
Non a caso utilizziamo il termine tecnica per designare una qualità perduta del
potere economico, la techne «consiste nella capacità di trovare (euriskein)», proprio
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!139 F. Tonnies, op. cit., p. 81 140 S. Žižek, Meno di niente, op. cit., p. 304 141 E. Canetti, Massa e Potere, Adelphi, 1981, pp. 220-222
! 58!
come nell’Edipo di Sofocle «le persone che parlano di Edipo si riferiranno a questa
capacità che lui possiede e che caratterizza propriamente la sua techne, la sua
capacità di trovare.»142
E’ un’arte di scoprire, attraverso gli indizi, gli eventi. [Più] precisamente, abbiamo a che fare con un’arte […] che è imparentata […] con due altre technai dello stesso tipo, la medicina e l’arte della navigazione […] Sapete bene che questa trilogia – l’arte di governare, l’arte di guarire, l’arte di navigare – sarà assolutamente fondamentale […] in tutta la tematica del pensiero politico occidentale fino, praticamente, al XVII o XVIII secolo. […] Un sapere peculiare all’esercizio del potere politico – e questo sapere ha la forma tecnica della scoperta della verità a partire da elementi materiali che vengono interrogati nel loro significato o in ciò a cui rinviano da una tecnica che è propria dell’esercizio di questo sapere.143
Mentre nell’Edipo di Sofocle alla techne del tiranno viene contrapposto il nomos
degli dei, per cui in ultima analisi «si tratta di ricusare il sapere di Edipo o, piuttosto,
di riprenderne solamente la parte conforme al nomos e invece di condannare, di
votare alla maledizione quella parte di techne che è servita ad alimentare gli eccessi
del suo potere tirannico»144, nel nostro caso della crisi l’aleturgia, la produzione di
verità, è impossibile da raggiungere.
Si rende evidente dai già citati hearings che non è stata colpa di nessuno. O
ancora meglio, se la colpa c’è è insondabile, invisibile, non imputabile. Ciò che resta
ai politici che interrogano il potere finanziario è la residuale possibilità di mettere
all’indice alcuni loro comportamenti eccessivamente vistosi (ma solo perché
avvenuti immediatamente dopo il salvataggio con soldi pubblici) e, in un movimento
circolare ma non paradossale, rivolgersi agli stessi presunti autori del disastro
economico per avere risposte e ricevere consigli.
Ma non dobbiamo ingannarci, la supposta sapienza dei supervincenti (Luttwak)
non fa di essi l’equivalente dell’analista in Lacan, non rende Fuld o chiunque altro un
soggetto supposto sapere, un qualcuno che sa già la verità e deve solo trovare un
modo per farla emergere. Non c’è cura nell’economia in sé e per sé. Allo stesso
modo questa impossibilità di individuare un vero colpevole, la litania per cui nessuno
avrebbe fatto nulla di diverso nei mesi precedenti alla crisi, non è da confondere con
il destino tragico dell’eroe edipico.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!142 M. Foucault, Mal Fare Dir Vero, op. cit., in nota, p. 66 143 Ivi, pp. 67-68 144 Ivi, p. 69!
! 59!
Da un lato è vero che, come abbiamo detto, la crisi finanziaria apre lo scenario di
un vuoto di razionalità – diventa evidente l’irrazionalità degli attori del mercato – ma
il vuoto di responsabilità è solo un’illusione: «Questa è la fondamentale violenza
sistemica del capitalismo, ben più inquietante della diretta violenza socio-ideologica
precapitalista: essa non è più attribuibile alle intenzioni «malvagie» di individui
concreti, dal momento che è puramente «oggettiva», sistemica, anonima.»145
La mano invisibile che permetteva misteriosamente il raggiungimento del bene
collettivo, allo stesso modo, nel momento in cui ottiene l’effetto contrario, trattiene
nell’invisibilità sia il merito che la colpa. Se prima era merito di tutti, adesso è colpa
di tutti; e forse un’affermazione così semplicistica non è poi così lontana dalla realtà.
A chi attribuire infatti i meriti e i demeriti del potere bancario? A chi ha prestato
soldi senza garanzie o a chi ha contratto prestiti sapendo di non poterli ripagare? Al
governo che ha deregolamentato il mercato finanziario? Alla FED che ha operato sui
tassi di interesse senza tenere conto delle conseguenze sul mercato immobiliare?146
Del resto il debito della bolla speculativa veniva alimentato con le stesse tecniche
con cui il potere bancario mantiene tutt’ora in vita il copioso debito pubblico
americano (come ricorda anche Fuld in una delle sue risposte).
Una spiegazione a questa istanza collettiva, a questo peccato diffuso nel senso
originario del termine – l’errore di percorso – non trova spiegazione se ci si perde
nell’infinità delle responsabilità individuali, ma acquista un senso se si osserva il
quadro generale per come lo legge la psicanalisi contemporanea.
Se il soggetto che entra nella teoria economica classica è infatti fondamentalmente
razionale, quello che invece compare nella teoria finanziaria attuale è un soggetto
fortemente irrazionale, cioè ha demandato alle pulsioni il criterio delle sue scelte sul
mercato, come nel caso della finanza comportamentale - che si occupa proprio di
spiegare l’assenza di razionalità nella formazione dei prezzi di mercato e
nell’allocazione delle risorse.
Rimanendo in ambito filosofico, la categoria che ci occorre per colmare le lacune
aperte dall’homo oeconomicus è quella che abbiamo già indicato come secondo
pilastro del potere bancario assieme al debito, cioè quella del godimento.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!145 S. Žižek, Meno di niente, op. cit., p. 299 146 Cfr. D. M. De Luca, “Il fallimento di Lehman Brothers”, IlPost.it, 15 settembre 2012!
! 60!
§2.3 Il debito come strumento di potere
Per introdurre il godimento nella nostra trattazione dobbiamo tenere di nuovo
presente lo status del denaro per come ce lo consegna Simmel:
Poiché il tipo di potere incarnato nel denaro, che abbiamo appena esposto, sviluppa un senso di potenza sublimato prima che il denaro venga speso – il «momento produttivo» si è in un certo senso fermato in lui -, l’avarizia è una forma della volontà di potenza, che illumina il carattere del denaro come mezzo assoluto. Avviene così che la potenza rimanga realmente soltanto potenza e non si trasformi nel proprio esercizio e nel suo godimento. […] Infatti, in quanto serve a soddisfare sia i bisogni indispensabili della vita che quelli voluttuari, associa all’urgenza intensiva del desiderio la sua mancanza estensiva di confini. Il denaro è in se stesso la base della struttura del bisogno di beni voluttuari, nella misura in cui rifiuta ogni limite al desiderio […].147
In questa rappresentazione dell’avaro troviamo tutti gli elementi utili a interpretare
sia il potere bancario sia il soggetto su cui tale potere insiste e che viene
comunemente denominato ‘soggetto di desiderio’. Mentre l’economia, nella sua
definizione più classica, fa riferimento al sistema dei bisogni, l’economia finanziaria,
che ha l’accesso al denaro come suo fulcro, oltrepassa il momento di soddisfazione
della necessità e si proietta in quella che nella sociologia attuale viene letta come la
costruzione di mondi di senso.
Se osserviamo le produzioni del marketing per quanto concerne i prodotti bancari
e l’accesso stesso al sistema bancario notiamo infatti un tema ricorrente: ciò che la
banca propone ai suoi clienti non sono più i classici motivi della sicurezza e della
stabilità (che comunque sono tornati in auge dopo la crisi), ma la possibilità di
godere delle piccole gioie - che già secondo la Arendt indicava il declino della sfera
pubblica a favore di quella privata148.
E’ il caso di un grande gruppo bancario che formula nel suo spot una domanda
destinata a farci riflettere attentamente sul ruolo che pensiamo svolgano le banche
nel sistema attuale: “E così vero? Quando hai bisogno di qualcosa in più, spariscono
tutti.” Questo spot in particolare mostra un uomo alle prese con una serie di piccoli
dettagli – non con bisogni veri e propri – che comunque definiscono in ogni
momento la sua personalità e il modo in cui vuole apparire nel mondo. Dal taglio del
barbiere alla qualità del caffè quello che ci viene mostrato è un mondo restìo ad
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!147 G. Simmel, op. cit., pp. 357, 365 148 Cfr. H. Arendt, Vita activa, op. cit.!
! 61!
accondiscendere alle sue richieste specifiche – dove l’unica eccezione è costituita
dalla banca che invece si pone idealmente al servizio di ogni ‘capriccio’ del suo
cliente.
Un altro esempio proveniente dal mondo della pubblicità e che ha avuto ancora
più fortuna del precedente è il messaggio promozionale della Mastercard “…non ha
prezzo. Per tutto il resto c’è Mastercard”, che ha sicuramente il pregio di
comunicare immediatamente il desiderio nella sua forma più attuale:
Finora si è parlato di desiderio in modo astratto perché è stato isolato un oggetto che si suppone essere l’oggetto del desiderio, e allora si può dire “desidero una donna, desidero partire in viaggio, desidero questo o quello…”. E noi dicevamo una cosa davvero semplice: voi non desiderate mai davvero qualcuno o qualcosa. Voi desiderate sempre un insieme. Non è complicato. E noi ponevamo una questione: qual è la natura dei rapporti tra gli elementi perché ci sia desiderio, perché diventino desiderabili? […] Proust l’ha detto e in modo bello: io non desidero una donna, io desidero anche il “paesaggio” che è contenuto in quella donna, un paesaggio che forse neanche conosco, ma che intuisco, e finché non ho sviluppato questo paesaggio che l’avviluppa io non sarò contento, cioè il mio desiderio non sarà compiuto, resterà insoddisfatto. Qui prendo ad esempio un insieme a due termini: la donna e il paesaggio, ma è ben altro. Quando una donna dice “desidero un vestito, desidero questo o quel vestito, quella camicetta…”, è evidente che non li desidera in astratto. Li desidera nel proprio contesto, nel proprio contesto di vita per come lei lo organizza. Li desidera non solo in relazione ad un “paesaggio”, ma a delle persone, che possono essere suoi amici o meno, o alla sua professione, ecc. Non si desidera mai qualcosa di isolato. Per di più, non desidero neanche un insieme, desidero in un insieme. (…) In altre parole, non c’è desiderio che non scorra – proprio così: che non scorra – in un concatenamento. Dunque, per me il desiderio è sempre stato… Se cerco il termine astratto corrispondente a desiderio, è costruttivismo. Desiderare è costruire un concatenamento, costruire un insieme. […] Ecco cos’è il desiderio. E costruire un concatenamento, significa costruire una regione; significa davvero concatenare. (…) Il concatenamento è un fenomeno fisico, è come una differenza. Perchè accada qualsiasi evento c’è bisogno di una differenza di potenziale e ci vogliono due livelli, bisogna essere in due, allora accade qualcosa. […] Tutti noi passiamo il tempo a costruire. Per me quando qualcuno dice “desidero la tal cosa”, significa che sta costruendo un concatenamento. Il desiderio non è nient’altro.149
L’insistenza sul desiderio è una caratteristica tipica del pensiero occidentale. Come
rilevava già Foucault in un’intervista:
Il problema dell’antichità greco-romana è che cosa fare del nostro piacere […]. Penso che noi siamo una civiltà, forse LA civiltà nella quale il problema del desiderio è diventato molto più importante del problema del piacere. […] Perché ci riconosciamo come soggetti di desiderio e non come agenti di piacere? […] [Penso che questo sia davvero
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!149 G. Deleuze, “D come Desiderio”, Abecedario di Gilles Deleuze, in Italia pubblicato in DVD da DeriveApprodi, Roma, 2005
! 62!
importante], la prevalenza del desiderio come caratteristica principale non solo della sessualità ma dell’essere umano stesso, dell’esistenza umana.150
Anche nel caso del potere bancario ci troviamo di fronte a un potere che crea
desiderio, prefigurando il momento del piacere. O almeno è quello che il potere
bancario vuole comunicare quando entra sul mercato alla ricerca di nuovi clienti. In
ogni altra situazione, come abbiamo già detto, il messaggio della finanza è ben
diverso da questo invito costante a desiderare sempre e sempre di più. Il discorso
istituzionale è all’insegna del risparmio, dell’avversione al rischio, dell’austerity.
Questo doppio discorso del potere non deve però trarci in inganno.
Già a partire dagli anni Sessanta acquista dignità nel pensiero filosofico l’idea che
«il potere è già sempre la sua trasgressione; se deve funzionare, deve rapportarsi a
una sorta di supplemento osceno.» Inoltre «questa “erotizzazione” del potere non è
un effetto secondario del suo tendere al proprio oggetto, ma il suo stesso fondamento
denegato, il suo “crimine costitutivo”, il suo gesto fondante che deve rimanere
invisibile affinché il potere funzioni normalmente.»151
Nel potere bancario quindi troviamo la stessa scissione che riguarda ogni tipo di
potere: da un lato l’’ideale dell’Io’, «l’ordine simbolico che regola la vita sociale e
mantiene la pace»152 - e possiamo fornire molteplici esempi come le regole che
ispirano Basilea 2, o l’insistente invito al risparmio, alla sicurezza, nonché lo stesso
termine con cui designiamo le politiche di austerità; dall’altro il suo «osceno inverso
superegoico»153, che mentre in apparenza si oppone alla lettera della legge, ciò che
realmente fa è renderla possibile ed effettiva.
In che modo i due volti della legge si relazionano al potere bancario è sempre
attraverso lo strumento del debito. Da un lato infatti abbiamo visto come il debito,
dall’inizio dei tempi, sia qualcosa da evitare a tutti i costi per entrambe le parti. Da
un altro punto di vista invece il debito è qualcosa di estremamente desiderabile,
soprattutto nell’economia capitalista che abbiamo delineato.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!150 La citazione riportata è la traduzione della trascrizione di un audio risalente ad aprile 1983, nel periodo in cui M. Foucault teneva presso l’università di Berkley i corsi intitolati The Culture of the Self. Tuttavia non siamo stati in grado di individuare in quale lezione comparissero questi enunciati, né se fosse parte di un’intervista. L’audio dei corsi è disponibile in lingua inglese presso il portale UbuWeb all’indirizzo http://ubu.com/sound/foucault.html, mentre la trascrizione dell’audio originale è visionabile all’indirizzo http://www.autoroute.plus.com/generation/p/fpfoucault4.htm 151 S. Žižek, Il godimento come fattore politico, op. cit., pp. 79-80 152 Ivi, p. 62 153 Ibidem!
! 63!
Il debito infatti, crea ricchezza. Il capitalista moderno e l’avaro hanno preso strade
differenti. Mentre per l’avaro ciò che conta è il momento, al capitalista interessa –
anzi, gli è vitale – il movimento.
Il movimento (anche se lo consideriamo in un ottimo puramente consumistica,
come il movimento delle merci nel processo di produzione e consumo), vive di
debito. Si potrebbe obiettare che questo non è vero per tutti e dappertutto. Ad
esempio esistono delle differenze tra la crisi del debito americana e quella europea.
Si tratta comunque di differenze che non si impongono all’attenzione della nostra
analisi, non risultano decisive nello scambio tra debito e ricchezza.
Questo per quella caratteristica peculiare del debito che avevamo già chiamato
responsabilità collettiva, non volendoci però con questo inoltrare nel concetto di
responsabilità, ma prendendolo in prestito per indicare il meccanismo con cui un
debito supera il soggetto debitore e investe dei suoi effetti anche le persone che non
possono essere materialmente responsabili per esso. Così è anche il debito
monetario: la crisi, causata da una cultura del debito giunta al massimo livello di
tolleranza da parte del sistema americano154, raggiunge il soggetto europeo attraverso
il debito sovrano e i meccanismi di interdipendenza del sistema bancario.
Ma sia che si parli di stati sia che si parli di individui, il debito (il prestito, la
creazione di moneta, ecc.), rende possibile un meccanismo che abbiamo già
osservato in apertura del capitolo. «Come un nulla che assume una qualche parvenza
di sostanza tessendo magicamente sé stesso in un eccesso di sé»155, ogni volta che il
debito viene costituito, con esso appare, dallo stesso nulla, la ricchezza.
Quando Burnham scriveva «quando ricordiamo che il governo è oggi la più
grande di tutte le imprese, nella sfera strettamente economica come in altre, la
possibilità, che i governi dimostrano, di continuare a funzionare in perdita non è
compatibile coi fondamenti stessi del capitalismo»156, non considerava quindi che la
‘perdita’ non è in questo caso una reale perdita, ma il disavanzo che diventa
investimento è a tutti gli effetti una ricchezza, una risorsa che permette agli stati di
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!154 Sul tema esiste molto materiale documentaristico precedente al 2008, tra cui ricordiamo D. Schechter, In Debt We Trust: America Before the Bubble Bursts, 2006 155 S. Žižek, Meno di niente, op. cit., pp. 301-302 156 J. Burnham, La rivoluzione dei tecnici, Mondadori, Milano, 1947, p. 126!
! 64!
mantenere in vita le proprie politiche e agli individui di consumare, cioè di tenere in
vita il sistema economico.
Ci troviamo dunque di fronte a un doppio discorso del debito in quanto strumento
di potere: da un lato infatti esso è necessario per alimentare i consumi, le politiche
sociali e così via; dall’altro – ed è il discorso post crisi – il debito è colpa, è qualcosa
di cui vergognarsi e, quasi religiosamente, da espiare.
Il caso greco è un esempio lampante di ciò di cui stiamo parlando: «Almost
overnight the country that entered the Euro and hosted the Olympics winning
unconditional international acclaim, EUs agent and preferential business partner in
the Balkans, a valued market for European commodities […] became the sic man of
Europe, a bête noire to be ridiculed, condemned and disciplined in the most severe
and exemplary way»157
Il problema sollevato dal professor Stavrakakis centra esattamente il cuore della
questione del potere bancario (e del capitalismo finanziario in generale).
Innanzitutto, analizzando il discorso dominante successivo alla crisi, l’autore fa
emergere una prima contraddizione:
In these narratives, these new representations, crisis does not appear merely as a neutral fact, as a simple disruption; it is crearly reconstructed as a major failure. If the crisis itself represents something is failure; but not, of course, any failure. We are not talking about the collapse of a system, a systemic failure, but about a personalised failure. It is not a question of ‘what?’ but of ‘who?’. Is is precisely here that the whole process of localisation starts, a process that, as we have seen, in order to localise and narrate this failure incorporates medical, rationalistic and moralistic categories and tropes in a political blend of great salience. Howewer, what are the conditions of possibility for the political effectivity of these discourses? How do they manage to affect so many people and social groups and so efficiently perform the sleight of hand of camouflaging a systemic failure as an exceptional/individual failure?158
In un’ottica biopolitica, che è la stessa in cui l’autore si muove, assistiamo ad un
discorso del potere che modella un determinato soggetto. Ma il soggetto emergente
dalla società del debito, il soggetto che diventa interlocutore privilegiato di questo
potere che trova nel debito il suo strumento per eccellenza, non è semplicemente
l’homo oeconomicus.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!157 Y. Stavrakakis, “Biopolitics, psychoanalysis and debt”, paper presentato alla conferenza intitolata Psychoanalysis and Political Theory, Università degli Studi di Salerno, 6 giugno 2013, p. 3 158 Ivi, p. 4!
! 65!
Per utilizzare il termine di Deleuze 159 , possiamo riferirci a questo nuovo
protagonista pre e post crisi come all’’uomo indebitato’, dove quindi il debito
diventa elemento centrale anche rispetto alla razionalità orientata al profitto.
Rispetto alle condizioni di possibilità di cui parlava Stavrakakis, esse vanno
quindi come prima cosa cercate in questo soggetto, e nel modo in cui il doppio volto
della legge di cui parlavamo prima si relaziona ad esso.
«Il debito secerne una «morale» propria, insieme diversa e complementare a
quella del «lavoro». La coppia «sforzo-ricompensa» dell’ideologia del lavoro viene
rivestita dalla morale della promessa (di onorare il proprio debito) e dell’errore (di
averlo contratto).»160
L’invito al godimento e l’imposizione dell’austerità, che possiamo per semplicità
tradurre come l’invito a indebitarsi e la punizione per averlo fatto, appartengono allo
stesso identico meccanismo: «Il potere del creditore sul debitore assomiglia molto
all’ultima definizione che dà del potere Foucault: un’azione su un’altra azione,
azione che mantiene “libero” colui sul quale si esercita il potere. Il potere del debito
vi lascia liberi, e vi incita e spinge ad agire affinché possiate onorare i vostri
debiti»161.
In questo senso, considerati i continui rimandi all’opera di Foucault, ci muoviamo
sicuramente in un’ottica anti-umanista; dove il soggetto cioè viene prodotto e
controllato («il debito […] agisce a livello immediatamente planetario […],
accompagnando e sollecitando la creazione “etica” dell’uomo indebitato»162)
Se al di là del discorso sul potere consideriamo anche quello psicoanalitico, quello
che abbiamo appena affermato trova una sua ragion d’essere non solo nel rapporto
tra potere e soggetto, ma anche nella dinamica del soggetto a sé stante.
Esiste un collegamento tra il senso di colpa, il potere e il superego, che può essere
riassunto come segue. Da un lato il senso di colpa prende la forma di un inconscio
‘desiderio di essere puniti’; dall’altro esso opera attraverso due varianti principali:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!159 Cfr. G. Deleuze, “Poscritto sulle società di controllo”, in Pourparler, Quodlibet, Macerata, 2000 160 M. Lazzarato, La fabbrica dell’uomo indebitato: saggio sulla condizione neoliberista, DeriveApprodi, Roma, 2012, p. 48 161 Ivi, p. 49 162 Ivi, p. 103!
! 66!
quella proibitiva e brutale, come in Freud, e quella permissiva e generativa, come in
Lacan163.
Una delle considerazioni di Lacan più riprese dal discorso filosofico moderno è
infatti quella che inscrive l’imperativo a godere a livello superegoico, come emerge
sia nel corso dei Seminari «Il diritto non è il dovere. Niente costringe qualcuno a
godere, tranne il super-io. Il super-io è l’imperativo del godimento – Godi!»164; sia
negli Scritti: «Vi ho mostrato come, al Devi di Kant, si sostituisca agevolmente il
fantasma sadiano del godimento eretto ad imperativo – puro fantasma certo, quasi
derisorio, ma che non esclude affatto la possibilità della sua erezione a legge
universale.»165
Lacan was perhaps the first to perceive the importance of this second paradoxical hybrid when he linked the (consumerist) command ‘enjoy!’ with the superego. […] He was the first to detect in this innocent call the unmistakable mark of power and authority. Such constitutive ambivalence and historical variability in the subjective infrastructure within civilization emerges as an indispensable technology of domination through its association with other processes in which splitting and mutual engagement continuously alternate: the dialectic between the two spirits of capitalism as well as that between the different faces of power as formulated by Foucault, to name just a couple. We can infer from all this that both enforced accumulation of debt as well as stigmatization and punishment of indebtedness constitute internal if antithetical moments of the same mechanism, utilizing subject construction in the service of social hierarchy. And when the loop between the two fails, debt cancellation and debt forgiveness is called for to sustain social order. Historically, all these three options have alternated sustaining but also gradually shifting power relations (especially in the third case).166
Si corrono sempre dei rischi nell’applicare la teoria psicanalitica alla società, non da
ultimo quello di arrendersi al fatto di vivere in una società malata (dal momento che
applichiamo i sintomi di un paziente al corpo sociale preso nella sua interezza). Né si
può ignorare il fatto che, pur in una visione anti-umanista come quella appena
presentata, il soggetto continui a sussistere come un cuneo tra le dinamiche di sapere
e potere che pretenderebbero di esaurire in tutto e per tutto la sua condotta.
Rimane insomma un ultimo punto per riallacciare insieme gli elementi che fanno
del potere bancario un vero e proprio potere, con dignità propria, con caratteristiche
inequivocabili. Un punto che forse rende più giustizia al soggetto delle sole ragioni
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!163 Cfr. Y. Stavrakakis, op. cit. 164 J. Lacan, Il seminario, XX, “Del godimento”, 12 dicembre 1972, Einaudi, Torino, 2011, p. 5 165 J. Lacan, Il seminario, VII, “I paradossi dell’etica”, 6 luglio 1960, Einaudi, Torino, 1994, p. 397 166 Y. Stavrakakis, op. cit., pp. 8-9!
! 67!
psicologiche. Esso ci riporta al discorso di prima, quello sulla diatriba tra essere e
apparire, che svela adesso la sua più ampia portata ai fini della nostra analisi.
«Come afferma Nietzsche, il compito principale del debito consiste nella
costruzione di un soggetto e della sua coscienza, di un sé che crede alla propria
individualità e che si fa garante delle proprie azioni, del proprio modo di vivere (non
soltanto del suo lavoro) e che ne è responsabile.»167
Il soggetto di cui parla Lazzarato è l’uomo occupabile, il soggetto che si fa
impresa, lo stesso di cui parlava Foucault quando affermava che l’arte di governare
nata negli anni trenta aveva come obiettivo quello di «ottenere una società orientata
non verso il mercato e l’uniformità della merce, ma verso la molteplicità e la
differenziazione delle imprese.»168 La caratteristica principale di questo soggetto non
è però la sempre maggiore responsabilità, ma quella che Foucault chiama
«l’inversione dell’asse di verbalizzazione nei rapporti di dominio.»169
Se è vero che nel capitalismo finanziario importa ciò che appare, cioè viene
comunicato, è anche vero che ciò che appare è quasi sempre un discorso. La
trasparenza, in questo senso, non è uno strumento al servizio della democrazia, ma
una verbalizzazione costante, come rileva anche Lazzarato nel caso delle politiche
dello Stato sociale «nel regime del debito, l’individualizzazione delle politiche […]
non è più solamente disciplinare […]. Comporta sempre una valutazione «morale»
[…]. Il rimborso del debito corrisponde a una normalizzazione dei comportamenti e
a una conformità alle norme di vita decretate dall’istituzione.»170
Nel caso, apparentemente dissimile, della subditio monastica, Foucault afferma
che «per arrivare a questa subditio, per fare in modo che ci sia sempre, al posto della
propria volontà, la volontà di un altro o di qualche altro che voglia al nostro posto e
che trasforma tutti gli atti volontari della nostra esistenza in atti di sottomissione,
perché questo sia possibile, si pone evidentemente un’esigenza. Un’esigenza
semplice, evidente: il fatto che bisogna parlare.»171
Se, con le dovute precauzioni, applichiamo questo caso all’economia finanziaria e
delineiamo il viaggio di questa esigenza, che nel lessico odierno abbiamo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!167 M. Lazzarato, op. cit., pp.144-145 168 M. Foucault, Nascita della biopolitica, op. cit., p. 132 169 M. Foucault, Mal fare dir vero, op. cit. p. 135 170 M. Lazzarato, op. cit., pp. 145-146 171 M. Foucault, Mal fare dir vero, op. cit., p. 134!
! 68!
giustamente chiamato ‘trasparenza’, possiamo facilmente accorgerci che il terminale
ultimo dove l’insieme delle informazioni relative al debito confluisce è proprio il
potere finanziario.
E non sono informazioni asettiche, tecniche, ma, nel momento in cui riguardano
l’accesso stesso alla società, cioè l’accesso al denaro, sono informazioni da cui
scaturisce inevitabilmente una valutazione morale, oltre che economica (nel senso
dell’efficienza).
Il debito però non agisce mai solamente a livello morale - affermare questo
sarebbe in contraddizione con il tentativo che abbiamo fatto di slegare lo strumento
del debito dall’epopea teologica che ne ha fatto il suo protagonista insieme alla
colpa. Che le popolazioni oggetto dell’austerity, come ci ricorda a più riprese
Stavrakakis, siano state delegittimate, ancora prima che economicamente,
verbalmente (con l’uso ad hoc di metafore mediche), non vuol dire che esista a
livello generale in queste popolazioni un senso di colpa collettivo da ricercare
nell’inconscio o un’altrettanta inconscia tendenza a riconoscersi come ‘malati’ e ad
accettare quindi ogni ‘cura’ proposta dal sistema di potere finanziario.
Se si vuole individuare un meccanismo, un dispositivo172 (per rimanere nel lessico
di Foucault), esso è necessariamente tra le parti, come il potere stesso di cui è a
disposizione, un potere che «induce piacere, forma del sapere, produce discorsi», da
considerare «come una rete produttiva che passa attraverso tutto il corpo sociale.»173
What I’m trying to pick out with this term [dispositivo ndr] is, firstly, a thoroughly heterogenous ensemble consisting of discourses, institutions, architectural forms, regulatory decisions, laws, administrative measures, scientific statements, philosophical, moral and philanthropic propositions–in short, the said as much as the unsaid. Such are the elements of the apparatus. The apparatus itself is the system of relations that can be established between these elements. Secondly, what I am trying to identify in this apparatus is precisely the nature of the connection that can exist between these heterogenous elements. Thus, a particular discourse can figure at one time as the programme of an institution, and at another it can function as a means of justifying or masking a practice which itself remains silent, or as a secondary re-interpretation of this practice, opening out for it a new field of rationality.174
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!172 Il termine ‘dispositivo’, non avendo Foucault mai fornito una definizione univoca, è stato oggetto di varie interpretazioni. In particolare ricordiamo le riflessioni di G. Agamben, Che cos’è un dispositivo?, Nottetempo, Roma, 2006 E quelle di G. Deleuze, Che cos’è un dispositivo?, Cronopio, Napoli, 2010 173 M. Foucault, Microfisica del Potere, op. cit., p. 13 174 M. Foucault, (ed. C. Gordon), “The Confession of the Flesh” (1977), Power/Knowledge Selected Interviews and Other Writings. 1972-1977, The Harvester Press, Limited, 1980, pp. 194-228. In questa traduzione inglese il termine dispotif/dispositivo viene tradotto, tradendo in parte il senso
! 69!
La trasparenza non è un dispositivo ad esclusivo appannaggio del potere bancario.
Investe dei suoi effetti la politica, l’amministrazione e il campo economico più
generale. Come ogni dispositivo essa non è un evento casuale scaturito dalla forza
magmatica della società, ma un intervento dettato dalla necessità contingente.
Né la trasparenza, in questo caso, va intesa come assenza di mediazione tra lo
sguardo e l’oggetto dello sguardo. Al contrario, ciò che il dispositivo della
trasparenza ottiene, è il monopolio della mediazione. Pensiamo ad esempio a tutti i
dati prettamente economici che quotidianamente il potere finanziario raccoglie e
mette in relazione, essi non sono mai meri dati, ma nel momento in cui appaiono e
vengono comunicati contengono già una mediazione che li ha resi passibili di verità.
Una verità che non è ovviamente assoluta, ma si appella comunque a una
molteplicità di discorsi (universitario, politico ecc.), in misura tale da renderla
effettiva.
E’ così che la virtualità dell’economia finanziaria assume una posizione di
dominio rispetto all’economia reale, attraverso cioè la possibilità (e non la pretesa),
di poter esprimere la verità sul mondo delle relazioni economiche.
E’ quindi attraverso questa molteplicità di strumenti che il potere bancario prende
forma nella società attuale, strumenti che come abbiamo visto attengono a
meccanismi soggettivi, economici e più generalmente sociali.
Un ultimo punto resta però ancora da chiarire, se il potere bancario sia o no, allo
stato delle cose, passibile di esercitare potere ‘politico’.
! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!originario, come apparatus. Come fa notare anche J. Bussolini, “What is a Dispositive?”, Foucault Studies, no. 10, novembre 2010, pp. 85-107
! 70!
! 71!
III.
IL TERRIBILE INGANNO
Il problema che più si impone all’attenzione delle discipline politiche è quello
dell’apparente declino della sovranità statale in favore di una supposta sovranità
economica sia nella sfera dei rapporti umani, sia in quella più ampia delle relazioni
istituzionali. In questo contesto il potere bancario gioca certamente un ruolo
rilevante, sia come attore principale, sia come voce tra le molte che definiscono il
modo di governare negli anni della globalizzazione.
L’interdipendenza che caratterizza la nostra epoca fa sì che una classica divisione
del mondo in ambiti di competenza - nonostante l’evidente differenziazione delle
varie funzioni in seno alla società – non sia più agevole, o meglio non lo sia più se
l’obiettivo è cercare il politico al di là delle istituzioni che se ne dicono depositarie.
In questo ultimo capitolo della trattazione, avendo chiarito di cosa parliamo
quando parliamo del potere bancario, cercheremo di individuare le dinamiche
conflittuali che più caratterizzano il rapporto tra finanza e società e di far emergere,
per quanto possibile, il profilo politico che le caratterizza.
Rispetto alle figure che incarnano di volta in volta il potere bancario, abbiamo
potuto osservare una serie di giudizi morali e di condotta dovuti principalmente alla
natura ambigua dell’arricchimento tramite denaro. Storicamente, un secondo ordine
di accuse si muove all’usuraio, al banchiere, a chi, nel suo tempo, è identificato con
il denaro che riproduce se stesso, cioè di tenere un comportamento a-morale, super
partes, asettico. In una parola, tecnico.
«Un dominio sugli uomini fondato su basi economiche deve apparire come un
terribile inganno proprio se resta non politico, poiché in tal caso si spoglia di ogni
responsabilità ed evidenza politica»175 scrive Schmitt e gli fa eco Jeins Weidmann,
dal board della BCE, quando afferma nell’agosto 2013 che «la politica monetaria è
entrata in un territorio sconosciuto e pericoloso».176
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!175 C. Schmitt, Le categorie del «politico», op. cit., p. 163 176 “Bce, Weidman: la politica monetaria è entrata in un territorio pericoloso”, IlSole24Ore.com, 25 agosto 2013
! 72!
Quale sia questo territorio non è specificato, ma facilmente intuibile. E’ lo
sconfinamento del tecnico nel politico, del bancario nelle vicende degli stati sovrani.
Sconfinamento osservato e temuto dal Weber di Parlamento e governo, che già
delineava chiaramente il nostro cruccio contemporaneo: «In uno stato moderno il
potere reale, che non si manifesta né in discorsi parlamentari né in dichiarazioni di
sovrani, bensì nel manovrare l’amministrazione nella vita quotidiana, sta
necessariamente e inevitabilmente nelle mani della burocrazia, sia militare che
civile.»177
Ma aggiunge anche:
Non è compito che riguarda il funzionario […] «fare politica», che significa sempre lotta. La direzione della burocrazia, che assegna ad essa i compiti, ha invece naturalmente continui problemi politici – di politica di potenza e di politica culturale – da risolvere. Controllarla in questa funzione è il primo compito fondamentale del parlamento. […] nelle condizioni moderne l’istruzione specializzata è il presupposto indispensabile per la conoscenza dei mezzi tecnici per il raggiungimento di fini politici. Ma porre fini politici non è una questione specialistica, e il funzionario specializzato, semplicemente in quanto tale, non deve determinare la politica.178
Per ovvie ragioni Weber non si riferiva al potere bancario, ma è immediata la
similitudine che lega la sua riflessione alla nostra indagine.
Tuttavia in Economia e Società, nella minuziosa analisi del denaro nelle sue
diverse manifestazioni, non troviamo riscontro della nostra situazione attuale. E cosi
pure nella ponderosa teoria monetaria di Knapp, a cui Weber fa esplicito riferimento
nel volume. Questo per un semplice motivo, cioè che la teoria monetaria sussisteva
ancora sulla duplice premessa del monopolio statale e della conversione del denaro
(aurea o argentea, e cosi via).
Allo stato attuale delle cose, almeno in Europa, l’emissione di moneta, svincolata
da un controllo parlamentare per come siamo abituati a intenderlo, è interamente
nelle mani della Banca Centrale Europea.
E’ dunque a questo livello, primariamente, che avviene la commistione di
bancario e politico, cioè nel momento in cui l’offerta di moneta non è più nelle mani
del singolo Stato, ma in quelle di un potere, per definizione, tecnico.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!177 M. Weber, Parlamento e governo, Laterza, Bari, 2002, p. 23 178 Ivi, p. 60!
! 73!
E’ in quest’ottica che vanno lette le parole di Weidmann, così come le posizioni
avverse – in primis di Draghi – nel momento in cui si appresta a difendere la sua
politica di fronte alla Corte Costituzionale tedesca. Sono i due sguardi opposti di chi
teme l’intromissione dell’economia nella politica, da un lato, e dall’altro di chi è
consapevole dell’eventualità che l’economia si debba regolare sulla politica.
Riprendendo il passaggio di Schmitt da dove l’avevamo interrotto:
Il concetto di scambio non esclude assolutamente, sul piano concettuale, che uno dei contraenti subisca un danno e che un sistema di contratti reciproci possa alla fine trasformarsi in un sistema del più crudo sfruttamento ed oppressione. Se gli sfruttati e gli oppressi […] ricorrono alla difesa, non possono ovviamente fare ciò con strumenti economici. E’ quindi facilmente comprensibile che i titolari del potere economico bollino come violenza e violazione e cerchino di impedire ogni tentativo di un mutamento «extraeconomico» della loro posizione di potere.179
In questo breve passo emergono tre questioni cruciali, la cui analisi costituirà
l’ultimo sforzo di questa trattazione.
Il termine stesso di sfruttato e oppresso ci conduce al primo punto problematico,
soprattutto se continuiamo a muoverci in una visione societaria à la Luhmann, che
nella sua opera mette continuamente il lettore di fronte all’opportunità di utilizzare
ancora l’oppressione come categoria interpretativa del sociale.
Il secondo punto riguarda la natura extrapolitica del potere bancario in quanto
economico.
L’ultima questione sollevata, profondamente connessa a quella politica, è se la
commistione tra politico e bancario avvenga solo in luogo di una commistione che
sia primariamente personale. Cioè se il problema sia dei titolari del potere, piuttosto
che dell’articolazione del potere.
§ 3.2 Oltre l’oppressione, oltre lo sfruttamento
Cominciando dal principio, interroghiamoci sullo status degli oppressi, che
sicuramente lo sono, almeno dal loro punto di vista, dal sistema bancario attuale.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!179 C. Schmitt, Le categorie del «politico», op. cit., pp. 163-164 !
! 74!
Se non si riconoscessero come tali, non assisteremmo all’enorme sollevazione
popolare che ha investito gli Stati Uniti (con episodi anche europei), e che è andata
sotto il nome di Occupy Wall Street. E’ cruciale questo tipo di iniziativa non tanto
per la portata mediatica e numerica, quanto perché è stata ed è tutt’ora un calderone
ideale che ha visto riunite sotto un unico slogan tutte le vie della critica
anticapitalista e antisistemica. E’ inoltre emblematica perché avviene in un paese
dove la cultura del debito è assurta ad un vero e proprio stato esistenziale del
cittadino americano (We are the 99%), e non tanto per volontà degli Stati, come in
Europa, quanto per l’adozione di un vero e proprio stile di vita.
Infatti alla base della crisi di credito del 2008 c’è ovviamente un debito diffuso e
generalizzato e non ripagabile. E’ il debito dei cosiddetti mutui subprime, cioè
l’indebitamento per l’acquisto di case che già in partenza si sapeva non sarebbe
potuto essere pagato. E’ il debito cattivo, che è circolato incessantemente sotto
svariate forme di banca in società assicurativa fino a scatenare il suo effetto letale nel
momento in cui non si è più potuta replicare la sua esistenza. Perché, come
accennavamo inizialmente un debito deve essere ripagato o deve essere rimesso o
non potrà fare a meno di manifestare i suoi effetti sulle parti in causa.
Per questo motivo ci domandiamo se sia corretto definire il soggetto emergente
dalla crisi americana un oppresso dal potere, una vittima del terribile inganno del
governo non politico dell’economia. Prendiamo in esame un passaggio delle lezioni
di Foucault quando, in apertura dei Corsi al Collège de France, afferma:
Si potrebbero dunque opporre due grandi sistemi di analisi del potere. […] L’uno […] si articola intorno al potere come diritto originario che si cede, che costituisce la sovranità e in cui il contratto funziona come matrice del potere politico. Il potere così costituito rischia di diventare oppressione quando oltrepassa se stesso, cioè quando va al di là dei termini stessi fissati dal contratto. Potere-contratto, con l’oppressione come limite o piuttosto come oltrepassamento del limite. L’altro sistema cercherebbe di analizzare […] il potere politico non più secondo lo schema contratto-oppressione, ma secondo quello guerra-repressione. A questo punto la repressione non è più quel che era l’oppressione rispetto al contratto, cioè un abuso, ma, al contrario, il semplice effetto e la semplice continuazione di un rapporto di dominazione.180
L’oppressione e la repressione sono due azioni tipiche di un potere che si esercita
dall’alto, ma mentre nel caso dell’oppressione si tratta dell’arbitrio del potere in virtù
della sua forza o della debolezza della controparte, nel caso della repressione si tratta
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!180 M. Foucault, “Bisogna difendere la società”, op. cit., pp. 23-24
! 75!
di contenere una forza che avanza, di spingerla indietro, come nel caso – riportato
anche nell’etimologia stessa della parola – del male.
Il male represso non è un male ontologico, ma un male contingente rispetto al
potere che ha organizzato, in una determinata società, il bene. Non è nemmeno un
male negativo, esso deve apparire e manifestarsi in qualche modo per essere represso
e in ogni caso deve costituirsi controparte di un bene determinato.
Se è vero che «appartiene al meccanismo dell’oppressione vietare la conoscenza
del dolore che produce» 181 , nel caso della repressione il dolore è esibito,
razionalizzato e a volte legalizzato, ma non occultato. Lo scopo della repressione,
nozione ancora una volta derivata dal campo della psicologia, è piuttosto quello di
interdire una determinata verità che se è il male dal punto di vista del potere, è
liberatoria dal suo stesso punto di vista.
Il problema di utilizzare ancora il concetto di repressione è però duplice: da un
lato, infatti, è un concetto che nega una natura relazionale del potere, lo individua in
un punto da cui le forze repressive tendono a dispiegarsi, ne fa un puro dominio;
dall’altro la repressione fa riferimento alla sovranità 182 , al sistema giuridico-
disciplinare, è insomma inattuale in un sistema come quello del capitalismo
finanziario, dove abbiamo potuto costatare che ciò che emerge non è tanto un
problema di disciplina, quanto uno più attuale, di controllo:
Talvolta si è pensato che Foucault organizzasse la tavola delle società moderne come altrettanti dispositivi disciplinari, in opposizione ai vecchi dispositivi di sovranità. Ma non è così: le discipline descritte da Foucault sono la storia di ciò che poco a poco cessiamo di essere e la nostra attualità si disegna in disposizioni di controllo aperto e continuo, molto diverse dalle recenti discipline chiuse. Foucault concorda con Burroughs che annuncia il nostro avvenire controllato piuttosto che disciplinato.183
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!181 T. W. Adorno, Minima moralia, op. cit., p. 64 182 «Quando si definiscono gli effetti di potere attraverso la repressione ci si dà una concezione puramente giuridica di questo potere; lo si identifica ad una legge che dice no; avrebbe soprattutto la potenza dell’interdizione. […] Se non fosse altro che repressivo, se non facesse mai nient’altro che dire no, credete veramente che gli si arriverebbe ad obbedirgli?». «Porre il problema in termini di Stato è ancora porlo in termini di sovrano e di sovranità ed in termini di legge. Descrivere tutti questi fenomeni di potere in funzione dell’apparato di Stato, è porli essenzialmente in termini di funzione repressiva […]. Non voglio dire che lo Stato non sia importante, quel che voglio dire è che i rapporti di potere e di conseguenza l’analisi che se ne deve fare deve andare al di là del quadro dello Stato. Deve farlo in due sensi: innanzitutto perché lo Stato, anche colla sua onnipotenza, anche coi suoi apparati, è ben lungi dal ricoprire il campo dei rapporti di potere; e poi perché lo Stato non può funzionare che sulla base di relazioni di potere preesistenti.» M. Foucault, Microfisica del Potere, op. cit., p. 13-16 183 G. Deleuze, Che cos’è un dispositivo?, op. cit., p. 28
! 76!
Anche l’oppressione, in quanto dominio incurante dei diritti o delle aspettative
dell’oppresso, non è un concetto che sembra funzionare nel campo economico.
Il potere economico rientra in un discorso e in una relazione di controllo, non
impone, ma pone piuttosto il suo interlocutore in una prospettiva che gli consenta di
desiderare, di esprimere interessi particolari.
Si potrebbe obiettare che consentire il desiderio non vuol dire affatto liberarsi dal
rischio che questo desiderio venga in gran parte inculcato - siamo liberi di desiderare
ma il modo in cui desideriamo è un modo appreso – per cui in ultima analisi la
repressione agirebbe sulle alternative rispetto a un modo imposto dall’alto, la libertà
sarebbe del tutto apparente. Come sosteneva anche Luhmann, «attraverso la cultura e
le condizioni sociali l’esercizio della libertà viene fortemente asimmetrizzato, nel
senso che all’individuo restano ormai soltanto decisioni irrilevanti; o proteste, che
non cambiano niente.»184
Ma lo stesso Luhmann, nell’ottica di superare le categorie del passato –
oppressione, sfruttamento e così via – propone di leggere le dinamiche della società
moderna attraverso i meccanismi di inclusione ed esclusione, dal momento che ci
troviamo in un sistema «senza centro, un sistema con un più elevato autorientamento,
ma senza orientamento centrale; un sistema che non è più comprensibile con le
vecchie teorie della tradizione politica orientate al dominio e che, soprattutto, non
può essere più sufficientemente criticato tramite esse»185.
A proposito del concetto di inclusione:
Il concetto di inclusione sta a significare l’inglobamento dell’intera popolazione nelle prestazioni dei singoli sistemi funzionali della società. Esso si riferisce da una parte all’accesso a tali prestazioni, dall’altra alla dipendenza degli stili di vita individuali da queste. Nella misura in cui l’inclusione si attua, spariscono quei gruppi di popolazione che non prendono parte affatto, o solo marginalmente, alla vita della società. […] L’uomo, come individuo, vive al di fuori del sistema di funzioni, però ogni singolo deve mantenere l’accesso a tutti i sistemi funzionali, se, e nella misura in cui, la sua vita esige il ricorso a funzioni sociali. Dal punto di vista del sistema sociale questa pretesa viene formulata col principio di inclusione.186
Abbandonare del tutto i concetti di oppressione e repressione in un mondo
fortemente interconnesso, dove necessariamente convivono dinamiche differenti,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!184 N. Luhmann, “Oltre le barbarie”, Sociologia e politiche sociali, n.3, 1999, p. 126 185 N. Luhmann, Teoria politica nello stato del benessere, op. cit., p. 77 186 Ivi, pp. 59-60
! 77!
forse non è del tutto corretto, ma in ambito economico l’inclusione si presenta
sicuramente come la chiave di lettura privilegiata, soprattutto per quanto riguarda il
rapporto tra potere finanziario e società.
Non a caso, un acceso dibattito negli ultimi anni ha riguardato proprio l’ipotesi di
riconoscere il diritto di accesso al credito come un diritto umano (idea promossa
inizialmente dall’ideatore del microcredito Yunus187), segno che se da un lato
riconferma il fatto che il credito è ricchezza (il successo del microcredito in
Bangladesh è esemplare), e che si riconosce un problema diffuso di inclusione;
dall’altro sembra già contenere in sé l’estrema problematicità di individuare un limite
tra l’economico e il politico.
Da un punto di vista formale, l’accesso al credito e dunque al sistema bancario, al
di là dei profili di potere che abbiamo individuato nel corso della trattazione,
dovrebbe consistere in uno scambio neutro, un servizio tecnico. Nell’ottica
dell’inclusione invece - tenendo a mente che l’inclusione riguarda la necessità di
accedere a una funzione in accordo al proprio stile di vita – l’accesso al credito
risulta politicamente fondamentale per chi si trova a vivere in una società altamente
differenziata e dove gli scambi sono basati sul denaro (come la nostra).
Inoltre da un punto di vista critico è evidente che la richiesta di un credito sempre
più diffuso e accessibile (non solo per le fasce di popolazione al momento escluse
dall’accesso ai servizi finanziari), risulterebbe in un ampliamento conseguente del
controllo che il credito riesce a configurare attraverso gli strumenti che descrive
Lazzarato e di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente.
Non bisogna però ingannarsi sul fatto che il controllo sia unilaterale. Lo scenario
è sempre corale, così come le banche controllano il flusso di denaro e l’accesso al
credito (con le conseguenze che abbiamo analizzato), così anche la società è in grado
di esercitare la sua influenza sul potere bancario. Il problema semmai è un altro,
possiamo anzi parlare di due problemi relativi al controllo da parte della società
civile.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!187 Cfr. M. Yunus, Credit for Self Employment: Fundamental Human Right, World Food DaySatellite Teleconference, 1986. Sono state elaborate varie risposte alla proposta di Yunus, in particolare per rilevanza Cfr. J. Gershman, J. Morduch, “Credit is not a right”, Financial Access Initiative (financialaccess.org), aprile 2011
! 78!
Il primo è che questa influenza non si misura mai in un ambito prettamente
politico:
Qui l’intuizione cruciale di Marx è attuale ancora oggi: la questione della libertà non dovrebbe essere riferita solo alla sfera politica, cioè a cose come le libere elezioni, l’indipendenza della magistratura, la libertà di stampa o il rispetto dei diritti umani. La vera libertà risiede nella rete “apolitica” dei rapporti sociali, dal mercato alla famiglia, dove la trasformazione necessaria per promuovere dei miglioramenti non è la riforma politica, ma un cambiamento nei rapporti sociali di produzione. Noi non votiamo su chi possiede cosa o sul rapporto tra i lavoratori in fabbrica. Queste cose sono lasciate a processi che esulano dalla sfera del politico, ed è un’illusione che si possa cambiarle “estendendo” la democrazia: creando, per esempio, banche “democratiche” controllate dal popolo.188
Il secondo è che, come i dati dimostrano, è l’ormai noto 1 percento (percentuale
valida per gli Stati Uniti, ma che raggiunge vertici ancora più ridotti in altri paesi del
mondo) a detenere la gran parte della ricchezza. Esiste dunque un’identità, personale
o di spirito, tra la società civile estremamente benestante e il sistema finanziario, tale
da determinare un diffuso senso di risentimento nel resto della popolazione, che vede
infrangersi le promesse liberiste di fronte all’impossibilità di ascendere socialmente
tramite la ricchezza.
Il caso americano lo dimostra chiaramente:
The Supreme Court, in its recent Citizens United case, has enshrined the right of corporations to buy government, by removing limitations on campaign spending. The personal and the political are today in perfect alignment. Virtually all U.S. senators, and most of the representatives in the House, are members of the top 1 percent when they arrive, are kept in office by money from the top 1 percent, and know that if they serve the top 1 percent well they will be rewarded by the top 1 percent when they leave office. By and large, the key executive-branch policymakers on trade and economic policy also come from the top 1 percent.189
Così in ultima analisi la sfida più grande, quella di riflettere sul sistema bancario alla
luce della crisi, se da un lato non si presta al discorso politico, dall’altra, per forza di
cose, lo definisce.
Abbiamo parlato di oppressione e repressione, affermando la necessità di superare
queste categorie in favore di una visione inclusiva à la Luhmann della società. Non
abbiamo però fatto riferimento a un altro termine che forse ancora di più ricorre nel
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!188 S. Žižek, “Slavoj Žižek: Occupy Wall street e l’illusione della democrazia”, Internazionale, 4 novembre 2011 189 J. E. Stiglitz, “Of the 1%, by the 1%, for the 1%”, VanityFair.com, maggio 2011
! 79!
dibattito pubblico e nelle dichiarazioni inerenti alla crisi, cioè quello di
‘sfruttamento’.
Amartya Sen, nella monografia dedicata all’analisi della diseguaglianza, mette
fortemente in discussione l’utilizzo della teoria dello sfruttamento per come ce la
consegna il pensiero marxista: «la teoria dello sfruttamento richiede di identificare
chi sta «producendo» che cosa. Lo sfruttamento è inteso come il godimento da parte
di una persona del frutto del lavoro di altri.»190
Come abbiamo avuto modo di affermare nei capitoli precedenti, il potere
finanziario viene considerato predatorio in quanto si fa mediatore di ogni mediazione
sociale e di mercato. Non si può però prescindere dalla considerazione che anche
quello che si svolge all’interno degli uffici di Wall Street, o di qualsiasi banca grande
o piccola che sia, è ugualmente un lavoro che concorre alla produzione e che può
essere iscritto nell’insieme del ‘lavoro sociale’.
Individuare chi sta producendo cosa in un sistema integrato di produzione non è un compito facile, e questa difficoltà è stata riscontrata anche in tentativi più moderni – sulla base dell’analisi economica neoclassica – di attribuire a ciascun fattore della produzione una quota definita del prodotto. […] Identificare chi ha prodotto una certa cosa è, in effetti, un’operazione del tutto arbitraria in un sistema integrato di produzione. La produzione è un processo interdipendente che implica l’uso congiunto di molte risorse, e non vi è in generale alcun modo evidente di decidere quale risorsa abbia prodotto quella data cosa. Il concetto di «prodotto marginale» di una risorsa non ha in effetti niente a che vedere con chi ha «concretamente» «prodotto» qualcosa; serve in realtà a guidare l’allocazione delle risorse esaminando cosa accadrebbe se si usasse una unità in più di una risorsa […]. Il voler leggere in questo esercizio controfattuale […] una identificazione di chi ha «di fatto» prodotto una data cosa nel prodotto totale significherebbe portare l’analisi marginalista ben oltre i suoi intenti e la sua portata.191
Inoltre, prendendo in esame il costo psichico che spesso si accompagna
all’inclusione nei sistemi funzionali della società, ci troviamo di fronte a un
paradosso simile a quello che avevamo riscontrato nell’estendere il concetto di
‘plebe’ ai vertici della finanza mondiale.
Il costo psichico rappresenta, nell’insieme dei costi sociali, i costi dovuti allo
stress aggiuntivo o alla perdita nella qualità della vita. Una conseguenza
dell’eccessivo costo psichico è dunque la deprivazione, cioè la perdita di qualità che
si ritengono fondamentali per una vita umana.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!190 A. Sen, La diseguaglianza, Il Mulino, Bologna, 2010 (1992), p. 167!191 Ivi, pp. 167-168
! 80!
In questo senso, la deprivazione attraversa tutto il tessuto sociale, riguarda tutti
anche se in misure differenti.
Se osserviamo le grandi masse di affamati, deprivati di tutto ciò che è necessario per condurre una vita umana decente, senza accesso alcuno ai sistemi di funzione, o se consideriamo tutti i corpi umani che lottano per sopravvivere fino al giorno dopo, né “sfruttamento” né “soppressione” […] sono descrizioni adeguate. Usiamo questi termini […] ma non c’è nulla da sfruttare nelle favelas, né esistono, ai livelli più alti della società, attori o gruppi dominanti che usano il proprio potere per sopprimere queste persone.192
E soprattutto la deprivazione non interessa esclusivamente le classi povere a livello
di reddito. Lo stesso Sen sottolinea l’importanza di utilizzare strumenti in grado di
registrare il grado di deprivazione di una persona al di là dell’utilità individuale, cioè
al di là della «metrica dell’appagamento del desiderio.»193
Ovviamente la deprivazione a cui l’autore fa riferimento è una deprivazione
radicata, riguarda bisogni fondamentali come quello di «nutrirsi adeguatamente,
vestirsi decentemente, educarsi soddisfacentemente e ripararsi confortevolmente»194,
ma nel caso di situazioni di povertà relativa, come può essere all’interno dei paesi
economicamente avvantaggiati, è necessario far riferimento a diversi fattori che
altrove non verrebbero considerati fondamentali, come quelli dell’’indice di
deprivazione’195 elaborato da Eurostat, che ad esempio considera tra gli indicatori la
possibilità o meno di acquistare una lavatrice, una macchina e così via, e da cui
prende forma di conseguenza una deprivazione relativa.
Ora, è facile constatare come in alcuni casi la deprivazione relativa e l’esclusione
tendano ad indicare lo stesso fenomeno sociale, ma renderle equivalenti non sarebbe
corretto. La deprivazione infatti non agisce solo a livello materiale, non riguarda cioè
esclusivamente le possibilità economiche del soggetto, ma anche e soprattutto la sua
sfera psicologica.
Lo star bene di una persona può essere visto in termini di qualità […] dell’essere di quella persona. Si può pensare che la vita consista di un insieme di «funzionamenti», composti da stati di essere e fare. Le acquisizione di una persona sotto questo profilo possono essere viste come il vettore dei suoi funzionamenti. I funzionamenti rilevanti possono variare da cose elementari come essere adeguatamente nutriti, essere in buona salute, sfuggire alla
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!192 N. Luhmann, “Globalizzazione o società-mondo: come pensare la società moderna”, Contratto, VI, 1998, pp. 123-124 193 A. Sen, La diseguaglianza, op. cit., p. 83 194 Ibidem 195 Indicatore sintetico di deprivazione, Istat.it, 2013
! 81!
morbilità prevedibile e alla morte prematura, ecc., ad acquisizioni più complesse come essere felice, avere rispetto di sé, prendere parte alla vita della comunità, e così via.196
Assieme al meccanismo di inclusione e esclusione, la deprivazione diventa dunque
centrale nell’analisi delle dinamiche che intercorrono tra potere finanziario e società.
Non solo come effetto primario di un debito non ripagato (distruzione della proprietà
privata, privazione dei mezzi di sussistenza ecc.), ma anche come conseguenza dello
stile di vita che si impone a chi deve e vuole prendere parte alla competizione del
mercato.
Una serie di articoli197 degli ultimi anni mettono in luce proprio l’estensione del
fenomeno della deprivazione ai lavoratori del settore finanziario. Circostanze che
certamente meriterebbero un’analisi adeguata, tra cui un brusco ricambio
generazionale, la crisi del 2008 e un ambiente ipercompetitivo, hanno permesso
anche all’opinione pubblica di rilevare come le conseguenze del governo economico
delle vite non abbia ripercussioni solamente sulle fasce escluse o meno abbienti della
popolazione ma in misura sempre crescente anche negli ambienti dove il potere
finanziario viene esercitato ai più alti livelli.
Nel ritratto che emerge dagli studi e dalle cronache riguardanti sia gli addetti alla
finanza, sia l’1 percento in generale (categorie che ovviamente non sempre
corrispondono l’una all’altra), si legge una dinamica ascrivibile non tanto al potere di
una parte o di un’altra, quanto a un funzionamento sistemico. Come nell’analisi che
conduce Bauman sulla globalizzazione, non ci troviamo di fronte a sovrani e sudditi, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!196 A. Sen, La diseguaglianza, op. cit., p. 63!197 Tra gli altri Cfr. J. Luyendijk, “Ex-City boy: ‘It’s easier to get people to talk about drugs than insider trading”, TheGuardian.com, 6 luglio 2012 dove l’intervistato afferma nelle ultime battute: «The City is a bit like flying on an aeroplane. You fasten your seatbelt, take off and at first everything seems great, you are flying. Someone hands you a lovely warm towel. You take it out of the sachet, rub it on your hands and it feels warm and moist. Then all of a sudden it gets cold and you want to throw it away immediately as it's horrible. But now you can't get off the flight unless you press the ejector seat button. I guess I mean very few have a happy and smooth landing at the end.» Luyendijk cura il Banking Blog per il sito del Guardian, dove sono raccolte molte altre esperienze di lavoratori del settore finanziario, spesso di carattere negativo (abuso di droga, lavoro sfinente, ambiente ipercompetitivo); Per il caso londinese Cfr. E. Franceschini, “Lo stress fa strage di banchieri: ritmi eccessivi anche per i ‘lupi’”, Repubblica.it, 29 gennaio 2014. In realtà il dato interessante è che, mentre la narrazione giornalistica e cinematografica mostra quotidianamente questa realtà (basti pensare a The Wolf of Wall Street, 2014, o a molte altre storie ad esempio Cfr. C. Hojnicki, “Cracked tales of cocaine on Wall Street”, BusinessInsider.com, 13 luglio 2012), non esistono studi che analizzino l’abuso di droga, la deprivazione da sonno e l’impatto sulla qualità della vita in relazione a questa tipologia di lavori. Soprattutto considerando che tra le ipotesi avanzate per spiegare il moral hazard delle istituzioni finanziarie negli anni precedenti al 2008, c’è proprio l’abuso di cocaina, Cfr. G. Anderson, “Did cocaine use by bankers cause the global financial crisis?”, TheGuardian.com, 15 aprile 2013
! 82!
ma a ‘turisti’ e ‘vagabondi’, dove è lo scenario – il mondo globalizzato – a scandire
il ritmo della sopravvivenza:
La vita dei turisti non è un letto di rose, e le rose che vi si possono incontrare crescono su steli sgradevolmente spinosi. Bisogna sopportare molte privazioni per godere della libertà del turista: l’impossibilità di rallentare, l’incertezza che caratterizza qualsiasi scelta, i rischi connessi a qualsiasi decisione […]. La vita del turista è resa sopportabile, le sue difficoltà si trasformano in irritazioni marginali, la tentazione di cambiare vita può venire messa su uno scaffale tra i più lontani, proprio per il fatto stesso di vedere il vagabondo che fa tremare.198
«Vincere è sopravvivere»199 scriveva Elias Canetti, e la vittoria è sempre ottenuta a
spese delle persone a cui sopravviviamo. Per cui anche se si potrebbe a ragione
obbiettare che i supervincenti del capitalismo vivano al di là della categoria dei
‘turisti’, ciò che li differenzia rispetto a loro è forse un grado più piacevole di
sopravvivenza, ma sarebbe sbagliato considerare l’1 percento come un élite situata
sopra e soprattutto al di fuori del sistema.
Come abbiamo affermato in apertura della trattazione, il potere finanziario vive di
una necessaria alleanza con le leggi e con il governo. Esso non esce – ancora – dal
perimetro definito da un più ampio sistema governamentale, anche se di quel sistema
costituisce la chiave di volta.
Questo passaggio, che sembra soffrire di una certa mancanza di riscontro
empirico, in realtà è pienamente confermato dal dibattito che ha visto coinvolto in
questi anni il ministro della giustizia statunitense Eric Holder, reo di aver considerato
le banche too big to jail, come riporta anche un recente editoriale del Financial
Times: «Legislatori e magistrati non sono intervenuti per timore che un’azione legale
potesse far crollare queste istituzioni fondamentali per il sistema»200.
Allo stesso modo Žižek, quando parla al pubblico dell’occupazione di Zuccotti
Park il 9 ottobre 2011, non fa della crisi del 2008 un problema etico, un errore
umano, ma ne parla come dell’autodistruzione di un sistema: «Ricordate: il problema
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!198 Z. Bauman, Dentro la globalizzazione: le conseguenze sulle persone, Laterza, Bari, 2007 (1998), pp. 108-109 199 E. Canetti, La provincia dell’uomo, Adelphi, Milano, 1978, pp. 188-189. A questo proposito Cfr. R. Esposito, Categorie dell’impolitico, Il Mulino, Bologna, 1999 (1988). Anche riguardo Hobbes, Esposito afferma «Si può assicurare la vita – la prima necessità – solo accumulando potere – la prima passione. Ma si può accumulare potere solo a spese degli altri: a costo della loro vita. Vivendo al loro posto – della loro morte.» in R. Esposito, Communitas: origine e destino della comunità, Einaudi, Torino, 1998, p. 12 200 “Le banche e i cittadini”, Internazionale, 14 febbraio 2014, p. 13
! 83!
non è la corruzione o l’avidità. Il problema è il sistema: costringe a essere
corrotti»201.
E’ questo il filo verticale che il Moderno taglia con una decisione esclusiva di qualsiasi rapporto […] con l’altro da sé. Non che esso sia semplice proliferazione di interessi contrapposti; che non aneli continuamente alla forma dell’unità: solo che l’intende come unità funzionale e autoreferenziale. E cioè: come ‘sistema’ capace di autogovernarsi al di fuori di qualsiasi finalità esterna (il Bene) o vincolo interno alla logica dei contenuti (i ‘soggetti’) che lo abitano.202
§3.3 Inter homines
Se parliamo di sistema e non di persone – la violenza è sistemica e agisce a più
livelli su tutta la società – si pone immediatamente il problema di giustificare un
accostamento tra politica ed economia finanziaria.
Il binomio, che ha necessariamente informato tutta la nostra analisi, costituisce in
sé un vero e proprio ossimoro. Già nel secondo capitolo ricordavamo come
l’autonomia dell’ambito economico, diretta conseguenza della separazione tra Stato e
società, fosse una delle caratteristiche principali del nostro tempo. A questo si
aggiunge, negli ultimi anni, una altrettanto forte socializzazione del mercato per cui
«il problema di garantire una cornice sociale alle attività del mercato cede il passo
all’esigenza di riconfigurare il sociale in una pluralità di mercati»203
Certo, esiste ancora il politico, ma il continuo sforzo di ottenere un primato sulle
altre funzioni della società non avrebbe fatto che indebolirlo e porlo sotto costante
minaccia, «non si può centrare sulla politica una società funzionalmente differenziata
senza distruggerla»204 scriveva Luhmann di fronte alle crescenti sfide dello stato del
benessere, ma questa tendenza entropica – come la definisce Esposito – del politico
nei confronti della società, il fenomeno di neutralizzazione a cui assistiamo a favore
di un dominio della Tecnica (il «processo senza soggetto» 205 ), cela ma non
annichilisce il politico:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!201 S. Žižek, “Non innamoratevi di voi stessi”, in A.V., Occupy: Teoria e pratica del movimento contro l’oligarchia finanziaria, Il Saggiatore, Milano, 2012 (2011), p. 92 202 R. Esposito, Categorie dell’impolitico, op. cit., p. 9 203 R. Ciccarelli, “Riformulare la libertà politica nell’analisi della governamentalità”, European Journal of legal studies, vol. 1, n. 3, 2008, p. 12 204 N. Luhmann, Teoria politica nello stato del benessere, op. cit., p. 56 205 R. Esposito, Categorie dell’impolitico, op. cit., p. 21
! 84!
E tuttavia è proprio la particolare configurazione dell’autonomia dell’economico […] a restituire il carattere contraddittorio, e cioè iperpolitico, di tale spoliticizzazione. Il paradosso che ne discende può essere enunciato in tale modo: la spoliticizzazione è la forma politica entro cui si determina l’autonomia dell’economico. Questa non si sviluppa naturalmente, ma ha bisogno di una forza (politica) capace di istituire e conservare le condizioni generali entro cui funzionare. Non solo, ma di una determinata autocoscienza di quel funzionamento.206
Con la consapevolezza che il tema apre ben altri scenari rispetto al solo potere
finanziario, cerchiamo comunque di rendere conto di questo aspetto controverso del
sistema attuale.
Tra le tante possibilità che si offrono di definire il politico, abbiamo scelto di
partire dalla più classica definizione di Carl Schmitt che ci consente di rivelare
l’esistenza del politico, così come avevamo fatto con il potere, a prescindere dalle
istituzioni o dalle figure che in un dato momento storico se ne fanno portavoce.
Schmitt individua nella dicotomia amico/nemico e nella possibilità della guerra il
presupposto del politico.
I concetti di amico, nemico e lotta si riferiscono in modo specifico alla possibilità reale dell’uccisione fisica. […] essa [la guerra ndr] deve però esistere come possibilità reale, perché il concetto di nemico possa mantenere il suo significato. […]La guerra non è dunque scopo o meta o anche solo contenuto della politica, ma ne è il presupposto sempre presente come possibilità reale, che determina in modo particolare il pensiero e l’azione dell’uomo provocando così uno specifico comportamento politico. […] Nulla può sottrarsi a questa conseguenzialità del ‘politico’. Se l’opposizione pacifista alla guerra fosse tanto forte da poter condurre i pacifisti in guerra contro i non pacifisti, in una «guerra contro la guerra», in tal modo si otterrebbe la dimostrazione che tale opposizione ha realmente forza politica poiché è abbastanza forte da raggruppare gli uomini in amici e nemici. Se la volontà di impedire la guerra è tanto forte da non temere più neppure la guerra stessa, allora essa è diventata un motivo politico, essa cioè conferma la guerra, anche se solo come eventualità estrema, e quindi il senso della guerra.207
Se prendiamo in esame l’ambito economico tuttavia ci accorgiamo presto che
applicare i concetti di nemico o amico può risultare scorretto nel momento in cui le
parti in causa non sono altro che concorrenti.
Se poi lo specifichiamo a livello bancario, dobbiamo ammettere che in quanto
mediatore della mediazione, la banca non sembra assumere in sé nessun tipo di
partitismo.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!206 Ivi, p. 13 207 C. Schmitt, Il concetto di «politico», op. cit., pp. 116-120!
! 85!
La difficoltà principale nel rintracciare un dato politico proprio del potere
bancario è data dal fatto che il politico non trova più una sua sede privilegiata nella
governamentalità liberale, sfugge all’individuazione in una data istituzione e a un
posizionamento gerarchico:
La società moderna è un sistema senza portavoce e senza rappresentanza interna. […] Si tratta di un fenomeno strutturalmente condizionato: della condizione della complessità e della di volta in volta funzionalmente specifica capacità di prestazione della moderna società. La teoria politica ha ripetutamente […] tentato di opporsi a questa diagnosi e di concepire lo stato e la politica come centri di controllo della società con responsabilità etica fondamentale per ciò che in essa, e con essa, accade. […] non si può centrare sulla politica una società funzionalmente differenziata senza distruggerla. […] lo sviluppo dello stato del benessere tende ad una sempre maggiore inclusione di temi ed interessi in quanto politicizzabili. Essa tiene conto perciò anche della crescente insicurezza e della dinamica del passaggio da una differenziazione bidimensionale ad una tridimensionale. Ciò porta ad uno spostamento della comunicazione orientata al potere: da una struttura simmetrica (gerarchica) ad una circolare. 208
Comunque è lo stesso Schmitt - consapevole delle neutralizzazioni che già allora
attraversavano il tessuto sociale e impegnato nel fornire una definizione classica, che
sopravvivesse alle evoluzioni storiche - che ribadisce più volte che ciò che importa è
sempre solo il caso di conflitto:
Se le controforze economiche, culturali o religiose sono così forti da determinare da sé sole la decisione sul caso critico, ciò significa che esse sono divenute la nuova sostanza dell’unità politica. […] L’unità politica è, per sua essenza, l’unità decisiva, senza che importi da quali forze essa trae i suoi ultimi motivi psichici. Essa esiste oppure no. Se esiste, è l’unità suprema, cioè quella che decide nel caso decisivo.209
E’ necessario inoltre ribadire che quando l’autore si riferisce alla guerra, ciò di cui
sta parlando è l’eventualità reale dell’uccisione fisica. Questo pone una serie di
questioni sull’utilità di applicare il concetto schmittiano di politico al campo
economico.
La prima è che il potere finanziario - almeno nel nostro caso delle democrazie
occidentali - non decide in caso di guerra; ciò che può fare e che ha sempre fatto nel
corso della storia210 è stato piuttosto attivare delle risorse, esercitare la sua influenza,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!208 N. Luhmann, Teoria politica nello stato del benessere, op. cit., p.56, 79 209 C. Schmitt, Le categorie del «politico», op. cit., pp. 122-126 210 In D. Graeber, op. cit., p. 20 tuttavia si fa presente come «La differenza tra un “debito” e un semplice obbligo morale non va ricercata nella presenza o nell’assenza di uomini armati che possono far valere quell’impegno […]. La differenza sta nel fatto che il creditore ha i mezzi per stabilire in maniera esatta, numericamente, quanto gli deve il debitore. […] A ogni modo, guardando le cose più da vicino si scopre che i due elementi, la violenza e la quantificazione, sono intimamente collegati».
! 86!
ma la guerra è stata ed è tutt’ora uno strumento nelle mani degli Stati. Allora il passo
successivo non sarà tanto quello di osservare la guerra o l’eventualità di una guerra,
quanto quello di porci in un’ottica per cui la politica non è che una guerra
continuata con altri mezzi.
Del resto lo stesso Foucault, che dedica alla guerra un intero ciclo di seminari,
sottolinea in chiusura degli stessi la necessità di ritrovare la guerra nelle maglie della
società:
Dietro gli oblii, le illusioni o le menzogne, che ci fanno credere a necessità di natura o alle esigenze funzionali dell’ordine, occorre ritrovare la guerra; la guerra è la cifra della pace. Essa lacera in permanenza l’intero corpo sociale; pone ciascuno di noi in un campo o nell’altro. E tuttavia, non basta ritrovare la guerra come un principio di spiegazione; occorre riattivarla, farle abbandonare le forme latenti e sorde attraverso cui essa permane.211
Se infatti teniamo in considerazione l’esclusione come destino di chi non può
permettersi l’accesso alle funzioni della società e la dipendenza dal debito per la
maggior parte degli altri, non possiamo rinunciare facilmente all’idea che il politico
oggi più che mai risieda anche nel potere finanziario; e che la guerra, in quanto
momento che definisce una dualità del mondo – sia pure di un mondo interamente
soggettivo, o puramente contingente – si ripresenti oggi nella dinamica che
contrappone gli inclusi e gli esclusi all’interno del sistema economico.
La seconda questione riguarda l’’unità politica’, la stessa che nella teoria elitista
viene chiamata la ‘classe politica’. La teoria elitista ci viene incontro nell’analisi che
stiamo conducendo perché fornisce alcune chiavi di lettura che ci permettono di
orientarci in una società «senza portavoce e senza rappresentanza interna»212, dove lo
Stato non è più un centro privilegiato di controllo.
«La forza di qualsiasi minoranza è irresistibile di fronte ad ogni individuo della
maggioranza, il quale si trova solo davanti alla totalità della minoranza organizzata; e !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Più avanti inoltre afferma: «Quasi tutte le bolle del XVIII secolo nacquero da qualche schema fantasmagorico per usare i guadagni delle imprese coloniali ai fini di finanziare le guerre in Europa. La moneta cartacea è una moneta di debito, e la moneta di debito è moneta di guerra. E’ sempre stato così.» p. 501. La nostra situazione attuale non rientra però in questo scenario. Siamo piuttosto passati da un ‘debito di guerra’, a una ‘guerra del debito’. Cfr. S. Carrere, “L’agenzia cinese Dagong declassa gli Usa al livello della Russia: singola a. Mercati asiatici in calo di oltre il 2%”, Ilsole24ore.com, 3 agosto 2011; M. Sgroi, “Vivere con un debito di guerra in tempo di guerra”, Formiche.net, 20 settembre 2013; R. Sommella, “Il caso Datagate e la guerra del debito europeo”, Europaquotidiano.it, 1 novembre 2013!211 M. Foucault, “Bisogna difendere la società”, op. cit., p. 231 212 N. Luhmann, Teoria politica nello stato del benessere, op. cit., p.56
! 87!
nello stesso tempo si può dire che questa è organizzata appunto perché è
minoranza.»213
In questa definizione di Gaetano Mosca del 1966 è facile ritrovare gli slogan delle
proteste che hanno interessato la maggior parte dei paesi capitalisti dopo la crisi.
Se confrontiamo la lettura di Mosca con gli eventi degli ultimi anni notiamo però
una differenza fondamentale. Il rapporto tra la classe politica e la società non viene
interpretato in un’ottica di governanti e governati. Ad esempio il rapporto percepito
tra l’1 percento e il 99 percento appartiene interamente alla linea di demarcazione tra
inclusi e esclusi, come nota anche Marco Roth nell’analisi di uno dei documenti
principali di Occupy Wall Street, il blog titolato per l’appunto “We are the 99
percent”214:
Che si tratti di una somiglianza stilistica voluta o meno, questa identificazione di Occupy con homeless e accattoni è uno degli aspetti più sconvolgenti e inquietanti delle proteste in corso. Proprio come i primi comunisti vedevano nel proletariato il serbatoio di una potenziale coscienza rivoluzionaria, Ows eleva i senzatetto a figure privilegiate dell’America postcapitalista. Tale elevazione, per cui chiunque si trovi escluso dall’1 percento di supercapitalisti è automaticamente assimilato ai senzatetto, avviene a più livelli, non solo nei cartelli.215
La questione politica allora, per come la delinea Schmitt, è ancora presente nella sua
estrema possibilità di creare raggruppamenti, ma è carente nel ‘caso decisivo’, cioè
quello della guerra.
Si potrebbe inoltre obiettare che una società inclusiva, ben lungi dallo stabilire un
campo del ‘politico’, ricade anzi in quelle neutralizzazioni elencate dallo stesso
Schmitt, in particolare in queste due accezioni di ‘neutralità’216 che riportiamo per
esteso:
2- Neutralità nel senso di concezioni strumentali dello Stato, per le quali lo Stato è un mezzo tecnico che deve funzionare in modo concretamente prevedibile e deve offrire a tutti le medesime possibilità di utilizzazione. 4 - Neutralità nel senso di parità, cioè di identica ammissione di tutti i gruppi e di tutte le tendenze esistenti, alle medesime condizioni e con la medesima considerazione quanto al godimento dei vantaggi o delle altre prestazioni statali.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!213 G. Mosca, La classe politica, Laterza, Bari, 1994 (1966), p. 53 214 wearethe99percent.tumblr.com 215 M. Roth, “Lettere di dimissioni dal sogno americano”, in A.V., Occupy: Teoria e pratica del movimento contro l’oligarchia finanziaria, op. cit., p. 45 216 C. Schmitt, “Rassegna dei diversi significati e funzioni del concetto di neutralità politica interna dello Stato”, (1931), in C. Schmitt, op. cit., pp. 187-189!
! 88!
Anche se prendendo in esame i documenti prodotti dal movimento è chiaro che pur
muovendoci in uno scenario di inclusione/esclusione, ciò a cui il 99 percento aspira
non è la riammissione nella società. Non ci troviamo di fronte a quella che avevamo
definito come ‘plebe hegeliana’, la protesta al contrario definisce un chiaro momento
di riconoscimento:
«Siamo il 99 percento» vuole sottolineare il divario fra la ricchezza dell’1 percento in cima alla piramide e il resto del mondo, mettendo in luce il significato politico di una statistica che fa emergere una disuguaglianza fondamentale: «noi» non faremo mai parte dell’1 percento. Lo slogan definisce così una collettività, che non si esprime in una identità sostanziale, di razza, etnia, religione o nazionalità, ma che si costituisce come il «noi» di una popolazione divisa in sfruttati e sfruttatori. Nel momento in cui si decide di occupare Wall Street, quel «noi» diventa una classe, una delle due classi contrapposte, ostili l’una all’altra: quella che possiede e detiene il controllo sulla ricchezza e quella che non fa nessuna di queste due cose.217
L’uso del termine ‘sfruttamento’ è già stato discusso. Ciò che maggiormente rileva in
questo passaggio è che il nemico che si profila nello scontro economico non è un
agente esterno, è un nemico interno alla società stessa di cui gli esclusi sanno di non
poter far parte. La figura del nemico interno218 risulta così completamente rovesciata
rispetto all’interpretazione tradizionale, cioè quella di criminale, estraneo, pericoloso
rispetto all’asse portante della società. Il nemico non è infatti al di fuori della società,
ma ne rappresenta il momento più alto, il vertice che ne garantisce il funzionamento.
Da questo punto di vista forse risulta erroneo interpretare i conflitti tra società e
economia unicamente in un’ottica di divisione in classi - richiamata dal passo
precedente - con il rischio di mancare il bersaglio dell’analisi.
Certo è che per quanto riguarda le attuali dinamiche del capitalismo finanziario e
del potere bancario non possiamo nemmeno pretendere di definire un’unica risposta
al problema né fornire una chiave di lettura univoca. Gli eventi di cui parliamo, i
fenomeni che analizziamo, sono ancora in pieno svolgimento. Tentare di
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!217 J. Dean, “Rivendica la divisione, denuncia il torto”, in A.V., Occupy: Teoria e pratica del movimento contro l’oligarchia finanziaria, op. cit., p. 113 218 P. Costa, La modernità penale fra secolarizzazione e permanenza nel ‘sacro’, Horizontes y Convergencias, 26 ottobre 2009, p. 7. A conferma di questa interpretazione Cfr. M. Moore, Capitalism: a love story, 2009 dove nelle scene dedicate alla deregulation promossa da Paulson, compare il discorso di una deputata che ricorda il giuramento di proteggere gli Stati Uniti da ogni nemico interno o esterno.
! 89!
cristallizzarli per fornirne una spiegazione esaustiva o un modello predittivo non
sarebbe né utile né corretto.
Tuttavia possediamo alcune certezze. Una in particolare, a cui accennavamo in
apertura del capitolo, è la chiave per ritrovare il politico nel governo tecnico del
potere finanziario: il potere di emettere moneta.
Come ricorda Roberto Ciccarelli a proposito della crisi in Europa «se una Banca
centrale nazionale ha potuto esercitare poteri politici supplementari in una fase di
grave crisi delle forze rappresentative del popolo sovrano è perché nei poteri di
emissione e di garanzia del credito di ultima istanza risiede il nucleo del potere
sovrano moderno.»219
Quando abbiamo definito il potere bancario abbiamo escluso che l’emissione di
moneta fosse una sua prerogativa fondamentale, che non rientrasse cioè nelle sue
caratteristiche principali. Da un punto di vista storico è un fatto comprovato: sebbene
il potere bancario avesse la facoltà di stabilire con l’uso un equivalente del debito, è
stato sempre e comunque il sovrano a fungere da emittente e garante di ultima
istanza:
Il sovrano politico crea l’ordine interrompendo il bellum omnium contra omnes, istituisce perciò stesso i beni-valori e la proprietà, infine garantisce gli scambi in ultima istanza perché nomina un valore simbolico (la moneta), che rende affidabili tutti gli altri scambi proprio perché legal-statale. In assenza di tale potere, il sistema economico collasserebbe. Se la definizione romana della volontà sovrana è: quod principi placuit legis habet vigorem, allora la parola del sovrano ha un valore tautologico. […] Da questa tauto-logica dell’autorità-competenza dipende il cuore del potere di emissione della moneta. In fondo, questa è un titolo di pagamento garantito universalmente e senza termine. E, dunque, al limite logico-giuridico, essa presuppone una sorta di auto-validazione da parte di un soggetto che trascende la circolazione, anche se, ovviamente, garantisce questi titoli di pagamento con riserve proprie.220
Se pure, almeno nel caso europeo, il potere sovrano non conosce più questa
prerogativa, ciò non vuol dire che il potere bancario abbia assunto in sé in caratteri
della sovranità. Al contrario, proprio questo trasferimento di poteri specificamente
sovrani in assenza del contenuto politico della sovranità ha condotto all’attuale
cortocircuito.
Ancora una volta la crisi americana e quella europea per quanto lontane appaiono !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!219 R. Ciccarelli, art. cit., p. 13 220 Ivi, p. 8!
! 90!
profondamente collegate, facendo scaturire da contesti diversi la medesima
domanda. Qual è infatti il nome di questo pericolo che incombe sui soggetti, che non
è la morte (come nella guerra, e dunque non ravvisabile nel ‘politico’ schmittiano),
non è il barbaro (il nemico), né tantomeno il sovrano?
Nelle prime scene del documentario In debt we trust, assistiamo a un curioso
rituale in cui una comunità di fedeli, nell’euforia generale, taglia a metà le carte di
credito e raccoglie fondi comuni per liberarsi dal debito monetario che li vincola al
sistema finanziario. Il gesto, per modi e contenuto, ben lontano dall’essere moderno,
riconduce lo spettatore a quell’arcaico terrore del debito di cui abbiamo già
lungamente parlato. Il debito che vincola le persone e che costituisce l’essenza stessa
della comunità.
Quando lo Stato cede il passo al potere finanziario e alle istanze dell’economia,
lasciando al mercato l’arduo compito di stabilire il destino dei debiti, come prima
conseguenza viene meno al suo compito hobbesiano di garantire un confine certo tra
gli individui.
Gli individui moderni divengono davvero tali – e cioè perfettamente in-dividui, individui ‘assoluti’, circondati da un confine che a un tempo li isola e li protegge – solo se preventivamente liberati dal ‘debito’ che li vincola l’un l’altro. Se esentati, esonerati, dispensati da quel contatto che minaccia la loro identità esponendoli al possibile conflitto con il loro vicino. Al contagio della relazione.221
La seconda conseguenza, non meno importante, è la distruzione della proprietà
privata. Come ricorda Esposito «ciò che ciascuno teme, nel munus ‘ospitale’ e
insieme ‘ostile’ […] è la perdita violenta dei confini che, conferendogli identità, gli
assicurano la sussistenza»222.
La comunità descritta da Esposito risulta ben diversa dalla comunità idealizzata di
cui abbiamo parlato in precedenza, tuttavia attraverso l’originale analisi dell’autore si
possono scorgere elementi non estranei alla situazione che si è venuta a creare in
molti paesi colpiti dalla crisi. Ad esempio, facendo riferimento a Kant, l’autore
osserva che la comunità è « un dono che non appartiene al soggetto; che anzi lo
riduce e lo scava attraverso un dovere inesauribile il quale prescrive ciò che interdice
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!221 R. Esposito, Communitas: origine e destino della comunità, op. cit., p. XXIV 222 Ivi, p. XVIII
! 91!
e interdice ciò che prescrive»223 e ancora «il munus che la communitas condivide non
è una proprietà o un’appartenenza. Non è un avere, ma, al contrario, un debito, un
pegno, un dono-da-dare. […] I soggetti della comunità sono uniti da un ‘dovere’ –
nel senso in cui si dice ‘ti devo qualcosa’ […] – che li rende non interamente padroni
di se stessi.»224
Con i dovuti distinguo – come quello tra il debito di vita e il debito monetario, che
comunque condividono una natura comune che è proprio quel munus, il ‘dono che
obbliga allo scambio’ - possiamo ammettere di trovarci di fronte a un’analisi che
coglie perfettamente il conflitto in atto tra politica e economia.
Laddove la politica, almeno per il suo senso moderno, divide, l’economia abbatte
i confini tra gli individui, confonde proprietà e ricchezza, sfera privata e sfera
pubblica. Su questo punto Arendt si esprime in un lungo passo di Vita Activa, che
riportiamo nei suoi momenti più rilevanti:
Prima dell’età moderna, che cominciò con l’espropriazione dei poveri e procedette poi all’emancipazione delle nuovi classi prive di proprietà, ogni civiltà si era fondata sulla sacralità della proprietà privata. La ricchezza, al contrario sia posseduta privatamente sia distribuita pubblicamente, non era mai stata sacra. Originariamente, proprietà privata significava né più né meno che avere un proprio luogo in una parte particolare del mondo, e perciò appartenere al corpo politico […] Perciò non è del tutto esatto dire che la proprietà privata, prima dell’età moderna, fosse considerata una condizione immediata per l’ammissione alla sfera pubblica; era molto più di questo. La sfera privata era simile all’altra, era il lato oscuro e nascosto della sfera pubblica, e mentre essere politico significava conseguire le più alte possibilità dell’esistenza umana, non avere un proprio posto privato (come uno schiavo) significava non essere più umani. […] L’accumulazione enorme e tuttora in espansione della ricchezza nella società moderna, che iniziò con l’espropriazione […] non ha mai mostrato molta considerazione per la proprietà privata ma l’ha sacrificata ogni qual volta venisse in conflitto con l’accumulazione della ricchezza. Il detto di Proudhon che la proprietà è un furto ha una solida base di verità nelle origini del capitalismo moderno. Più significativo ancora è che anche Proudhon esitasse ad accettare il dubbio rimedio dell’espropriazione generale, perché sapeva benissimo che se l’abolizione della proprietà privata poteva mitigare il male della povertà, era probabilmente solo per aprire la strada al peggior male della tirannia.225
Anche Žižek, che pure tende a utilizzare proprietà privata e ricchezza come sinonimi,
sottolinea che nel capitalismo attuale «la svolta fondamentale riguarda lo status della
proprietà privata» e che «il capitalista ideale […] non «possiede realmente»
qualcosa, magari è pure indebitato, e tuttavia ha il pieno controllo della
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!223 Ivi, p. XXX!224 Ivi, p. XVI 225 H. Arendt, Vita activa, op. cit., pp. 46-48
! 92!
situazione»226.
Da questa crescente preponderanza dell’accumulazione individuale della
ricchezza rispetto alla proprietà privata risultano conseguenze per noi tangibili e
verificabili, come la perdita della sfera privata in favore della privacy, o l’istanza
generalizzata della ricchezza sociale che ha via via preso il posto della proprietà
privata.
Il capitalista ideale o il potente finanziere possono occupare un ruolo privilegiato
in questo scenario, essi possono – metaforicamente – mantenersi sulla cresta
dell’onda della ricchezza sociale, per volontà o per contingenze varie (non da ultima,
quella che Arendt chiama oclocrazia227), ma le conseguenze di una simile società,
oltre che essere ormai balzate agli onori della cronaca, riguardano inevitabilmente
tutti.
La perdita di confini certi e della proprietà privata hanno come effetto quello di
rendere gli uomini schiavi, li deprivano innanzitutto di quel nucleo segreto e
insondabile che costituisce la loro umanità. Il debito - che è potere - quando non si
trova in una cornice istituzionale che lo amministri o che lo annulli, quando cioè è
affidato esclusivamente ai meccanismi anonimi e casuali del mercato, svolge i suoi
effetti fino alla catastrofe umanitaria, come dimostra perfettamente la situazione
greca:
In Grecia l’austerity imposta dall’esterno, tradotta in tagli lineari che non hanno tenuto conto dei contemporanei effetti della crisi – perdita del lavoro, sfratti, difficoltà di accesso ai prestiti bancari, rapido esaurimento dei “tesoretti” risparmiati dalle famiglia – sta avendo effetti nefasti sulla salute della popolazione. Fisica e psichica. Basterebbe un dato su tutti: l’aumento esponenziale del tasso di suicidi, arrivato al 40%.228
Inoltre, se c’è un dato già leggibile in questo panorama incerto e mutevole in cui ci
muoviamo, è che nessuno desiderava o pianificava la crisi, tantomeno i titolari del
potere finanziario.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!226 S. Žižek, Meno di niente, op. cit., pp. 309-310!227 «Se la tirannia può esser descritta come il tentativo, sempre destinato a fallire, di sostituire la violenza al potere, l’oclocrazia, il dominio della massa, che ne è l’esatto contraltare, può essere caratterizzato dal tentativo, molto più promettente, di sostituire il potere alla forza. Il potere è certamente in grado di distruggere ogni forza, e noi sappiamo che dove la principale sfera pubblica è la società, c’è sempre il pericolo che, attraverso una forma pervertita di “agire in comune” […] siano portati alla ribalta quelli che non si intendono di nulla e non sanno far nulla» in H. Arendt, Vita Activa, op. cit., p. 150 228 B. Gobbi, M. Perrone, P. Del Bufalo, “Gli effetti della crisi: la Grecia (e gli altri), ci rimettono la salute”, Il Sole24Ore Sanità, n.6/2012!
! 93!
Il ‘capitalismo’, inteso come sistema nel suo complesso, sicuramente ha da tempo
trovato nelle crisi o nei disastri una linfa vitale, laddove nuovi mercati sono sempre
più difficili da individuare, ma – per dirlo come Naomi Klein, che ha teorizzato la
Shock Economy229 in tempi non sospetti – si tratta di approfittare di una tabula rasa,
non di crearla.
Dalle testimonianze scritte (resoconti, blog, libri) del movimento Occupy Wall
Street emerge infatti un ritratto inedito dei lavoratori del settore finanziario. Quando
all’inizio dell’occupazione sono stati creati i punti informativi ai confini di Zuccotti
Park, questo ha permesso ai volontari che se ne occupavano di interagire non solo
con curiosi e turisti, ma, soprattutto nelle ore notturne, con gli impiegati di Wall
Street:
Ma se attirava persone con domande e critiche sull’occupazione, il marciapiede orientale era anche un confessionale dove si consumava il rito dell’assoluzione. Levine ricorda una visita a tarda notte di un investment banker. “[…] Diceva ‘Ho cercato di vendere derivati buoni, ho cercato di vendere derivati buoni, i derivati non sono intrinsecamente cattivi’. E prima di andarsene aveva infilato una ventina di dollari nel cestino delle donazioni. Era molto strano, nelle prime due settimane il punto informativo era diventato un confessionale in piena regola”.230
Il volontario menzionato nel passo, lo studente Daniel Levine, nel primo mese
dell’occupazione lavorava presso l’infopoint a ritmi continuati, fino alle 16 ore al
giorno. Nel libro che raccoglie la sua esperienza ci sono ulteriori riferimenti a queste
peculiari confessioni. Dello stesso impiegato della Citybank addetto alla vendita dei
derivati, Levine riporta le parole esatte: «I knew when this started it was gonna
collapse. I see these guys around me in my office and they’re selling absolute s**t.
[…] And I mean, you had to sell these things, there wasn’t much choice in it.»231
Quando gli abbiamo chiesto ulteriori dettagli riguardo le reazioni del mondo della
finanza alla crisi (perlomeno quelle che la sua posizione nel movimento gli ha
consentito di osservare e registrare), Levine ha risposto come segue:
«My interactions with finance sector people since Occupy has been interesting. I'm a Marxist now and out of curiosity bring it up. It's confirmed my suspicion that despite their outward shows of bravado, the bankers are the only people wholly convinced that Marx's prophecy of capitalism collapsing by eating itself alive will come true and that there will
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!229 Il libro a cui ci riferiamo è N. Klein, Shock Economy, Rizzoli, Milano, 2007 230 A.V. (writers for the 99%), Occupy Wall Street, Feltrinelli, Milano, 2012, p. 141 231 D. Levine, Every Time I Check my messages, somebody thinks I’m dead: a memoir of Occupy Wall Street, Edizione Kindle, 2012, pos. 260-62!
! 94!
be a bloody proletarian reckoning. The self-proclaimed Marxists wish they had 1/10th of the faith in eventual workers revolt that fuels the bankers' paranoia.» «I think everyone's aware of the coming collapse on some level but we're consumed by a collective lust for Thanatos. Wilhelm Reich's "Mass Psychology of Fascism" comes closest to described this sort of scenario.»232
Nonostante questo non c’è traccia nelle sue parole, o in quelle di altri esponenti del
movimento, di un’apologia delle persone coinvolte nel settore finanziario.
Al contrario, torna sempre il motivo del nemico interno («They have discovered a
common enemy and are taking unified action»233) e il riferimento ai crimini impuniti
della finanza, argomento chiave nelle interviste rilasciate alla stampa: «There have
been a lot of major crimes committed by the banking and financial sector in this
country over the past 10-15 years. There has been no accountability for these crimes
and there’s no sign of any coming down the pipeline».234
Secondo Foucault si possono distinguere tre principali forme di lotta: «lotte contro
le dominazioni (politiche); lotte contro gli sfruttamenti (economiche); lotte contro gli
assoggettamenti (etiche)»235. Muovendoci nell’ambito di una società del controllo,
caratterizzata da quello che viene definito come potere pastorale, ci dovremmo
aspettare che la lotta seguita alla crisi fosse anch’essa, principalmente, una lotta
contro l’assoggettamento.
Invece ci troviamo di fronte al problema del giudizio, o meglio della legge. Il
richiamo continuo alla mancanza non solo di una punizione, ma soprattutto
dell’individuazione di un responsabile, della spartizione della colpa dopo gli
avvenimenti culminati nella crisi, non si può ascrivere a una lotta contro
l’assoggettamento di uno Stato pastorale, «che trasforma gli individui in soggetti»,
né a una lotta contro uno specifico sovrano economico colto in fallo nell’esercizio
della sua funzione. Ciò che è venuto meno è la possibilità di misurare e dividere la
colpa, non solo per la titubanza del sistema giudiziario, ma perché apparentemente
impossibile.
In questo senso la vera novità della crisi, prefigurata dagli eventi europei, è lo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!232 L’intervista è stata realizzata per iscritto con il consenso alla pubblicazione da parte di Daniel Levine, il 9 febbraio 2014 233 Il «They» è riferito al movimento nel suo insieme in D. Levine, op. cit., pos. 260-262 234 Ivi, pos. 731-35 235 F. Gros, “Nota del curatore”, in M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto, Feltrinelli, Milano, 2011, p. 490!
! 95!
scenario in cui lo Stato smetta di essere per gli uomini legge e confine236, laddove il
compito di guida e soggettivazione viene delegato sempre più alla governamentalità
economica. A confermare questa linea interpretativa – che rimane comunque una tra
le molte – basterebbero le parole di Draghi, che in un’intervista del 2012 al Wall
Street Journal dichiara senza mezze misure che «il modello sociale europeo è
andato»237, riferendosi proprio a quel modello di stato sociale ormai orfano della
prima idea neoliberista che l’aveva generato:
Contro le teorie del declino dello Stato-nazione e per affermarne al contrario la vitalità, si è osservato che il numero degli Stati-nazione è aumentato e non diminuito con l’avvento del neoliberismo. Ma il problema non sta in questo, poiché ciò che è cambiato sono le funzioni dello Stato-nazione, le sue modalità di intervento e le sue finalità. […] Gli Stati europei si limitano ad applicare politiche economiche e sociali dettate dai mercati (ovvero dal blocco di potere economico-politico-finanziario) a partire dal nuovo patto di stabilità europeo. Le elezioni che si svolgono in questi paesi si fanno su programmi economici già dettati dai vincoli economici e finanziari decisi all’esterno del territorio nazionale.238
Lazzarato in questo ammette di voler superare lo stesso Foucault che in Nascita della
biopolitica «tralascia di prendere in considerazione le funzioni della finanza, del
debito e della moneta» 239 ma continua a scorgere nella produzione dell’uomo
indebitato sempre e comunque l’opera primaria dello Stato (uno Stato rinunciatario,
ma comunque protagonista del suo disfacimento).
Il ‘cuore politico delle spoliticizzazioni’ di cui parlava Esposito trova in questa
teoria una solida conferma, ma entrambe tralasciano di considerare le analogie fin
troppo evidenti che la società del debito crea con la communitas prepolitica.
L’utente trasformato in «debitore», diversamente da ciò che accade sui mercati finanziari, non deve rimborsare con denaro contante, ma con comportamenti, atteggiamenti, modi di agire, progetti, impegni soggettivi, tempo dedicato alla ricerca del lavoro, tempo utilizzato per formarsi secondo canoni dettati dal mercato e dall’impresa. Il debito rimanda direttamente a una disciplina di vita e a uno stile di vita che implicano un lavoro su di «sé», un negoziato permanente con se stessi, una produzione di soggettività specifica: quella dell’uomo indebitato.240
Esposito si esprime con parole molto simili quando afferma che la legge che ci è
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!236 Nel suo senso più originale, il nomos. 237 “L’intervista di Draghi al Wall Street Journal”, IlPost.it, 23 febbraio 2012 238 M. Lazzarato, op. cit., pp. 112-113 239 Ivi, p. 104 240 Ivi, p. 117
! 96!
ingiunta (nel passo specifico il riferimento è all’imperativo categorico di Kant241)
«non è in nessuna maniera un prodotto del soggetto, anche se il soggetto le è
soggetto»242 e che dunque il soggetto si ritrova passivo – appunto, ‘assoggettato’ – a
una legge che «prescrivendo incondizionatamente l’inadempibile, prescrive in un
certo senso la destituzione del soggetto cui si rivolge»243. E’ così accade che la
comunità non vada «cercata fuori, ma esattamente nei confini della legge – anche se
è proprio questa a precluderne il compimento»244.
In questa lettura la comunità assume quindi i caratteri dell’impossibile, e gli
uomini si trovano ad essere «accomunati dall’impossibilità della comunità, da
quell’impossibile che è il loro munus comune»245:
Questo è l’oggetto stesso della legge della comunità: esso – questo Niente-in-comune – non può essere annientato, ridotto a semplice niente, come voleva Hobbes, dal momento che precede e comprende ogni annientamento. Ma non può nemmeno essere neanche realizzato, riempito di sostanza, come a volte sembra volere Rousseau, perché l’unico modo di realizzare la mancanza è quello di mantenerla tale. La Cosa è inseparabile dal Niente. Questo dice la Legge – della comunità: che il limite non può essere cancellato, ma nemmeno varcato.246
Ritornano in mente a questo punto le riflessioni sul debito e sul denaro, che più di
ogni altra cosa al momento possono incarnare la doppiezza della comunità e della
legge. Il denaro, infatti, proprio come elemento fantasmatico, sembra primariamente
connesso a questo nucleo di vuoto centrale a cui il passo citato si riferisce.
Ovviamente la visione della comunità non è sempre e comunque interpretata a
partire dal suo elemento assente, negativo. Come abbiamo visto in Arendt, che pure
non tratta in modo specifico l’argomento, essere tra gli uomini ha un valore positivo,
si viene al mondo e questo mondo che appare a tutti mette in relazione e separa gli
uomini allo stesso tempo247.
Ma anche in Arendt il negativo fa la sua comparsa e non a caso proprio in
chiusura del volume, dove l’oggetto diventa l’analisi dell’età moderna, quando
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!241 Tra i vari riferimenti di cui Esposito si avvale nel volume dedicato alla comunità, abbiamo preferito citare i passaggi riguardanti Kant, che a detta dell’autore è l’unico che resta fedele alla contraddizione indissolubile tra legge e comunità. 242 R. Esposito, Communitas, op. cit., p. 77 243 Ibidem 244 Ivi, p. 79 245 Ibidem 246 Ivi, pp. 79-80 247 Cfr. H. Arendt, Vita Activa, op. cit.
! 97!
l’uomo ripiega su se stesso a sfavore del mondo e della sua umanità e in favore del
«processo vitale della specie umana» 248 , quando cioè diventa preponderante
(nonostante la centralità dell’interesse personale), la sfera sociale nel suo essere ‘di
massa’. «La società di massa non solo distrugge la sfera pubblica, ma anche quella
privata, priva gli uomini non solo del loro posto nel mondo ma anche della loro
dimora privata, dove una volta si sentivano al riparo dal mondo». 249
Il cerchio tracciato dall’analisi politica del potere finanziario in questo modo si
chiude. Dalla comunità come vertigine dell’apertura250 al rapporto creditore-debitore,
da un lato ciò che vediamo riapparire tra le trame della modernità è la diffidenza251
per l’altro, divenuto - via via che quel confine si assottigliava - troppo prossimo per
non risultare, potenzialmente, fatale; dall’altro, nel momento in cui la comunità di
ripresenta, assistiamo al paradossale declino della sfera pubblica.
La sfera pubblica e la comunità, nonostante vengano spesso sovrapposte, non
indicano la stessa realtà delle cose:
La diffusa, ma assai dubbia, omologazione comunitas-res publica […]. La disparità semantica che in tale omologazione si registra riguarda da un lato l’eccessiva genericità connotativa dell’attributo publica, ma dall’altro, e soprattutto, la ‘qualità’ della res. Qual è
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!248 Ivi, p. 239!249 H. Arendt, Vita activa, op. cit., p. 44 250 «da una parte un ordine governato dalla legge della necessità e dal principio della paura [Hobbes ndr], dall’altra [Bataille ndr] un disordine affidato all’impulso del desiderio e alla vertigine del rischio.» R. Esposito, Communitas, op. cit., p. 142 251 Marx afferma: «The credit relationship – for the creditor as well as for the debtor – becomes an object of trade, an objet of mutual betrayal and misuse. Here mistrust is brilliantly apparent as the basis of economic trust […]. In the credit system on the state level the state occupies completely the same position as shown above for man…The game with governmental bonds shows how far the state has become the plaything of men of commerce.» K. Marx, “Excerpt-Notes of 1844”, Selected Writings, Hackett Publishing Company, Indianapolis, 1994, p. 45; Anche Graeber ricorda come «i termini per “commercio e baratto” in quasi tutte le lingue europee sono derivati da parole che significano “ingannare”, “truffare” o “raggirare”.» D. Graeber, op. cit., p. 420 Ma, a sostegno della nostra ipotesi, rileviamo come la diffidenza, prima ancora che fondare – paradossalmente - la fiducia economica, sia soprattutto un residuo della comunità dove gli uomini sono esposti al danno reciproco. Esiste una differenza sostanziale tra il commercio e il baratto, che lo stesso Graber rileva: «il baratto di solito era realizzato tra stranieri, o addirittura tra nemici.» p. 39. Mentre il commercio, come nel caso esemplare delle disposizioni coraniche, richiede onestà: «Guai ai Frodatori, che quando comprano esigono colma la misura, ma quando sono loro a misurare o a pesare, truffano.» Corano, LXXXIII. Per completezza ricordiamo anche la ricostruzione di Diego Fusaro, pur sul fronte opposto, che scrive «Tanto la diagnosi hegeliana quanto quella marxiana presentano un’analoga dinamica di sviluppo: con il momento del negativo e della scissione, il Sé. L’individuo singolo, conquista validità ed effettualità universale e astratta […]. Tuttavia, nello stesso tempo, si disgiunge dalla “sostanzialità” […] di rapporto con gli altri soggetti individuali, smarrisce l’essenza comunitaria che gli è propria, e il rapporto sociale con gli altri va incontro a una Verdinglichung [reificazione ndr] che fa apparire tale nesso come un ente separato, indipendente e minaccioso, astratto.» D. Fusaro, op. cit., p. 179
! 98!
la ‘cosa’ che i membri della comunità hanno in comune? […] communitas è l’insieme di persone unite non da una ‘proprietà’, ma, appunto, da un dovere o da un debito.252
La sfera pubblica, al contrario, in quanto sfera privilegiata del bios politkos, si pone
necessariamente oltre le necessità della vita biologica e, nonostante l’evoluzione253
che il termine ha conosciuto a partire dagli albori del capitalismo, il suo significato
originale si distacca nettamente dal senso che gli è comunemente attribuito oggi. La
res che abita il cuore della sfera pubblica non è un’assenza, essa è «lo spazio
dell’apparire, […] dove appaio agli altri come gli altri appaiono a me, dove gli
uomini non si limitano ad esistere come le altre cose viventi o inanimate ma fanno la
loro esplicita apparizione».254
E non a caso Arendt annovera tra coloro che sono capaci di azione e parola, ma
nonostante questo non vivono nello spazio pubblico, «l’impiegato o l’uomo d’affari
del nostro tempo»255. Dalla trasparenza che caratterizza il nostro sistema economico
(e in grado sempre maggiore anche l’ambito politico) risulta infatti solo una falsa
apparenza. Fatto che nota anche Lazzarato, quando afferma:
A differenza dell’opacità e del segreto che caratterizzano la fabbrica e l’industria, il potere finanziario si definisce anzitutto come un potere di valutazione «pubblica», che ha la pretesa di rendere trasparente qualunque organizzazione, di rendere visibili e quindi valutabili (misurabili) qualunque relazione e qualunque comportamento degli attori di ogni istituzione.256
Infatti il potere finanziario non fa apparire gli uomini in quanto tali, la sfera pubblica
che trova la sua ragion d’essere solo nell’incontro tra uomini, è negata in partenza.
Come nel caso del bancomat descritto da Lazzarato «non c’è più il soggetto che
agisce, ma il «dividuale» che funziona»257.
L’aumento della valutazione è in realtà assimilabile a una espropriazione e alla confisca del potere di agire. Alla moltiplicazione delle tecnologie di management concentrate sulla valutazione, corrisponde, appunto, un restringimento dello spazio di calcolo, scelta e decisione concesso ai lavoratori salariati, agli utenti e ai governati in genere.258
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!252 R. Esposito, Communitas, op. cit., p. XV 253 Cfr. J. Habermas, The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category of bourgeois society, MIT Press, 1991 254 H. Arendt, Vita Activa, op. cit. p. 145!255 Ivi, p. 146 256 M. Lazzarato, op. cit., p. 148 257 Ivi, p. 157 258 Ivi, p. 150
! 99!
La triade che compone la sfera pubblica - la molteplicità degli uomini, il potere che
si instaura nella loro relazione, l’azione e il discorso – è in questo modo destinata a
sfaldarsi, se non a scomparire, sotto la pressione crescente delle istanze del potere
finanziario.
E non di questo potere finanziario, che sembra illuderci che il problema sia la
titolarità del potere, o la corruzione dei suoi vertici, ma anche e soprattutto di quello
a venire. Come nel caso molto discusso della nuova moneta elettronica Bitcoin, che
ha raggiunto la massima popolarità proprio negli anni della crisi.
Un sistema del genere, lungi dal restituire democraticità al sistema finanziario,
porta alle estreme conseguenze l’evoluzione di un’economia profondamente atea259
(contro le ragioni della teologia economica), liberata non solo da un’eventuale
sovrano extraeconomico che ne sia garante, ma dalla necessità stessa del legame
fiduciario260. Il potere bancario cioè, per quanto ne risulti atomizzato, procede
comunque nella direzione di ottenere il monopolio su ciò che può e non può essere
promesso, svincolato a questo punto da un potere politico e giudiziario che lo
coadiuvino ma soprattutto, che lo limitino.
Se c’è un bersaglio che la critica filosofica dovrebbe puntare con tutte le sue forze
allora forse non si tratta delle vecchie ricette neoliberiste261, ma delle nuove soluzioni
che sotto mentite spoglie - sempre più non-umane - rischiano di prendere in
consegna i nostri attuali meccanismi di potere rendendoli ancora più invisibili
all’analisi e indifferenti alla responsabilità.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!259 Cfr. M. Foucault, Biopolitica, op. cit., pp. 231-232 260 Cfr. M. Andreessen, “E’ ora di fare i conti con Bitcoin”, Internazionale, 14 febbraio 2014, p. 34 261 La linea di pensiero con cui chiudiamo la riflessione può apparire in contrasto con il tentativo di non fornire ‘soluzioni’ al problema politico del potere bancario. Tuttavia esistono riflessioni molto simili in merito, tra cui ricordiamo per il caso Bitcoin D. Golumbia, “Bitcoin: The Cryptopolitics of Cryptocurrencies”, Harvard University Press, 28 febbraio 2014 in cui l’autore afferma: «Yet cyberlibertarians continually write as if money is simple, straightforward, that any attempt to delve into its complexities is disinformation propounded by central bankers, and so on—despite themselves being unwilling even to investigate the basic parameters of the thing they claim to have bettered.». Più avanti inoltre rileva come proprio l’assenza di regolamentazione da parte dello Stato americano nei confronti dei CDS sia uno dei motivi principali della bolla finanziaria. Sul problema del post-neoliberalismo inoltre Cfr. S. Springer, “Postneoliberalism?”, Review of Radical Political Economics, 29 marzo 2013 dove accanto all’analisi di alcune conseguenze del movimento Occupy l’autore – che scrive da un punto di vista critico - sottolinea il rischio di replicare i modelli neoliberali anche in una fase che si presume possa decretare la fine di questo tipo di capitalismo. Non a caso negli ultimi anni è tornata in auge l’immagine dello zombie per descrivere l’attuale forma di capitalismo. A questo proposito Cfr. C. Harman, Zombie Capitalism: global crisis and the relevance of Marx, Haymarket Books, Chicago, 2009 e B. Fine, “Zombieconomics: The living death of the dismal science”, ESRC Neoliberalism Seminar, 1 aprile 2008
! 100!
! 101!
Conclusioni
In merito agli obiettivi che ci eravamo proposti inizialmente – fornire una
definizione di potere bancario e individuarne il dato politico – possiamo affermare
che perlomeno il primo è stato sicuramente raggiunto.
Anche la metodologia utilizzata – avvalersi della letteratura filosofica senza
rinunciare agli spunti dell’attualità e di discipline differenti, come la psicanalisi – a
nostro avviso ha reso possibile l’analisi di un fenomeno che non si fa leggere da un
unico punto di vista. Questo tipo di approccio, lungi dall’essere originale, è in realtà
caratteristico delle produzioni filosofiche degli ultimi tempi, che testimoniano non
solo il recupero del pensiero di Foucault e dei suoi contemporanei, ma soprattutto –
attraverso la commistione tra diverse materie – la possibilità di scavare dentro un
fenomeno fino a rovesciarlo completamente.
Definire il potere bancario non tramite ciò che esso, in modo contingente, si trova
a fare, ma attraverso le categorie del debito e del godimento, ha permesso infatti di
sintetizzare agevolmente la sua specificità, altrimenti persa non appena il paradigma
storico o economico ne abbia trasformato le caratteristiche esteriori.
Il potere bancario si instaura quindi sul debito – nella sua doppia veste di legame
sociale e generatore di ricchezza – e sul godimento, eretto ormai a imperativo
categorico nella società del consumo. Questa particolare contingenza è resa possibile
da un sistema politico-economico che trova nel potere finanziario il fulcro della sua
attività, nella trasparenza il suo dispositivo e nella meccanicità del mercato la
possibilità di delegare la propria e l’altrui responsabilità.
Tuttavia il debito, la questione del desiderio e del godimento sono tematiche
trasversali nel corso della storia della nostra civiltà, e con molta probabilità avremo
ancora a che fare con esse dopo che il sistema economico attuale avrà compiuto il
suo ciclo vitale. Infatti, come abbiamo potuto osservare soprattutto grazie all’inedito
percorso tematico compiuto da Esposito sulla comunità, sono tre elementi che
sopravvivono sempre e comunque tra le maglie che idealmente separano il politico,
l’impolitico e il prepolitico.
Da questo punto di vista la fruizione della nozione di ‘potere bancario’ resta
! 102!
problematica, soprattutto alla prova del concetto di ‘politico’, continua a risultare
opaca e chiama continuamente in causa il potere statale e quello legislativo. Questo
perché, sebbene la nostra intenzione iniziale fosse quella di isolare il potere bancario
- anche solo a livello teorico - dal resto dei discorsi di potere, ci siamo presto resi
conto che ciò non era possibile se si ha a che fare con un potere articolato in modo
circolare, governamentale.
Pur non risultando politico in senso classico, il potere finanziario è comunque
assurto a una posizione dominante in ogni funzione della società, non da ultimo
quella politica, per cui – come giustamente osserva Žižek – si possono pensare
mondi paralleli, persino la fine del mondo, ma non viene mai presentata
un’alternativa al capitalismo finanziario. Nonostante questo, così come non si può
centrare sulla politica una società funzionalmente differenziata senza distruggerla è
probabile che non si possa centrare nemmeno sull’economia, a meno di non
scatenare i risultati di cui tutti siamo tutti testimoni (fermo restando che decretare la
fine di un sistema sulle orme della crisi262 vuol dire affidare le proprie previsioni al
beneficio del caso, dal momento che la crisi è connaturata al sistema stesso).
Come uscire dal vicolo cieco di un sistema simile, ormai caratterizzato dal legame
indissolubile tra libertà e assoggettamento, tra libera scelta e condizionamento, non è
certo una questione che si può risolvere in questa sede. In un’intervista del 1984
Foucault, negli anni della riflessione fondamentale sull’etica, affermava: «when an
individual or a social group manages to block a field of relations of power, to render
them impassive and invariable and to prevent all reversibility of movement – by
means of instruments which can be economic as well as political or military – we are
facing what can be called a state of domination».263
Le parole del filosofo francese si applicano senza sforzo al caso dell’élite
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!262 «quel che si designa come la crisi dell’università non deve essere interpretata come una perdita di potere, ma al contrario come la moltiplicazione ed il rafforzamento dei suoi effetti di potere, in mezzo ad un insieme multiforme d’intellettuali che, praticamente tutti, passano attraverso e si riferiscono ad essa.» M. Foucault, Microfisica del potere, op. cit., p. 21 Il discorso ‘universitario’, in termini diversi, ha ricoperto grande importanza anche nel pensiero di Lacan, come sapere che riproduce ciò che già sa. Da entrambi i punti di vista anche il sapere economico sembra soffrire, da un lato, di un’eccessiva concentrazione di sapere e potere, dall’altro dell’impasse che lo costringe a ricercare soluzioni negli stessi principi che alimentano i suoi problemi. 263 M. Foucault in R. Fornet-Betancourt, H. Becker, A. Gomez-Muller, “The ethic of care for the self as a practice of freedom: an interview with Michel Foucault on January 20, 1984”, Philosophy & Social Criticism, 12:112, 1987, p. 114
! 103!
finanziaria. Il problema che nel corso della trattazione abbiamo definito ‘della
titolarità’ del potere, è stato però messo in secondo piano per un motivo principale:
evitare, come spesso accade nella critica giornalistica o documentaristica, di additare
alcuni colpevoli e dimenticare in che modo quei soggetti sono stati messi nella
condizione di esercitare una simile influenza. Si tratta di considerare da un lato la
struttura del sistema e, insieme a essa, la capacità tutta umana di agire, da cui
scaturiscono gli avvenimenti264.
Una futura indagine sul tema che voglia dirsi etica, non potrà quindi ascrivere il
male a pochi individui scordandosi della malvagità265 che per forza di cose si
manifesta negli affari dell’uomo. Del resto, fortunatamente, non ci troviamo ancora
di fronte a un male assoluto, impunibile e imperdonabile266 , e i prossimi mesi sono
ancora tutti da scrivere per quanto riguarda le responsabilità dei politici e
amministratori americani che hanno fatto franare l’economia occidentale.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!264 «l’azione, dal punto di vista dei processi automatici che sembrano determinare il corso del mondo, assomiglia a un miracolo. Nel linguaggio della scienza naturale, essa è l’”improbabilità infinita che si verifica regolarmente”. […] Solo la piena esperienza di questa facoltà può conferire alle cose umane fede e speranza, le due essenziali caratteristiche dell’esperienza umana che l’antichità greca ignorò completamente.» H. Arendt, Vita activa, op. cit., p. 182 «Ma ciò che importa è di non fare per l’avvenimento ciò che si è fatto per la struttura. Non si tratta di ripiegare tutto su un certo piano, che sarebbe quello dell’avvenimento, ma di ben considerare che esiste tutto un disporsi su piani distinti di tipi di avvenimenti diversi che non hanno né la stessa portata, né la stessa ampiezza cronologica, né la stessa capacità di produrre effetti.» M. Foucault, Microfisica del potere, op. cit., p. 8 265 «Tutti i pensatori che partono dalla malvagità dell’uomo possiedono un’immensa forza di persuasione. Suonano esperti, coraggiosi e veritieri. Guardano la realtà negli occhi e non temono di chiamarla per nome. Che non sia mai l’intera realtà, lo si capisce solo più tardi; e che ancora più coraggioso sarebbe vedere, in questa stessa realtà, senza falsificarla né abbellirla, il nucleo di un’altra, possibile in circostanze mutate, questo se lo confessa solo chi conosce ancora meglio la malvagità, chi l’ha in sé, la cerca in sé, la trova in sé: un poeta». E. Canetti, La provincia dell’uomo, op. cit., p. 291 «Insomma, si muti in bene o in male, deve essere eccezionalmente temprato quell’individuo, che, cambiando notevolmente posizione sociale, conserva inalterato il proprio carattere.» G. Mosca, op. cit., p. 63 266 Cfr. H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 2004. La metafora nazista applicata al capitalismo è stata avanzata a più riprese negli ultimi anni, probabilmente perché in entrambi si è manifestato un male sistemico, cioè quel male ‘banale’, compiuto dal padre di famiglia, dall’uomo qualunque, che Arendt aveva individuato a costo di tante critiche. In proposito Cfr. L. Demichelis, “Il nichilismo tedesco. O la banalità del male (economico)”, Micromega Online, 15 giugno 2012; S. Latouche, Etica e Capitalismo, Milano, 5 maggio 2011, (l’intervento è pubblicato online da diverse fonti). Sul tema del male nel capitalismo una riflessione non banale di Badiou in C. Cox, M. Whalen, “On Evil: an interview with Alain Badiou”, Cabinet Magazine Online, 2001, 5: 2.
! 104!
! 105!
BIBLIOGRAFIA OPERE FONDAMENTALI A.V., Occupy: Teoria e pratica del movimento contro l’oligarchia finanziaria, Il
Saggiatore, Milano, 2012 A.V. (writers for the 99%), Occupy Wall Street, Feltrinelli, Milano, 2012 T. W. Adorno, Minima moralia, Einaudi, 1979 G. Agamben, Che cos’è un dispositivo?, Nottetempo, Roma, 2006 H. Arendt, Vita activa, Bompiani, Milano, 2011 (1958) La vita della mente, Il Mulino, Bologna, 2004 Aristotele, Etica Nicomachea, Bompiani, Milano, 2000 M. Atwood, Payback: Debt And The Shadow Side Of Wealth, House of Anansi Press
Inc., Toronto, 2008 Z. Bauman, Dentro la globalizzazione: le conseguenze sulle persone, Laterza, Bari,
2007 (1998), Z. Baumann, Capitalismo parassitario, Laterza, Bari, 2009 F. Braudel, La dinamica del capitalismo, Il Mulino, Bologna, 1988 J. Burnham, La rivoluzione dei tecnici, Mondadori, Milano,1947 A. Caillé, Critica dell’uomo economico. Per une teoria anti-utilitarista
dell’azione, Il Melangolo, Gênes, 2010 E. Canetti, La provincia dell’uomo, Adelphi, Milano, 1978 Massa e Potere, Adelphi, 1981 G. Deleuze, Pourparler, Quodlibet, Macerata, 2000 Che cos’è un dispositivo?, Cronopio, Napoli, 2010 J. Derrida, Il segreto del nome. Tre saggi, Jaca Book, Milano, 1997 R. Esposito, Categorie dell’impolitico, Il Mulino, Bologna, 1999 (1988) Communitas: origine e destino della comunità, Einaudi, Torino, 1998
! 106!
M. Foucault, Microfisica del Potere: interventi politici, Einaudi, Torino, 1977 “The Confession of the Flesh” (1977), Power/Knowledge
Selected Interviews and Other Writings. 1972-1977, The Harvester Press, Limited, 1980
Nascita della biopolitica: Corso al Collège de France (1978-1979), Feltrinelli, Milano, 2012 (2004)
“Bisogna difendere la società”, Feltrinelli, Milano, 2010 L’ermeneutica del soggetto, Feltrinelli, Milano, 2011 Mal Fare Dir Vero: funzione della confessione nella giustizia, Einaudi,
Torino, 2013 D. Fusaro, Minima Mercatalia: filosofia e capitalismo, Bompiani, Milano, 2012 L. Gallino, Finanzcapitalismo: la civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino, 2013 D. Graeber, Debito. I primi 5000 anni, Il Saggiatore, Milano, 2012 J. Habermas, The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a
category of bourgeois society, MIT Press, 1991 G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Bari, 1965 N. Klein, Shock Economy, Rizzoli, Milano, 2007 J. Lacan, Il seminario, II, Einaudi, Torino, 1991 Il seminario, XX, Einaudi, Torino, 2011 Il seminario, VII, Einaudi, Torino, 1994 S. Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati Boringhieri, Torino, 2008 M. Lazzarato, La fabbrica dell’uomo indebitato: saggio sulla condizione
neoliberista, DeriveApprodi, Roma, 2012 J. Le Goff, La borsa e la vita, Laterza, Bari, 2003 D. S. Landes, La ricchezza e la povertà delle nazioni, Garzanti, Milano, 2002 D. Levine, Every Time I Check my messages, somebody thinks I’m dead: a memoir
of Occupy Wall Street, Edizione Kindle, 2012 N. Luhmann, Teoria politica nello stato del benessere, Franco Angeli, Milano, 1987 Potere e complessità sociale, Il Saggiatore, Milano, 2010 E. N. Luttwak, La dittatura del capitalismo, Mondadori, Milano, 1999 K. Marx, Il Capitale, Vol. I Selected Writings, Hackett Publishing Company, Indianapolis, 1994
! 107!
G. Mosca, La classe politica, Laterza, Bari, 1994 (1966) F. Ruda, Hegel’s rabble: an investigation into Hegel’s Philosophy of right,
Continuum, 2011 J. Rueff, L’errore monetario dell’occidente, L’oro e la guerra delle monete,
Universale Etas, 1971 C. Schmitt, Le categorie del «politico», Il Mulino, Bologna, 1972 Dialogo sul Potere, Il Melangolo, Genova, 1990 A. Sen, La diseguaglianza, Il Mulino, Bologna, 2010 (1992) La ricchezza della ragione, Il Mulino, Bologna, 2000 Etica ed economia, Laterza, Bari, 2006 E. Severino, Il declino del capitalismo, Rizzoli, Milano, 2007 G. Simmel, Filosofia del Denaro, Utet, Torino, 1984 E. Stimilli, Il debito del vivente, Quodlibet, Macerata, 2011 F. Tonnies, Comunità e Società, Laterza, Bari, 2011 M. Weber, Economia e società, Vol. I-II, Edizione di Comunità, Milano, 1980 Parlamento e governo, Laterza, Bari, 2002 H. Winter, T. Rommel, La ricchezza delle nazioni: guida e commento, Garzanti,
Milano, 2001 S. Žižek, Il Grande Altro, Feltrinelli, Milano, 1999 Il godimento come fattore politico, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001 In difesa delle cause perse: Materiali per la rivoluzione globale, Ponte delle
Grazie, Milano, 2009 Meno di Niente: Hegel e l’ombra del materialismo dialettico, Ponte delle
Grazie, Milano, 2013 ALTRE OPERE CONSULTATE M. Foucault, N. Chomsky, Della natura umana. Invariante biologico e potere
politico, DeriveApprodi, Roma, 2005
G. Deleuze, F. Guattari, L’Anti-Edipo: capitalismo e schizofrenia, Einaudi, Torino, 2002
!H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 2004
! 108!
F. Chabod, Storia dell’Idea di Europa, Laterza, Bari, 2003 (1961) U. Curi, Prolegomeni per una popsophia, Mimesis, Milano, 2013 R. Girard, La violenza e il sacro, Adelphi, Milano, 1980 C. Harman, Zombie Capitalism: global crisis and the relevance of Marx, Haymarket
Books, Chicago, 2009 K. Marx, Critica del programma di Gotha, edizione di pubblico dominio, 1891 M. Mauss, Saggio sul dono, Einaudi, Torino, 2002 F. Nietzsche, La genealogia della morale, Einaudi, Torino, 2012 A. Smith, Teoria dei sentimenti morali, BUR, Milano, 1995 M. Yunus, Un mondo senza povertà, Feltrinelli, Milano, 2010 S. Žižek, Leggere Lacan, Bollati Boringhieri, Torino, 2009 ATTI DI CONFERENZE M. Draghi, Gli economisti e la crisi, Intervento del Governatore della Banca d’Italia,
in Società italiana degli economisti, 50a Riunione scientifica annuale, Roma, 22 ottobre 2009
B. Fine, “Zombieconomics: The living death of the dismal science”, ESRC
Neoliberalism Seminar, 1 aprile 2008 S. Latouche, Etica e Capitalismo, Milano, 5 maggio 2011 T. Sankara, Discorso all’ONU del 4 ottobre 1984 L. Strauss, What is Liberal Education?, 6 giugno 1959 Y. Stavrakakis, “Biopolitics, psychoanalysis and debt”, Psychoanalysis and Political
Theory, Università degli Studi di Salerno, 6 giugno 2013 M. Yunus, Credit for Self Employment: Fundamental Human Right, World Food
DaySatellite Teleconference, 1986
! 109!
ARTICOLI A. M. Inness, “What is Money?”, The Banking Law Journal, maggio 1913 T. Adorno, E. Canetti, “Dialogo sulle masse, la paura e la morte”, MicroMega, n. 2,
1986 R. Fornet-Betancourt, H. Becker, A. Gomez-Muller, “The ethic of care for the self as
a practice of freedom: an interview with Michel Foucault on January 20, 1984”, Philosophy & Social Criticism, 12:112, 1987
J. Persky, “Retrospectives: The Ethology of Homo Economicus.” The Journal of
Economic Perspectives, Vol. 9, No. 2 (Spring, 1995) N. Luhmann, “Globalizzazione o società-mondo: come pensare la società moderna”,
Contratto, VI, 1998 N. Luhmann, “Oltre le barbarie”, Sociologia e politiche sociali, n.3, 1999 C. Cox, M. Whalen, “On Evil: an interview with Alain Badiou”, Cabinet Magazine
Online, 2001, 5: 2. J. Sonnemansa,, C. Hommesb, J. Tuinstrab, H. van de Veldenb, “The Instability of a
Heterogeneous Cobweb economy: a Strategy Experiment on Expectation Formation”, Journal of Economic Behavior & Organization, Volume 54, Issue 4, agosto 2004
M. Senaldi, “ Žižek e l’immaginario”, International Journal of Žižek Studies, Vol.
1.4, 2007 R. Ciccarelli, “Riformulare la libertà politica nell’analisi della governamentalità”,
European Journal of legal studies, vol. 1, n. 3, 2008 P. Krugman, “How did Economists Get It So Wrong?”. The New York Times, 2
Settembre 2009 P. Costa, La modernità penale fra secolarizzazione e permanenza nel ‘sacro’,
Horizontes y Convergencias, 26 ottobre 2009 V. Carlini, “L’ex ceo di Lehman Brothers Richard Fuld accusa: ci lasciarono fallire.
Agli altri gli aiuti negati a noi”, Ilsole24ore.com, 1 settembre 2010 J. Bussolini, “What is a Dispositive?”, Foucault Studies, no. 10, novembre 2010 J. Gershman, J. Morduch, “Credit is not a right”, Financial Access Initiative
(financialaccess.org), aprile 2011
! 110!
J. E. Stiglitz, “Of the 1%, by the 1%, for the 1%”, VanityFair.com, maggio 2011 S. Carrere, “L’agenzia cinese Dagong declassa gli Usa al livello della Russia: singola
a. Mercati asiatici in calo di oltre il 2%”, Ilsole24ore.com, 3 agosto 2011 S. Žižek, “Slavoj Žižek: Occupy Wall street e l’illusione della democrazia”,
Internazionale, 4 novembre 2011 B. Gobbi, M. Perrone, P. Del Bufalo, “Gli effetti della crisi: la Grecia (e gli altri), ci
rimettono la salute”, Il Sole24Ore Sanità, n.6/2012 “L’intervista di Draghi al Wall Street Journal”, IlPost.it, 23 febbraio 2012 L. Demichelis, “Il nichilismo tedesco. O la banalità del male (economico)”,
Micromega Online, 15 giugno 2012 J. Luyendijk, “Ex-City boy: ‘It’s easier to get people to talk about drugs than insider
trading”, TheGuardian.com, 6 luglio 2012 C. Hojnicki, “Cracked tales of cocaine on Wall Street”, BusinessInsider.com, 13
luglio 2012 W. Tiolfi, “Il «credetemi» di Draghi e le aspettative dei mercati”, Il Sole 24 Ore, 27
luglio 2012 D. M. De Luca, “Il fallimento di Lehman Brothers”, IlPost.it, 15 settembre 2012 M. Dotti, “Bisogno e desiderio, gli inganni del denaro”, ilmanifesto.it, 25 ottobre
2012 R. Esposito, “Teologia politica e teologia economica”, Micromega, n.1 anno 2013 A. Tarquini, “L’Ungheria di Orban sfida l’Ue e il Fmi. A rischio indipendenza Banca
Centrale”, Repubblica.it, 1 marzo 2013 S. Springer, “Postneoliberalism?”, Review of Radical Political Economics, 29 marzo
2013 G. Anderson, “Did cocaine use by bankers cause the global financial crisis?”,
TheGuardian.com, 15 aprile 2013 “Bce, Weidman: la politica monetaria è entrata in un territorio pericoloso”,
IlSole24Ore.com, 25 agosto 2013 M. Sgroi, “Vivere con un debito di guerra in tempo di guerra”, Formiche.net, 20
settembre 2013
! 111!
R. Sommella, “Il caso Datagate e la guerra del debito europeo”, Europaquotidiano.it, 1 novembre 2013
E. Franceschini, “Lo stress fa strage di banchieri: ritmi eccessivi anche per i ‘lupi’”,
Repubblica.it, 29 gennaio 2014 “Le banche e i cittadini”, Internazionale, 14 febbraio 2014 M. Andreessen, “E’ ora di fare i conti con Bitcoin”, Internazionale, 14 febbraio 2014 D. Golumbia, “Bitcoin: The Cryptopolitics of Cryptocurrencies”, Harvard University
Press, 28 febbraio 2014 VIDEO Abecedario di Gilles Deleuze, in Italia pubblicato in DVD da DeriveApprodi, Roma, 2005 M. Moore, Capitalism: a love story, 2009 D. Schechter, In Debt We Trust: America Before the Bubble Bursts, 2006 SITI INTERNET Europa.eu Fednews.com Ubu.com Istat.it wearethe99percent.tumblr.com
!



























































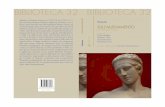
![Fra il nome e la stora. Trasformazioni del discorso politico e concetto di classe in Francia al principio della monarchia di Luglio (1831-1832) - [PhD Thesis - Ita]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6319729ce9c87e0c09102069/fra-il-nome-e-la-stora-trasformazioni-del-discorso-politico-e-concetto-di-classe.jpg)







![La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6317fdaebc8291e22e0e7df2/la-molteplice-direzione-temporale-nelle-confessioni-dun-italiano-fra-il-varmo.jpg)








