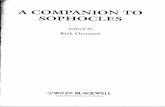Il cielo e il soffitto: speculazione filosofica e realtà romana nell'epistola 90 di Seneca, in...
Transcript of Il cielo e il soffitto: speculazione filosofica e realtà romana nell'epistola 90 di Seneca, in...
RITA DEGL’INNOCENTI PIERINI ESTRATTO DAL VOLUME COLLOQUIO SU SENECA TRENTO 2004
IL CIELO E IL SOFFITTO
SPECULAZIONE FILOSOFICA E REALTÀ ROMANA NELL'EPISTOLA 90 DI SENECA
Tra le numerose contraddizioni rilevate dalla critica nella complessa personalità
di Seneca non si è mai mancato di sottolineare come il filosofo stoico, legato ad una scuola che doveva sospingere i suoi seguaci verso un ottimismo pressoché assoluto,
verso una fiducia quasi illimitata nel progresso umano, sia invece fortemente
condizionato da una sorta di pessimismo della storia e sulla storia1, che nasce da una visione cupa e demonizzante del presente: il moralismo romano, il culto di un passato
idealizzato, e probabilmente sopravvalutato, incidono in modo evidente su una dicotomia, che non sta certo a noi tentare di risolvere, ma che non possiamo non
rilevare. Non ci interessa tentare di individuarne le motivazioni interne ad un'evoluzione
del pensiero nell'ambito dello stoicismo (anche perché in assenza quasi totale di testimonianze dirette, saremmo costretti a formulare continue ipotesi, come è stato
spesso fatto), quanto ci sembra utile indagare su questo complesso intreccio, che
costituisce anche l'interesse per una personalità affascinante proprio per le sue contraddizioni di uomo, che vive intensamente la realtà dei suoi tempi, ma che sente di
poter comunicare con i posteri, che 's'illumina d'immenso' nell'illusione, quasi superomistica, di agire per le generazioni future.
La diffidenza, direi anche il disgusto, del Seneca maturo verso l'azione politica
concreta e la storia del passato traspare molto spesso, talvolta è addirittura assoluta (leggiamo in epist. 1, 2 quidquid aetatis retro est, mors tenet), mentre la proiezione nel
futuro del proprio impegno filosofico appare espressa con accenti fideistici quasi iperbolici, con una consapevolezza di sé che sembra rasentare proprio la superbia, che
veniva spesso rimproverata agli stoici; nell'epistola 21, 5 l'autocoscienza
dell'immortalità della propria opera propone al destinatario Lucilio un destino luminoso
1 Una buona sintesi offre L. CASTAGNA, Storia e storiografia nel pensiero di Seneca, in A. SETAIOLI (a
cura di), Seneca e la cultura, Napoli 1991, pp. 89-117.
2
fuori dalle tenebre dell'anonimato: "Piomberà su di noi il profondo abisso del tempo,
pochi uomini d'ingegno alzeranno la testa, e, per quanto siano destinati a finire quando
verrà il tempo stabilito nello stesso silenzio, resisteranno all'oblio e rivendicheranno la loro parte di gloria per lungo tempo. Ti prometto, o Lucilio, quello che Epicuro poté
promettere al suo amico: io godrò del favore dei posteri, io ho il potere di fare uscire dalle tenebre insieme a me nomi destinati a durare"2.
Seneca mostra nella sua opera, in particolare nelle Epistole a Lucilio, una lucida
consapevolezza d'immortalità del suo messaggio filosofico, che si può sintetizzare nella nota ed icastica formulazione di epist. 8, 2 posterorum negotium ago ("curo gli affari
dei posteri, non i miei personali") e che consiste nel presentare attraverso Lucilio ai suoi lettori presenti e futuri salutares admonitiones uelut medicamentorum utilium
compositiones ("consigli di salvezza dell'anima non molto diversi dalle ricette con le
quali i medici sanano i loro pazienti"). E' in questo colloquio ideale con le generazioni future che Seneca sente la validità e l'utilità, anche pratica, del suo messaggio filosofico:
epist. 8, 6 "Se parlo di questi valori ideali con me stesso, si haec cum posteris loquor, se
instauro un dialogo con i posteri, non ti sembra che mi renda più utile (ed il verbo che usa è il concreto prodesse) che se mi presentassi in tribunale a fare l'avvocato difensore,
se apponessi il mio sigillo ad un testamento, se prestassi la mia voce e la mia gestualità ad un candidato in senato? Credimi, coloro che non sembrano far niente di concreto,
fanno cose più importanti: si occupano ad un tempo di ciò che è divino ed umano
(humana diuinaque simul tractant)". La scelta della vita filosofica colloca il sapiens stoico in una dimensione ucronica, che lo rende simile alla divinità e talvolta addirittura
ad essa superiore: nel concetto stesso del prodesse senecano c'è una finalità etica ed universalistica che fa sì che egli ormai progetti la sua predicazione più per le
generazioni future che per i poco amati contemporanei.
Per analizzare il complesso intreccio di messaggio filosofico e di disgusto del presente che caratterizza il pensiero e la personalità senecana ho pensato oggi, in questa
sede, di occuparmi dell'epistola 90, una lettera, che per la sua lunghezza, inusitata anche per il particolare genere dell'epistola senecana, si avvicina ad un vero e proprio trattato
2 Può essere interessante ricordare che quest'epistola è tradotta da Giordano Bruno nel Dialogo primo
della seconda parte degli Eroici furori (pp. 410-1 ediz. Gentile).
3
sul tema del progresso umano3 e che è stata spesso studiata, direi addirittura quasi
vivisezionata, più che per sondare i complessi snodi della personalità del filosofo, per
ricostruire i misteriosi percorsi della scuola stoica e soprattutto il pensiero di Posidonio. Infatti nella nostra lettera il nome di Posidonio e le sue tesi impegnano Seneca in un
dialogo non privo di polemiche e di ironiche prese di distanza: ricordo per i più giovani che la Posidoniosfrage ha costituito per anni un comodo escamotage critico per tentare
di sanare, dall'esterno, molte delle contraddizioni rilevabili in filosofi come Cicerone e
Seneca, stante la conclamata importanza del filosofo greco per il pensiero romano e l'assenza di testimonianze dirette delle sue opere (anche la nostra epistola 90 trova
spazio nelle edizioni dei frammenti posidoniani, per esempio nella più recente curata ottimamente da Edelstein e Kidd, Cambridge 1988, fr. 284).
L'epistola 90, che si apre con una domanda tanto sommessa nel tono quanto
impegnativa nella sostanza dottrinale (Quis dubitare, mi Lucili, potest quin deorum
inmortalium munus sit quod uiuimus, philosophiae quod bene uiuimus?), si avvicina da
subito al carattere del protrettico4, l'exhortatio, collegando strettamente provvidenzialità
divina5 e necessità ineluttabile della filosofia, vera ed unica via per la felicità6: e del
3 Sul tema del progresso ricordo solo le trattazioni di A. O. LOVEJOY - BOAS, Primitivism and Related
Ideas in Antiquity, rist. New York 1965; A. NOVARA, Les idées romaines sur le progrès d'après les
ecrivains de la République (Essai sur le sens latin du progrès), II, Paris 1983; L. EDELSTEIN, L’idea di
progresso nell’antichità classica, trad. it., Bologna 1987, vd. anche A.L. MOTTO - CLARK, The Idea of
Progress in Senecan Thought, in Essays on Seneca, Frankfurt am Main 1993, pp. 21-39. 4 Si veda G. MAZZOLI, Sul protrettico perduto di Seneca: le «Exhortationes», «RIL» 36, 1977, pp. 7-47,
in particolare pp. 20 sg. n. 29. Sul rapporto con il Protrettico di Aristotele, vd. R. MONDOLFO, La
comprensione del soggetto umano nell'antichità classica, Firenze 19672, pp. 720 sgg.; sui caratteri
distintivi della letteratura protrettica, a partire dall'Hortensius ciceroniano, ampia disamina in A. GRILLI,
M. Tulli Ciceronis Hortensius, Milano-Varese 1962; sui rapporti Cicerone-Seneca in relazione
all'Hortensius, vd. ora anche A. GRILLI, Seneca e l'Hortensius, in P. DEFOSSE (a cura di), Hommages à
C. Deroux, vol. II: Prose et linguistique, Médecine, Bruxelles 2002, pp. 196-205 (sull'epist. 90, cfr. in
particolare pp. 203 sgg.). 5 La trattazione più incisiva del tema della provvidenzialità di Seneca è nel penetrante saggio di A.
TRAINA, La domanda più antica del mondo, Prefazione a Seneca, La provvidenza, a c. di A. TRAINA,
con un saggio di I. DIONIGI, Milano 1997, pp. 7-31. 6 Vd. MAZZOLI, art. cit., p. 31.
4
resto è appena il caso di ricordare come anche al nome di Posidonio si collegasse un
notissimo Protrettico7.
Se volessimo sintetizzare al massimo il complesso e ricco contenuto dell'epistola, potremmo parlare di una storia dell'umanità vista con l'ottica, moralistica,
della contrapposizione fra passato, idealizzato, vs. presente, negativamente denigrato, una teoria quindi di un progresso, che, lungi dall'aderire al fideismo stoico sulle
«magnifiche sorti e progressive» dell'umanità, contrappone il progresso delle arti al
regresso morale dei contemporanei: l'età dell'oro del filosofo non è quindi, paradossalmente, né nel passato né nel presente, è al di fuori della storia, anche mitica,
non si colloca certo nei Saturnia saecula dell'utopia letteraria (Illo ergo saeculo quod
aureum perhibent, come sottolinea con evidente distacco Seneca in epist. 90, 5), si nutre
della speranza di un rinnovamento morale, che può lievitare esclusivamente in interiore
homine e che solo la filosofia stoica sembra poter garantire. Se la polemica esplicita è contro Posidonio8, che, pur esaltando il governo dei sapienti della cosiddetta età dell'oro,
cade nell'errore di affermare (§7) che artes quidem a philosophia inuentas quibus in
cotidiano uita utitur, cioè anche le arti pratiche9 sono state escogitate dai sapienti, la polemica implicita, come vedremo, è anche con i poeti che hanno 'incoraggiato' una
visione idealizzata e ottimistica dell'età primitiva, definita aurea, dal pregio di un metallo10, che ha contribuito invece in modo irreversibile al decadimento etico di uomini
7 Non entro in merito al problema, per cui rimando alla ricca documentazione offerta da A. SETAIOLI,
Seneca e i Greci. Citazioni e traduzioni nelle opere filosofiche, Bologna 1988, pp. 323 sgg. 8 Per una trattazione del tema, cfr. E. BERTOLI, L'età dell'oro in Posidonio e Seneca, «Quad.Ling.Lett.»
7, 1982, pp. 151-179. 9 § 19: Omnes istae artes quibus aut circitatur ciuitas aut strepit corpori negotium gerunt, cui omnia olim
tamquam seruo praestabantur, nunc tamquam domino parantur. Itaque hinc textorum, hinc fabrorum
officinae sunt, hinc odores coquentium, hinc molles corporis motus docentium mollesque cantus et
infractos. Recessit enim ille naturalis modus desideria ope necessaria finiens; iam rusticitatis et miseriae
est uelle quantum sat est. 10 Il tema è esplicitamente affrontato nell'epist. 115, in particolare cfr. § 13 (dove sono citati i versi di Ov.
met. 2, 1-2; 107-8, relativi alla reggia e al carro di Fetonte): Accedunt deinde carmina poetarum, quae
adfectibus nostris facem subdant, quibus diuitiae uelut unicum uitae decus ornamentumque laudantur.
Nihil illis melius nec dare uidentur di inmortales posse nec habere.
Regia Solis erat sublimibus alta columnis,
clara micante auro.
5
corrotti dalla luxuria. C'è quindi come sempre in Seneca una componente di letterarietà,
di matrice anche retorica11, che non può essere disgiunta dalla sua competenza filosofica
e dall'impulso etico verso un'ideale di vita semplice, che arriva ad evocare come esemplare perfino una figura come quella di Diogene il cinico (§14), che si era liberato
di tutte le sovrastrutture imposte dalla società e che aveva rifiutato quelle artes
sordidae, che contribuiscono invece ora a creare i falsi bisogni della società
contemporanea.
Il complesso e sapiente intreccio di questi diversi livelli di lettura rende quindi arduo riassumere e sintetizzare la dialettica interna dell'epistola, punteggiata anche di
riferimenti espliciti e impliciti a poeti latini: per questo si sente oggi la necessità di un commento moderno12, che tenga conto di queste componenti, ed il mio contributo di
oggi, nato nell'ambito di un corso universitario, si muove in quest'ottica.
Un elemento che colpisce immediatamente nell'affrontare la lettura dell'epistola è che la contrapposizione passato idealizzato vs. presente esecrato si esplica soprattutto
nell'evocazione dell'immaginario connesso col tema delle artes applicate al lusso
edilizio13: l'ossessione delle insidie insite nella casa, legate ai frequenti crolli, diviene in Eiusdem currum aspice:
Aureus axis erat, temo aureus, aurea summae
curuatura rotae, radiorum argenteus ordo.
Denique quod optimum uideri uolunt saeculum aureum appellant. 11 Mi riferisco naturalmente al tema del conuicium saeculi, molto frequentato dai retori citati da Seneca
padre e molto presente anche in Seneca filosofo: qualche esempio ho discusso recentemente in Ritratto di
famiglia. Seneca e i suoi nella «Consolatio ad Heluiam», Atti del Convegno internazionale (Milano-Pavia
2-6 Maggio 2000): Gli Annei. Una famiglia nella storia e nella cultura di Roma imperiale, Como 2003,
pp. 339-356. 12Non può certo soddisfare il pur ampio commento di S. BLANKERT, Seneca (epist. 90) over Natuur en
Cultuur en Posidonius als zjin bron, Amsterdam 1941, che si occupa soprattutto di rintracciare il pensiero
di Posidonio; molto succinto e di taglio divulgativo il più recente commento di C.D.N. Costa, Seneca 17
Letters, Warminster 1988. 13 Si veda P. ESPOSITO, Parsimonia e «luxuria» edilizia: Seneca e alcuni eccessi neroniani, «Vichiana»
3ª serie, 4, 1993, pp. 211-221; P. PENSABENE PEREZ, I marmi in Seneca: residenze fastose ed
esecrazione del lusso, in P. PARRONI (a cura di), Seneca e il suo tempo, Atti del Convegno internazionale
di Roma-Cassino 11-14 Novembre 1998, Roma 2000, pp. 91-109. Utile anche il saggio di M. PANI, La
polemica di Seneca contro le «artes» (Ep. 90). Un caso di sconcerto, in Potere e valori a Roma fra
Augusto e Traiano, Bari 1992, pp. 99-112.
6
Seneca una sorta di rischio più profondo ed esistenziale, causato da altri, e più
sottilmente incombenti, pericoli contemporanei14.
Vediamo in sintesi i passi che sembrano più utili al nostro discorso: dopo aver sostenuto (§ 7) che "questi congegni di tetti che sorgono su tetti, di città che incalzano
città" (has machinationes tectorum supra tecta surgentium et urbium urbes prementium) sono stati originati non certo dalla filosofia, come sembra avesse affermato Posidonio,
ma dalla gula e dalla luxuria, entità moralisticamente negative, quasi personificate15,
sviluppa un motivo importante della dialettica interna del suo discorso al § 9, che si apre con le polemiche affermazioni: Mihi crede, felix illud saeculum ante architectos fuit,
ante tectores ("Credimi, veramente fortunata fu quella generazione che non conobbe architetti, che non conobbe decoratori") e continua con le seguenti argomentazioni:
9 Ista nata sunt iam nascente luxuria, in quadratum tigna decidere et serra per designata currente certa
manu trabem scindere;
nam primi cuneis scindebant fissile lignum.
Non enim tecta cenationi epulum recepturae parabantur, nec in hunc usum pinus aut abies deferebatur
longo uehiculorum ordine uicis intrementibus, ut ex illa lacunaria auro grauia penderent. 10 Furcae
utrimque suspensae fulciebant casam; spissatis ramalibus ac fronde congesta et in procliue disposita
14 Molti elementi della polemica senecana sono già presenti in un lungo conuicium anti-luxuria di Papirio
Fabiano in Sen. contr. 2, 1, 11 sg., non a caso maestro del filosofo (lo nota E. PASOLI, Scienza e tecnica
nella considerazione prevalente del mondo antico: Vitruvio e l'architettura, in Scienza e tecnica nelle
letterature classiche, Genova 1980, pp. 63-80, in particolare p. 73 n. 21): si legga per es. Primum, si inde
incipere uelis, aedes ipsas, quas in tantum extruxere ut, cum domus ad usum ac munimentum paratae
sint, nun c p er icu lo , non pra es id io <sint>: tanta altitudo aedificiorum est tantaeque uiarum
angustiae ut neque aduersus ignem praesidium nec ex ruinis ullam [uillam] in partem effugium sit. § 12
Ad delicias dementis luxuriae lapis omnis eruitur, caeduntur ubique gentium siluae aeris ferrique usus,
iam auri quoque, in extruendis et decorandis domibus, nempe u t anx ii et in te rd iu et no cte ru inam
ignemque m etuan t qui siue tectis iniectus est <siue> fortuitus, ruinae et incendia illa urbium excidia
sunt quippe non defendunt sua, sed in communi periculo ad praedandum <ut> hostes <discurrunt
appetunt>que aliena, et in suis domini a ualidioribus caeduntur <accenduntur> alia ipsaque cum
maxume flagrantia spolium ex alienis ruinis feruntur. 15 Vd. S. CITRONI MARCHETTI, Plinio il vecchio e la tradizione del moralismo romano, Pisa 1991, pp.
116 sgg.; P. MANTOVANELLI, 'Perversioni' morali e letterarie in Seneca, in P. FEDELI (a cura di),
Scienza, cultura, morale in Seneca, Atti del Convegno di Monte S. Angelo (27-30 settembre 1999), Bari
2001, pp. 53-86, in particolare pp. 72 sgg.
7
decursus imbribus quamuis magnis erat. Sub his tectis habitauere [sed] securi: culmus liberos texit,
sub marmore atque auro seruitus habitat.
Il makarismós del § 9 riguarda la vita umana ante architectos, ante tectores, una
polemica di viva attualità, probabilmente incrementata dal maggior spazio guadagnato nella considerazione sociale da categorie come quella degli architetti, che, come
vediamo dalle prefazioni di Vitruvio16, tendevano a presentarsi ormai come intellettuali, senza troppi complessi d'inferiorità nei confronti, per esempio, dei filosofi. I tectores
sono invece artigiani17 specializzati nel rifinire e completare gli edifici con ornamenti in
legno e stucco, artigiani del lusso secondo Seneca18, che tagliavano a squadra le assi e con mano sicura e veloce procedevano a segare secondo linee segnate, a differenza degli
uomini primitivi dell'età aurea, che come leggiamo nel verso delle Georgiche 1, 144 riportato al § 9 "per primi tagliavano il legno coi cunei rendendolo cedevole”.
Immediatamente dopo la polemica senecana si focalizza contro il lusso,
identificato col fasto della sala da pranzo, la cenatio (termine che proprio a partire da quest'età si specializza con questo valore19), luogo deputato alle epulae, all'ostentazione
di una luxuria, che ha bisogno di esibirsi platealmente20. L'attenzione senecana si sposta
16 PASOLI, art. cit., pp. 73 sgg. mette giustamente l'accento sulla possibilità che la polemica senecana sia
anche contro Vitruvio. Sul ruolo dell'architetto nella società romana contemporanea è da leggere E.
ROMANO, La capanna e il tempio: Vitruvio o dell'architettura, Palermo 1987. 17 Sui tectores, che lavoravano al fianco dei pictores negli interni e degli scultori negli esterni (lo stucco
veniva utilizzato come sostituto del marmo), vd. N. BLANC, Les stucateurs romains: témoignages
littéraires, épigraphiques et juridiques, «MEFRA» 95, 1983, pp. 859-907, in particolare p. 887. 18 Concezione presente anche nell'epist. 88, dedicata al tema delle artes: vd. § 18 In illo feras me necesse
est non per praescriptum euntem; non enim adducor ut in numerum liberalium artium pictores recipiam,
non magis quam statuarios aut marmorarios aut ceteros luxuriae ministros, da leggere col commento ad
loc. di A. STÜCKELBERGER, Seneca 88. Brief. Über Wert und Unwert der freien Künste, Heidelberg
1965. 19 Cfr. Y. PERRIN, La «Domus aurea» et l'idéologie néronienne, in E. LEVY (a cura di), Le système
palatial en Orient, en Grèce et à Rome, Actes du Colloque de Strasbourg 19-22 Juin 1985, Leiden 1987,
p. 388. 20 Sul carattere profondamente moralistico delle descrizioni di banchetti si sofferma con osservazioni
acute C. TORRE, Il banchetto di «luxuria» nell'opera in prosa di Seneca, «Paideia» 52, 1997, pp. 377-
396.
8
sulle conseguenze che le nuove dispendiose abitudini provocano nella città di Roma,
dove il procedere delle lunghe ed ininterrotte teorie di carri che trasportano i materiali
per costruire i lacunaria auro grauia, "i soffitti appesantiti d'oro" tanto cari ai Trimalchioni contemporanei, suscita una sorta di innaturale 'terremoto' sugli alti edifici
circostanti (uicis intrementibus)21: non a caso, direi, sono qui evocati la pinus e l'abies22, che sono tradizionalmente anche i materiali usati per la costruzione della prima e
nefasta nave, Argo, che dette inizio non solo alla vicenda di Medea, ma anche alla
hybris della navigazione, topos tradizionale nell'ambito del mito delle età23; potremmo dire che i carri procedono per le vie di Roma, oltraggiandone la sacralità e la
tranquillità, come Argo aveva osato violare le onde del mare, contribuendo idealmente a porre fine all'età dell'oro.
Il primitivismo senecano porta il filosofo (§ 10) a idealizzare invece la capanna
primitiva, la casa delle origini, come la casa Romuli, ancora visibile sul Campidoglio24 e della quale aveva già parlato con accenti di nostalgico rimpianto dall'esilio in Corsica
scrivendo alla madre Elvia25: il quadro che il filosofo intende offrire ai nostri occhi (§
21 BLANKERT, op. cit., ad loc. cita Plin. paneg. 51 Idem tam parcus in aedificando quam diligens in
tuendo. Itaque non, ut ante, immanium transuectione saxorum urbis tecta quatiuntur; stant securae
domus nec iam templa nutantia (anche se Plinio si riferisce ai tempi di Domiziano è un passo egualmente
molto significativo e valido anche per gli eccessi edilizi dell'età neroniana). 22 Cfr. per es. Enn. scen. vv. 246 sgg. V.2 Utinam ne in nemore Pelio securibus / caesae accidissent
abiegnae ad terram trabes; Catull. 64, 1 Peliaco quondam prognatae uertice pinus; Ov. met. 1, 94-96
Nondum caesa suis, peregrinum ut uiseret orbem, / montibus in liquidas pinus descenderat undas, /
nullaque mortales praeter sua litora norant. 23 Ottima documentazione ed analisi in F. BELLANDI-E. BERTI-M. CIAPPI, «Iustissima Virgo». Il Mito
della Vergine in Germanico e in Avieno, Pisa 2001, in particolare sulla navigazione pp. 51 sgg.; 167 sgg.;
174 sg. 24 Si parlava anche di una casa Romuli sul Palatino, ma sicuramente la più celebrata era sul Campidoglio,
come si evince da Vitruv. 2, 1, 5 item in Capitolio commonefacere potest et significare mores uetustatis
Romuli casa e, nell'ambito della polemica moralistica, soprattutto da Sen. contr. 1, 6, 4: Nudi <hi> stetere
colles, interque tam effusa moenia nihil est humili casa nobilius: fastigatis supra tectis auro puro fulgens
praelucet Capitolium. Potes obiurgare Romanos quod humilitatem suam cum obscurare possint
ostendunt, et haec non putant magna nisi apparuerit ex paruis surrexisse? 25 Si veda cons. ad Heluiam 9, 2-3 Quo longiores porticus expedierint, quo altius turres sustulerint, quo
latius uicos porrexerint, quo depressius aestiuos specus foderint, quo maiori mole fastigia cenationum
9
10) è quello di una capanna sorretta da rustiche furcae, col tetto coperto di rami secchi e
di fronde ammassate, tale comunque già da consentire il deflusso corretto delle acque;
una descrizione della costruzione delle dimore umane primitive, che trova notevoli punti di contatto con Vitruvio 2, 1, 326, maggiori certo rispetto a quanto si sia fino ad oggi
genericamente osservato27. Diversamente da Vitruvio, Seneca insiste su un dato non tecnico, ma psicologico: in quelle umili dimore gli uomini primitivi abitavano non solo
securi28, ma sotto l'umile culmus essi erano anche veramente liberi, mentre ora sub
marmore atque auro seruitus habitat29. E' evidente che questa sententia conclusiva, marcatamente antitetica, stigmatizza
il presente senza ambiguità e fa intravedere chiari risvolti autobiografici da parte di un Seneca, cui anche Tacito nel noto discorso a Nerone di ann. 14, 54 fa dire, tra l'altro,
nell'atto di abbandonare il proprio prestigioso ruolo accanto all'imperatore, cum opes
meas ultra sustinere non possim. Nell'epistola 90 è inoltre facile percepire una forte influenza della letteratura
augustea, che da Virgilio ad Ovidio aveva identificato nella casa, nella capanna
subduxerint, hoc plus erit quod illis caelum abscondat. In eam te regionem casus eiecit in qua
lautissimum receptaculum casa est: ne [et] tu pusilli animi es et sordide se consolantis, si ideo id fortiter
pateris quia Romuli casam nosti. [...] Nullus angustus est locus qui hanc tam magnarum uirtutium
turbam capit. 26 Vitruv. 2, 1, 3 Efficiebant in dies meliora genera casarum. Cum essent autem homines imitabili
docilique natura, cotidie inuentionibus gloriantes alius alii ostendebant aedificiorum effectus, et ita
exercentes ingenia certationibus in dies melioribus iudiciis efficiebantur. Primumque furci s e rec ti s et
uirgulis interpositis luto parietes texerunt. [...] Posteaquam per hibernas tempestates tecta potuerunt
imbres sustinere, fastigia facientes, lu to indu c to pro c lina t is t ect is , stillicidia deducebant. Per
alcuni confronti utili BLANKERT, op. cit., pp. 126 sgg.; PASOLI, art. cit., pp. 74 sg. 27 Naturalmente una base dottrinale comune poteva essere costituita da opere di Posidonio: vd. per es. per
gli aspetti etnografici quello che osserva K. REINHARDT, Poseidonios, München 1921, pp. 79 sgg. 28 Vd. CITRONI MARCHETTI, op. cit., pp. 133 sg. 29 Il tema era già stato affrontato altrove: vd. per es. epist. 8, 5 [...] domus munimentum sit aduersus
infesta temporis. Hanc utrum caespes erexerit an uarius lapis gentis alienae, nihil interest: s c i to te tam
bene ho min em cu lmo quam au ro teg i. Contemnite omnia quae superuacuus labor uelut
ornamentum ac decus ponit; cogitate nihil praeter animum esse mirabile, cui magno nihil magnum est.'
Da leggere col ricco commento di G. SCARPAT, Brescia 1975, pp. 178 sg.
10
semplice dei contadini del buon tempo andato30, molti ideali della restaurazione
augustea, che in questo caso venivano anche a coincidere col gusto letterario
alessandrino, che nello spazio della dimora rustica aveva voluto ambientare anche storie di eroi (basterà ricordare l'Ecale callimachea). Anche nel passo che ci interessa si
colgono chiari segnali di queste presenze: non saprei dire con certezza se tutti denotino intento allusivo (nell'epistola oltre a citazioni dirette da Virgilio e Ovidio, si individuano
chiare allusioni a questi poeti31) o si rivelino mere sedimentazioni mnemoniche di
letture: certo è che in ogni caso risultano significative testimonianze di un preciso gusto letterario, confermato in modo inequivocabile da Seneca poeta tragico32. Basterà citare
alcuni termini di origine rustica, ma nobilitati dalla tradizione letteraria, come culmus, molto probabilmente desunto da memorie virgiliane33 oppure ramalia34, che mi sembra
30 Povere dimore che nel presente erano riservate ai soli popoli barbari, come leggiamo con accenti
pretacitiani in Sen. prou. 4, 14 sgg. (un tema di probabile derivazione posidoniana, cfr. G.
PFLIGERSDORFFER, Fremdes und Eigenes in Senecas 90.Brief an Lucilius, in J. STAGL (a cura di),
Aspekte der Kultursoziologie. Aufsätze zur Soziologie, Philosophie, Anthropologie und Geschichte der
Kultur. Zum 60.Geburtstag von M. Rassem, Berlin 1982, p. 313, che non cita comunque il de prou.):
Omnes considera gentes in quibus Romana pax desinit, Germanos dico et quidquid circa Histrum
uagarum gentium occursat: perpetua illos hiemps, triste caelum premit, maligne solum sterile sustentat;
imbrem cu lmo au t frond e d e fendun t , super durata glacie stagna persultant, in alimentum feras
captant. Miseri tibi uidentur? nihil miserum est quod in naturam consuetudo perduxit; paulatim enim
uoluptati sunt quae necessitate coeperunt. 31 Gli echi rilevati sono in riferimento al solo mito delle età: si veda per es. A. NOVARA, «Rude
saeculum» que l'âge d'or selon Sènèque, «BAGB»1988, pp. 129-139; e soprattutto M. ARMISEN-
MARCHETTI, Le statut moral de l’homme primitif chez Sénèque: anthropologie, éthique, théâtre, in Les
origines de l’homme, Publications de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de Nice, 46, 1998,
pp. 197-208, in particolare p. 202 n. 24. 32 I confronti più significativi sono con le parole di Ippolito nella Phaedra, vv. 483 sgg.: una serie
notevole di loci similes è raccolta nell'articolo di A. GRILLI, Seneca di fronte a Ippolito, in Filologia e
forme letterarie. Studi offerti a F. Della Corte, Urbino 1987, pp. 305 sgg., poi anche in Stoicismo,
Epicureismo e Letteratura, Brescia 1992. 33 Vd. SCARPAT, op. cit., p. 179, a proposito di Sen. epist. 8, 5 scitote tam bene hominem culmo quam
auro tegi, che confronta Verg. Aen. 8, 654 Romuleoque recens horrebat regia culmo. Il termine è
attestato, oltre che negli scrittori di agricoltura, solo in Virgilio, Ovidio, Lucano. 34 Il termine è piuttosto raro: oltre che in Ovidio e Seneca, lo leggiamo in Persio (1, 97; 5, 59), Tacito
(ann. 13, 58), Servio (ad georg. 4, 303). A proposito delle attestazioni in Persio è da leggere F.
11
derivare con grande probabilità dall'episodio ovidiano di Filemone e Bauci nell'VIII
delle Metamorfosi (8, 644-64635), un contesto estremamente rilevante per la nostra
epistola, come del resto anche per i contemporanei Lucano e Petronio36. La pertinenza dell'ipotesto ovidiano è inequivocabilmente dimostrata dalla 'morale' conclusiva che
contrappone la sicura felicità della paupertas alla seruitus spirituale della ricchezza: met. 8, 632 sgg. (i due vecchi sposi) illa / consenuere casa paupertatemque fatendo /
effecere leuem nec iniqua mente ferendo / nec refert, dominos illic famulosne requiras: /
tota domus duo sunt, idem parentque iubentque. La retorica della capanna è del resto ben presente in Seneca poeta in passi dal tono chiaramente gnomico, come Thy. 451-
452 scelera non intrant casas, / tutusque mensa capitur angusta cibus o Phaedr. 1126- 1127 seruat placidos obscura quies / praebetque senes casa securos37 e si connette più
in generale all'elogio della paupertas38, topica molto frequente anche nella scuola di
retorica. Al di là dell'esplicita polemica con Posidonio su a chi attribuire l'escogitazione
degli strumenti artigianali (per Seneca i sapientes non possono essere coinvolti in
invenzioni che implicano un uomo che ricerca corpore incuruato et animo humum
BELLANDI, Persio. Dai «verba togae» al solipsismo stilistico, Bologna 19962, pp. 135 sg. Altra, più
vaga, eco virgiliana è forse da individuare in fronde congesta rispetto ad ecl. 1, 68 pauperis et tuguri
congestum caespite culmen, passo la cui eco, secondo SCARPAT, op. cit., p. 178 affiora nel termine
caespes di epist. 8, 5. 35 […] nutrit et ad flammas anima producit anili / multifidasque faces ramaliaque arida tecto / detulit et
minuit paruoque admouit aeno. 36 La vicenda di Filemone e Bauci ha trovato eco in Lucano, che, nell’episodio di Amicla (5, 515 sgg.), ne
mutua alcune espressioni, ma soprattutto lo utilizza come exemplum della securitas del pauper e in
contrapposizione alla smania di potere di Cesare: si veda E. NARDUCCI, Lucano. Un'epica contro
l'impero. Interpretazione della «Pharsalia», Roma-Bari 2002, pp. 258 sgg. e quanto ho scritto in Tra
Ovidio e Seneca, Bologna 1990, pp. 87 sg. e in Tra filosofia e poesia. Studi su Seneca e dintorni, Bologna
1999, pp. 42 sgg. Per quanto riguarda Petronio, il riferimento è ai versi relativi alla capanna di Enotea nel
cap. 135 del Satyricon, su cui vd. in particolare A. PERUTELLI, Enotea, la capanna e il rito magico:
l’intreccio dei modelli, «MD» 17, 1986, pp. 128 sgg. 37 Sulla consonanza con Lucano, vd. NARDUCCI, op. cit., pp. 258 sgg. 38 Ricordo anche [Sen.] Oct. 896-898 Bene paupertas humili tecto / contenta latet; / quatiunt altas saepe
procellae / aut euertit Fortuna domos.
12
spectante39), è evidente che al filosofo interessa contrapporre costantemente passato e
presente, mettendo in luce la degenerazione prodotta dal lusso contemporaneo, che
esercita l'ingenium esclusivamente nell'escogitare (§15) futilità raffinatissime, come i condotti che permettono di immettere nei teatri essenze profumate, i canali che ora sono
riempiti, ora prosciugati, e soprattutto i soffitti girevoli delle sale da pranzo contemporanee, i uersatilia cenationum laquearia, che sono costruiti in modo tale da far
susseguire l'un l'altra figure, che mutano ogni volta che cambiano le portate (ita
coagmentat ut subinde alia facies atque alia succedat et totiens tecta quotiens fericula
mutentur).
La critica della luxuria contemporanea diviene quindi anche polemica accesa contro gli artigiani del lusso40, pronti a soddisfare le più astruse esigenze di una società
decadente, schiava della manualità e dimentica dei veri valori della sapientia: per il
discorso che intendo svolgere oggi è particolarmente interessante questa dettagliata descrizione dei raffinati soffitti contemporanei, mobili e pronti a modificare le loro
figure ad ogni portata della cena.
Quest'atteggiamento di Seneca appare confermato e spiegato con grande efficacia successivamente, nella parte conclusiva della lettera (§§ 35 sgg.), quando il
tema dell'età dell'oro viene chiaramente recuperato, punteggiato da citazioni dirette, ma anche da implicite allusioni a poeti41. Seneca nega che i primitivi possano dirsi
sapientes, ma rivendica agli uomini di quella età definita aurea un'innocentia, che ne fa
sicuramente dei privilegiati, in quanto dediti alla publicarum opum secura possessio e ignari dell'auaritia e della luxuria. La vera paupertas è infatti nell'ottica senecana figlia
dell'auaritia42 e nasce dalla smania insaziata di acquisire: non è povero chi non
39 BLANKERT, op. cit., ad loc., confronta Plato rep. 500b; Sen. nat. 5, 15, 3; epist. 94, 54. 40 Mi sono occupata più ampiamente di questi temi nella tradizione satirica di Orazio in una relazione
attualmente in corso di stampa: Mestieri, professioni, lavoro in Orazio fra tradizione letteraria e realtà
romana, in Politica e cultura in Roma antica, Incontro di studio in memoria di Italo Lana (Torino 16-17
Ottobre 2003). 41 Molto carente per questo aspetto il commento di BLANKERT, come si evince dall'Indice finale dei passi
confrontati. Qualche riferimento utile negli articoli che si occupano solo del tema dell'età dell'oro come
NOVARA, art. cit.; ARMISEN MARCHETTI, art. cit., in particolare p. 202 n. 24. 42 Sulla posizione senecana nei confronti della povertà e della ricchezza, osservazioni molto valide in F.
BELLANDI, Etica diatribica e protesta sociale nelle Satire di Giovenale, Bologna 1980, pp. 11 sgg.
13
possiede, ma chi non si accontenta di ciò che ha. Dopo aver percorso una serie di motivi
topici dell'età dell'oro (come ben dimostra l'anafora del modulo negativo del nondum43
al § 40: Nondum ualentior inposuerat infirmiori manum, nondum auarus abscondendo
quod sibi iaceret alium necessariis quoque excluserat: par erat alterius ac sui cura),
Seneca ritorna ad un tema predominante in questa lettera, cioè l'allusione alle ricche dimore: è un passo non breve (§§ 41-43), ma che è opportuno ripercorrere con
attenzione per il suo grande interesse letterario e filosofico:
Illi quos aliquod nemus densum a sole protexerat, qui aduersus saeuitiam hiemis aut imbris uili
receptaculo tuti sub fronde uiuebant, placidas transigebant sine suspirio noctes. Sollicitudo nos in
nostra purpura uersat et acerrimis excitat stimulis: at quam mollem somnum illis dura tellus dabat!
42 Non inpendebant caelata laquearia, sed in aperto iacentis sidera superlabebantur et, insigne
spectaculum noctium, mundus in praeceps agebatur, silentio tantum opus ducens. Tam interdiu
illis quam nocte patebant prospectus huius pulcherrimae domus; libebat intueri signa ex media
caeli parte uergentia, rursus ex occulto alia surgentia. 43 Quidni iuuaret uagari inter tam late sparsa
miracula? At uos ad omnem tectorum pauetis sonum et inter picturas uestras, si quid increpuit,
fugitis attoniti. Non habebant domos instar urbium: spiritus ac liber inter aperta perflatus et leuis
umbra rupis aut arboris et perlucidi fontes riuique non opere nec fistula nec ullo coacto itinere
obsolefacti sed sponte currentes et prata sine arte formosa, inter haec agreste domicilium rustica
politum manu - haec erat secundum naturam domus, in qua libebat habitare nec ipsam nec pro ipsa
timentem: nunc magna pars nostri metus tecta sunt.
Seneca insiste molto sul concetto della sicurezza degli uomini primitivi (tuti sub
fronde uiuebant: già prima aveva sostenuto al § 10 sub his tectis habitauere securi e parlato di secura possessio al § 38): umili dimore rustiche offrono notti tranquille sine
suspirio, mentre i ricchi uomini contemporanei nei loro letti di porpora sono tenuti
svegli da preoccupazioni non diverse dai pungoli delle torture (Sollicitudo nos in nostra
purpura uersat et acerrimis excitat stimulis); con antitesi di facile retorica ossimorica il
43 Sul mito delle età rimando al fondamentale studio di E. PIANEZZOLA, Forma narrativa e funzione
paradigmatica di un mito: l’età dell’oro latina, in Ovidio. Modelli retorici e forma narrativa, Bologna
1999, 43-61 (con ampia documentazione bibliografica). Qualche notazione utile su questo tema anche in
C. MAXIA, Seneca e l' età dell’oro, «BollstudLat» 30, 2000, 90 sgg:, che analizza l'epistola 90 soprattutto
sul piano strutturale con eccessivo schematismo interpretativo; sul motivo della descrizione per negazione
dell'età dell'oro, cfr. anche M. DAVIES, Description by Negation: History of a Thought-Pattern in Ancient
Account of Blisful Life, «Prometheus» 13, 1987, pp. 265-284.
14
filosofo nota che era paradossalmente la dura tellus primitiva ad offrire invece un
mollem somnum. Qui Seneca sembra ritornare col pensiero agli ovidiani Filemone e
Bauci, securi nel loro misero tugurio, come nella poesia contemporanea l'Amicla di Lucano, che nel V libro della Pharsalia incontra il potente Cesare e l'accoglie nella sua
umile capanna di pescatore44: anche in Lucano, come in Seneca l'attenzione è rivolta verso il sonno dei potenti contrapposto a quello degli umili45. Ricorrono nel notturno
lucaneo stereotipi già senecani46, come la sollicitudo del potente e la securitas del
pauper, motivi questi ben presenti anche in Seneca tragico, nella Phaedra per esempio, in un contesto ideologicamente determinante, la rhesis di Ippolito, che ha molti punti di
contatto con la nostra epistola: basterà almeno ricordare i vv. 520-521 certior somnus
premit / secura duro membra laxantem toro.
Non sarà così casuale che nell'epistola 90 il motivo ricorrente dei soffitti
incombenti (non impendebant caelata laquearia) sia contrapposto alla contemplazione del cielo, l'insigne spectaculum noctium § 4247, accompagnato da un silenzio complice
ed appagante: Seneca si abbandona qui all'ottimismo consueto alla sua scuola ed esalta
le bellezze del cielo e le gioie della contemplazione del cosmo, la più bella delle case (pulcherrima domus48), il cui 'soffitto' è costituito dalla volta punteggiata di
costellazioni, che si muovono armoniche e silenziose. La descrizione si conclude al § 43 con un'esclamazione particolarmente efficace: Quidni iuuaret uagari inter tam late
sparsa miracula? L'ideale della vita contemplativa si condensa nell'immagine
44 Ampia e valida trattazione in NARDUCCI, op. cit., pp. 247 sgg. 45 Sul tema, cfr. già Hor. epist. 1, 7, 35; carm. 3, 1, 21 sgg. 46 Si legga Lucan. 5, 504 sgg. Soluerat armorum fessas nox languida curas, / parua quies miseris, in
quorum pectora somno / dat uires fortuna minor; iam castra silebant, / tertia iam uigiles commouerat
hora secundos: / Caesar sollicito per uasta silentia gressu / uix famulis audenda parat, cunctisque relictis
/ sola placet Fortuna comes; 515 sgg. secura […] domus, non ullo robore fulta / sed sterili iunco
cannaque intexta palustri / et latus inuersa nudum munita phaselo; 526 sgg. (Amyclas) securus belli:
praedam ciuilibus armis / scit non esse casas. O uitae tuta facultas / pauperis angustique lares! o munera
nondum / intellecta deum! 47 Sul motivo della contemplazione del cielo in Seneca, informa esaurientemente G. SOLIMANO, La
prepotenza dell'occhio. Riflessioni sull'opera di Seneca, Genova 1991, pp. 34 sgg. 48 Vd. già ad Helu. 20, 2 (animus) tum peragratis humilioribus ad summa perrumpit et pulcherrimo
diuinorum spectaculo fruitur, aeternitatis suae memor in omne quod fuit futurumque est uadit omnibus
saeculis.
15
suggestiva del godimento profondo indotto dal percorrere con la mente le vie del cielo,
segno evidente dell'esistenza divina e della vocazione dell'uomo, destinato a guardare
alto, a contemplare, solo tra gli esseri viventi, le meraviglie cosmiche; basterà richiamare quello che costituisce il testo fondamentale di questa concezione a Roma, le
parole dello stoico Balbo nel De natura deorum ciceroniano 2, 140: Qui (scil. deus)
primum eos humo excitatos celsos et erectos constituit, ut deorum cognitionem caelum
intuentes capere possent. Sunt enim ex terra homines non ut incolae atque habitatores
sed quasi spectatores superarum rerum. Quello che è assente nel più dottrinale e meno 'partecipato' intervento di Cotta è
l'elemento soggettivo, e quasi superomistico, che spinge Seneca ad esprimersi in termini di entusiastico ed appagante godimento, come implica chiaramente la formula quidni
iuuaret, che, al pari del precedente libebat49, appare più vicina al linguaggio poetico, dei
poeti didascalici in particolare, che avevano evocato la suggestiva possibilità di un metaforico percorso della mente attraverso le splendide vie del cielo50: il pensiero va a
Manilio (poeta la cui incidenza in Seneca è ancora in gran parte da sondare) che proprio
nel primo proemio51, caratterizzato dall'entusiasmo per intraprendere il viaggio astrale, sosteneva: iuuat ire per ipsum / aera52.
49 BLANKERT, op. cit., ad loc. confronta Aetna 227 sgg. ingenium sacrare animumque attollere caelo [...]
diuina est animi ac iucunda uoluptas. 50 Il sarcasmo caratterizza invece un passo con analoga movenza in Naturales quaestiones 1, praef. 7
Tunc iuuat inter ipsa sidera uagantem diuitum pauimenta ridere et tota cum auro suo terram; vd. anche
successivamente contemnere... lacunaria ebore fulgentia. Sulle dinamiche che oppongono talvolta
filosofia e realtà romana nell'opera è da leggere ora F.R. BERNO, Lo specchio, il vizio e la virtù. Studio
sulle «Naturales quaestiones» di Seneca, Bologna 2003, passim. 51 Un'informata analisi del proemio in L. LANDOLFI, «Integra prata». Manilio, i proemi, Bologna 2003,
pp. 11 sgg. Sulla dipendenza da Manilio della formula iuuat in Sen. nat. 1, praef. 7, vd. ancora
LANDOLFI, op. cit., p. 12 n. 3 (con opportuni riferimenti bibliografici). Mi occupo più ampiamente di
questo passo senecano in un articolo in corso di stampa su «Prometheus» dal titolo Gli sparsa miracula di
Ovidio (met. 2.193) e Seneca (epist. 90.43). 52 Manil. 1, 13 sgg. Iuuat ire per ipsum / aera et immenso spatiantem uiuere caelo / signaque et aduersos
stellarum noscere cursus. / Quod solum nouisse parum est. impensius ipsa / scire iuuat magni penitus
praecordia mundi, / quaque regat generetque suis animalia signis / cernere et in numerum Phoebo
modulante referre.
16
Che Seneca in questa breve, ma densa interrogativa si mostri suggestionato sul
piano espressivo dai poeti dimostra anche la presenza di una «iunctura» sparsa
miracula, che costituisce un vero e proprio omaggio allusivo ad Ovidio, che descrivendo il viaggio astrale di Fetonte in met. 2, 193 sg., aveva affermato:
Sparsa quoque in uario passim miracula caelo
uastarumque uidet trepidus simulacra ferarum.
Le meraviglie del cielo possono stordire chi come Fetonte non è preparato a
comprenderle, tanto che sono assimilate a dei veri e propri mostri, ma per il filosofo non suscitano certo paura, quella paura53 che attanaglia invece gli uomini contemporanei, cui
rivolge nella stessa epistola 90, 43 il seguente monito: "voi tremate di paura a ogni
rumore della casa e fra i dipinti delle vostre pareti fuggite atterriti al minimo scricchiolio"54. Come appare evidentissimo, Seneca non disgiunge mai l'aspetto
contemplativo - l'anima umana che anela a raggiungere la sede celeste, che le è congeniale e a cui può aspirare attraverso la conoscenza - dall'acuta e straniante
percezione delle angosce della società contemporanea, esemplificate dalle enormi
dimore in cui i ricchi romani si rinchiudevano, paradisi di una natura artificiale, grandi come città intere e tali da impedire il godimento degli spettacoli naturali, domus ormai
temibile in sé e per sé e non solo per i rischi che comporta. Di tutti gli spettacoli naturali, quello più connaturato all'essenza profonda
dell'uomo, è dunque la contemplazione del cielo55, cui nella realtà contemporanea si
sostituisce il ricco soffitto, pesante d'oro e di stucchi, squadrato perfettamente nei lacunaria, nei cassettoni istoriati, o addirittura, meraviglia delle meraviglie, girevole per
cambiare aspetto ad ogni portata delle cene, i uersatilia cenationum laquearia, che
53 Sulla paura dei contemporanei, legata alla ricchezza e al potere, si veda quanto ho scritto, a proposito
delle tragedie, in Tra filosofia e poesia, cit., pp. 42 sgg. 54 Cfr. Sen. epist. 96, 1 Familia decubuit, fenus offendit, domus crepuit, damna, vulnera, labores, metus
incucurrerunt: solet fieri; Phaedr. 495 nec omnes conscius strepitus pauet; benef. 4, 6, 2 Si domus tibi
donetur, in qua marmoris aliquid resplendeat et tectum nitidius auro aut coloribus sparsum, non
mediocre munus uocabis; ingens tibi domicilium sine ullo incendii aut ruinae metu struxit, in quo uides
non tenues crustas et ipsa, qua secantur, lamna graciliores, sed integras lapidis pretiosissimi moles, sed
totas uariae distinctaeque materiae, cuius tu paruula frusta miraris, tectum uero aliter nocte, aliter
interdiu fulgens: negas te ullum munus accepisse? 55 Motivo molto frequente in Seneca: ricordo oltre al finale dell'ad Heluiam (cit. supra, n. 48), benef. 4, 5,
1-4, 6, 3 (un lungo elogio dei numerosi munera offerti all'uomo dalla provvidenzialità divina).
17
abbiamo incontrato al §15: ci troviamo di fronte a quella che definirei una vera e propria
ossessione del soffitto, luogo deputato ad offrire ai ricchi gaudenti Romani raffinate
sorprese, come ben sappiamo da altre fonti letterarie. Come non ricordare la spettacolare meraviglia56 che viene dal soffitto a stupire
gli attoniti commensali della cena di Trimalchione nel Satyricon 60, 157 quando “all'improvviso i lacunaria cominciarono a scricchiolare e tutto il triclinio tremò.
Atterrito saltai in piedi e temetti che qualche funambolo scendesse giù attraverso il tetto.
Anche gli altri commensali mirantes erexere uultus, con meraviglia alzarono in su gli sguardi, attendendo quale novità si preannunciasse dal cielo. Ecco che allora, apertosi il
soffitto, viene calato giù un grosso cerchio, tolto da una botte certo di grandi dimensioni, lungo la cui intera circonferenza stavano appese corone d'oro con vasetti di
profumo in alabastro”.
I diducta lacunaria di Trimalchione, soffitti apribili e girevoli in forza di meccanismi simili a quelli scenici58, altro non sono che la riproduzione in scala ridotta
(e piuttosto approssimativa, come dimostra la ruota ricavata alla meglio da una botte), in
una casa privata di un ricco parvenu, di quella che era con ogni probabilità la lussuosa e dispendiosa procedura dei banchetti nella coeva domus imperiale; basterà a confermarlo
un famoso passo della vita svetoniana di Nerone, che descrive le meraviglie della Domus Aurea59, Nero 31, 3:
56 Su questo aspetto spettacolare del Satyricon, vd. C. PANAYOTAKIS, «Theatrum Arbitri». Theatrical
Elements in the Satyrica of Petronius, Leiden - New York - Köln 1995. 57 Petron. 60, 1-3: r epen te la cunar ia sona re co eperunt totumque triclinium intremuit.
Consternatus ego exsurrexi et timui ne per tectum petauristarius aliquis descenderet. Nec minus re l iqu i
conuiua e m iran tes e rexere uul tus , expectantes quid noui de caelo nuntiaretur. Ecce autem
d iduc t is la cunar ibus subito circulus ingens, de cupa uidelicet grandi excussus, demittitur, cuius per
totum orbem coronae aureae cum alabastris unguenti pendebant. 58 Vd. infatti per es. Plin. nat. 36, 117 Theatra iuxta duo fecit amplissima ligno, cardinum singulorum
versatili suspensa libramento. 59 Uno studio ancora valido, almeno per le tematiche che più ci interessano, è costituito da A. BOËTHIUS,
Nero's Golden House, «Eranos» 44, 1946, pp. 442-459. Per quanto riguarda la descrizione dei resti della
Domus Aurea, molto utile il volumetto della Soprintendenza Archeologica di Roma curato da E.
SEGALA-I. SCIORTINO, Domus Aurea, Roma 1999.
18
In ceteris partibus cuncta auro lita, distincta gemmis unionumque conchis erant; cena t iones
laqu eatae tabu li s eburn eis uersa t il ibus , ut flores fistulatis, ut unguenta desuper
spargerentur; praecipua cenationum rotunda, quae p erp etuo d iebus ac no c tibu s u ice
mundi cir cu mag er etur .
Colpisce nella descrizione di Svetonio60, che non conosceva che indirettamente la
domus neroniana, la compresenza nella sfarzosa dimora imperiale dei soffitti mobili e della cenatio rotunda, di una sala da pranzo circolare dal soffitto girevole, che
riproduceva il moto del cosmo e l'alternarsi del giorno e della notte: prescindendo dal
problema squisitamente archeologico, cioè se questa sala descritta da Svetonio possa essere identificata con la sala ottagonale dell'attuale Domus aurea61, è per noi molto
significativo che il soffitto presenti una sorta di 'cielo artificiale', spettacolarizzazione
della natura, che paradossalmente tiene lontano l'uomo dall'osservazione del più meraviglioso degli spettacoli donati all'uomo dalla divinità, il cielo stellato62. Quello che
mi interessa quindi sottolineare è la presenza di un soffitto, che 'imita' il moto degli astri nel cielo, che si sostituisce alla visione dello spettacolo per eccellenza, il moto cosmico:
60 Cfr. il ricco commento di K.R. BRADLEY, Suetonius' Life of Nero. An Historical Commentary,
Bruxelles 1978, ad loc.; con la bibliografia citata a p. 170; sul nome stesso di Domus Aurea, si vedano le
diverse interpretazioni discusse a p. 173. Un'analisi del passo svetoniano, sul piano anche letterario, offre
anche M. BLAISON, Suétone et l'ekphrasis de la Domus Aurea (Suét., Ner. 31), «Latomus» 57, 1998, pp.
617-624 (da correggere comunque quanto si legge a p. 618 n. 9 che «tous les archèologues s'accordent à
reconnaître dans la salle octagonale de l'aile orientale la cenatio rotunda dont parle Suétone»: vd. infatti
quanto osservato nella nota seguente). 61 Si tratta di un problema dibattutissimo e sul quale c'è una bibliografia ricchissima; mi limito a citare i
titoli più recenti e più documentati per la questione che ci interessa da vicino: una buona dimostrazione
della possibile identificazione della cenatio rotunda con la sala ottagonale offre, a mio parere, l'articolo di
H. PRÜCKNER-S. STORZ, Beobachtungen im Oktogon der Domus Aurea, «RM» 81, 1974, pp. 323-339;
ulteriori utili considerazioni e bibliografia anche in E. CHAMPLIN, God and Man in the Golden House, in
Horti Romani, Atti del Convegno Internazionale (Roma 4-6 maggio 1995), a cura di M. CIMA e E. LA
ROCCA, Roma 1998, pp. 333-344; E.M. MOORMANN, “Vivere come un uomo”. L'uso dello spazio nella
«Domus aurea», Ibid., pp. 345-361. 62 Non sarà un caso che un esempio contemporaneo di raffigurazione dello zodiaco sia presente in un
piatto presentato da Trimalchione ai suoi commensali, in cui si coniugano cattivo gusto e arte 'raffinata' di
un cuoco di nome Daedalus: Petron. 35, 1-5 Laudationem ferculum est insecutum plane non pro
expectatione magnum nouitas tamen omnium conuertit oculos.
19
non sarà forse un caso che in Lucrezio l'aggettivo uersatile fosse impiegato invece per
configurare proprio il mundi magnum templum in un passo63 della conclusione del V
libro, dove si tratta della storia dell'umanità come nell'epistola 90. Del resto, per inciso, è appena il caso di ricordare che fino da Ennio le metafore per descrivere il cielo hanno
spesso un'evidente matrice architettonica64, come ha ben ribadito Sebastiano Timpanaro in uno dei suoi ultimi contributi.
Seneca, che è costantemente un acuto e spietato osservatore della realtà
contemporanea, ha sicuramente in mente, se non ancora davanti agli occhi, progetti edilizi neroniani65, derivati probabilmente da modelli di palazzi e sale delle corti
orientali66, che preludono all'edificazione di quel monstrum, che apparve ai
contemporanei la 'villa' divenuta enorme palazzo imperiale: il racconto di Tacito ann. 15, 42 conferma come la costruzione, una lussuosissima villa suburbana artificialmente
collocata al centro di Roma67, fosse sentita come una forma di oltraggio non solo alla
città, ma alla natura stessa (come si evince da termini come miraculum per la costruzione e machinatores68 per i 'dedalici' architetti): Ceterum Nero usus est patriae
63 5, 1436 sgg. At uigiles mundi magnum uersatile templum / sol et luna suo lustrantes lumine circum /
perdocuere homines annorum tempora uerti. 64 S. TIMPANARO, La volta celeste e il cielo stellato in Ennio, «SCO» 1996, pp. 29-59; soprattutto 35
sgg. 65 Non mi sembra che basti a negare ogni riferimento alla Domus aurea la cronologia, incerta, della
lettera 90: lo sostiene J.-M. ANDRÉ, Sénèque et la topographie de Rome, in Neronia VI, Rome à l'époque
néronienne, Actes du VIe Colloque international de la SIEN (Rome, 19-23 mai 1999), Bruxelles 2002,
pp. 170-177 (l'osservazione che ci interessa è a p. 175 n. 26). 66 Cfr. BOËTHIUS, op. cit., pp. 447 sgg., che parla di influssi persiani e partici; cfr. anche il commento di
BRADLEY, op. cit., p. 180. 67 Sulla valutazione dell'edificio come 'villa', si leggano le considerazioni di BOËTHIUS, art. cit., pp. 442
sg.; CHAMPLIN, art. cit., pp. 334 sg.; P. GROS, La transfiguration du modèle de la domus dans les palais
néroniens de Rome: l'exemple de la «suite du nymphée» de la Domus Aurea, in Neronia VI, Rome à
l'époque néronienne, Actes du VIe Colloque international de la SIEN (Rome, 19-23 mai 1999), Bruxelles
2002, pp. 55 sgg. Sul nuovo assetto urbanistico neroniano, cfr. P. SOMMELLA, Note sull'aspetto
urbanistico di Roma nell'età neroniana, in P. PARRONI (a cura di), Seneca e il suo tempo, Atti del
Convegno internazionale di Roma-Cassino 11-14 Novembre 1998, Roma 2000, pp. 123-134. 68 Non dimentichiamo le parole di Seneca nell'epistola 90, 7-8: Ego uero philosophiam iudico non magis
excogitasse has machinationes tectorum supra tecta surgentium et urbium urbes prementium quam
20
ruinis extruxitque domum in qua haud proinde gemmae et aurum miraculo essent, solita
pridem et luxu uulgata, quam arua et stagna et in modum solitudinum hinc siluae inde
aperta spatia et prospectus, magistris et machinatoribus Seuero et Celere, quibus
ingenium et audacia erat etiam quae natura denegauisset per artem temptare et uiribus
principis inludere. Se il passo senecano di epist. 90, 15, che parla di uersatilia cenationum laquearia,
è stato talvolta69, ma non sempre, messo in relazione con le meravigliose
machinationesdella domus neroniana, mi sembra importante porre l'accento anche su un altro luogo della lettera 90, che non mi consta invece essere stato discusso a questo
proposito: al § 43 Seneca, riferendosi agli uomini primitivi, sostiene Non habebant domos instar urbium ("non possedevano case grandi come città"). Mi sembra di
avvertire qui la chiara eco di un Leitmotiv popolare antineroniano, che stigmatizzava
con feroce ironia il fervore edilizio del principe per quella dimora che, come leggiamo in Tac. ann. 15, 52, era inuisa et spoliis ciuium extructa, motivo chiaramente
testimoniato in versi anonimi70 citati da Svetonio (Nero 39, 2) Roma domus fiet: Veios
migrate, Quirites, / si non et Veios occupat ista domus, e poi ripreso anche da Marziale epigr. 2, 4 unaque iam tota stabat in urbe domus71.
Ma i soffitti contemporanei con i loro misteriosi meccanismi, così presenti nell''immaginario edilizio' della lettera 90, possono evocare non solo sfarzose
meraviglie, ma anche insidie mortali, come apprendiamo ancora da un noto passo della
vita svetoniana di Nerone, relativo ai molteplici tentativi dell'imperatore di liberarsi dell'ingombrante presenza della madre Agrippina72, Nero 34, 2:
uiuaria piscium in hoc clausa ut tempestatum periculum non adiret gula et quamvis acerrime pelago
saeviente haberet luxuria portus suos in quibus distinctos piscium greges saginaret. 69 Senza pretese di completezza tra i contributi prima citati, ricordo solo PRÜCKNER-STORZ, art. cit., pp.
334 sgg.; BRADLEY, op. cit., p. 179; SOMMELLA, art. cit., pp. 125 sg. (tutti studi che sembrano giungere
indipendentemente alle stesse conclusioni). 70 Su questi versi nell'ambito della poesia popolare, documentazione in G. CUPAIUOLO, Tra poesia e
politica. Le pasquinate nell'antica Roma, Napoli 1993, p. 73. 71 Interessante anche benef. 7, 10, 5, dove Seneca, in un conuicium anti-luxuria ricorda, aedificia priuata
laxitatem urbium magnarum uincentia. 72 Vedi anche la versione dell'episodio in [Sen.] Oct. 316-318 fertur in altum prouecta ratis, / quae
resoluto robore labens / pressa dehiscit sorbetque mare.
21
Verum minis eius ac uiolentia territus perdere statuit; et cum ter ueneno temptasset
sentiretque antidotis praemunitam, lacun ar ia , quae noctu sup er dormientem
lax a ta machin a d ecid er en t, p ar au it . Hoc consilio per conscios parum celato,
solutilem nauem, cuius uel naufragio uel camarae ruina periret, commentus est73.
Nerone, che fa progettare un soffitto a cassettoni, che di notte per un cedimento del meccanismo (laxata machina) potesse crollare sulla madre mentre dormiva, sembra
costituire una perfetta spiegazione dei pericoli che si celano a palazzo e delle paure che
Seneca vede annidarsi nella casa stessa: inoltre è altresì evidente come l'abilità degli architetti e degli artigiani contemporanei, al servizio della saeuitia imperiale74, potesse
arrivare ad escogitare strumenti di morte come una solutilis nauis, che si sarebbe sfasciata o per naufragio o per il crollo del soffitto75.
Il pericolo può dunque venire dal soffitto e questo tema doveva essere presente
anche nella predicazione moralistica greca, se lo leggiamo già con accenti simili di polemica anti-luxuria in un'epoca che ancora non aveva raggiunto gli eccessi di fasto
dell'età imperiale, vale a dire in Cicerone a proposito di un episodio notissimo anche a noi per la sua proverbialità, la spada di Damocle, narrato con dovizia di particolari in
73 Il verbo implica una ricerca degenerata o inutile, come già spesso anche in Seneca: così nella lettera
90, 14 Quomodo, oro te, convenit ut et Diogenen mireris et Daedalum? Uter ex his sapiens tibi videtur?
qui serram commentus est, an ille qui, cum vidisset puerum cava manu bibentem aquam, fregit protinus
exemptum e perula calicem <cum> hac obiurgatione sui: 'quamdiu homo stultus supervacuas sarcinas
habui!', qui se conplicuit in dolio et in eo cubitavit?; 90, 23 sg Non multum afuit quin sutrinum quoque
inventum a sapientibus diceret. Omnia ista ratio quidem, sed non recta ratio commenta est; cfr. anche per es. epist. 14, 5 quidquid aliud praeter haec commenta saevitia est; 78, 23 Hoc enim iam luxuria
commenta est: ne quis intepescat cibus, ne quid palato iam calloso parum ferveat, cenam culina
prosequitur; 86, 8 Aliquid noui luxuria commenta est. 74 Non a caso un' analoga escogitazione funesta sarà operata da Eliogabalo per soffocare suoi cortigiani:
Script. Hist. Aug., Heliogabalus 21, 5 Oppressit in tr ic l in ii s u ersa t i l ibu s parasitos suos uiolis et
floribus, sic ut animam aliqui efflauerint, cum er<e>pere ad summum non possent. 75 Cfr. anche Tac. ann. 14, 3 Obtulit ingenium Anicetus libertus, classi apud Misenum praefectus et
pueritiae Neronis educator ac mutuis odiis Agrippinae invisus. Ergo navem posse componi docet cuius
pars ipso in mari per artem soluta effunderet ignaram. Su questo episodio, vd. C. FERONE, Suet. Nero
34 e la nave di Agrippina, «RhM» 147, 2004, pp. 80-87.
22
Tusc. 5, 61-6276. La setola equina che scende dal soffitto a cassettoni, sospendendo una
spada sulla testa dell'adulatore Damocle, voglioso di sostituirsi all'invidiato tiranno
Dionigi, materializza nell'immaginario comune, con plastica icasticità77, non un generico pericolo, ma i rischi cui si espone chi viene a contatto col potere, che affascina
coll'abbagliante splendore della ricchezza, ma può nascondere insidie incombenti: non ci si può avvicinare al potere senza correre dei rischi, come è ben chiaro anche nel
recupero del tema nell'ode 3, 1 di Orazio e soprattutto nella stringata sentenziosità di
Persio 3, 4078. Qual'è dunque per Seneca l'antidoto ai veleni dei falsi valori contemporanei, proposto
anche nella lettera 90? E' la filosofia (cfr. §§ 44-46), che lungi dall'aver insegnato agli 76 Quamquam hic quidem tyrannus ipse iudicauit, quam esset beatus. Nam cum quidam ex eius
adsentatoribus, Damocles, commemoraret in sermone copias eius, opes, maiestatem dominatus, rerum
abundantiam, magnificentiam aedium regiarum negaretque umquam beatiorem quemquam fuisse, 'Visne
igitur' inquit, 'o Damocle, quoniam te haec ita delectat, ipse eam degustare et fortunam experiri meam?'
Cum se ille cupere dixisset, iussit hominem in aureo lecto strato pulcherrimo textili stragulo, magnificis
operibus picto, abacosque compluris ornauit argento auroque caelato. Tum ad mensam eximia forma
pueros delectos iussit consistere eosque nutum illius intuentis diligenter ministrare. 62 Aderant unguenta
coronae, incendebantur odores, mensae conquisitissimis epulis extruebantur. Fortunatus sibi Damocles
uidebatur. In hoc medio apparatu fulgentem gladium e lacunari saeta equina aptum demitti iussit, ut
impenderet illius beati ceruicibus. Itaque nec pulchros illos ministratores aspiciebat nec plenum artis
argentum nec manum porrigebat in mensam iam ipsae defluebant coronae denique exorauit tyrannum ut
abire liceret, quod iam beatus nollet esse. Satisne uidetur declarasse Dionysius nihil esse ei beatum, cui
semper aliqui terror impendeat? Atque ei ne integrum quidem erat, ut ad iustitiam remigraret, ciuibus
libertatem et iura redderet; iis enim se adulescens inprouida aetate inretierat erratis eaque commiserat,
ut saluus esse non posset, si sanus esse coepisset. 77 Può essere interessante ricordare come anche nella tragedia senecana l'immaginario del potere si
traduca in metafore architettoniche, come ha ben messo in luce G. ROSATI, La scena del potere. Retorica
del paesaggio nel teatro di Seneca, in «Hispania terris omnibus felicior». Premesse ed esiti di un
processo di integrazione, Atti del Convegno int., Cividale del Friuli, 27-29 settembre 2001, Pisa 2002,
pp. 232 sgg. 78 Hor. carm. 3, 1, 17 sgg. Destrictus ensis cui super inpia / ceruice pendet, non Siculae dapes / dulcem
elaborabunt saporem, / non auium citharaeque cantus / somnum reducent: somnus agrestium / lenis
uirorum non humilis domos / fastidit umbrosamque ripam, / non Zephyris agitata Tempe; Pers. 3, 40 et
magis auratis pendens laquearibus ensis / purpureas subter ceruices terruit. Sulla natura dell'aneddoto, di
23
uomini arti manuali, che tengono inchiodato il loro sguardo alla terra, li sospinge verso
il cielo a contemplare le armonie del cosmo, astraendoli dalle miserie della storia,
lontano dai rumori convulsi della vita contemporanea, li invita a vivere teste caelo, "sotto gli occhi del cielo", come afferma Ippolito nella rhesis della Phaedra (v. 525).
Il pessimismo sulla storia passata e presente trova la sua consolazione nel viaggio astrale della mente, nel riconoscimento dell'eternità di una bellezza armoniosa e
rasserenante, che osserva senza interrogare, che sfida la natura senza oltraggiarla: l'età
dell'oro del filosofo è un locus amoenus della mente, che non si situa nella mitica aurea
aetas, ma che ne recupera gli accenti descrittivi come i perlucidi fontes79 e i prata sine
arte formosa (§ 43); il ritorno alla primitiva innocenza, depurata dalle scorie dell'inquinamento morale della civiltà contemporanea80, porta il filosofo ad un
'ottimismo relativo', perché comunque, come leggiamo nel grandioso finale del terzo
libro delle Naturales quaestiones, l’uomo nuovo che rinascerà purificato dalle acque del diluvio sarà anch’esso destinato a subire una successiva degradazione sul piano morale
(3, 30, 8): Omne ex integro animal generabitur dabiturque terris homo inscius scelerum
et melioribus auspiciis natus. Sed illis quoque innocentia non durabit, nisi dum noui
sunt. Cito nequitia subrepit: uirtus difficilis inuentu est.
Rita Degl'Innocenti Pierini Università di Firenze
cui non conosciamo attestazioni prima di Cicerone, cfr. J. VAN WAGENINGEN, De Damoclis gladio,
«Mnemosyne» 1905, pp. 317-329: me ne occuperò più ampiamente in altra sede. 79 L'immagine richiama il linguaggio topico delle descrizioni dei loca amoena (cfr. per es. la descrizione
della fonte Aretusa in Sen. cons. ad Marciam 17, 3 Videbis celebratissimum carminibus fontem
Arethusam, nitidissimi ac perlucidi ad imum stagni, gelidissimas aquas profundentem; Apul. met. 5, 1
Videt lucum proceris et uastis arboribus consitum, uidet fontem uitreo latice perlucidum), ma anche
l'esaltazione stoica della bellezza della natura: non a caso ricorre già in Cic. nat. 2, 98 Adde huc fontum
gelidas perennitates, liquores perlucidos amnium. 80 Sul rapporto di Seneca con la natura, cfr. P. FEDELI, Seneca e la natura, in P. PARRONI (a cura di),
Seneca e il suo tempo, Atti del Convegno internazionale di Roma-Cassino 11-14 Novembre 1998, Roma
2000, pp. 25-45.