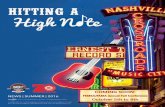I diritti delle donne negli statuti dello Specchio Sassone e il concetto di bona fama e mala fama...
Transcript of I diritti delle donne negli statuti dello Specchio Sassone e il concetto di bona fama e mala fama...
I diritti delle donne negli statuti dello Specchio
Sassone e il concetto di bona fama e mala fama nel
medioevo tedesco
Con il presente scritto mi pongo l’obiettivo di mostrare quali
fossero le circostanze discriminanti da parte delle autorità
nei confronti delle donne nel medioevo tedesco, basandomi su
una fonte storica, ovvero quella degli statuti dello Specchio
Sassone e, successivamente, su un saggio che tratta di forme
gestuali sulle miniature dello Specchio Sassone.
Incentro il mio lavoro prevalentemente su un discorso di
carattere giuridico che riguarda le discriminazioni delle
donne nel XIII secolo nelle terre tedesche.
Come fonti ho scelto lo “Specchio Sassone” del giurista Eike
von Repgow, redatto tra il 1220 e il 1230 e il saggio di M. H.
Caviness e C. G. Nelson “Silent witnesses, absent women, and
the law courts in Medieval Germany” (2003). Essi cercano di
interpretare, grazie ai gesti dei personaggi riprodotti nelle
miniature dello Specchio Sassone, il ruolo delle donne nei
confronti delle autorità (maschili). Con la storiografia
“Sexualisierte Gewalt 1500-1850, Plädoyer für eine historische
Gewalforschung” di Francisca Loetz (2012) concludo il discorso
con due accusatorie concrete di Zurigo degli anni 1536 e 1539.
Dopo il contesto storico-giuridico in Germania tra il X e il
XIII secolo ed una breve presentazione dello Specchio Sassone,
primo documento giuridico del medioevo tedesco, prenderò in
esame le rubriche e i paragrafi di questa fonte giuridica per
analizzare le disuguaglianze tra uomini e donne. Aggiungerò
alle mie “scoperte” le osservazioni di Caviness e Nelson i
quali si sono occupati del concetto della bona fama e mala
fama delle miniature nel manoscritto sassone.
Infine presenterò due accusatorie di Zurigo degli anni 1536 e
1539, dove le donne offese chiamano gli accusati davanti al
giudice collegando il concetto di mala fama e bona fama
all’integrità sessuale. Il mio lavoro si basa su testi scritti
in lingua tedesca e inglese. Oltre a tradurre molti testi, ho
cercato di esprimere i concetti principali nel modo più
facilmente comprensibile. Spero che questo lavoro, malgrado
tratti terre lontane, possa suscitare interesse.
1. Contesto storico-giuridico in Germania tra il X e il XIII
secolo
Lo ius romanum costituiva la principale fonte di diritto in
vaste zone dell'Impero Romano che però venne deposto in
seguito alle invasioni barbariche. Ma già nel 533,
l'imperatore romano d'Oriente Giustiniano I emanò il corpus iuris
civilis anche detto corpus iuris justinianeum, una raccolta di materiale
normativo e giurisprudenziale di tutte le antiche leggi romane
ma anche di leggi nuove.
Ma le continue invasioni barbariche ostacolarono il
diffondersi del corpus iuris justinianeum nel continente Europeo,
limitato ai territori dell'Italia meridionale, riducendolo a
mero ius comune.1 Il diritto romano non era però sparito del
tutto. Nell’alto medioevo venne mantenuto in vita da tribunali
ecclesiastici e si sviluppò progressivamente nell'Europa
continentale dal X secolo in poi. Il diritto giustinianeo sarebbe
diventato la base per la reintroduzione del diritto romano in
tutto l’Occidente Europeo, come anche in terre tedesche.
Con la morte di Carlo Magno, l’impero carolingio si disgregò
in innumerevoli feudi e solo più tardi, con Ottone I fu
riunificato sotto un unico potere.2 Gli imperatori del Sacro
Romano Impero erano visti come diretti successori di Cesare.
Grazie a questa auctoritas tramandata loro dal passato e
incoronati dal Papa, gli imperatori erano detentori del
plenitudo potestatis, termine coniato da Papa Leone I detto Magno
(440-461), che significava essere in possesso legittimo di
entrambi i poteri, quelli spirituali e quelli temporali.
In seguito l'insistenza degli imperatori romano-germanici
di proclamarsi diretti successori dell'Impero romano, in
particolare della dinastia ottoniana di Sassonia, favorì,
poi grazie anche alle università, la reintroduzione del
diritto romano in Occidente, andando a rimpiazzare le
tradizioni giuridiche degli invasori germanici.3
1 Franco Cardini, storico e saggista italiano e Marina Montesano, Storia Medievale, Firenze, Le Monnier Università/Storia, 2006, p. 97 "È questo il famoso Corpus iuris civilis, nel quale Giustiniano dettò le sue nuove leggipreoccupandosi però di armonizzarle coerentemente con quelle antiche. Tale monumento alla sapienza giuridica di Roma sarebbe stato alla base della rinascita degli studi giuridici e delle istituzioni politiche della stessa Europa; e costituisce ancora oggi il fondamento sul quale si appoggiano i sistemi giuridici di gran parte dei paesi del mondo”2 National Geographic, Storica, numero 33, novembre 2011, pp. 723 Franco Cardini e Marina Montesano, Storia Medievale, Firenze, Le Monnier Università/Storia, 2006, pag. 179 "La pretesa di questi re di atteggiarsi aimperatori romani non fu priva di risultati anche importanti: essa fu ad
Nel 936 Ottone I di Sassonia, Re di Germania4, riunificò i
territori carolingi e nel 962 fu incoronato da Papa
Giovanni XII in San Pietro Imperatore del Sacro Romano
Impero. Alla dinastia ottoniana ne susseguirono altre di
origine germanica come i Salici, i Billunghi e Welfen-
Brunswick, fino ad arrivare al periodo degli Hohenstaufen,
famiglia nobile originaria della Svevia.5
Tuttavia, il diritto romano restò marginale fino alla fine della
dinastia sveva e soltanto
con la dinastia salica si cominciò a ricorrere isolatamente al
diritto romano, che divenne poi indispensabile presupposto per un
impero unito da un dominus mundi.6
esempio uno dei motivi per cui, a partire dalla metà del XII secolo, il diritto romano rientrò nell'Europa occidentale e -anche grazie al lavoro che fu allora espletato nelle università- s'impose come nuovo diritto sostituendosi in tutto o in massima parte alle precedenti tradizioni giuridiche ereditate dai germani delle invasioni."4 Pirenne, Storia d’Europa dalle invasioni al XVI secolo, Grandi Tascabili Economici Newton, 2010, pp.113: „In realtà, non esiste re di Germania; il re si chiamerà Rex Romanorum, come l’imperatore: Imperator Romanorum. Non ci sono termini per indicare la Germania.“5 Treccani.it, Enciclopedia italiana online, Scienza giuridica, regno di Germania, di Bernhard Diestelkamp, Federiciana (2005): “Quanto fosse modesta l'influenza del diritto romano in Germania fino alla fine dell'età sveva, emerge anche dal fatto che i cataloghi di libri ‒ comunque tramandati solo raramente ‒ delle istituzioni ecclesiastiche fino al 1200 circa comprendevano pochi manoscritti relativi a leggi civili e nel corso del XIII sec. il loro numero subisce solo gradualmente un lieve incremento.” Franco Cardini e Marina Montesano, Storia Medievale, Firenze, Le Monnier Università/Storia, 2006, pag. 179 "La pretesa di questi re di atteggiarsi a imperatori romani non fu priva di risultati anche importanti:essa fu ad esempio uno dei motivi per cui, a partire dalla metà del XII secolo, il diritto romano rientrò nell'Europa occidentale e -anche grazie al lavoro che fu allora espletato nelle università- s'impose come nuovo diritto sostituendosi in tutto o in massima parte alle precedenti tradizioni giuridiche ereditate dai germani delle invasioni."6 http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_comune, 11 luglio 2013: “Alla concezione universalistica e sovranazionale medievale del Sacrum imperium, inteso come Sancta romana respublica universale e indivisibile, non poteva in effetti non fare riscontro una visione universalistica anche nella sfera
Fu soltanto durante l’impero degli Hohenstaufen, soprattutto
sotto Federico I detto Barbarossa, nel cosiddetto "secolo
legale" a cavallo tra il XII e il XIII, che queste leggi si
svilupparono. In questo periodo fu avviato il lavoro legale.
Il Medio Evo era arrivato ad un punto di svolta. Si parla
anche di una "rinascita della cultura giuridica" (Wiedergeburt
der Rechtskultur), una rinascita della procedura civile in cui
il diritto romano rifiorì.
In terre germaniche, fino a Federico II Hohenstaufen (1220 -
1250), le consuetudini giuridiche erano orali. Con il secondo
imperatore svevo iniziarono a fiorire i primi testi
manoscritti sulle leggi vigenti e la formalità processuale
aumentò.
2. Lo Specchio Sassone, il primo documento giuridico del
medioevo tedesco
Dal XII secolo in poi il diritto romano, il diritto canonico e
il diritto feudale longobardo dell'Italia settentrionale
iniziarono ad influenzare lentamente il sistema giuridico
medievale dell’Europa centrale e settentrionale.
Il diritto romano si dovette adattare alle legislazioni
regionali, alle raccolte giurisprudenziali, agli statuti
urbani e ai costumi locali. Si può presumere che questi
"diritti stranieri" diedero un impulso significativo al
del diritto: ad un unico impero non poteva che corrispondere un solo diritto (ius commune), volto a disciplinare la vita giuridica di tutti i popoli riuniti nell’Impero e partecipi di un comune patrimonio di valori spirituali e culturali. Il rinnovato Impero romano-cristiano era considerato come posto al servizio del genere umano per volontà divina e l’unum ius in grado di regolare i rapporti intersoggettivi era ritenuto il diritto romano, ossia il Corpus iuris civilis”.
diritto locale ed furono quindi responsabili della stesura dei
primi documenti giuridici tedeschi.
In terre germaniche, il diritto esisteva solo attraverso una
serie di statuti, carte, frasi orali e attraverso la
giurisprudenza. Pochi tedeschi avevano frequentato
un’università, ed è in quest’ambiente che bisogna valutare la
portata del lavoro del cavaliere e giurista Eike von Repgow
che, per primo, con lo “Specchio Sassone” (Schachsenspiegel),
ci fornisce per iscritto la prima raccolta normativa del
medioevo tedesco. Redatto su incarico del principe Hoyer von
Falkenstein tra il 1220 – 1230, lo “Specchio Sassone”
costituisce il primo e quindi il più antico tentativo di
fissare leggi tribali germaniche su un codice manoscritto. Il
titolo parla da sé: proprio come si può guardare il volto allo
specchio, così i sassoni avrebbero, secondo l’autore, potuto
vedere ciò che era giusto e lecito, e ciò che non lo era nel
loro libro della legge. Lo Specchio Sassone è stato redatto
nel monastero cistercense di Altzelle (Kloster Altzelle). La
prima versione, scritta in latino, è purtroppo andata persa,
mentre la seconda, in volgare, ci è pervenuta.7 Lo Specchio
dei Sassoni non è soltanto il più prestigioso e il più antico
codice di leggi tedesche medioevali ma anche il primo testo
letterario in prosa composto in medio basso tedesco. È uno dei
primi testi in prosa in medio basso tedesco (elbostfälisch-
niederdeutsch) che si è mantenuto nel tempo e che ha un valore
linguistico rilevante.
Prima della sua stesura, la legge medievale in Germania era un
diritto consuetudinario di tradizione orale, caratterizzata7 T. Fenster e D. L. Smail, FAMA, The Politiks of talk and reputation in medieval Europe, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, pp. 48
dal peso della tradizione, dall'importanza della
sperimentazione e della ricerca di un compromesso. Il
Sachsenspiegel non deve essere considerato come una
peculiarità soltanto tedesca, ma è da considerarsi l’inizio di
una partecipazione della Germania agli sviluppi generali
europei. Entrò a far parte dei grandi studi del diritto
consuetudinario (Gewohnheitsrechts) in Europa, ossia degli
studi che nacquero ovunque tra il XII e il XIII secolo in
Europa occidentale.
È da notare che lo Specchio Sassone comprende soltanto il
diritto della popolazione rurale (Landrecht), suddiviso in tre
libri, per un totale di 325 rubriche, dove sono introdotti dei
diritti sia papali che imperiali,8 e quello dei cavalieri
(Lehenrecht) che consiste in un unico libro con 78 rubriche.
Eike von Repgow non introduce il diritto delle città
(Stadtrecht). Ciò non sorprende, sapendo che in Sassonia nel
XIII secolo non esistevano centri che si potessero definire
città (come p.es. in Italia).9 Ci troviamo in una civiltà
puramente agricola e in un contesto feudatario con tanto di
domini terrea.
La Chiesa aveva i propri tribunali che convivevano con i
tribunali secolari.
8 Eike von Repgow, Der Sachsenspiegel, Manesse Verlag Zürich, testo in copertina: „Nei libri del Landrecht ci sono i diritti del papa e dell’imperatore come anche le regole fondamentalo della convivenza ordinaria.“9 Pirenne, Storia d’Europa dalle invasioni al XVI secolo, Grandi Tascabili Economici Newton, 2010, pp. 236, nota 6: „All’epoca, tranne che lungo il Reno, le città germaniche incominciavano appena a svilupparsi.“
Eike von Repgow ha voluto mettere per iscritto la tradizione
giuridica del suo popolo e presentare il diritto come parte
dell'ordine cristiano.10
In breve, il sistema giuridico medievale era caratterizzato
dall’oralità, dall’eterogeneità e dalla disuguaglianza
rispetto all’ambito di validità territoriale e personale.
Tipico del sistema giuridico medievale era la posizione
contrastante dei diversi gruppi sociali; si distingueva tra
persone religiose e secolari e tra contadini e nobili. I servi
dei nobili, grazie al potere giuridico dei loro padroni,
potevano amministrare la giustizia in modo arbitrario. Grazie
a diritti scritti come lo Specchio Sassone, la legislazione
divenne più trasparente, organica e ordinata.
Come ci insegna Henri Pirenne, il mondo feudale germanico era
strutturato in modo gerarchico:
“Nel X secolo, gli Stati europei vedevano nascere una
classe sociale giuridica nuova, la nobiltà [...] la sola,
nella società laica, a possedere diritti politici. Il
diffondersi del sistema del grande feudo, da un punto di
vista giuridico, degradava la popolazione rurale,
riducendola a uno stato di servitù più o meno completa.
[...] Dal X secolo, la parola liber assumeva il significato
di nobilis. Questi uomini liberi conservavano il diritto di
portare le armi. Le proprietà permettevano loro di
mantenere un cavallo da guerra. La nobiltà, in realtà, era
10 Eike von Repgow, Der Sachsenspiegel, Manesse Verlag Zürich, pp.30: „Adesso che siamo convertiti e Dio ci ha ripreso nella sua grazia, ci atteniamo ai suoi diritti, che ci hanno insegnato i suoi profeti e persone pie appartenenti al clero come anche i re cristiani: Costantino e carlo, dei quali la terra sassone trae ancora oggi le sue leggi.“
l’esercito; i nobili, prima di tutto guerrieri. Accanto a
loro c’era un’altra classe di uomini liberi, i vassalli
(che in Germania si chiamavano Lehnsmannen, responsabili
soltanto del loro feudo) che vivevano del loro feudo ed
erano uomini d’armi. A differenza dei primi, la loro
posizione non era ereditaria. Accanto a questi uomini
liberi [...] ve ne erano altri non-liberi. Erano servi
robusti e fedeli che in guerra i signori assumevano come
guardie del corpo (Dienstmannen) [...] le quali, sopratutto
in Germania, formavano l’aristocrazia della servitù.
Come regola generale, il contadino di quell’epoca era un
non-libero.”11
La struttura fortemente gerarchica si poteva ben rappresentare a
forma di piramide con al vertice il re, seguito dal clero (oratores),
poi seguivano i vassalli che erano nobili feudatari (bellatores).
11 Pirenne, Storia d’Europa dalle invasioni al XVI secolo, Grandi TascabiliEconomici Newton, 2010, pp. 85 e 122-124
Alla base i servi liberi e quelli della gleba (laboratores). I nobili
amministravano la giustizia e imponevano delle tasse.
3. Disuguaglianze di genere riscontrato nello Specchio Sassone
Il lavoro di Eike von Repgow è suddiviso, come già menzionato,
in due temi: da un lato l’autore tratta il diritto
territoriale (Landrecht) dall’altro lato tratta il diritto
feudale (Lehnsrecht).
Il Landrecht trattava argomenti relativi all'ordine medievale
come la successione testamentaria, il diritto matrimoniale o
il diritto di proprietà, mentre la legge feudale regolava le
relazioni feudali tra feudatario e vassallo.
Nel Landrecht riscontriamo alcune rilevanti informazioni sulla
posizione delle donne giudicate inferiori agli uomini.
Indistintamente dal rapporto processuale nel quale si trovava
una donna, essa aveva comunque bisogno di essere rappresentata
da un “protettore” maschile, chiamato Munt. In medio alto-
tedesco la parola “Munt” significa mano o protezione.
Già nel primo libro del Landrecht c’è scritto inequivocabilmente
per tali casi:
Le ragazze e le donne devono avere per ogni tipo di
querele un protettore, affinché non possano essere citate
in giudizio, per quello che avrebbero affermato o fatto in
tribunale. [...]12
Già con questo primo esempio dello Specchio Sassone vengono
messe in risalto, inequivocabilmente, le discriminazioni
contro le donne per una generale incapacità di intendere e di
volere.
La ragione che la donna fosse affidata, soltanto a causa della
sua debolezza specifica di genere, alla tutela di un uomo, non
può essere assunta come esauriente. Nel Sachsenspiegel è
presente anche un altro elemento per la tutela delle donne.
Queste, come d’altronde anche gli ebrei, i sagrestani, i preti
e i pastori, non erano autorizzate al porto d’armi e dato che
un processo medievale veniva concepito come una battaglia, si
riteneva opportuno non lasciare che si esponessero senza
appoggio.13
Per quanto riguarda lo status giuridico delle donne, il
concetto del Munt svolge un ruolo centrale, perché la donna
non era sotto tutela soltanto in questioni procedurali, ma
anche nella vita quotidiana. Fino al suo matrimonio era il
padre o il prossimo parente maschio ad esercitare l’autorità
del Munt. Con il matrimonio, la donna arrivava ad essere sotto
la tutela del marito, con il risultato della sua totale
dipendenza economica:
12 Eike von Repgow, Der Sachsenspiegel, Manesse Verlag Zürich, primo libro del Landrecht rubrica 46, pp.70: "Maget unde wif moten vormunde hebben an iewelker klage, da man sie nicht anhand dessen überführen könne, was sie vor Gericht sprächen oder täten.”13 Eike von Repgow, Sachsenspiegel, Landrecht. I, 48, § 3
"Se un uomo prende una donna come sposa, diventa il suo
legittimo protettore e ha quindi il diritto di prendere
anche tutti i suoi beni.14
Per il matrimonio consensuale o per il rapporto sessuale
vigeva il cosiddetto principio di consenso (Konsensprinzip);
vale a dire che con il consenso del suo protettore (Muntherr),
spesso il padre della sposa, e sotto protezione di un
protettore autorizzato (Traungstutor), di solito un chierico, la
donna era data in moglie al suo futuro marito.
Il marito non poteva essere citato in giudizio dalla moglie,
perché suo protettore, contrariamente però, in quanto sua
protetta, il marito era giuridicamente responsabile della
donna.
Un elemento chiave del diritto di famiglia era quello del
matrimonio e dell'eredità, che ci fa capire meglio le
questioni concernenti l’eredità in caso di decesso di un
coniuge.
Il matrimonio regolare era, come appena spiegato, il
matrimonio contrattuale detto anche Muntehe (connubio con il
protettore), cioè un accordo tra la parentela della donna e
l'uomo. Il padre della sposa consegnava al genero l'autorità
su sua figlia. Il marito dava alla famiglia della sposa un
certo patrimonio, mentre la sposa portava una dote. Questa
dote forniva un’indennità di diritto ereditario della donna
sul patrimonio del padre.
14 Eike von Repgow, Der sachsenspiegel, Manesse Verlag Zürich, primo libro del Landrecht rubrica 31, § 2, pp.61, 62: „Swen en man wif nimt, so nimt hein sine were al er gut to rechter vormuntscap."
Il matrimonio diventava giuridicamente legale con l’atto
sessuale. Dopo la notte di nozze la sposa riceveva dallo sposo
il dono del mattino detto morgengabio (Morgengabe), il giorno
immediatamente dopo la prima notte di nozze. Questo regalo era
anche chiamato praetium virginitatis o morgincapitis.15 Il morgengabio
rappresentava una sorta di pensione vedovile, ma solo con la
morte del marito.
“Ascoltate ora cosa un uomo di ceto cavalleresco può
regalare a sua moglie per morgengabio. Quando di mattina si
reca a tavola con lei, prima della colazione, le può
regalare senza consenso degli eredi un servo o una serva,
non ancora adulti e un appezzamento e una camera ed
animali di campo.”16
Il morgengabio apparteneva alla vedova ma durante il matrimonio
la coppia non aveva possedimenti distinti.
Durante tutta la vita i beni della coppia sono indivisi.
Una donna non può vendere i propri beni senza il consenso
del marito.17
15 Giosuè Musca, Il Mezzogiorno normanno-svevo e le Crociate: atti, Università di Bari. Centro di studi normanno-svevi, 200216 Eike von Repgow, Der Sachsenspiegel, Manesse Verlag Zürich, primo libro del Landrecht rubrica 20, § 1, pp. 51, 52: „Nun vernehmt, was ein mann von ritterlichem Stand seiner Frau zur Morgengabe schenken darf. Am Morgen, wenn er mit ihr zu Tische sitzt, vor dem Frühstück, kann er ihr ohne Zustimmung der Erben einen Knecht oder eine Magd schenken, die noch nicht erwachsen sind, und Zaun und Zimmer und feldgängiges VieM.“17 Eike von Repgow, Der Sachsenspiegel, Manesse Verlag Zürich, primo libro del Landrecht rubrica 31, § 1, pp. 60, 61: „Mann und Frau haben zu lebzeiten ungeteilten Besitz. Eine Frau kann von ihrem Besitz nichts ohne Einwilligung des Mannes verkaufen.“
Il marito, essendo il protettore legale, aveva diritto
illimitato d’uso (Vermögensvormundschaft) dell'intero patrimonio
e i guadagni comuni generati erano di proprietà dell’uomo.
Per questi motivi, le donne non potevano fare dei regali ai
loro mariti. Nel primo libro del Landrecht nel paragrafo 2 della
rubrica 31 si apprende inoltre:
"Se un uomo prende una donna come sposa [...] prende anche
tutti i suoi beni. Per questo motivo una donna non può
fare nemmeno un regalo a suo marito dal suo patrimonio
personale [...].18
Anche il guadagno, effettuato dalle donne lavorando, non era
legalmente considerato separatamente. La donna era
praticamente esclusa dal commercio pubblico per tutta la sua
vita.
Alla morte di un coniuge, i beni venivano separati, si
disfacevano con queste conseguenze per l’eredità:
- I beni propri venivano dati in eredità ai discendenti
legittimi.
- Per diritto ereditario dello Specchio Sassone alle donne
toccava la metà degli approvvigionamenti, la propria dote
e il dono del mattino. Ove la moglie moriva prima
18 Eike von Repgow, Der Sachsenspiegel, Manesse Verlag Zürich, primo libro del Landrecht rubrica 31, § 1, pp. 60, 61: „Swen en man wif nimt, so nimt he in sine were al er gut. Deshalb kann eine frau ihrem Mann auch keine Geschenke machen von ihrem Grundeigen [...]"
dell'uomo, la dote veniva restituita alla sua famiglia, a
meno che non ci fossero figli con diritto ereditario.
- La donna doveva obbedire all'uomo, mentre lui aveva il
permesso di castigarla. Nell’atto giuridico lei dipendeva
da suo marito in quanto sotto la sua tutela.
Lo Specchio Sassone si occupa anche di due altre forme di
matrimonio, vale a dire il cosiddetto Kebsehe e il matrimonio
Friedelehe.
Nel primo caso si tratta di una forma già esistente nell’alto
medioevo.
La parola medievale “Kebse” significa concubina mentre "Ehe"
deriva dalla parola medievale “ewa” che sta per legge. Un
Kebsehe veniva concluso tra un uomo libero, di stato alto, come
un padrone terriero, e una donna di stato basso come una donna
non libera (serva della gleba).19
Il secondo è quello che veniva concluso con un atto pubblico,
mentre le famiglie della sposa e dello sposo rimanevano
estranee.
"Friedel" deriva dalla parola medievale "friudiea", che
significa amante. "Ehe" deriva, come già detto, dal termine
alto tedesco medio "ewe", che significa legge, giustizia.
Caratteristico per il Friedel era che il marito non risultava
protettore della donna e che il matrimonio si basava su un
accordo volontario tra l'uomo e la donna, dove entrambi
avevano il desiderio di sposarsi.
19 Artikel Minderehe in Haberkern, Eugen / Wallach, Joseph Friedrich : Hilfswörterbuch für Historiker. Mittelalter und Neuzeit. Bd. 2, 5. Aufl., München : Francke Verlag, 1977, pp. 427
Lo Specchio Sassone tratta queste diverse forme di matrimonio
in merito alle conseguenze che ne derivano sia sullo stato
sociale sia sui figli, nel primo libro del Landrecht in modo
dettagliato.
Il diritto del Sachsenspiegel riteneva la copula carnalis,
l'unione fisica, come consumazione del matrimonio con valore
giuridico sia nell’ambito della comunità sia nell’ambito
sociale: in caso di differenza di classi sociali il matrimonio
non si sarebbe potuto fare fin dall'inizio anche se certe
volte succedeva. A questo proposito apprendiamo nello Specchio
Sassone che in caso di una disuguaglianza di ceto la donna
acquisiva la classe sociale del marito (anche se questi era
inferiore) ma in caso di decesso del coniuge, la moglie
ricadeva sotto la protezione del proprio padre o del prossimo
parente di genere maschile, ritornando al vecchio ceto.
Se un uomo non è di pari ceto della moglie, resta comunque
il suo protettore e lei di stato sociale del marito. [...]
Ma se lui muore sarà libera dei diritti del ceto di suo
marito e riacquisisce i diritti del suo ceto di nascita.
Per questo motivo il prossimo parente deve essere, come
suo protettore, della famiglia di suo padre e non del
marito decesso.20
20 Eike von Repgow, Der Sachsenspiegel, Manesse Verlag Zürich, primo libro del Landrecht rubrica 45, § 2, pp. 69, 70: „Wenn ein Mann seiner Frau nichtebenbürdig ist, so ist er doch ihr Vormund und sie seine Standesgenossin [...] Wenn er aber stirbt, so ist sie von seinem Recht frei und erhält das Recht ihres eigenen Geburtsstandes zurück. Aus diesem Grund muss auch der nächste männliche Verwandte von der Seite ihres Vaters und nicht von der Seite ihres Mannes ihr Vormund sein."
Nel diritto ereditario la donna era gerarchicamente secondaria
alla cerchia ristretta del marito. Lei ereditava soltanto nel
caso che nessun figlio, padre o fratello del defunto marito
erano ancora in vita. Tuttavia, le era concesso il diritto
d'usufrutto dell’appezzamento, inoltre le era permesso di
tenere per se la dote e il morgengabio (donum propter nuptias) come
immobili, gioielli o bestiame ricevuti da suo marito come
segno di ringraziamento per la sua dedizione fisica (o
verginità / dos propter nuptias, pretium virginitatis,
praemium pudicitiae).
Eppure per quel che concerneva il diritto penale, lo
Sachsenspiegel tutelava la donna, in modo particolare, contro
i reati sessuali. Lo stupro era punibile con la morte,
indifferentemente dal ceto della donna. Questo si spiega
perché a quell’epoca ci si sforzava di dare più peso alla
sicurezza e all'ordine pubblico. Mediante punizioni pubbliche
si cercava di diminuire il diritto a difesa personale.
Lo Specchio Sassone non conosceva però una punizione per danni
verso l’onore (fama) sessuale femminile. Dal punto di vista
odierno ci sorprende la pratica legale germanica in cui, in
caso di stupro, veniva punito non solo l'autore del reato, ma
anche gli oggetti e gli animali coinvolti. Infatti, veniva
distrutto l’edificio nel quale si era verificato lo stupro.
Anche gli animali presenti all’atto venivano decapitati.
Nella rubrica numero 13 del primo libro del Landrecht vengono
elencate dettagliatamente tutte le conseguenze in caso di
stupro:
Ascoltate quali editti vengono emessi per atti criminosi
[...] chi ammazza un uomo, lo cattura oppure lo saccheggia
o lo brucia non per un incendio doloso, oppure stupra una
donna o una ragazza, se rompe la pace e quelli (uomini e
donne) sorpresi nell’adulterio verranno decapitati.21
Ma è la prima rubrica del terzo libro del Landrecht a spiegare
che
In caso di stupro di donne o ragazze:
§ 1: Per nessun delitto si deve distruggere un edificio
del villaggio, tranne in caso che una donna o una ragazza
sia stata stuprata nel suo interno o che ci sia stata
portata dopo lo stupro [...] Tutti gli esseri viventi
presenti all’atto carnale devono essere decapitati.22
In caso d’adulterio, entrambi i partner, se colti in
flagrante, erano puniti con la morte.
Il Sachsenspiegel, per quanto riguarda la punizione, non
faceva alcuna differenza tra uomini e donne.
Eppure c’era una discriminante a favore delle donne in
gravidanza. In questi casi, esse potevano essere punite
21 Eike von Repgow, Der Sachsenspiegel, Manesse Verlag Zürich, secondo librodel Landrecht, rubrica 13, § 1 - 5, pp. 69, 70: „.Nun vermehrt von Verbrechen, welches Gericht darüber ergeht. [...] Wer einen Mann erschlägt oder fängt, oder ausraubt oder verbrennt ohne Mordbrand, oder eine frau oder Mädchen vergewaltigt, den Frieden bricht, und die, die im Ehebruch ergriffen werden, denen soll man den Kopf abschlagen."22 Eike von Repgow, Der Sachsenspiegel, Manesse Verlag Zürich, terzo libro del Landrecht, rubrica 1, § 1, pp. 160: „Wenn Frauen oder Mädchen vergewaltigt werden. Wegen keinerlei Verbrechen soll man Gebäude im Dorf niederlegen, es se denn, dass ein Mädchen oder eine Frau darin vergewaltigtoder vergewaltigt dorthin gebracht worden ist. Allen Lebewesen, die bei derVergewaltigung zugegen waren, denen soll man den Kopf abschlagen.”
soltanto "sulla pelle e sui capelli”, così si decideva di
tagliar loro i capelli o di flagellarle oppure, come si può
vedere su questa miniatura, entrambe le cose.23 La donna
gravida veniva legata ad un palo e dopo averle tagliato i
capelli veniva picchiata con una frusta particolare, detta
"Staupbesen". 24
4. Il concetto della bona fama e della mala fama nello Specchio
Sassone
La storica dell'arte M. H. Caviness e il germanista C. G.
Nelson affermano nel loro saggio “Silent witnesses, absent
women, and the law courts in Medieval Germany”, che le donne
nelle miniature dello “Specchio Sassone” sono rappresentate in
modo prevalentemente negativo tenendo conto dei gesti delle
mani che, secondo l’ opinione degli studiosi, simboleggiano
degli atti linguistici e che queste rappresentazioni hanno
inciso sulla posizione giuridica delle donne. Gli autori
illustrano in modo persuasivo l’importanza del gesto come
codice medievale universale in una società dove lo scambio
orale dominava ancora il costume della legge.
23 Eike von Repgow, Der Sachsenspiegel, Manesse Verlag Zürich, terzo libro del Landrecht, rubrica 3, pp. 161: „Non si deve punire una donna incinta che sulla pelle e sui capelli.24 Eike von Repgow, Der Sachsenspiegel, Manesse Verlag Zürich, terzo libro del Landrecht: immagine numero 114:“Bestrafung einer Schwangeren: Haare abschneiden, dann stäupen.“
Per i due studiosi, i gesti delle mani sono di massimo rilievo
perché indicano chiaramente che le enunciazioni delle donne
erano respinte.
Tuttavia, le loro interpretazioni sulle immagini mi sembrano
talvolta esagerate.
Ciò nonostante, nelle immagini sarebbe evidente la portata
"nella quale l’esegesi di bona fama e di mala fama erano
controllate dalla parte maschile della società.” 25
Il termine fama nei suoi vari significati medievali ha giocato
un ruolo fondamentale nella cultura orale dei tribunali (corte
di giustizia). L’esame delle rappresentazioni pittoriche e
testuali nel Schachsenspiegel ha mostrato fino a che punto le
costruzioni di bona fama e di mala fama erano controllate da
uomini. Le dichiarazioni verbali delle donne erano molto
ridotte. Nel migliore dei casi erano riferite indirettamente
dal difensore legale. La testimonianza della donna non era
così rilevante rispetto a quella che forniva l’uomo, questo in
base al diritto di nascita che sanciva la superiorità
dell’uomo sulla donna.
I due autori riprendono il discorso dello stupro e informano
il lettore che, in tal caso, la vittima del reato doveva
gridare aiuto in modo da attirare l’attenzione di testimoni
per rafforzare le sue recriminazioni affinché l'azione penale
in senso giuridico sarebbe potuta essere avviata. Vicini o
25 T. Fenster e D. L. Smail, FAMA, The Politiks of talk and reputation in medieval Europe, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, pp. 72:[...] to which the construction of bona fama and mala fama was controlled by men.
testimoni erano tenuti ad accorrere senza indugio in aiuto in
caso di un tale allarme. Eike von Repgows, l’autore dello
"Specchio Sassone” scriveva:
“In questo caso si deve correre dal giudice e gridare
aiuto contro l’ignobile assassino”.26
In caso di perpetrazione di atti di violenza contro le donne,
la semplice parola di una donna non era sufficiente.
Donne o ragazze che sporgono querela per stupro davanti
alla corte devono, con grida, querelare il delitto
pubblico e la costrizione che vogliono dimostrare.27
I due autori scrivono a questo riguardo:
"Una donna o una ragazza che afferma di essere stata
stuprata, deve farlo con strilli e pianti sia durante il
reato stesso (red-handed deed) sia durante il processo,
dove dovrà dimostrare la resistenza.28
26 Eike von Repgow, Sachsenspiegel, da http://de.wikipedia.org/wiki/Zetermordio 06.06.2013: „So fure en vor den richter und schry obir den schuldigen zcether obir mynen morder und ober des landes morder, ader wy der bruch geschen.“27 Eike von Repgow, Der Sachsenspiegel, Manesse Verlag Zürich, secondo librodel Landrecht, rubrica 64, § , pp. 151: „.Frauen oder Mädchen, die wegen Vergewaltigung vor Gericht klagen, die sollen mit Notruf die Klage erheben wegen des offenen Verbrechen un der Nötigung, die sie da beweisen will.”28 T. Fenster e D. L. Smail, FAMA, The Politiks of talk and reputation in medieval Europe, Cornell Universitz Press, Ithaca and London, 2003, pp. 68:„A woman or girl bringing charges for rape shall do so with hue and cry [gerufte] for the red-handed deed [handhafte tat] and for rape, witch si must proove.”
Poiché la donna non poteva segnalare immediatamente la
violenza carnale, come i segni della violenza subita, si
trovava in difficoltà. Gli "strilli e i pianti" erano
necessari per attirare l’attenzione e con ciò attirare dei
testimoni. I testimoni confermavano, o meno, grazie alla
querela, l’accaduto, che altri codici legali trovavano,
invece, sufficiente per stabilirne la fama.29
(fig. 5, in basso p. 58 Secondo Caviness e Nelson l'artista della minatura
va anche oltre rispetto al testo svalutando la parola della vittima)
La fama della donna ha preceduto il presentarsi dinanzi al
giudice. L’artista della miniatura rende in modo chiaro il
fatto che da sola il suo rapporto non sarebbe bastato. Lei sta
davanti al giudice ovviamente spettinata e scalza, una
condizione generalmente considerata necessaria per una
convincente prova di stupro.30
Di particolare interesse è il modo in cui la bona fama e la mala
fama si intersecano a secondo il gender nelle illustrazioni che
accompagnano il testo dello Specchio Sassone. A questo
proposito gli autori scrivono che
tra queste intersezioni ci sono divieti concernenti il
discorso pubblico femminile che assicuravano che gli
uomini in tribunale parlassero con altri uomini di donne.29 T. Fenster e D. L. Smail, FAMA, The Politiks of talk and reputation in medieval Europe, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, pp. 68:„Witnesses will corroborate, or not, her claim from common knowledge, whichother legal codes find sufficient to establish fama.”30 T. Fenster e D. L. Smail, FAMA, The Politiks of talk and reputation in medieval Europe, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, pp. 68
Per supportare l'accusa di stupro (una donna parlava di un
uomo), la prova più convincente per una donna era il suo
aspetto fisico (che doveva apparire spettinata) e non la
parola, mentre un uomo, poteva semplicemente, con un
giuramento orale, i giuramenti degli uomini erano sacri,
proclamare la sua innocenza, evitava così di esser
processato, oppure potevano chiamare in assemblea sei
testimoni che parlassero per lui.31
I due autori rivelano, nel codice di diritto tedesco, come le
donne fossero tenute a freno, mentre il discorso maschile
aveva validità. La fama era controllata dagli uomini. Diverse
figure e una chiave utile tramite lo studio dei gesti delle
mani completano questo studio dettagliato.
Ciascuna di queste situazioni è esaminata nel trattato di M.
H. Caviness e Ch. G. Nelson. Le loro analisi si basano in gran
parte sulle immagini ma facendo sempre attenzione al testo,
concentrandosi principalmente sui gesti delle mani delle
figure.
31 T. Fenster e D. L. Smail, FAMA, The Politiks of talk and reputation inmedieval Europe, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, pp. 47:„Among these intersections were proscriptions concerning women’s publicspeech that ensured that men talk to men about women in the courts. Tosupport a charge of rape (a women talking about a man), the most persuasiveevidence a woman could muster lay in her physical appearance , not her word(she had to appear disheveled). Men, on the other hand, could avoidprosecution by talking an oath of innocence, or might assemble sixwitnesses to speak on their behalf. Each of these situations is elaboratedbelow. Analyses are based largely on the images, with appropriate attentionto the text, and especially on the hand gestures of the figures when theystand for various kinds of speech that is often defamatory.
(fig. 3: I gesti nelle miniature dello Specchio Sassone Monaco:
Accademia reale bavarese delle scienze1905)32
Ci troviamo in una società in cui gli scambi verbali
occupavano ancora un posto importante nella creazione degli
atti giuridici (nascite, doti, successioni, ecc), la natura
misogina del sistema giuridico era chiara: la parola di un
uomo conta, non conta invece quella di una donna.
Calunnie o pettegolezzo, così spesso associate al discorso
delle donne, potevano essere respinti dal giuramento di un
uomo.33
D'altra parte, un numero sufficiente di testimonianze maschili
convocate in tribunale, potevano rafforzare la reputazione di
32 T. Fenster e D. L. Smail, FAMA, The Politiks of talk and reputation in medieval Europe, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, pp. 55:Figure 333 T. Fenster e D. L. Smail, FAMA, The Politiks of talk and reputation in medieval Europe, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, pp. 72:„Rumor or gossip, so often associated with women’s speech, may be dismissedby the oath-taking man.“
un uomo accusato di un reato, o lo poteva scagionare il suo
giuramento (atto sacro).
Gli uomini avevano anche il diritto, contrariamente alle
donne, di diffamare altri uomini, mentre le donne potevano
diffamare soltanto altre donne.
Si osserva che gli uomini sono meno spesso rappresentati
commettendo contravvenzioni o crimini sulle miniature dello
Specchio Sassone.
Questo pregiudizio contribuisce al fatto che essi avessero una
maggiore reputazione, una condizione che era energicamente
proclamata nel discorso autorevole degli atti discussi qui.34
Nel periodo della redazione dello Specchio Sassone, sarebbe
stato assolutamente impensabile che una donna si presentasse
da sola in tribunale per difendersi.
Nel diritto dei popoli germanici dell'antichità e del Medioevo
il cosiddetto “Munt” era indispensabile, cioè un protettore
legale come per esempio un re che difendeva il suo popolo
oppure un padre che difendeva suo figlio.35
Non importa in quali questioni legali, ma una donna avrebbe
avuto sempre il bisogno di essere spalleggiata da un “Munt”,
ossia da un protettore legale.
Gli autori ci fanno presente che
La legge sassone tace sull'argomento sulla bona fama o mala
fama degli stessi testimoni. In questi testi la coscienza
di classe e le distinzioni per quanto riguardava tali34 T. Fenster e D. L. Smail, FAMA, The Politiks of talk and reputation in medieval Europe, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, pp. 47-7235 Balard, Genet et Rouche, Le Moyen Âge en Occident, Paris, Hachette, 2003, pp. 32 e 42
testimoni avevano più rilievo e il valore di tale
testimonianza era rafforzata da una posizione sociale più
elevata: più in alto ci si trovava sulla scala sociale,
più credibile si era, si puntava a combinare fama bona con
il rango, una combinazione che ulteriormente collegava il
rango con un buon carattere. Così, al vertice della
gerarchia giuridica, c'è un altissimo ufficio, quello
dello sculdascio (Schultheiss), "funzionario di tribunale e
giudice", carica che poteva essere ricoperta solo da un
uomo o da un proprietario terriero dal carattere
impeccabile, che aveva bona fama. Le donne non potevano
aspirare a tale carica.36
Ma non sempre il protettore legale aveva la meglio sulla sua
protetta. A pagina 68 la figura 13 ci mostra due donne, una
non sposata (ragazza), indicata dai capelli sciolti, l'altra,
una moglie o vedova riconoscibile perché velata, che si
rivolgono ad un giudice seduto senza protettore e con gesti
molto ossequiosi.37
36 T. Fenster e D. L. Smail, FAMA, The Politiks of talk and reputation in medieval Europe, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, pp. 66:„The Saxon law is silent on the subject oft he good or poor reputation oft he compurgators themselves. In this most class-conscious of texts, distinctions with regard to such witnesses are more likely to be associatedwith their station in life, as if the value of such testimony was enhanced by a higher social positions: the higher up the ladder, the more credible, pointing to an association of bona fama with rank, an association that further links rank with good character. Thus, at the top of the legal hierarchy there is one very high office, that of the schultheiss, „a count’s appointed court officer and judge,“ which can be filled only by a man and a landowner of unblemished character.“37 T. Fenster e D. L. Smail, FAMA, The Politiks of talk and reputation in medieval Europe, Cornell Universitz Press, Ithaca and London, 2003, pp. 66 On folio 13v,5, two women, one unmarried as designated by her loose hair, the other veiled as a wife or widow, approach a seated judge with very deferential gestures.
Esse vanno a lamentarsi dal giudice riguardo al loro
protettore, assente, su una questione di proprietà.
“Se una ragazza o una vedova si lamenta del suo protettore
secondo il diritto del Landrecht [...], e questi non
presentandosi a corte nemmeno al terzo giorno come prevede
il diritto, viene dichiarato un cattivo protettore
(Vormund) e privato da tutti i diritti da tutore. In tal
caso sarà il giudice il protettore delle donne che le
rimetterà in possesso dei loro beni.” 38
38 Eike von Repgow, Der Sachsenspiegel, Manesse Verlag Zürich, primo libro del Landrecht, rubrica 41, pp. 67: „.Klagt ein Mädchen oder eine Witwe nachLandrecht über ihren Vormund [...] und kommt er auch nicht am dritten Gerichtstag nicht, um der Gerichtspflicht Genüge zu tun, so soll man ihn für einen schlechten Vormund halten, das heisst, man soll ihm jede Vormundschaft aberkennen. Dann sei der Richter der Frauen Vormund und setztsie von seiten des Gerichts in den Besitz ihres Gutes, das ihnen genommen worden ist..”
5. Integrità sessuale e il concetto di bona fama e mala fama
a Zurigo agli inizi del XVI secolo
La violenza sessuale era finalizzata alla sottomissione
sessuale della vittima, dovuta alla costituzione fisica molto
diversa tra donne, bambini e uomini. Ma come si reagiva di
fronte alle violenze sessuali verso le donne nella città stato
di Zurigo nel 1351, che per motivi di sicurezza contro la casa
reale degli Asburgo, entrò a far parte della Confederazione
Elvetica?
Francisca Loetz, professoressa di storia medievale a Zurigo,
si pone due domande nella sua "Requisitoria per la ricerca storica sulla
violenza": come giudicano i contemporanei zurighesi l'equilibrio
di potere tra donne e uomini? Quale asimmetria può essere
osservata tra le vittime in una prospettiva storica?39
Nel periodo a cavallo tra il medioevo e la modernità, la
giustizia e la medicina legale avevano delle ben chiare
aspettative sulle donne.
Una donna sana doveva essere in grado (teoricamente) di
difendersi contro la violenza sessuale di un uomo, al fine
di proteggere la sua integrità sessuale.40
39 Francisca Loetz, Sexualisierte Gewalt 1500-1850, Plädoyer für eine historische Gewalforschung, Campus Verlag Frankfurt/New York, 2012, pp. 70 40 Francisca Loetz, Sexualisierte Gewalt 1500-1850, Plädoyer für eine historische Gewalforschung, Campus Verlag Frankfurt/New York, pp. 70: „Einegesunde Frau war in der Lage (und hatte es zu sein), sich gegen den sexuellen Übergriff eines Mannes zu wehren, um ihre sexuelle Integrität zu
Se si confronta la città di Zurigo con le altre regioni
d'Europa dell’epoca, si possono notare molte similitudini per
quanto riguarda la violenza sessuale. In Europa, fino alla
metà del XIX° secolo, si riteneva che le donne fossero
fisicamente in grado di difendersi con successo contro gli
aggressori maschi. Le ragazze madri o donne “non protette” con
una mala fama, invece, erano equiparate a prostitute, non
avevano in sostanza alcuna possibilità di citare in giudizio
con successo un aggressore per stupro. In caso di "stupro"
era, quindi, sempre da verificare se il rapporto sessuale non
fosse stato, in ultima analisi, consumato con il consenso
della donna.
Questo discorso giuridico sulla donna onorevole e valorosa era
onnipresente negli atti giuridici della città di Zurigo.
Sapendo dell’innata debolezza fisica delle donne e presumendo
anche una loro debolezza morale, erano controllate.41
Con difesa rigorosa contro la violenza sessuale non si
intendeva soltanto adempiere ad un obbligo morale, ma anche
proteggere la propria fama. L’onore sessuale non era soltanto
un fatto privato delle donne ma ricadeva soprattutto sugli
uomini, sui padri, sui fratelli, sui mariti e sul nome della
famiglia.
I riferimenti, che si fanno negli atti giuridici a proposito
dell'onore della vittima e della sua famiglia, mettono in
evidenza che la fama era percepita come un capitale
simbolico.42
schützen.“41 Ibidem, p. 7242 Ibidem, pp. 70
Più era alta la fama più valeva la sposa. L'integrità sessuale
della vittima andava oltre la “sola” incolumità fisica.
L'integrità sessuale e la buona condotta stabilivano il
“valore del matrimonio” di una nubile, e determinava lo status
sociale della famiglia della vittima. Non a caso la corte
zurighese, nella sentenza del 1535, rilevò che a Els
Aubenstoss si doveva dare "una lettera e un sigillo" affinché
lei non fosse stata disonorata ("nit verfelt worden sei") dal
suo aggressore.43
In molte pratiche europee è sottolineata l’importanza
linguistica dell’onore sessuale.
Il termine "Stupro" (Notzucht) viene circoscritto con le
parole "rubare l'onore" (die Ehre stehlen) oppure con
"furto ancillare" (Raub des Magdtums), invece in
Inghilterra si circoscriveva il termine con “rape upon the
body of”.44
L’onore, associato al rapporto con il sesso, caratterizzava lo
status di tutte le donne, sia quelle in salute sia quelle
disabili.
Per questo motivo, i genitori di Els Aubenstoss e altri
insistevano sul fatto che "l'onore" delle proprie figlie
adolescenti doveva essere salvato grazie alla condanna dei
colpevoli.45
43 Ibidem, pp. 72-7344 Ibidem, pp. 73: „Notzucht wird etwa mit „die Ehre stehlen“ oder „Raub desMagdtums“ umschrieben [...] während in England dies häufig mit der Wendung “rape upon the body of” umschrieben wurde.45 Ibidem, p. 74
Un processo che dimostrava una violenza sessuale era, in
quanto collegato all’alto valore capitale intrinseco alla
fama, fortemente associato ad un rischio enorme di perdita
della medesima.
Se l’accusa era respinta o attenuata dalla corte, gli
accusatori avevano reso pubblica l’integrità sessuale della
figlia e avevano così perso il loro onore, senza essere più in
grado di compensare tale perdita tramite la sentenza. Per gli
uomini era diverso, perché avevano buone probabilità di
influenzare l’opinione del tribunale in loro favore,
sostenendo di aver avuto a che fare con una prostituta,
riuscendo così a non assumersi le loro responsabilità.
La professoressa Francisca Loetz ci presenta due accusatorie
di Zurigo degli anni 1536 e 1539, dove le donne offese
chiamano gli accusati davanti al giudice. Ho cercato di
tradurre i testi:
Nel 1536, l’apprendista Giacobbe Schrigg di Zurigo spiegò
alla corte che si era seduto allegramente insieme alla
signora Schmid e a sua figlia in una locanda e dopo aver
pagato il conto le aveva accompagnate a casa. Lungo la
strada aveva di fatto palpeggiato la figlia e che questa
si era difesa. Tuttavia, egli non aveva preso sul serio la
difesa della giovane donna dal momento che, nella locanda,
la madre della ragazza aveva accettato di essere invitata
a bere e che si erano raccontati barzellette sporche.
Egli sosteneva che nella locanda avrebbe parlato con la
figlia, col consenso della madre, e che pagando il conto
pensava di aver pagato un anticipo.
Mentre accompagnava la ragazza a casa, si era giustamente
aspettato che lei fosse una prostituta.
Questo caso illustra tuttavia, quanto le donne dovevano
stare attente ad evitare qualsiasi comportamento che
lasciava insinuare una provocazione sessuale o addirittura
una disponibilità sessuale.
I genitori ribadirono e sottolinearono che Schrigg aveva
pagato il conto all’insaputa delle due donne e che la
figlia si era inequivocabilmente e vigorosamente difesa.46
In un caso particolare le disuguaglianze, soprattutto in casi
di violenza carnale, rappresentano situazioni in cui delle
donne onorevoli (cum bona fama) sono state trattate da
prostitute.
Un esempio estremo è il caso di Regula Studer di Zurigo che
risale al 1539.
In tribunale, la donna aveva testimoniato di essere stata
chiamata con un pretesto in una locanda. Regula - aveva
visto nella locanda Hans Kramer con dei protettori (Siner
metzenn) e apparentemente inconsapevole circa la dubbia
reputazione della casa - era stata sospettosa a tal punto
da andarci soltanto dopo che la sua padrona le aveva dato
il permesso di farlo.
46 Ibidem, p. 78
Nella locanda, Schreiber l’avrebbe afferrata e costretta a
mangiare in sala con lui e con gli ospiti, poi l’avrebbe
condotta in una stanza, una volta lì avrebbe chiuso la
porta, e lo stesso avessero fatto i padroni di casa
chiudendo tutte le finestre, affinché non avesse potuto
fuggire. Nonostante la forte resistenza, Schreiber sarebbe
riuscito ad abusare sessualmente della ragazza e l’avrebbe
rilasciata soltanto in seguito.
Quando la ragazza si lamentò con la locandiera, questa la
invitò a non dire nulla, in quanto nel caso di un
processo, l’onta avrebbe potuto far cadere in disgrazia
anche i suoi padroni.
Quando Regula tempo dopo, esortata dal suo padrone,
dovette andare a prendere del vino nella suddetta taverna,
fu di nuovo circuita in modo pressante da Schreiber e di
nuovo lasciata da sola dai locandieri.47
La professoressa zurighese afferma che questo caso, oggi come
oggi, sarebbe valutato come uno stupro violento mentre per il
tribunale dell’epoca appariva come un caso di prostituzione. I
giudici decisero che Regula Studer avesse offerto a Schreiber
lo spunto e avevano condannato quest’ultimo, soltanto ad una
pena pecuniaria, pagando così una multa non per l’abuso
sessuale ma per adulterio.48
Schreiber era quindi riuscito a respingere la denuncia di
stupro della Studer. La cameriera non ebbe nessuna chance
47 Ibidem, p. 8648 Ibidem, p. 87
contro l'alleanza dei locandieri e dei loro clienti, che
evidentemente gestivano un bordello.
Le donne di bona fama erano molto più tutelate, e questo
grazie al loro ceto sociale; le donne “non custodite” invece,
come le serve domestiche, non godevano di una reputazione
sufficiente. Le serve venivano spesso equiparate a delle
semplici meretrici ed erano per questo motivo delle vittime
predilette.
Conclusione
Vorrei concludere riportando una frase posta sotto un’
immagine nel libro del Concilio di Costanza del 1548, in data
7.7.1548. L’immagine posta al margine della pagina mostra la
testa di un buffone di corte con una cresta di gallo e con
delle orecchie d'asino. Questa assomiglia molto al berretto
del buffone Hansel della Schnetztor (una delle torri di
Costanza) del XIV secolo. Sotto quest’immagine si può leggere:
„Omnia si perdas, famam servare memento" (Anche se perdi
tutto, ricordati di mantenere la tua reputazione).49
Questa frase sintetizza il discorso sulla bona fama e mala fama
argomento ricorrente e di notevole importanza nel medioevo e
oltre.
49 http :/ / www.blaetzlebuebe-zunft.de/index.php/die-hansele/unsere-
geschichte, 20.4.213
Omnia si perdas, famam servare memento
Raffaele Coda (matr.
1217691)
Bibliografia
Fonte:
- Eike von Repgow, “Der Sachsenspiegel”, Manesse Verlag
Zürich, 1984
Storiografie:
- Saggio di M. H. Caviness e C. G. Nelson “Silent witnesses,
absent women, and the law courts in Medieval Germany” (2003)
in
T. Fenster e D. L. Smail, “FAMA, The Politiks of Talk and
Reputation in Medieval Europe”, Cornell University Press,
Ithaca and London, 2003
- Francisca Loetz, “Sexualisierte Gewalt 1500-1850, Plädoyer
für eine historische Gewalforschung”, Campus Verlag
Frankfurt/New York, 2012
- Henri Pirenne, “Storia d’Europa dalle invasioni al XVI
secolo”, Grandi Tascabili Economici Newton, 2010
altro:
- Joseph Friedrich, “Hilfswörterbuch für Historiker.
Mittelalter und Neuzeit.” Bd. 2, 5. Aufl., München, Francke
Verlag, 1977
- Franco Cardini e Marina Montesano, “Storia Medievale”,
Firenze, Le Monnier Università/Storia, 2006- National
Geographic, “Storica”, numero 33, novembre 2011
- Giosuè Musca, “Il Mezzogiorno normanno-svevo e le Crociate”,
Università di Bari. Centro di studi normanno-svevi, 2002
- Balard, Genet et Rouche, “Le Moyen Âge en Occident”, Paris,
Hachette, 2003
- www.blaetzlebuebe-zunft.de
- Treccani.it, Enciclopedia italiana online
- Wickipedia