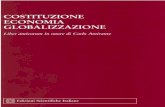Verso una memoria transculturale: il cinema turco-tedesco contemporaneo
Transcript of Verso una memoria transculturale: il cinema turco-tedesco contemporaneo
Our own experience cannot be separated from the account we can give of ourselves. It is in telling our own stories that we give ourselves an identity. We recognize ourselves in the stories that we tell about ourselves. It makes very little difference whether these stories are true or false, fiction as well as ver-ifiable history provides us with an identity1.
A cinquant’anni dall’arrivo dei primi Gastarbeiter turchi in Germa-nia, si registra al cinema – così come negli scrittori di terza genera-zione – un tono sempre più umoristico nella rappresentazione della propria identità e della propria storia. Il fenomeno è molto recente e fino a poco tempo fa si riscontrava prevalentemente nel cabaret o in televisione2, mentre adesso si ritrova anche in pellicole di suc-cesso che vengono spesso etichettate come Migrantenkino3 quan-do sarebbe più giusto ascriverle alla storia della Postmigration. Se all’inizio le storie d’amore raccontavano le divergenze culturali dei protagonisti (le cosiddette Culture-Clash-Komödien)4, si è passati poi ai ritratti di famiglia e alle storie familiari che tendono a costruire una vera e propria Erinnerungskultur turca e a riscrivere la storia dei Gastarbeiter turchi da altri punti di vista e da più punti di vista, sen-za tralasciare l’immagine stereotipata di sé e degli altri5. È il caso di Almanya – Willkommen in Deutschland, un film autobiografico delle sorelle Yasemin e Nesrin Şamdereli del 2011. Presentato fuori con-corso alla Berlinale dove è stato applauditissimo, ha avuto subito un enorme successo di pubblico, con un milione e duecentomila spettatori nelle sale cinematografiche tedesche, e il premio per la migliore sceneggiatura della Deutsche Filmakademie (il film è uscito alla fine dell’anno 2011 anche in Italia con il titolo Almanya – La mia famiglia va in Germania). Definita dalla stampa una Tragikomödie,
Verso una memoria transculturale: il cinema turco-tedesco contemporaneo
Nicoletta Gagliardi
272 nicoletta GaGliardi
narra – in breve – la storia della famiglia Yılmaz: dell’arrivo del non-no Hüseyin, il milionesimoeuno Gastarbeiter in Germania6 negli anni Sessanta, del ricongiungimento familiare negli anni Settanta e della morte improvvisa in Turchia, durante un viaggio di piacere con la sua famiglia. Il film è senza dubbio un esempio di come vengano tematizzati gli stereotipi «im transkulturellen Humor»7. La comicità del film è prodotta dai molti stereotipi8 che si riscontrano anche nel repertorio linguistico dei protagonisti. Infatti, dal punto di vista so-ciolinguistico si può notare quanto la differenza tra le ‘lingue’ parlate nel film risulti un’importante risorsa per la stilizzazione e la conno-tazione dei personaggi così come indicato da Androutsopoulos in un suo recente saggio:
In the context of cinematic discourse, the notion of sociolinguistic difference refers to any difference in cinematically staged ways of speaking, within as well as across languages, that can be perceived as indexing social traits of and relations among characters. […]The point is, however, that films from Turkish-German cinema make narratively motivated choices that contribute to characterisation and character contrasts and represent social heteroglossia in ways that reproduce sociolinguistic stereotypes9.
Hüseyin, la notte prima di andare a prendere il passaporto te-desco – mentre la moglie è eccitata all’idea, è indecisa sull’abito a fiori10 da indossare per l’occasione e prega il marito di aiutarla a sce-gliere tra due vestiti molto simili – fa un sogno sull’approssimarsi di quel Deutschwerden11, che almeno nella situazione onirica significa l’accettazione della Leitkultur tedesca, ovvero: far parte di una Schüt-zenverein, mangiare due volte alla settimana carne di maiale, vedere ogni settimana Tatort e trascorrere l’estate a Maiorca. L’impiegato mette alla prova la coppia invitandoli a mangiare Schweinsachse e Knödel. La moglie indossa un Dirndl e parla bavarese:
TRAUMSEQUENZ:Beamter: So! Herr und Frau… Yielmatz… jetzt fehlt nur noch Punkt 4 auf Anlage 18!Verpflichten sie sich, als baldige deutsche Staatsbürger die deutsche Kultur als Leitkultur zu übernehmen?Sehr schön. Das bedeutet… sie werden Mitglied in einem Schüt-zenverein, essen zwei Mal die Woche Schweinefleisch……schauen jede Woche „Tatort“ und… verbringen jeden zweiten
273Verso una memoria transculturale: il cinema turco-tedesco contemporaneo
Sommer auf Mallorca!!! Ach und ja, falls sie Humor haben… weg damit!Sind sie bereit, diese Pflichten auf sich zu nehmen?Fatma (mit türkischem Akzent): Ja! Natürlich! Muss ja alles Ordnung haben!Beamter: Ich gratuliere!!! Sie sind jetzt… DEUTSCHE!Hüseyin: Fatma! Hör sofort auf damit! Frau, hörst du nicht?!Fatma (plötzlich bayerisch): Ja mei, Hüsseyn! Jetz hoab di net so! Mir san doch imma no Türkn! Ja mei, Hüssein, wir müossen uons doch anpassn!12
Per dirla ancora con le parole di Androutsopoulos, anche nel film Almanya si può osservare «how the dramatic deployment of lingui-stic difference can become iconic to some dimension of narrative difference among characters»13.
La comicità del film è data anche dall’Anders-Sehen, dalle diverse prospettive dalle quali viene narrata la storia, quella attuale della famiglia di Hüseyin e quella della sua emigrazione attraverso il rac-conto che fa la nipote ventenne Canan al cugino Cenk di sei anni. Ma questo Anders-Sehen è anche un Anders-Sprechen, in quanto i di-versi punti di vista si riflettono sin dall’inizio nella lingua dei prota-gonisti. Nel film il tedesco standard è la lingua dei nipoti di Hüseyin, Canan e Cenk, ma anche di Ali, il padre di Cenk, l’unico figlio della coppia che è nato in Germania, che ha sposato una tedesca e parla male il turco. Il tedesco ‘quasi nativo’ viene parlato dai primi tre fi-gli dei coniugi Yilmaz, Muhamed, Veli, e Leyla, la madre di Canan, che sono nati e in parte cresciuti con la madre in Turchia e hanno imparato poi nelle scuole tedesche la lingua standard. Hüseyin e Fatma parlano invece quell’interlingua degli emigrati turchi di pri-ma generazione modellata sullo stereotipo del Gastarbeiterdeutsch. Il turco si parla in famiglia e, naturalmente, in Turchia. Inoltre in alcuni momenti del racconto che Canan fa a Cenk i tedeschi parlano una lingua inventata, una sorta di Kauderwelsch, accentuando il senso di straniamento che provocava l’ignoranza della lingua tedesca nei componenti della famiglia Yilmaz nei primi anni in Germania. Que-sta scelta linguistica viene motivata al principio della narrazione di Canan, che – ricordando l’incontro tra i nonni Hüseyin e Fatma – riporta i dialoghi in ‘originale’, in turco, fin quando Cenk, curioso di ascoltare la storia della sua famiglia, le chiede: «Können die nicht alle Deutsch reden?»14, perché conosce solo qualche parola in turco. Da questo momento in poi, nel racconto della ragazza, la lingua
274 nicoletta GaGliardi
parlata dai turchi è il tedesco standard – anche nelle imprecazioni, come la più frequente Söhne eines Esels! che è evidente traduzione dell’esclamazione turca Eşek sıpası! usata spesso da Hüseyin, e Al-lmächtiger!, equivalente di Allahim! adoperata da Fatma – , mentre la lingua parlata dai tedeschi è una lingua inventata e incomprensibile, come ad esempio nell’episodio del saluto dell’autorità all’arrivo dei Gastarbeiter turchi a Colonia, nell’episodio della visita della dot-toressa a Fatma che è in attesa di un bambino e che si serve di sua figlia Leyla come traduttrice, o ancora nella scena in cui la donna per la prima volta va a fare la spesa da sola:
TANTE-EMMA-LADEN, 1970 Verkäufer: Nö kröte Ingste! Mö dricken nö.Fatma: Guten Tag!Verkäufer: Guuuhter Tack!Fatma: Ich hätte gerne ein Brot!Äh… BROT?Aber nict doch… BROT! Brooot!Verkäufer: Nö kröte Ingste… dricken nö!Fatma: Dann eben kein Brot! Haben sie MILCH?Verdammt, der versteht aber auch gar nix! MILCH!MUHHHHH! Muhhh!Verkäufer: Metta! Jö, Metta!Fatma: Dem Allmächtigen sei Dank! Sie kennen Milch!
In effetti, sono i bambini i primi ad apprendere correttamente il tedesco standard a scuola e a notare sottili differenze:
Leyla: wenn ich groß bin, werde ich Müllmann.Muhamed: Du bist ein Mädchen, du kannst kein Müllmann werden. Leyla: kann ich doch!Muhamed: Kannst du nicht. Es heißt ja auch Müllmann und nicht Müllfrau. Oder hast du schon mal eine Müllfrau gesehen?
Questa Lebensgeschichte diventa subito anche una Sprachbiogra-phie15 o una SprachGeschichte, come viene definita nei più recenti studi di sociolinguistica16 che si soffermano sull’identità narrativa e sulla stretta connessione tra lingua e costruzione identitaria nei rac-conti orali degli intervistati mit Migrationshintergrund/-Geschichte. A tal proposito è stato adottato il concetto di «Positionierung»17 come strumento per lo studio empirico di identità narrative nell’ambito di
275Verso una memoria transculturale: il cinema turco-tedesco contemporaneo
racconti autobiografici, perché si è osservato che l’identità narrativa non è un dato di fatto immutabile, una caratteristica della persona che narra, ma piuttosto «eine perspektivische Konstruktion im Akt des Erzählens und muss im Interpretationsprozess entfaltet wer-den»18. Questo si riscontra anche nella finzione cinematografica di Almanya: ad esempio il modo in cui i Gastarbeiter vengono chiamati in Germania nell’immaginazione di Cenk19, oppure i diversi gradi di conoscenza della lingua tedesca e della lingua turca dei vari com-ponenti della famiglia Yilmaz e la continua oscillazione tra turco e tedesco nel contesto familiare.
Se le Bindestrichformationen20, come ‘türkisch-deutsch/deutsch-türkisch’, si basano su un legame nazionale e territoriale delle iden-tità, il continuo movimento, questo sprachliches Grenzgängertum, che è code-switching, code-mixing, code-shifting delle lingue nella realtà così come nel contesto del film, fa sì che ci sia anche un con-tinuo superamento del confine e una continua ridefinizione di ciò che è proprio ed estraneo. Il movimento coinvolge allo stesso tempo il piano visivo e musicale, dove il personale ricordo dell’esperienza della migrazione e dei viaggi dalla Germania in Turchia e viceversa lascia lo spazio per l’inserimento di alcuni documentari originali de-gli anni Sessanta e Settanta che hanno sì un effetto estraniante ma nel contempo intendono avvicinare la storia ufficiale tedesca e la storia privata della famiglia Yilmaz21. In questo modo si verifica una interessante percezione dei luoghi, un orientamento per così dire topografico da parte di chi guarda, ascolta e legge, così come avvie-ne in Cenk, il bambino appartenente alla terza generazione a cui viene raccontata la storia della propria famiglia proprio perché ha difficoltà ad orientarsi. Quando infatti, nel primo giorno di scuola, la maestra chiede a tutti i bambini il luogo d’origine dei propri fami-liari, Cenk non sa che cosa rispondere perché la cartina dell’Europa non contempla l’Anatolia e il paesino del nonno. Il bambino, inol-tre, non viene accettato né dalla squadra di calcio turca né da quella tedesca, litiga con i compagni di classe e si becca un occhio nero, per cui disorientato chiede ai familiari: «Was sind wir denn jetzt? Türken oder Deutsche?» perché dal calcio gli è chiaro, «Entweder die eine Mannschaft oder die andere!» Questo ‘dissidio’ verrà risolto da Hüseyin nell’improvvisazione del discorso (che fa in un negozio di barbiere turco) che dovrebbe tenere in occasione dell’invito della Cancelliera Merkel all’evento Deutschland sagt Danke per i Gastar-beiter della prima ora:
276 nicoletta GaGliardi
BARBERSHOPHüseyin: Ich danke ihnen viel, dass sie mich haben hier eingeladen.Cenk: Das heißt sehr! Ich danke ihnen sehr, man Opa!Hüseyin: Ja ja. Schon wieder vergessen. Also, ich danke ihnen sehr.Hüseyin: Was wollte ich nochmal sagen? Ach, weißt du was? Ich sag einfach zu Bundeskanzlerin: Hey Angela, wo Problem. Ich komme aus dem Osten und du auch! Wir beide gleich: Ossis! Oder, viel-leicht besser ich sollte singen.
Il concetto di identità è fluido come l’acqua che in Turchia – se-condo un antico rituale che si osserva anche nel film – si lancia per augurio dietro a qualcuno da cui ci si congeda quando intraprende un lungo viaggio. Ali utilizza di nuovo la metafora dell’acqua per spiegare al figlio Cenk la morte del nonno:
VOR EINER TÜRKISCHEN POLIZEIWACHEAli: Weißt du noch, was wir letzte Woche gesehen haben…das mit dem Wasser? Dass es seine Form verändert?... Wenn es richtig kalt ist, wird Wasser zu Eis, wenn es warm ist, wird es flüssig… und wenn es kocht, dann verdampft das Wasser… und steigt in die Luft. Aber egal, wie das Wasser gerade aussieht, … es bleibt immer Was-ser. Verstehst du, was ich meine?Cenk: Ja! Opa ist verdampft.
Al funerale del nonno, così come nella sequenza finale del film, sono presenti tutti i protagonisti, bambini e adulti, e la storia di Ca-nan, che aspetta un figlio dal fidanzato inglese, si conclude con le parole di Salman Rushdie, tratte da I figli della mezzanotte (Midnight’s Children, 1981), per sottolineare la ricchezza della propria identità familiare, di queste «plurale Identitätskonstruktionen» di cui ha vo-luto raccontare:
Ein kluger Mann antwortete einmal auf die Frage: Wer oder was wir sind? Wir sind die Summe all dessen, was vor uns geschah, all dessen, was unter unseren Augen getan wurde, all dessen, was uns angetan wurde. Wir sind jeder Mensch und jedes Ding, dessen Da-sein das unsrige beeinflusste oder von unserem beeinflusst wurde. Wir sind alles, was geschieht, nachdem wir nicht mehr sind, und was nicht geschähe, wenn wir nicht gekommen wären.
Il film è sicuramente uno strumento della memoria22, un mezzo per ricordare, e il racconto di Canan nel film ha tutte le caratteristi-
277Verso una memoria transculturale: il cinema turco-tedesco contemporaneo
che di una Oral History. Aleida Assmann23 definisce questa forma di trasmissione orale di ricordi individuali «kommunikatives Gedächt-nis». La memoria familiare, fatta di ricordi, esperienze, racconti, può durare al massimo 80-100 anni ma può perdurare e continuare a circolare grazie al racconto cinematografico24, e così da Familienge-dächtnis diventa un «kulturellen Gedächtnis» come inteso da As-smann. Non a caso il protagonista del film è l’emigrante della prima ora, ormai pensionato in Germania, così come osserva M. El Hissy:
Es ist zu erwarten, dass die Erinnerung an die Migration und nicht die Migration selber in den Vordergrund rückt. Die Migration wird verstärkt zu einer (Bühnen-)Performance, die von deutsch-türki-schen Künstlerinnern und Künstlern als (Familien-)Sage imagi-niert und/oder erinnert wird. Gegenwärtig macht sich die Figur des Rentners bemerkbar, die allegorisch zu deuten ist:. Die Migration-sgeschichte wird alt. Sie wird zwar nicht sterben, sondern kommt in das Archiv und bildet ›nur‹ einen Teil der Familiengeschichte der gegenwärtig in Deutschland lebenden Deutsch-Türken25.
In conclusione si può dire che l’ironia e l’umorismo con cui le autrici del film hanno trattato i temi controversi dell’identità e del rapporto con il territorio hanno consentito di mostrare – attraverso le diverse prospettive della finzione filmica – come questi temi ven-gono sempre di nuovo rinegoziati a livello individuale e di gruppo in nuove diverse riconfigurazioni dei rapporti tra lingua, etnicità e appartenenza26.
278 nicoletta GaGliardi
Note
1 anthony paul Kerby, Narrative and the Self, Indianapolis 1993, p. 113. Citazione tratta da eVa-maria thüne, Sprachbiographien: empirisch und literarisch, in Poly-phonie. Mehrsprachigkeit und literarische Kreativität, hrsg. von M. Bürger-Koftis, H. Schweiger, S. Vlasta, Wien 2010, pp. 59-80, qui p. 60.
2 Ad es. i duo comici Dragan e Alder, Stefan ed Erkan, i cabarettisti Kaya Yanar e Serdar Somuncu.
3 Il concetto racchiude sia quei film di autori di origine straniera, sia quelli che narrano storie di emigrazione. D. Göktürk è in disaccordo con questa classi-ficazione, che come altre tende a marginalizzare quei film che hanno ormai diffusione internazionale e trattano temi comuni a tutti.
4 Si vedano le Culture-Clash-Komödien come ad esempio: Alles getürkt! 2002, Su-perseks, 2004, Kebab Connection 2005, Evet, ich will! 2008, e il film per la TV Meine verrückte türkische Hochzeit, 2006 e la fortunata serie Türkisch für Anfänger 2006 e ss.
5 «Die Abkehr vom ‘Problemfilm’ und die Wahl des Genres der Komödie sig-nalisiert demnach zwar einen ‘entspannteren’ Umgang mit Klischees und Stereotypen, jedoch nicht automatisch deren Aufhebung». Jochen neubauer, Türkische Deutsche Kanakster und Deutschländer, Würzburg 2011, p. 211
6 Nella finzione, Hüseyin lascia infatti passare il portoghese Armando Rodriguez che verrà festeggiato dai mass media come milionesimo Gastarbeiter in Ger-mania.
7 Theresa specht, Transkultureller Humor in der türkisch-deutschen Literatur, Würz-burg 2011.
8 Si pensi ad esempio a quando Fatma riceve dei regali dalle amiche del villaggio prima della sua partenza in base a tutti i pregiudizi che hanno nei confronti dei tedeschi (sono sporchi, mangiano solo patate e poi dalle loro parti fa molto freddo).
9 Jannis androutsopoulos, Repertoires, characters and scenes: Sociolinguistic differ-ence in Turkish-German comedy, in “Multilingua” 31 (2012), pp. 301s. e 309.
10 Ancora uno stereotipo, perché un retaggio del tradizionale abbigliamento della donna di un villaggio turco.
11 Kathrin emeis, Julia booG, Almanya oder Deutschland revisited: Der Culture Clash im deutsch-türkischen Kino – 50 Jahre später, in 50 Jahre Türkische Arbeitsmigration in Deutschland, hrsg. von Şeida Ozil, Michael Hoffmann, Yasemin Dayioğlu-Yücel, Göttingen 2011, pp. 165-181, qui p. 173.
12 La sceneggiatura del film è stata pubblicata nella serie Deutsche Drehbücher, Jah-rgang 2011, a cura di F. Breinersdorfer e D. Schön per la Deutsche Filmakade-mie.
13 androutsopoulos, cit., p. 307.14 Cenk, più avanti, quando sarà in viaggio in Turchia, chiederà: «Wie viele Jahre
ist Opa schon in Deutschland?» e Canan: «Fast 45!» e ancora: «Warum reden Dede und Nene dann so schlecht Deutsch?»
15 Finora sono state analizzate Sprachbiographien empiriche e letterarie e non ci si è soffermati sul mezzo cinematografico, che a mio parere, dal punto di vista linguistico, si inserisce a metà strada tra le reali biografie degli intervistati e quelle della finzione letteraria.
279Verso una memoria transculturale: il cinema turco-tedesco contemporaneo
16 Si pensi ad esempio ai contributi di eVa-maria thüne, Anne betten, patricK ste-Venson, e nell’ambito della linguistica applicata a Gabriele lucius-hoene e ar-nulf deppermann, Rekonstruktion narrativer Identität: Ein Arbeitsbuch zur Analyse narrativer Interviews, Wiesbaden, 20042. Cfr. anche eVa-maria thüne, simona leonardi (a c. di), I colori sotto la mia lingua. Scritture transculturali in tedesco, Roma 2009, eVa-maria thüne, anne betten (Hrsg.), Sprache und Migration. Lin-guistische Fallstudien, Roma 2011, arnulf deppermann (Hrsg.), Das Deutsch der Migranten, Berlin-New York 2013.
17 Gabriele lucius-hoene, arnulf deppermann, Narrative Identität und Position-ierung, in Gesprächsforschung, “Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion” 5 (2004), pp. 166-183 (http://gespraechsforschung-ozs.de).
18 lucius-hoene, deppermann, Rekonstruktion, cit., p. 271.19 «Liebe Weltenbürger! Hier spricht die Bundesrepublik Deutschland! Wir
suchen Arbeitskräfte! Bitte wenden Sie sich unverzüglich an die nächste be-hördliche Stelle!»
20 deniz GöKtürK, Mobilisierte Zuschauer: Topographische Überlagerungen in der transnationalen Zirkulation, in Türkisch-deutscher Kulturkontrakt und Kulturtrans-fer, hrsg. von Şeida Ozil, Michael Hoffmann, Yasemin Dayioğlu-Yücel, Göttin-gen 2010, pp. 108 s.
21 aleida assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Ge-schichtspolitik, München 2006, p. 207: «Ein Film oder Roman ist als Kunstwerk und damit als eine verallgemeinerte ästhetische Formulierung immer schon Teil des kulturellen Gedächtnisses und kein Exklusivbesitz einer bestimmten Generation».
22 Wir haben vergessen zurückzukehren (2001) è il titolo ironico e provocatorio di un film documentario che F. Akin ha girato nel 2001 per non dimenticare la storia della propria famiglia. Cfr., a tal proposito, daGmar brunow, Film als kulturelles Gedächtnis der Arbeitsmigration: Fatih Akins Wir haben vergessen zurückzukeh-ren, in ozil, hoffmann, dayioğlu-yücel, 50 Jahre Türkische Arbeitsmigration, cit., p. 183.
23 Cfr. assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit, cit.24 Racconto che è soggetto ad essere continuamente attualizzato nella sua ricezi-
one da parte del pubblico e con la sua diffusione nelle sale, in tv, su YouTube.25 Maha el hissy, Getürkte Türken. Karnevaleske Stilmittel im Theater, Kabarett und
Film deutsch-türkischer Künstlerinnen und Künstler, Bielefeld 2012, p. 271.26 Si legga il saggio di zafer ŞenocaK, Deutschsein. Ein Aufklärungsschrift, Hamburg
2011.