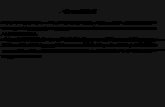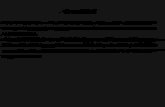Mario Castelnuovo-Tedesco - Intellettuali in fuga dall'Italia ...
GIANNI CIMADOR, Calvino e il romanzo del pubblico, in Autori, lettori e mercato nella modernità...
Transcript of GIANNI CIMADOR, Calvino e il romanzo del pubblico, in Autori, lettori e mercato nella modernità...
LA MODERNITÀ LETTERARIA
collana di studi e testi
diretta daAnna Dolfi, Sandro Maxia, Nicola Merola
Angelo R. Pupino, Giovanna Rosa
[26]
000_pagine editoriali tomo II_000_pped 26/05/11 15.49 Pagina 1
Autori, lettori e mercatonella modernità letteraria
a cura diIlaria Crotti, Enza Del Tedesco,Ricciarda Ricorda, Alberto Zava
Tomo II
con la collaborazione di
Stefano Tonon
Edizioni ETS
000_pagine editoriali tomo II_000_pped 26/05/11 15.49 Pagina 3
© Copyright 2011EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 [email protected]
DistribuzionePDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]
ISBN 978-884672997-2
www.edizioniets.com
Il presente volume è stato pubblicato con il contributodel Dipartimento di Italianistica, Università degli Studi di PadovaDipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di VeneziaMOD - Società Italiana per lo Studio della Modernità Letteraria
In copertinaJACQUES SABLET, Elegia romana, 1791
000_pagine editoriali tomo II_000_pped 26/05/11 15.49 Pagina 4
PREMESSA
Il convegno affronta la radicale modificazione dell’idea stessa di lette-ratura provocata dall’accelerarsi del processo di modernizzazione a parti-re dal Settecento, mettendo in crisi l’idea umanistica di Repubblica deiletterati e la sua stessa autoreferenzialità con l’imporsi di un più largo, equasi universale, destinatario delle opere letterarie identificato nel “pub-blico”, con il quale ogni relazione si stabilisce nel mercato.Il convegno, dunque, ha inteso occuparsi della formazione del pubbli-
co, del suo rapido evolversi, del suo complesso articolarsi, e poi ancoradei modi in cui si esprime la relazione autore-pubblico, studiando parate-sti e contesti, e poi le mediazioni editoriali e la pratica critica e interpreta-tiva. Sono state inoltre oggetto d’indagine l’evoluzione dei generi e la loro
diversa fortuna (teatro, romanzo, racconto ecc.), la pratica della scritturasu commissione, o più in generale di una letteratura “servile” (dal feuilet-ton all’antologia, per fare solo qualche esempio), la riutilizzazione di ele-menti dell’invenzione letteraria in linguaggi diversi dalla musica (l’opera)al cinema, le problematiche del diritto d’autore nel momento in cui l’e-volversi dell’universo mediatico sembra rimettersi in discussione la stessaesistenza.
Cesare De Michelis
000_pagine editoriali tomo II_000_pped 26/05/11 15.49 Pagina 5
COMUNICAZIONIPARTE II
DAGLI ANNI CINQUANTA A OGGI
000_pagine editoriali tomo II_000_pped 26/05/11 15.49 Pagina 7
giaNNi ciMador
caLvino e iL roManZo deL PuBBLico
in Un progetto di pubblico calvino sottolinea come ariosto, nell’ultimo canto dell’Orlando furioso, abbia messo in scena anche il pubblico ideale della sua opera, che è insieme l’immagine di una società ideale:
È quella la prima volta, credo, che non il lettore singolo e solitario ma il “pub-blico” appare riflesso nel libro come in uno specchio; o meglio, il libro vede se stesso come riflesso negli occhi di una folla di lettori. non è una folla qualsiasi: il poeta ha ritagliato una sua società di lettori ideali all’interno del mondo dei lettori potenziali, cioè della società delle corti italiane del tempo. È un modello di società che può riconoscere se stessa nel suo modo di leggere quel libro; e che anche se non lo leggesse costituirebbe un modello di società di per sé, contrapposto alla società quale essa è.1
anche il finale de Il cavaliere inesistente si proietta retrospettivamente sull’intero romanzo: oltre a essere un brillante esempio di parodia, è un modello del tutto originale di ipertestualità, visto che il libro, invitato a leggere se stesso, svolge il ruolo di pubblico. L’operazione di calvino è analoga a quella di ariosto, nel senso di un coinvolgimento di tutte le com-ponenti che costituiscono l’opera letteraria:
Per una specie di rovesciamento strutturale, il poema esce da se stesso e si guar-da attraverso il censimento dei suoi destinatari. e a sua volta è il poema che serve da definizione o da emblema per la società dei lettori presenti e futuri, per l’insie-me di persone che parteciperanno al suo gioco, che si riconosceranno in esso.2
il ‘progetto di pubblico’ che calvino vuole individuare, proprio per lo stesso intrecciarsi di una dimensione performativa e di una capacità spe-culare, sviluppa i presupposti di ariosto e prevede, allo stesso modo, la definizione di un «contropubblico», nel senso dell’«enucleazione di una società di lettori che si distingue in qualche modo dalla società quale essa è»:3 su questo terreno si misura la differenza rispetto allo scrittore «dozzi-
1 italo calViNo, Un progetto di pubblico [1974], in Saggi 1945-85, tomo i, a cura di Mario Baren-ghi, Milano, Mondadori, 1995, p. 342.
2 ideM, La struttura dell’«Orlando furioso», in Saggi 1945-85, tomo i cit., p. 768.3 ideM, Un progetto di pubblico cit., pp. 342-343.
350 autori, Lettori e Mercato neLLa Modernità Letteraria
nale», che invece «ha in mente solo la società quale essa è e la sua risposta immediata»,4 ed emerge la necessità di una distinzione tra «letteratura po-polare», «letteratura di consumo» e «letteratura di massa», nei termini pro-posti da Petronio.5 il nodo problematico è la possibilità di un ‘censimento’ dei destinatari e la loro differenziazione sociale e culturale che incrina certo la compiuta specularità dell’opera ariostesca e, di conseguenza, porta a una molteplicità di livelli e stratificazioni.
nella sua consueta tendenza alla definizione di territori, e proprio in rapporto a un pubblico ideale, calvino sente l’urgenza di definirsi rispetto allo scrittore popolare e allo scrittore di best seller: citando come esem-pi di grandi scrittori popolari Balzac e dickens, nei quali «il progetto di una nuova società di lettori coincide con l’emergere di una nuova strut-tura sociale»,6 calvino si colloca su una linea gramsciana, per quanto il confronto con la Morante de La storia, che ripropone il grande romanzo popolare, offra lo spunto per un’ulteriore ridefinizione.
L’idea calviniana del romanzo popolare, che «è basato sul funziona-mento oggettivo della macchina narrativa, e ha anche nei suoi esempi più illustri un carattere quasi di produzione anonima che lo apparenta alle mitologie»,7 ribadisce una concezione dell’opera come “meccanismo”, si-glata in Cibernetica e fantasmi attraverso la priorità della fabulazione sulla mitopoiesi: completamente diverso è il best seller che «anziché sull’oggetti-vità e impersonalità si basa sulla pretenziosa e vaga soggettività dell’autore che trabocca nella pretenziosa e vaga soggettività dei lettori, in una melassa di “umanità”».8
secondo calvino, il best seller si basa su un errore di metodo che rasenta la «ruffianeria morale», cioè «credere che entità non ben definite come l’umanità, la vita, le passioni, i sentimenti possano passare direttamente sulla carta scritta»:9 se si tratta di una prospettiva interessante dal punto di vista sociologico, perché rivela in negativo la cattiva coscienza sociale, non lo è invece dal punto di vista letterario.
Per calvino la condizione di esistenza di una «futura possibile letteratu-ra popolare» consiste nel saper «affrontare l’insieme di procedimenti e di effetti di tecnica letteraria della commozione, e cercare di capire cosa sono,
4 ivi, p. 343.5 cfr. giUSePPe PetroNio, Dieci tesi sulla letteratura di consumo e sulla letteratura di massa, in
«Trivialliteratur?». Letterature di massa e di consumo, a cura di Giuseppe Petronio e ullrich schulz-Buschhaus, trieste, Lint, 1979, p. 17.
6 i. calViNo, Un progetto di pubblico cit., p. 343.7 ibidem.8 ivi, p. 344.9 ibidem.
caLvino e iL roManZo deL PuBBLico 351
cosa significano, come funzionano, perché comunicano qualcosa che molti lettori credono di riconoscere. a una chiara coscienza tecnica di questi pro-cedimenti letterari forse potrebbe corrispondere un nuovo uso del pathos come pedagogia morale non mistificante».10
a questa esigenza di una nuova consapevolezza, che porta inevitabil-mente a confrontarsi con un pubblico composito, non omogeneo né cul-turalmente né sociologicamente, sono inscindibilmente legate l’attenzione ai generi di una narrativa di intrattenimento e la riabilitazione del «roman-zesco», teorizzata ne Il romanzo come spettacolo: qui calvino insiste infatti sulla necessità di chiudere i conti con il programma di dissoluzione delle forme letterarie delle avanguardie, ispirato a Flaubert, recuperando inve-ce le modalità con cui dickens presentava i suoi romanzi, in performan-ces recitate, integrate da illustrazioni e dalle reazioni del pubblico: è una prospettiva molto vicina ai dibattiti sugli ‘orizzonti d’attesa’ e sull’’estetica della ricezione’, nati negli stessi anni nell’ambito della scuola di costanza guidata da Jauss.
Per calvino il recupero del «romanzesco» nelle forme della letteratura di massa non inflaziona ma innova realmente i modi della letteratura spe-rimentale, nel senso di una concezione epistemologica della finzione, di un’’interattività’ tra autore e lettore:
se ora conosciamo le regole del gioco “romanzesco” potremo costruire romanzi “artificiali”, nati in laboratorio, potremo giocare al romanzo come si gioca a scac-chi, con assoluta lealtà, ristabilendo una comunicazione tra lo scrittore, pienamente cosciente dei meccanismi che sta usando, e il lettore che sta al gioco perché ne co-nosce le regole e sa che non può esser preso più a zimbello. Ma siccome gli schemi del romanzo sono quelli d’un rito d’iniziazione, d’un addestramento delle nostre emozioni e paure e dei nostri processi conoscitivi, anche se praticato ironicamente il romanzo finirà per coinvolgerci nostro malgrado, autore e lettori, finirà per rimet-tere in gioco tutto quel che abbiamo dentro e tutto quel che abbiamo fuori.11
come rileva anche Lavagetto, calvino stipula una specie di contratto con il lettore, nel quale «il racconto deve “chiudere” e il lettore deve essere in grado di svolgere la sua parte e di assumere se necessario (come in Se una notte) il ruolo di personaggio clandestino o, in circostanze talvolta diverse, quello non meno impegnativo di co-narratore».12
La necessità di riservare uno spazio dell’opera all’interazione dei let-tori si abbina alla consapevolezza di una professionalità ‘artigianale’: «io
10 ivi, p. 345.11 ideM, Il romanzo come spettacolo [1970], in Saggi 1945-85 cit., pp. 272-273.12 cfr. Mario laVagetto, Dovuto a Calvino, Milano, Bollati Boringhieri, 2001, p. 103.
352 autori, Lettori e Mercato neLLa Modernità Letteraria
resto uno scrittore d’impianto artigiano, mi piace fare delle costruzio-ni che chiudono bene, ho un rapporto col lettore basato sulla reciproca soddisfazione».13
il modello di calvino è, in questo senso, ancora una volta stevenson, dal quale ha imparato che «credere nelle storie con un principio e una fine, una bellezza, una morale, vuol dire credere nel legame dello scrittore con la gente, nel suo posto in una società, quella degli isolani di samoa, e quella dei milioni di ragazzi e di uomini che continuano nel mondo a leggere i suoi libri»:14 è una dichiarazione dalla quale emerge chiaramente l’idea calvinia-na di ‘letteratura popolare’ e tutta la fiducia che lo scrittore nutre ancora nel futuro di questo tipo di letteratura.
L’ideale di un pubblico di lettori attivi e partecipativi, come nuovo sce-nario di una realtà multimediale, caratterizzata da quello che Genette chia-ma «effetto rebound»,15 costituisce indirettamente anche una risposta al problema della ‘morte dell’autore’ e avvicina la strategia di calvino a quella che diderot, uno dei padri della letteratura contemporanea, mette in cam-po in Jacques le fataliste, opera che è, nello stesso tempo, ‘antiromanzo’, ‘metaromanzo’ e ‘iperromanzo’:
capovolgendo quello che già allora era l’intento principale di ogni romanziere – fare dimenticare al lettore di star leggendo un libro perché s’abbandoni alla storia narrata come se la stesse vivendo – diderot mette in primo piano la schermaglia tra l’autore che sta raccontando la sua storia e il lettore che non attende altro che d’ascoltarla: le curiosità, le aspettative, le delusioni, le proteste del lettore e le intenzioni, le polemiche, gli arbìtri dell’autore nel decidere gli sviluppi della storia sono un dialogo che fa da cornice al dialogo dei due protagonisti, a sua volta cornice d’altri dialoghi [ … ]. trasformare il rapporto del lettore col libro da accet-tazione passiva a messa in discussione continua o addirittura a una specie di doccia scozzese che tenga sveglio lo spirito critico: questa è l’operazione con cui diderot anticipa di due secoli quello che Brecht volle fare col teatro.16
ciò che differenzia calvino da diderot è tuttavia il fatto che quest’ul-timo finisce per giocare con il lettore come fa il gatto con il topo, «a ogni nodo della storia aprendogli davanti il ventaglio delle varie possibilità, qua-si a lasciarlo libero di scegliere il seguito che più gli aggrada, per poi delu-derlo scartandole tutte tranne una che è sempre la meno “romanzesca”»:17
13 cfr. la lettera a Guido Fink, datata 24 giugno 1968, ora in i. calViNo, Lettere 1940-1985, a cura di Luca Baranelli, Milano, Mondadori, 2000, p. 1003.
14 ideM, «L’isola del tesoro» ha il suo segreto [1955], in Saggi 1945-85, tomo i cit., pp. 970-971.15 cfr. gérard geNette, Nuovo discorso del racconto [1983], tr. it., torino, einaudi, 1987, p. 62.16 i. calViNo, Denis Diderot, Jacques le fataliste [1984], in Saggi 1945-85, vol. i cit., p. 844.17 ibidem.
caLvino e iL roManZo deL PuBBLico 353
pur smentendola nei fatti, diderot pone le premesse di quella ‘letteratura potenziale’ che ispirerà anche il modello del «racconto a modo vostro» di Queneau, e nella quale per calvino si esprime emblematicamente un ruolo attivo e partecipativo dei lettori.
calvino è ossessionato dal modello della ‘macchina’, costruzione sinte-tica per eccellenza, definita anzitutto in ragione della sua funzionalità: in essa, modello e prodotto coincidono.
se Le città invisibili sono il ‘racconto di una rappresentazione’, Se una notte d’inverno un viaggiatore è invece la ‘rappresentazione di una rappre-sentazione’: il ‘contenuto’ è infatti un altro testo, con lo stesso titolo, che esiste per quanto ne è fatto filtrare attraverso l’esposizione dell’atto della sua lettura.
in questo caso, il ‘procedimento’ è quindi la struttura romanzesca stessa, declinata secondo diversi ‘generi’ e diversi tipi di approccio che posso-no modificarla: l’oggetto e la forma del racconto, contenuto e contenitore, coincidono, la letteratura descrive se stessa.
il registro metanarrativo è già ne Il cavaliere inesistente un racconto complementare e parallelo, nel quale l’autore, come in uno specchio obli-quo, riconosce la sua vena più autentica, anche nella consapevolezza che il suo lavoro è un «rituale per non sprofondare nel nulla»: è una visione che emerge chiaramente quando suor teodora afferma che «l’intreccio d’av-venture in cui consiste ogni romanzo cavalleresco, ora mi pare una guar-nizione superflua, un freddo fregio, la parte più ingrata del mio penso».18
il ‘progetto’ di calvino non è molto diverso da quello del Barthes di S/Z, rivolto a rendere visibile e trasparente, nel romanzo, anche la ‘teoria’ del romanzo e i suoi diversi livelli di leggibilità: «Quel che è raccontato è il “raccontare”. infine non c’è oggetto del racconto: il racconto non tratta che di se stesso: il racconto si racconta».19
L’esplicitazione ipermediale delle strutture del romanzo, lungi dall’in-debolirlo, produce una tensione interna con i vari racconti, in grado di generare un ‘senso secondo’ dell’opera. L’inedito spazio autotestuale mima le dinamiche della ‘macchina segreta’ che le ha poste in essere, costituisce una rete inestricabile di sovrasensi narrativi: moltiplica così le proprie di-mensioni reinnestandosi continuamente su se stesso.
anche ne Le città invisibili nel ‘procedimento’ si esplica una ricchezza tutta implicita dell’opera, attivata dai percorsi possibili della lettura e non dalla scrittura: come la quantità di cose che si possono leggere nel tassello
18 cfr. ideM, Il cavaliere inesistente cit., p. 93.19 rolaNd bartheS, S/Z [1970], tr. it., torino, einaudi, 1973, p. 219.
354 autori, Lettori e Mercato neLLa Modernità Letteraria
di ebano liscio e vuoto sommerge Kublai Kan, così, dietro al processo com-binatorio, ci sommerge la ricchezza di emblemi o «logogrifi» che evocano le città invisibili.
analogamente a quanto si ricava dal capitolo su Zora, le città sono casel-le e ogni casella è una matrice di possibilità di lettura:
Questa città che non si cancella dalla mente è come un’armatura o reticolo nelle cui celle ognuno può disporre le cose che vuole ricordare. nomi di uomini illustri, virtù, numeri, classificazioni vegetali e minerali, date di battaglie, parti del discorso.20
come sottolinea celati, il rapporto tra scrittura e fabulazione, rappre-sentate rispettivamente dall’imperatore e da Marco Polo, è assimilabile a quella tra game e play nella teoria dei giochi definita da von neumann e Morgenstern, ossia al rapporto tra regole e partita:
il game è soltanto un’astrazione, come le caselle del Gran Kan, in quanto ma-trice di mosse possibili, senza riguardo alle mosse concrete. il game è il gioco fuori dal contesto, meta-gioco o forma normativa del gioco. ciò coincide bene con il modello usato dal Kan per interpretare le sue città: la scacchiera vuota, le caselle come spaziatura del nulla, ossia le unità discrete senza alcun significato proprio ma che possono ordinare tutte le città del possibile, corrispondono alla funzione della scrittura nel testo. La scrittura non è che una matrice di mosse.21
i tradizionali confini dell’oggetto-testo si dissolvono e lo spazio sintattico è uno spazio mobile, nel quale ciascun elemento ridefinisce il proprio statuto e la propria collocazione in funzione del percorso di lettura: si affermano le idee di ‘apertura’ dell’opera, di ‘interattività’ o libertà di agire ‘nel/con’ l’ope-ra, di ‘associazione/connessione’ e ‘multisequenzialità’ opposta a linearità, strettamente collegate ai concetti di ‘itinerario’, come viaggio, navigazione su cui basare il modo di ‘accesso’ e ‘uso’, e di ‘processo’, opposto a creazione, in corso, continuo, senza opposizioni tra diverse sfere sensoriali.
come in un ipertesto, il lettore non è vincolato dalla sequenzialità linea-re, ma può muoversi da un’unità testuale a un’altra, costruendosi ogni volta il proprio testo, che scaturisce dalla selezione di alcuni legami piuttosto che di altri: diventa un navigatore, secondo una metafora che ricorre anche in calvino, nelle cui opere combinatorie il personaggio o è un viaggiatore testuale, come in Se una notte d’inverno un viaggiatore, o un gruppo di viandanti, come ne Il castello dei destini incrociati, o appunto un navigatore o esploratore, come il Marco Polo de Le città invisibili.
20 i. calViNo, Le città invisibili, torino, einaudi, 1972, p. 23.21 giaNNi celati, Il racconto di superficie, in «il verri», Xviii, n. 1, marzo 1973, pp. 104-105.
caLvino e iL roManZo deL PuBBLico 355
Proponendo molteplici percorsi, una narrativa ipertestuale offre un’im-magine più complessa e ‘plurale’ del mondo narrato, demandando al letto-re, reso parte attiva nel processo creativo, il compito di collegare e ricostru-ire il disegno, o uno dei disegni possibili, dell’autore:
il navigatore partecipa [ … ] alla redazione o quantomeno all’edizione del testo che “legge” poiché è lui a determinare la sua organizzazione finale (la dispositio della retorica antica) [ … ]. con l’ipertesto ciascuna lettura è un atto di scrittura.22
La lettura diventa così scrittura: si passa da testi ‘leggibili’ a testi ‘scri-vibili’, dove il lettore svolge anche il ruolo di produttore, non solo di con-sumatore.23 Landow usa spesso il termine wreaders (da writers, autori, e readers, lettori) per identificare la nuova figura di autore-lettore,24 associata anche da calvino all’immaginario informatico.25
anche ne Il castello dei destini incrociati, il testo emerge nel momento stesso in cui viene composto dal lettore, il quale crea, arbitrariamente, la sua sequenza di unità discrete di blocchi di testo per sovrapposizioni e con-nessioni, e a ogni nodo o biforcazione può scegliere fra due o più percorsi, essendo i tarocchi codici aperti e flessibili, che lasciano spazio all’inventivi-tà e all’immaginazione: è una sequenzialità azzerata ogni volta dal rimesco-lamento delle carte, come quella cancellata con lo spegnersi del computer.
il gioco delle carte è un gioco di costruzione e distruzione, simile al puzzle di Barthlebooth nel romanzo di Perec, un gioco che fa sì che il rac-conto rimanga fluido e provvisorio, allo stesso modo di un ipertesto, dove il lettore si muove nelle lessie, come un enigmista che cerca di ricostruire un disegno accostando tra loro le sue tessere disperse.
nella lettura pluridirezionale è rappresentata simbolicamente la fluidità del racconto orale, della conversazione e del pensiero, che non è lineare ma multilineare, a zigzag, costituito da deviazioni e frasi lasciate a metà.
analogamente alla dimensione ‘navigazionale’ dell’ipertesto, che di per sé corrisponde alla possibilità di muoversi all’interno delle informazioni secondo percorsi non lineari e personalizzati, Le città invisibili hanno una struttura narrativa ‘modulare’, capace di adeguarsi alle possibili direzioni di lettura di ogni singolo lettore: da un lato, questa struttura consente di leggere le unità autonomamente, senza seguire un ordine gerarchico, tipico
22 cfr. Pierre léVy, Il virtuale [1995], tr. it., Milano, raffaello cortina editore, 1997, p. 35.23 cfr. r. bartheS, S/Z cit., p. 10.24 cfr. george P. laNdow, L’ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria (1994), tr. it., Milano,
Bruno Mondadori, 1998.25 cfr. johN USher, Calvino and the computer as writer/reader, in «Modern Language review»,
Xc, n. 1, gennaio 1995, pp. 41-54.
356 autori, Lettori e Mercato neLLa Modernità Letteraria
della struttura sequenziale; dall’altro lato, non è necessario percorrere iti-nerari prefissati secondo selezioni progressive di pertinenza, come avviene nei percorsi ad albero.
oltre a dare evidenza al ruolo del lettore, in Se una notte d’inverno un viaggiatore calvino organizza la struttura romanzesca sul motivo dell’atte-sa, adottando «una procedura letteraria determinata – propria della narra-tiva popolare e di consumo ma variamente adottata dalla letteratura colta – che si basa in primo luogo sulla capacità di costringere l’attenzione su un intreccio nella continua attesa di ciò che sta per avvenire».26
La centralità dell’intreccio, sulla quale si gioca il rapporto con il pub-blico e la stessa professionalità artigianale dello scrittore, ribadisce la con-cezione dell’opera come ‘meccanismo’ e, nello stesso tempo, riformula in termini nuovi il primato strutturale assegnato da calvino alla fiaba, come modello di racconto di avventura e di prova, lineare, fondato sulle azioni e su un atteggiamento essenzialmente estrovertito verso la realtà, ispirato a una forte concentrazione simbolica.
il medesimo interesse per gli aspetti stilistici e strutturali, per il ritmo e per la logica costruttiva del racconto, caratterizza l’attrazione di calvino per i folktales e per i fairytales, come egli stesso ammette in Rapidità:
La tecnica della narrazione orale nella tradizione popolare risponde a criteri di funzionalità: trascura i dettagli che non servono ma insiste sulle ripetizioni, per esempio quando la fiaba consiste in una serie di ostacoli da superare. il piacere infantile d’ascoltare storie sta anche nell’attesa di ciò che si ripete: situazioni, frasi, formule. come nelle poesie e nelle canzoni le rime scandiscono il ritmo, così nelle narrazioni in prosa ci sono avvenimenti che rimano tra loro. La leggenda di carlo Magno ha un’efficacia narrativa perché è una successione d’avvenimenti che si rispondono come rime in una poesia.27
il richiamo alla matrice orale del racconto è forte già ne Il sentiero dei nidi di ragno, dove calvino individua un pubblico ideale nella collettività di persone che hanno vissuto nella stessa ‘atmosfera’ storica, tentando di mettersi nei panni di un ‘anonimo narratore orale’:
alle storie che avevamo vissuto di persona o di cui eravamo stati spettatori s’aggiungevano quelle che ci erano arrivate già come racconti, con una voce, una cadenza, un’espressione mimica. durante la guerra partigiana le storie appena vissute si trasformavano e trasfiguravano in storie raccontate la notte attorno al fuoco, acquistavano già uno stile, un linguaggio, un umore come di bravata, una ricerca d’effetti angosciosi o truculenti. alcuni miei racconti, alcune pagine di que-
26 cfr. i. calViNo, Se una notte d’inverno un narratore, in «alfabeta», i, n. 8, dicembre 1979, p. 5.27 ideM, Lezioni americane, in Saggi 1945-85, tomo i cit., p. 660.
caLvino e iL roManZo deL PuBBLico 357
sto romanzo hanno all’origine questa tradizione orale appena nata, nei fatti, nel linguaggio.28
se, nel primo romanzo, il modello della fiaba è presente come archetipo del racconto di avventura e di prova nei modi di una narrativa picaresca, su questo paradigma ideale si innestano soluzioni del romanzo realistico, di quello intimista, procedimenti euristico-retrospettivi propri dell’intrec-cio ‘giallo’, esplicite citazioni fumettistiche e cinematografiche, formule espressive riprese dalla ‘paraletteratura’ di consumo, come i canti popolari, gli album di avventure colorati o i ‘supergialli’, entrate ormai a far parte dell’immaginario collettivo e, quindi, di immediata ‘leggibilità’.
con Il Sentiero dei nidi di ragno, possiamo già parlare di ‘pluridiscorsi-vità’, calibrata sulla prospettiva di un pubblico eterogeneo, che risolve in maniera originale il problema della scelta tra «letteratura d’arte» e «lettera-tura di consumo», facendo confluire gli estremi verso una zona media che Petronio chiamerebbe «avanguardia di massa»:29 calvino dimostra come un unico macrogenere popolare possa traghettare istanze assimilabili at-traverso mezzi di comunicazione di massa e materie espressive differenti e, contemporaneamente, offrire un ritratto in sezione di un periodo, pervaso e attraversato dalle medesime tendenze culturali e sociali che trovano in esso varie manifestazioni intertestuali.
nell’ottica di un pubblico sempre più eterogeneo, che giustifica la fu-sione e contaminazione verticale dei generi e dei registri linguistici, la ‘dif-ferenziazione’ organizzata, Le cosmicomiche rappresentano l’esperimento più significativo di calvino, nel quale coesistono fantasia e realtà, artificio e semplicità, attraverso l’incrocio di narrativa premodernista e sperimentale, di letteratura popolare e sofisticata: inaugurano un nuovo, personalissimo, genere che va al di là dell’oscillazione tra ‘realismo a carica fiabesca’ e ‘fiaba a carica realistica’.
La fantascienza costituisce un pretesto per dare un nuovo rilievo a si-tuazioni e immagini quotidiane, in un contesto straniante, e rendere ogni associazione legittima, come calvino stesso esplicita nella prefazione a La memoria del mondo e altre storie cosmicomiche (1968) marcando le distanze dalla science-fiction:
La prima differenza [ … ] è che la “science-fiction” tratta del futuro, mentre ognuno dei miei racconti si rifà a un passato remoto, ha l’aria di fare il verso d’un “mito delle origini”. Ma non è soltanto questo: è il diverso rapporto tra dati scien-
28 ideM, Prefazione, in Il sentiero dei nidi di ragno [1947], Milano, club degli editori, 1964, p. 8.29 cfr. g. PetroNio, Racconto del Novecento letterario in Italia, 1940-1990, Bari, Laterza, 1994,
p. 266.
358 autori, Lettori e Mercato neLLa Modernità Letteraria
tifici e invenzione fantastica. io vorrei servirmi del dato scientifico come d’una carica propulsiva per uscire dalle abitudini dell’immaginazione, e vivere anche il quotidiano nei termini più lontani dalla nostra esperienza; la fantascienza invece mi pare che tenda ad avvicinare ciò che è lontano, ciò che è difficile da immagina-re, che tenda a dargli una dimensione realistica o comunque a farlo entrare in un orizzonte d’immaginazione che fa parte già d’una abitudine accettata.30
se il ricorso ai linguaggi della scienza recupera un campo di possibilità illimitate alla scrittura, la ‘familiarizzazione’ dei contenuti, ottenuta anche attraverso l’uso di frasi ed espressioni trite e colloquiali, li rende concreti, leggibili, e investe il paradigma fantascientifico di effetti comici, parodiz-zanti: questa tensione tra ‘recupero’ e ‘dissoluzione’ dei generi produce un effetto ‘straniante’, tipico di una prospettiva postmoderna inclusiva e pluralista.
Quella di calvino, come l’ha definita Montale, è una «fantascienza al contrario» che spiega fenomeni naturali grandiosi con comportamenti e oggetti usuali: si tratta di una declinazione del fantastico comunque diversa rispetto a quella indicata ne La letteratura fantastica di todorov, che vede ne La metamorfosi di Kafka il testo più emblematico del fantastico nove-centesco.31
Tutto in un punto, in modo particolare, ci dà la misura della fantasia mul-tidimensionale e multispaziale di calvino, che, nello stesso tempo, rimane ‘centripeta’, ben ancorata alla realtà: è un esempio di letteratura ‘di massa’, capace, come direbbe Petronio, di dare ai propri lettori «in modi realistici o fantasiosi, diretti o metaforici [ … ] una visione epica di sé e del mondo in cui vive», presentando «eroi con i quali identificarsi».32
La fusione di “cosmico” e di “comico” realizza l’intreccio di livelli ‘alti’ e di livelli ‘bassi’, di cui è sintomatico il ricorso a metafore gastronomiche per dare corpo alle teorie della scienza contemporanea che, come osserva calvino, «non ci dà più immagini da rappresentare».33
alla base de Le cosmicomiche ci sono gli stessi principi che hanno ispira-to «Futuro», una delle prime riviste italiane di science-fiction, nata nel 1963 e diretta da Lino aldani, in un periodo di grande vivacità del genere (ricor-diamo soltanto le esperienze di «interplanet» e del Festival internazionale di trieste, nato nello stesso 1963): vi troviamo la medesima rivendicazione
30 i. calViNo, Prefazione a La memoria del mondo e altre storie cosmicomiche, Milano, club degli editori, 1968, pp. 5-6.
31 cfr. tzVetaN todoroV, La letteratura fantastica [1970], tr. it., Milano, Garzanti, 1977, pp. 172-179.32 cfr. g. Petronio (a cura di), Letteratura di massa, letteratura di consumo, roma-Bari, Laterza,
1979, p. LXXi.33 cfr. i. calViNo, Prefazione a La memoria del mondo e altri racconti cosmicomici cit., p. 5.
caLvino e iL roManZo deL PuBBLico 359
della priorità della ‘cifra esteriore’, del ‘procedimento’ e dell’’effetto’ ri-spetto all’esattezza del dato scientifico, dell’efficacia della strategia lingui-stica rispetto alla critica del presente o a una riqualificazione conoscitiva della letteratura e dell’immaginario tecnologico.
viene propugnata «un’idea della letteratura come finzione, attraverso cui la science-fiction assurgerebbe a forma narrativa esemplare del tempo dello spettacolo; e la scienza annegata nei giochi dell’immaginazione, co-stretta allo spazio della parola, disegnerebbe una dimensione fittiva, nella quale il ‘presente’ si eclissa».34
La riscrittura dei generi si espone inevitabilmente al rischio del conven-zionale e della banalizzazione, anche se, come sottolinea schulz-Buschhaus, è comunque positiva perché porta alla scoperta «che l’autentico è in fondo tanto irraggiungibile quanto il convenzionale è inevitabile (altrimenti non vi sarebbe comunicazione)».35 chiunque operi nell’orizzonte della lettera-tura di massa deve ormai convivere con questo presupposto, di cui anche calvino è consapevole, sviluppandone i connotati ludici e ricollegandolo alla matrice mitica del racconto: «il ripetitivo cui vuoi sfuggire poi lo ritrovi come significati elementari e immagini primarie, cioè non altro che strut-ture mitiche fondamentali, che il linguaggio continuamente veicola, cela e rivela».36
L’instabilità dei generi, oscillante tra riflessività metatestuale e paro-dia, ne porta al limite le strutture, le ‘dissipa’: da questa «produzione per dissipazione»37 deriva un nuovo ‘supergenere di ricerca’, risultato del rico-noscimento dell’esistenza dei generi ‘altri’, appartenenti alla letteratura di consumo.
L’’automazione del principio costruttivo’ diventa centrale ed esibita ne L’incendio della casa abominevole (1973), il progetto oulipiano nel quale calvino sembra essere in piena consonanza con todorov, che vede nel ro-manzo poliziesco il prodotto più rappresentativo delle narrazioni di massa, caratterizzate dalla conformità integrale alle norme del genere.38
La detection story conserva il senso di un gioco di enigmistica, di una combinazione di incastri che produce effetti inattesi: in quanto meccani-smo puro, individua la struttura paradigmatica di ogni narrazione.
34 cfr. brUNo brUNetti, Rileggendo «Futuro» (1963-64). Note su un’esperienza della fantascienza italiana, in Romanzo e forme letterarie di massa. Dai “Misteri” alla fantascienza, Milano, edizioni deda-lo, 1989, p. 152.
35 cfr. U. SchUlz-bUSchhaUS, Critica e recupero dei generi. Considerazioni sul “moderno” e sul “postmoderno”, in «Problemi», XXiX, n. 101, gennaio-aprile 1995, p. 14.
36 i. calViNo, La macchina spasmodica [1969], in Saggi 1945-85, tomo i cit., p. 254.37 cfr. oMar calabreSe, L’età neobarocca, Bari, Laterza, 1987, p. 153.38 cfr. t. todoroV, Poetica della prosa. Le leggi del racconto [1971], tr. it., Milano, Bompiani, 1989, p. 56.
360 autori, Lettori e Mercato neLLa Modernità Letteraria
in Se una notte d’inverno un viaggiatore, i dieci inizi di romanzo rap-presentano altrettante tipologie di ‘romanzesco’ moderno: si tratta di dieci ‘stili di storie’, di un repertorio delle diverse possibilità del narrabile, che conducono a «una vera enciclopedia delle forme narrative fra le quali, tan-to il lettore specialista quanto il lettore non specialista e letterariamente più ingenuo troveranno degli aspetti vicendevolmente avvincenti».39 come nel-la letteratura di massa, «il genere diventa contemporaneamente lo spazio del dicibile e la sintassi che ne regola le produzioni».40
il vero tema del romanzo è la testualità, nei suoi vari aspetti, com-presi quelli delle dinamiche della destinazione e della «codificazione eteronoma»,41 ovvero delle esigenze esterne del mercato culturale e mas-smediologico che sembra trasferire la stratificazione della produzione lette-raria, dei diversi target, all’interno dell’opera stessa, per poter raggiungere contemporaneamente più categorie possibili di lettori: quando calvino af-ferma che bisogna «ritrovare le funzioni vere d’un rapporto col pubblico: il piangere, il ridere, la paura, l’avventura, l’enigma»,42 egli pensa a un pubbli-co esteso, composito, anche distratto, un pubblico differenziato che va dal lettore colto al lettore di fumetti e che è «l’equivalente contemporaneo del pubblico dei romanzi d’appendice».43
in un certo senso, calvino realizza pienamente la vocazione ariostesca, sottesa a tutto il suo percorso di scrittore, di creare un’opera che tracci una «geometria dei sentimenti e dei destini», e sia un’«algebra delle avventure umane»:44 nello stesso tempo, il romanzo si propone come momento di incontro e di interazione tra diversi tipi potenziali di pubblico, il ritratto di una società complessa, non più rapportabile a quella che si rispecchiava nel ‘progetto di pubblico’ di ariosto.
il frantumarsi dell’oggettività realistica, che segna la «dissoluzione nove-centesca del romanzo», determina «l’oggettivarsi della tecnica dell’intrec-cio che viene considerata in sé, come un ghirigoro geometrico portando alla parodia, al gioco del romanzo costruito “romanzescamente”».45
39 cfr. U. SchUlz-bUSchhaUS, Critica e recupero dei generi. Considerazioni sul “moderno” e sul “postmoderno” cit., p. 14.
40 cfr. giUSePPe gagliozzi, Ipertesti e modelli testuali (ciclo di seminari febbraio-giugno 1994), roma, accademia nazionale dei Lincei, 1997, p. 138.
41 cfr. Marcello Sechi, La deriva dei generi, in M. Sechi, b. brUNetti, Lessico novecentesco, Bari, edizioni Graphis, 1996, p. 8.
42 cfr. i. calViNo, Colloquio con Ferdinando Camon, in Saggi 1945-85, tomo ii cit., pp. 2785-2786.43 cfr. Mario bareNghi, Italo Calvino, le linee e i margini, Bologna, il Mulino, 2007, p. 188.44 cfr. i. calViNo, Ariosto geometrico, in «italianistica», iii, n. 3, settembre-dicembre 1974, p. 657,
ora in Saggi 1945-85, tomo i cit., p. 776.45 cfr. ideM, Pasternak, «Il dottor Zivago» [1958], in Saggi 1945-85, tomo i cit., p. 1364.
caLvino e iL roManZo deL PuBBLico 361
La soluzione calviniana per ovviare alla situazione di impasse creata dal «canone dell’interdetto» e dall’estremo nominalismo dell’arte moderna, è il ‘recupero’ del ‘romanzesco’, nel quale avviene il ritorno ai generi e alle tecniche narrative di un passato rifiutato dalle avanguardie novecentesche (gotico, storico, avventura, favola, fiaba) attraverso i generi e le tecniche narrative di un presente, o passato prossimo, emarginato (rosa, giallo, thril-ler, spionistico, fantascienza, fantasy, western).
al rischio di approdare a una letterarietà autosufficiente, che non ha più alcun rapporto con il lettore reale e che trova la sua personificazione in er-mes Marana, grande falsificatore di testi e demistificatore, calvino oppone il personaggio vincente della lettrice Ludmilla, che riafferma la centralità della lettura come condizione di esistenza del mondo scritto: in questo modo lo scrittore rilancia il ruolo della letteratura, alla quale, come nota bene Jauss, spetta «il compito di rompere lo schermo delle parole e dei concetti per far vedere di nuovo il mondo come per la prima volta».46 non si tratta quindi di un’idea della letteratura «come puro piacere»,47 ma di una presa di coscienza della realtà socio-culturale che lo scrittore ha di fronte.
La conseguenza di questo approccio è una ridefinizione dei confini del letterario e del concetto stesso di letterarietà, nel senso di una sempre mag-giore «eteronomia del testo»:48 diventa urgente una nuova formulazione dei ‘canoni’, finora eccessivamente subordinata ai generi ‘forti’;49 risulta su-perata ogni distinzione tra autori ‘maggiori’ e autori ‘minori’, come calvino stesso dichiara in una lettera a Guido Fink del 1968.50
riprendendo le caratteristiche che raimondi attribuisce al pluralismo dialogico del Postmoderno, si può parlare del canone nei termini di una tradizione che «si istituzionalizza e insieme si decostruisce», di una «nor-ma da inventare di continuo»:51 in questa prospettiva l’’orizzonte di attesa’ del pubblico diventa sempre più significativo per comprendere la strategia dello scrittore.
46 cfr. haNS robert jaUSS, Italo Calvino: ‘Wenn ein Reisender in einer Winternacht’. Plädoyer für eine postmoderne Ästhetik, in Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne, Frankfurt, suhr-kamp, 1990, p. 276.
47 cfr. roMaNo lUPeriNi, La fine del postmoderno, napoli, Guida, 2004, pp. 73-74.48 cfr. giUlio ferroNi, Dopo la fine, torino, einaudi, 1996, p. 76.49 cfr. alfoNSo berardiNelli, La forma del saggio. Definizione e attualità di un genere letterario,
venezia, Marsilio, 2002, pp. 91-92.50 cfr. la lettera a Guido Fink, datata 24 giugno 1968, ora in i. calViNo, Lettere 1940-1985 cit.,
p. 1004.51 cfr. ezio raiMoNdi, Poetiche della modernità in Italia, Milano, Garzanti, 1990, p. 9 e p. 105.
INDICE
TOMO I
PrefazioneCesare De Michelis 5
RELAZIONI
Cesare De Michelis (Università di Padova)Il mercato delle lettere 9
Vittorio Spinazzola (Università di Milano)Le responsabilità della lettura 15
Alberto Cadioli (Università di Milano)L’officina dei testi 21
Cristina Benussi (Università di Trieste)Il romanzo d’esordio nella modernità letteraria 33
Annamaria Andreoli (Università della Basilicata)Pubblico / folla / popolo nell’estetica simbolista di d’Annunzio 49
COMUNICAZIONIParte I
1. TRA SETTECENTO E OTTOCENTO
Loredana Castori (Università di Salerno)Le «Novelle letterarie» nei giornali veneziani del Settecento 65
Riccardo Donati (Università di Firenze)«Ma in Italia chi scrive poco mangia poco». Note sull’industria culturalenel secondo Settecento veneto 77
007_indice volume II-683_000_pped 27/05/11 08.52 Pagina 683
Roberta Delli Priscoli (Università di Salerno)Un periodico innovatore di fine Settecento:il «Magazzino Enciclopedico Salernitano» 87
Anna Scannapieco (Ca’ Foscari, Venezia)Il pubblico teatrale nella riflessione teorica e nella prassidrammaturgica di Carlo Gozzi 101
Ida De Michelis (La Sapienza, Roma)In principio era un ciarlatano: Faust come mise en abîmedell’Io moderno 113
Novella Primo (Università di Catania)Il «libro» leopardiano tra logiche editoriali «efimere»e cristallizzazioni letterarie 123
Patrizia Zambon (Università di Padova)Sul pubblico. Lettura di Il viaggio di un ignorante di Giovanni Rajberti 135
Anna Rinaldin (Ca’ Foscari, Venezia)Verso l’unità linguistica: le Letture italiane di Niccolò Tommaseo 147
Manuela Brunetta (Ca’ Foscari, Venezia)Francesco Dall’Ongaro e la Tipografia Elvetica di Capolago 159
Ricciarda Ricorda (Ca’ Foscari, Venezia)Letteratura di viaggio, giornalismo e pubblico femminile:strategie della rivista “La donna” (1868-1870) 171
Luca Clerici (Università di Milano)Il paradosso di Edmondo De Amicis 183
Alberto Carli (Università del Molise)Emma e i suoi editori. Letteratura giovanile e pubblico popolarenell’opera di Emma Perodi 189
Anna Lorella Giuliani (Università della Calabria)Il pendolo di Collodi. Emergenza educativa, disillusione storicae leggi di mercato 199
684 AUTORI, LETTORI E MERCATO NELLA MODERNITÀ LETTERARIA
007_indice volume II-683_000_pped 27/05/11 08.52 Pagina 684
Alberico Guarnirei (Università della Calabria)«Il romanzo di un maestro»: la varietà metamorfica del realenella narrativa di De Amicis 211
Ilaria Accardo (L’Orientale, Napoli)Contributo per la storia della ricezione di una lezione desanctisianasull’umorismo. Gli Scritti critici di Francesco De Sanctis,con prefazione, postille e note di Vittorio Imbriani 227
Elisa Bosio (Università di Padova)Arrigo Boito nella Casa Ricordi 237
Claudio Panella (Università di Torino)Gli scrittori e le Esposizioni: scritture su commissionenella Torino di fine ’800 247
Alberto Zava (Ca’ Foscari, Venezia)Alberto Cantoni e il rapporto con il pubblico e il mercato editoriale:fra testo, metatesto ed edizioni 257
Clara Borrelli (L’Orientale, Napoli)Mastriani e i suoi lettori 263
Angela Carpentieri (L’Orientale, Napoli)Matilde Serao: un colloquio con i lettori(Brevi riflessioni su Matilde Serao) 273
Dora Marchese (Università di Catania)Percezioni sensoriali fra letteratura e pubblicità nell’operadi Matilde Serao 281
Rosaria Tagliatatela (L’Orientale, Napoli)Il Saper vivere di Matilde Serao: consigli di vita nella conversazionequotidiana con i lettori, dalle rubriche giornalistiche all’edizionein volume 293
Rosa Pisano (L’Orientale, Napoli)La letteratura per l’infanzia di Luigi Capuana 305
INDICE 685
007_indice volume II-683_000_pped 27/05/11 08.52 Pagina 685
2. DAL PRIMO NOVECENTO AGLI ANNI QUARANTA
Mario Cimini (Università di Chieti)L’arte come «bisogno diffuso»: D’Annunzio e l’ideadel consumo letterario 317
Vito Santoro (Università di Bari)Tra cronaca e letteratura: Guerre politiche di Goffredo Parise 239
Emanuela Scicchitano (Università della Calabria)Fra la Chimera e la Gorgone: Il fuoco di Gabriele d’Annunzio 341
Carlo Santoli (Università di Salerno)D’Annunzio tra innovazione e modernità:il linguaggio figurativo del film Cabiria 353
Maria Panetta (La Sapienza, Roma)Benedetto Croce editor e mediatore editoriale 365
Isabella Pugliese (Federico II, Napoli)L’inchiesta internazionale sul verso libero (1905-1907) 379
Virginia di Martino (Federico II, Napoli)Sergio Corazzini: tra libri senza prezzo e poesia in vendita 389
Mario Musella (L’Orientale, Napoli)Marinetti editore: organizzatore, disorganizzatore, censore 397
Katia Trifirò (Università, Messina)Avanguardia letteraria e giornalismo militante. La specificitàdel movimento marinettiano in Sicilia, tra adesione e rifiuto,nella rivista messinese «La Balza Futurista» 409
Dario Tomasello (Università, Messina)Junges italien. Un’antologia “degenerata” degli scrittori italianicontemporanei nella Germania degli anni Trenta 415
Susanna Sitzia (Università, Cagliari)«Il mercato librario in Italia è assolutamente nullo per il mio genere».L’editoria italiana e il caso Campana 423
686 AUTORI, LETTORI E MERCATO NELLA MODERNITÀ LETTERARIA
007_indice volume II-683_000_pped 27/05/11 08.52 Pagina 686
Laura Piazza (Università, Catania)Contro le «industrie del cadavere».Dino Campana nel carteggio inedito Falqui-Vallecchi 435
Alessandro Zammataro (Università, Catania)Tozzi, Formiggini e La città della Vergine: tra mercato e Medioevo 447
Antonio Giampietro (Università, Bari)Il pubblico come maschera: «Le lettere» di Renato Serra 459
Domenico Giorgio (Federico II, Napoli)Cineasti letterati nel primo Novecento. Il caso di Salvatore di Giacomo 569
Laura Cannavacciuolo (L’Orientale, Napoli)Tra crisi e rivolta. Note sulla ricezione critica del Teatro Grottescoin italia 479
Silvia Acocella (Federico II, Napoli)Nella fitta scrittura del libricino dei conti: mondi di cartae taccuini segreti 481
Graziana Frantone (Università, Bari)Italo Svevo e la Grande Guerra: una voce nascostanella Pazifismus-Debatte 501
Anna Antonello (Università di Pavia)Zeno Zenobi, Zenobi Cosini e Zeno Cosini 511
3. DAL PRIMO DOPOGUERRA AGLI ANNI CINQUANTA
Sara Lonati (Université de Genève)Luigi Rusca e il Touring. Arrivi, partenze e ritorni tra «le vie d’italia»e «le vie del mondo» 527
Elisabetta Dibenedetto (Università di Bari)L’officina degli «Indifferenti». La funzione del raccontonella carriera di un «romanziere nato» 539
Dario Momigliano (Università di Catania)Roberto Bazlen e la grammatica critica delle «Lettere editoriali» 547
INDICE 687
007_indice volume II-683_000_pped 27/05/11 08.52 Pagina 687
Barbara Sturmar (Università di Trieste)«Ma come dimenticare Giotti?».Mediazioni editoriali per la poesiadi Virgilio Giotti 553
Massimiliano Mancini (La Sapienza, Roma)Il rapporto autore-pubblico nei dialettali: il caso Tessa 563
Monica Venturini (Università di Roma Tre)Alterità e funzione del pubblico nel romanzo colonialee post-coloniale 577
Bartolo Calderone (Università di Catania)«Gli inferni intimi» da Comisso (e Cocteau) a Saba 587
Sergio Di Prima (Università di Messina)Le prose venete di Diego Valeri 599
Dario Stazzone (Università di Catania)Carlo Levi e la casa editrice Einaudi. Dal Cristo si è fermato a Ebolia Un volto che ci somiglia. Ritratto dell’Italia 611
Giovanni Di Malta (Università di Cagliari)La letteratura russo-sovietica nel polisistema letterario italiano 623
Francesca Piccolo (Università di Messina)Segni e di-segni: storia de «La famosa invasione degli orsi in Sicilia»di Dino Buzzati 633
Serena Amalia Mazzone (Università di Catania)Una cosa che tocca lo spettatore dà fastidio: Buzzati e la provadel palcoscenico 639
Davide Torrecchia (Università di Palermo)Artemisia di Anna Banti e il mercato delle lettere 649
Maria Teresa Imbriani (Università della Basilicata)«Il Teatro dell’Usignolo» (1947-1949): Sinisgalli, Giagnie la poesia alla radio 659
Daniela Bernard (L’Orientale, Napoli)La storia editoriale di Bernari nel carteggio con Mondadori 669
688 AUTORI, LETTORI E MERCATO NELLA MODERNITÀ LETTERARIA
007_indice volume II-683_000_pped 27/05/11 08.52 Pagina 688
Marco Fumagalli (Università di Milano)Le edizioni Rosa e Ballo e Rizzoli del «Bubù di Montparnasse»:tra ragioni autoriali, traduttive e editoriali 00
Beatrice Sica (New York University)Da Italie magique (1946) a Italia magica (1988): Gianfranco Continie il mercato editoriale da Aux Portes de France a Einaudi 00
TOMO II
COMUNICAZIONIParte II
PrefazioneCesare De Michelis 5
4. DAGLI ANNI CINQUANTA A OGGI
Niccolò Scaffai (Università di Siena)L’intervista con l’autore: il caso di Montale 9
Anna Ferrari (L’Orientale, Napoli)Ideologia e passione: il “caso Scotellaro” 19
Marco Viscardi (Federico II, Napoli)La biblioteca del Principe. Tomasi di Lampedusa lettoree critico letterario 29
Elisabetta Reale (Università di Messina)Un Gattopardo popolare: Terra matta ovvero il bestsellerdi uno scrittore inconsapevole 41
Teodora Nicoleta Pascu (Università di Catania)Fare libri in Sicilia: I «Quaderni di Galleria»di Salvatore Sciascia Editore, breve storia di una collana 47
Giovanna Tomasello (L’Orientale, Napoli)Giornalismo, satira e sperimentazione ne «Il Caffè»di Giambattista Vicari 59
INDICE 689
007_indice volume II-683_000_pped 27/05/11 08.52 Pagina 689
Annalisa Carbone (Federico II, Napoli)«Le ragioni narrative» a Napoli negli anni Sessanta 67
Marco Rustioni (Università di Firenze)La primavera del «Che fare» 75
Federico Fastelli (Università di Firenze)La relazione autore-pubblico nella poesia della neoavanguardia:l’esempio di Pagliarani 83
Alessandro Terreni (Università di Milano)Antonio Porta e l’industria culturale: la prospettiva antiapocalitticadi un intellettuale neo-moderno 93
Teresa Spignoli (Università di Firenze)Poesia verbo-visiva: mercato e antimercato 103
Giancarlo Russo (Università di Catania)Autore, pubblico e poesia nelle riflessioni critiche di Caproni 117
Rossana Esposito (Federico II, Napoli)I casi letterari negli anni Sessanta 129
Andrea Tullio Canobbio (Università di Ferrara)Libri, polli e lettori: Bianciardi e il mercato delle lettere 141
Giuseppina Giacomazzi (Università di Roma)Scrittura e industria culturale nell’opera di Luciano Bianciardi 151
Antonia Marchianò (Università di Salerno)La gestazione editoriale dei romanzi einaudiani:il caso di Ottiero Ottieri 159
Lavinia Spalanca (Università di Palermo)Autori, lettori ed editori. Il sodalizio Chiara -Sciascia nel carteggio 1959-1979 169
Ilaria Crotti (Ca’ Foscari, Venezia)Per un’idea di pubblico negli anni Sessanta: l’autolettura d’autorenei Ritratti su misura di Elio Filippo Accrocca 177
690 AUTORI, LETTORI E MERCATO NELLA MODERNITÀ LETTERARIA
007_indice volume II-683_000_pped 27/05/11 08.52 Pagina 690
Alessandro Cinquegrani (Ca’ Foscari, Venezia)‘Piccolo mondo antico’ di Mario Soldati: primi sondaggiper una tassonomia dell’autore invisibile 189
Antonello Perli (Université de Nice)Ermeneutica filmica e ethos del romanzo:Bassani dal libro allo schermo 199
Luca Daino (Università di Milano)Come nasce un libro di poesia? Fortini, Bassanie Sereni editori e poeti 211
Adriana Mormina (Università di Catania)«La tentazione della prosa» di Vittorio Sereni tra letteratura e società 221
Caterina Marras (Università di Cagliari)Vittorio Sereni e il pubblico della poesia 231
Lisa Gasparotto (Università di Udine)Poeti leggono poeti. Sereni ha trasformato «L’Usignolo»? 241
Antonia La Torre (L’Orientale, Napoli)Il cinema di Pier Paolo Pasolini come rilettura e mercificazionedel patrimonio letterario italiano. Figurazioni e trasfigurazionidi Dante e Boccaccio da «Mamma Roma» a «Salò» 257
Maria Rizzarelli (Università di Catania)Un blob su commissione: ‘La rabbia’ di Pier Paolo Pasolini 267
Gianpaolo Altamura (Università di Bari)Autori e lettori. Il manifesto del “Nuovo Teatro” di Pasolini 277
Bruno Pischedda (Università di Milano)«So bene che dico delle cose terribili».(Appunti su «Lettere luterane» di P.P. Pasolini) 289
Chiara Marasco (Università della Calabria)Da «Solaria» al «Menabò»: la scrittura letterariae l’attività intellettuale di Elio Vittorini 295
INDICE 691
007_indice volume II-683_000_pped 27/05/11 08.52 Pagina 691
Pasqua Gasparro (Università di Bari)Le copertine della rivista «Il Menabò» 307
Rita Valentina Ronchei (Università di Bari)Il lettore in Calvino: «l’insostituibilità della letteraturae della lettura in un mondo che non vorrà più leggere» 315
Maria Elena Palmisano (Università di Bari)Calvino e la «febbre della pubblicazione» 325
Luigi Marfè (Università di Torino)Per chi si scrive? Autore, lettore e mercato nei saggi di Italo Calvino 331
Marina Paino (Università di Catania)Se una notte d’inverno uno scrittore: mercato, desiderio e angoscianella cornice di Calvino 339
Gianni Cimador (Università di Trieste)Calvino e il romanzo del pubblico 349
Nadia Rosso (Università di Catania)«Garanzia» e «serietà». Calvino e il mercato delle traduzioniin casa Einaudi 363
Emanuele Zinato (Università di Padova)Fortini, Calvino e la verifica dell’editoria scolastica 373
Ilaria Rubino (Università di Bari)«Centopagine». Un riconoscimento di forme nella narrativa italianatra Otto e Novecento 382
Federica Pastorino (Università di Genova)«Il partigiano Johnny»: un caso letterario del 1968tra mercato editoriale e dibattiti politici 389
Daniele Fioretti (Miami University - Ohio)Volponi e «Le difficoltà del romanzo»: il caso di «Corporale» 401
Antonella Santoro (Università di Salerno)L’idea di pubblico nel ‘Fuoco’ di Gabriele D’Annunzio 409
692 AUTORI, LETTORI E MERCATO NELLA MODERNITÀ LETTERARIA
007_indice volume II-683_000_pped 27/05/11 08.52 Pagina 692
Carlo Dilonardo-Giorgio Taffon (Università di Roma Tre)L’esempio Testori (Milano, Piccolo Teatro, 1960):uno scrittore al debutto, la committenza, la fruizione 421
Anna Guzzi (Università della Calabria)L’orlo di Benjamin e l’odore della realtà: una moderna genealogia 431
Carla Gubert (Università di Trento)«Niebo» (1977-1980): una comunità poetica degli anni Settanta 445
Maria Giovanna Italia (Università di Catania)Un lettore dell’altro mondo. Mario Luzi recensore della letteraturalatinoamericana negli anni Settanta 453
Caterina Paterlini (Università di Bologna)Dante a teatro fra testo e contesto 465
Ornella Bonarrigo (Università di Catania)L’autore prende per mano il lettore: Bufalinoe le ‘Istruzioni per l’uso’ del suo romanzo di esordio 475
Claudia Carmina (Università di Palermo)«Una scherma amorosa»: Bufalino e il lettore 483
Maria Cristina Uccellatore (Università di Catania)Gesualdo Bufalino e il giallo dell’editor in fabula 489
Andrea Gialloreto (Università di Chieti)Le scritture d’apprendistato di Giampaolo Rugarli 501
Federico Francucci (Università di Pavia)Lo scrittore-buffone s’inventa il suo editore.Su ‘Encomio del tiranno’ di Giorgio Manganelli 511
Silvana Tamiozzo Goldmann (Ca’ Foscari, Venezia)Fate partire le immagini: ‘il testamento letterario di Pier Maria Pasinetti,autore-lettore nel mercato internazionale’ 519
Nives Trentini (Università di Barcelona)L’appello al lettore, involontario complice,in ‘Venite, venite B-52’ di Veronesi 529
INDICE 693
007_indice volume II-683_000_pped 27/05/11 08.52 Pagina 693
Elisabetta Macaione (Università di Bari)Baricco: lettore e narratore tra ordine e caos 537
Ewa Nicewicz (Università di Varsavia)Tutti a scuola. La Holden e il fenomeno della scrittura creativadi massa 547
Silvia Zangrandi (IULM, Milano)«L’odore delle cose». I ‘treni’ di Ettore Mo:una scrittura fatta per durare? 557
Stefania Rimini (Università di Catania)La nuova epica di ‘Gomorra’ fra teatro e cinema 567
Luigi Marseglia (Università di Bari)Le dinamiche della storia e il moderno:‘Santa Maria delle Battaglie’ di Raffaele Nigro 577
Marialuigia Sipione (Ca’ Foscari, Venezia)Sfogliarne le vite: gli editori italiani e le loro biografie 589
Filippo Secchieri (Università di Ferrara)Dalla conversazione al libro. Intorno all’intervista letteraria 599
Alessandro Scarsella (Ca’ Foscari, Venezia)Postille di metodologia a margine di paraletteratura, cinema, fumettoe graphic novel 607
Elena Porciani (Università della Calabria)Le canzoni nei romanzi. Studiare il tema della musica popnella narrativa contemporanea 619
Guglielmo Pispisa (Università di Messina)Scrittura collettiva e superamento del narcisismo autoriale:un fenomeno in crescita 631
Giuseppe Palazzolo (Università di Catania)L’autore nella rete: dal romanzo storico al ‘New Italian Epic’ 641
694 AUTORI, LETTORI E MERCATO NELLA MODERNITÀ LETTERARIA
007_indice volume II-683_000_pped 27/05/11 08.52 Pagina 694
INDICE 695
Rosalba Galvagno (Università di Catania)La lettura ad alta voce. «Mondo di carta» - «A voce alta The reader» 651
Aldo Nemesio (Università di Torino)Il Web e i nuovi lettori 663
Giuliana Benvenuti (Università di Bologna)Come si studia la letteratura mondiale? La letteratura italiana sulla scena del mondo 671
007_indice volume II-683_000_pped 27/05/11 08.52 Pagina 695
Edizioni ETSPiazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
[email protected] - www.edizioniets.comFinito di stampare nel mese di maggio 2011
007_indice volume II-683_000_pped 27/05/11 08.52 Pagina 696
BIBLIOTECA DELLA MODERNITÀ LETTERARIA
collana di studi e testi
1. MARIA CARLA PAPINI, DANIELE FIORETTI, TERESA SPIGNOLI [a cura di], Il romanzodi formazione nell’Ottocento e nel Novecento, 2007, pp. 656.
2. GIOVANNA CALTAGIRONE, Io fondo me stesso. Io fondo l’universo. Studio sullascrittura di Alberto Savinio, 2007, pp. 272.
3. ANNA DOLFI, NICOLA TURI, RODOLFO SACCHETTINI [a cura di], Memorie, autobio-grafie e diari nella letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento, 2008,pp. 916.
4. BARBARA ZANDRINO, Trascritture. Di Giacomo, Licini, Cangiullo, Farfa, Testori,2008, pp. 184.
5. ELENA PORCIANI, Studi sull’oralità letteraria. Dalle figure del parlato alla parolainattendibile, 2008, pp. 144.
6. MARTA BARBARO, I poeti-saltimbanchi e le maschere di Aldo Palazzeschi, 2008,pp. 148.
7. PIERO PIERI, Memoria e Giustizia. Le Cinque storie ferraresi di Giorgio Bassani,2008, pp. 272.
8. PIERO PIERI, VALENTINA MASCARETTI [a cura di], Cinque storie ferraresi. Omaggioa Bassani, 2008, pp. 176.
9. GIUSEPPE LANGELLA, Manzoni poeta teologo (1809-1819), 2009, pp. 208.
10. ANNA GUZZI, La teoria nella letteratura: Jorge Luis Borges, 2009, pp. 216.
11. ALESSANDRO GAUDIO, Animale di desiderio. Silenzio, dettaglio e utopia nell’operadi Paolo Volponi, 2009, pp. 122.
12. EPIFANIO AJELLO, Il racconto delle immagini. La fotografia nella modernità lette-raria italiana, 2008, pp. 238.
13. ALESSANDRO MANZONI, Storia della Colonna infame. Saggio introduttivo, appara-ti e note a cura di Luigi Weber, 2009, pp. 212.
14. ELENA CANDELA, Amor di Parthenope. Tasso, Arabia, De Sanctis, Fucini, Serao,Di Giacomo, Croce, Alvaro, 2008, pp. 200.
15. IDA DE MICHELIS, Tra il ‘quid’ e il ‘quod’. Metamorfosi narrative di Carlo EmilioGadda, 2009, pp. 142.
16. MARIO DOMENICHELLI, Lo scriba e l’oblio. Letteratura e storia: teoria e critica del-le rappresentazioni nell’epoca borghese, 2011, pp. 330.
007_indice volume II-683_000_pped 27/05/11 08.52 Pagina 697
17. GIULIANO CENATI, Disegni, bizze e fulmini. I racconti di Carlo Emilio Gadda,2010, pp. 190.
18. PASQUALE MARZANO, Quando il nome è «cosa seria». L’onomastica nelle novelledi Luigi Pirandello. Con un regesto di nomi e personaggi, 2008, pp. 208.
19. SIMONA COSTA, MONICA VENTURINI [a cura di], Le forme del romanzo italiano e leletterature occidentali dal Sette al Novecentoi, 2010, 2 tomi: tomo I, pp. 860 -tomo II, pp. 652.
20. RICCARDO DONATI, Le ragioni di un pessimista. Mandeville nella cultura deiLumi, 2011, pp. 192.
21. ELISABETTA CARTA, Cicatrici della memoria. Identità e corpo nella letteraturadella Grande Guerra: Carlo Emilio Gadda e Blaise Cendrars, 2010, pp. 250.
22. PIER VINCENZO MENGALDO, In terra di Francia, 2011, pp. 170.
23. CATERINA VERBARO, I margini del sogno. La poesia di Lorenzo Calogero, 2011,pp. 188.
24. EMANUELA SCICCHITANO, «Io, ultimo figlio degli Elleni». La grecità impura diGabriele d’Annunzio, 2011, pp. 220.
25. NICOLA MEROLA [a cura di], Gianfranco Contini vent’anni dopo. Il romanista, ilcontemporaneista, 2011, pp. 234.
26. ILARIA CROTTI, ENZA DEL TEDESCO, RICCIARDA RICORDA, ALBERTO ZAVA [a curadi], Autori, lettori e mercato nella modernità letteraria, 2011, 2 tomi: tomo I,pp. 718 - tomo II, pp. 698.
007_indice volume II-683_000_pped 27/05/11 08.52 Pagina 698